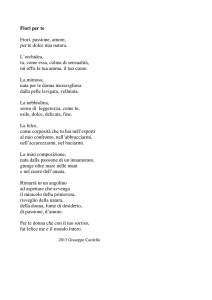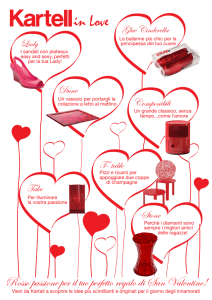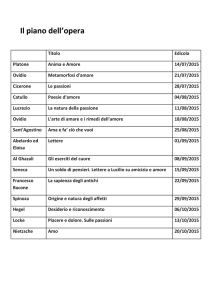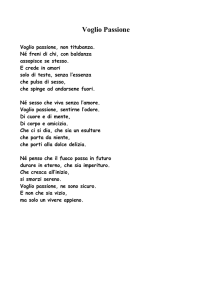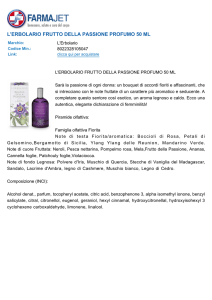LE PASSIONI.
Ciò che fa paura a Kant – ma non a Tommaso – è la dimensione pre-razionale dell’uomo: quella
dotazione energetica che dà vita agli stessi bisogni. Il linguaggio classico ne parla come della
dimensione passionale dell’uomo.
Parte I. Verso una considerazione appropriata della passione.
L’uomo non è esaurientemente descritto dalla sua dimensione razionale. Non a caso la tradizione
filosofica ne parla come dell’ “animale razionale”. E l’animalità dell’uomo, che pure partecipa della
razionalità, non è mai totalmente conciliata con questa, ma sembra seguire anche e prevalentemente
logiche proprie, mai del tutto impenetrabili, ma anche mai del tutto trasparenti alla razionalità. Ora,
la tradizione filosofica ha cercato, dall’antichità, di nominare e indagare la dimensione dell’uomo
che è solo mediatamente partecipe della razionalità. Platone la articolava in due parti, che
designava1 come epithymetikón (potere di bramare) e thymoeidés (potere di conoscere
emozionalmente): due forze, con le quali la razionalità umana (il loghistikón) deve fare i conti.
1) Alcune precisazioni terminologiche.
Il termine “passione” (in greco, páthos; in latino, passio) va inteso adeguatamente. Esso non
indica qualcosa che subiamo dall’esterno; bensì qualcosa che subiamo dall’interno di noi stessi. Lo
“subiamo” nel preciso senso che in noi vive come dotazione che non possiamo né darci né toglierci.
A ben vedere, le passioni, nel senso classico che qui riprendiamo, corrispondono a quel mondo
emotivo – come oggi diremmo -, che è il materiale energetico cui la nostra razionalità è chiamata a
dar forma. Un materiale che – come richiesto dal concetto classico di “materia” – è instabile, in
continuo ricambio2. Il nostro umore, infatti, cambia continuamente, pur all’interno di un medesimo
tracciato di vita, e pur nella coerenza di una impostazione morale.
1.1. La passione non è una “favorevole predisposizione”.
1
Cfr. Platone, Repubblica, IV, 439-440. Nel quarto libro della Repubblica, Platone introduce
criticamente la distinzione tra un principio razionale ed uno passionale nell’anima dell’uomo. E lo
fa argomentando per assurdo. Si pensi al caso di un uomo che ha sete, e si sente spinto a bere;
ebbene, lo stesso uomo, in qualche caso, può anche avvertire in sé una spinta opposta: qualcosa che
in lui si oppone al bere (ad esempio, perché altri ha più bisogno di lui di quell’acqua, o perché bere
in quel momento gli farebbe male). Spiega Socrate al riguardo: «È chiaro che l’identico soggetto
nell’identico rapporto e rispetto all’identico oggetto non potrà insieme fare o patire cose
contraddittorie. Sicché, se scoprissimo che in quei principi [dell’anima] si verificano questi fatti,
sapremo che non erano il medesimo principio, ma più principi diversi». La conclusione è allora che
nell’uomo hanno luogo, appunto, due principi diversi, che il Socrate platonico chiamerà:
epithymetikón (corrispondente al mondo passionale) e loghistikón (corrispondente alla razionalità).
(Cfr. ivi, IV, 436 b-439 d).
2 Al riguardo, Tommaso osserva che: «il patire come espulsione e trasformazione è proprio della
materia, quindi si rinviene solo nei composti di materia e forma» (cfr. Summa Theologiae, P. I IIae,
q. 24, a. 1, ad 1um).
36
Sono stati soprattutto i moralisti libertini, come La Rochefoucauld o Vauvenargue, a dare alla
parola “passione” il senso, ancor oggi corrente, di piega emotiva che domina il carattere di una
singola persona, rispetto alla quale anche le motivazioni razionali che quella persona adduce del
proprio comportamento, finiscono per assumere l’aspetto di interessate giustificazioni. In tal senso,
si dice che qualcuno “ha la passione del gioco”, o “delle automobili”, e così via. La passione, nel
senso in cui abbiamo iniziato a parlarne, è una disposizione energetica non ancora caratterizzata da
scelte o da abitudini.
1.2. Passione e istinto.
“Passione” non significa “istinto”. L’uomo infatti non ha veri e propri istinti. Le sue tendenze
non sono rigide come quelle dell’animale bruto. Per istinto si intende piuttosto una predisposizione
che fa agire in modo cieco, specifico, immutabile e tendenzialmente infallibile.
1.3. Passione e pulsione.
“Passione” non significa neppure propriamente “pulsione” (Trieb), nonostante l’originaria teoria
freudiana delle pulsioni parli di queste ultime, per certi aspetti, come se fossero passioni. Il fatto è
che l’uomo non può avere pulsioni allo stato puro. In fondo, la pulsione è la base organica
(neurofisiologica) della passione; quest’ultima è dunque una elaborazione della pulsione, che si
riferisce a comportamenti acquisiti, abitudini, immagini evocative introiettate, che legano a sé, e
danno una certa forma all’energia pulsionale. La passione, insomma, è il risultato dell’esposizione
del mondo pulsionale al mondo simbolico. I processi biochimici – che, ad esempio, gli psicofarmaci
possono aiutare a regolare - sono condizione necessaria, ma non sufficiente, dello svilupparsi o
dell’inibirsi della passione.
Il neurobiologo Jean-Didier Vincent, nel suo testo La biologia delle passioni (Parigi 1988),
propone che le passioni vengano interpretate non soltanto come implicanti un attivo milieu intérieur
(e cioè, un “sistema ghiandolare”), ma come implicanti anche un insieme di referenti extracorporei
(correlati intenzionali, simbolici, normativi), senza dei quali l’uomo avrebbe solo mere pulsioni.
L’“uomo ghiandolare” deve fare i conti, dunque, con l’“uomo simbolico”.
1.3.1. Le pulsioni secondo Freud.
La teoria delle pulsioni è messa a fuoco classicamente da Siegmund Freud. In Pulsioni e loro
destini (1915), Freud constata che in psicologia non si può fare a meno del concetto di pulsione
(Trieb), eppure non si sa come definirlo. La pulsione certo si distingue dallo “stimolo”, che agisce
come forza momentanea ed esterna al corpo, la risposta alla quale è una scarica rivolta all’esterno.
«La pulsione, al contrario, non agisce mai come una forza d’urto momentanea, bensì sempre come
una forza costante. E, in quanto non preme dall’esterno, ma dall’interno del corpo, non c’è fuga che
possa servire contro di essa». Alla pulsione non si può rispondere con una semplice reazione, bensì
con un “soddisfacimento”, «che può essere ottenuto soltanto mediante una opportuna modificazione
della fonte interna dello stimolo». Nell’infante, la distinzione tra stimoli da cui è possibile fuggire e
stimoli da cui non è possibile fuggire, costituisce il primo criterio per distinguere un “fuori” da un
“dentro”. Caratteri generali delle pulsioni sono - per Freud -: la “spinta”, cioè il suo carattere di
37
movimento attivo; la“meta”, cioè l’orientamento al soddisfacimento; l’ “oggetto”, ovvero ciò in
relazione a cui la pulsione può raggiungere il suo soddisfacimento; la “fonte”, cioè lo stimolo
organico che, psichicamente, è avvertito come pulsione. Quali sono le pulsioni semplici ed
originarie? Freud ne indica due gruppi: le “pulsioni dell’io o di autoconservazione” e le “pulsioni
sessuali”; ma aggiunge subito che tale articolazione è una congettura che può essere modificata. E lo
aggiunge anche sulla base della tendenza che tali pulsioni hanno ad intrecciarsi o a contrapporsi in
situazioni differenti. Le pulsioni hanno - secondo Freud - una plasticità, che può portarle (1) a
“trasformarsi nel loro contrario”; (2) a “volgersi sulla persona stessa del soggetto”; (3) a “essere
rimosse”; (4) a “essere sublimate”. In realtà, gli esempi che Freud porta del caso (1) sono tali da far
capire che, ciò cui egli allude, non è tanto un mutamento qualitativo della pulsione, quanto una sua
duttilità circa l’individuazione della meta (come quando si ha la trasformazione “dell’amore in odio”
nella relazione uomo-donna). Quanto al caso (2), esso corrisponde tanto poco ad uno stravolgimento
dello statuto della pulsione, da essere la norma per le “pulsioni dell’io”, e una normale fase di
sviluppo (fase “narcisistica”) per le stesse “pulsioni sessuali”. Infine, circa i casi (3) e (4) – quello
della rimozione o riconduzione alla stato inconscio; e quella della sublimazione, o elaborazione
culturale -, va detto che “rimozione” e “sublimazione” riguarderanno particolari tendenze a
particolari atti, e non certo le dimensioni del bisogno autoconservativo o di quello sessuale in quanto
tali.
1.4. Passione e bisogno.
“Passione” non è neppure sinonimo di “bisogno”. Piuttosto, “passioni” sono quelle energie che
pulsano costruttivamente nei bisogni - come fattori funzionali al raggiungimento del fine
razionalmente individuabile -; ma che possono anche essere deviate verso la distruzione dell’uomo.
Il bisogno, infatti, è già un che di strutturato: esso è come una forma che, culturalmente e
socialmente, le passioni ricevono. Già la descrizione delle sfere o dei livelli di bisogno dell’uomo,
indica – rispetto alla semplice passionalità – l’intervento di una forma culturalmente strutturata. In
particolare, i bisogni sono orientati ad una meta di soddisfacimento socialmente condivisa e
riconosciuta
Si può dire che le passioni siano la fonte energetica dei bisogni; e che, da parte loro, siano ignare
di mete di soddisfacimento. Ora, le forze passionali sono dotate di una loro inerzialità, oltre che di
una loro plasticità. La plasticità, è la caratteristica che consente loro, se cadono nell’orbita della
consapevolezza dell’io, di ricevere la forma del bisogno. L’inerzialità è invece la tendenza a seguire
la traiettoria e l’impulso loro originari – fin dove regge il supporto energetico.
1.5. Passione ed emozione.
È opportuno anche distinguere tra “passione” ed “emozione”, se con quest’ultimo termine
indichiamo ciò che della passione è avvertibile, ciò che la passione ci fa provare. Nonostante i due
termini vengano spesso sovrapposti, si potrebbe paragonare l’emozione alla punta emergente di
quell’iceberg che è la passione, la cui vita e le cui dinamiche per lo più sfuggono alla vita cosciente.
Ciò comporta che, per intervenire sulle passioni, non ci si possa limitare ad intervenire sulle
emozioni cui esse danno luogo, ma si debba piuttosto intervenire più al fondo, addestrando le
energie con l’esercizio e la costanza.
38
1.6. Passione e sentimento.
Dobbiamo anche distinguere tra “passione” e “sentimento”: le passioni sono qualcosa in cui ci
troviamo immersi, i sentimenti sono qualcosa che edifichiamo. Essi, infatti, sono stabili disposizioni
del mondo passionale intorno ad un “oggetto” permanente. I sentimenti, in altre parole, non sono
semplici reazioni emotive, ma piuttosto sono il frutto di un paziente lavoro – condotto su di sé e
sugli altri -, che ha come scopo quello di investire stabilmente le proprie energie passionali su realtà
permanenti (persone, ambienti, luoghi), e non semplicemente su qualità, di cui le realtà ora citate
possano essere occasionali portatrici.
2) Il contributo della Klein alla comprensione del nostro tema.
Una nota allieva di Freud - Melania Klein, la prima psicoanalista dei bambini – ci può aiutare a
capire la differenza che c’è tra passione e sentimento. Secondo la Klein, il lavoro dell’educatore, ma
anche quello del terapeuta, devono riconoscere come propria meta lo sviluppo, nel ragazzo, della
capacità di amare le persone, e non solo di reagire a stimoli emotivi di cui le persone siano fonte.
Almeno a tratti, la Klein presenta la “coscienza morale” (Gewissen) come un Super-Io evoluto,
che educa l’Io ad un “atteggiamento etico” - coincidente, ci sembra, con l’affermarsi del “principio
di realtà”. «Il Super-Io» - scrive la Klein nel 1933 -, «da potere minaccioso e tirannico, fonte di
pretese insensate e contraddittorie che l’Io non è assolutamente in grado di soddisfare, comincia a
trasformarsi in un’istanza che esercita un’autorità più moderata e persuasiva, e che pone esigenze
suscettibili di essere effettivamente soddisfatte. Il Super-Io, insomma, diventa a poco a poco
coscienza morale nel vero senso del termine». Lo stesso lavoro “analitico” ha come scopo quello di
migliorare la «capacità di sublimare e di adattarsi socialmente», rendendo così «il bambino non solo
più felice e più sano ma anche più capace di senso sociale e morale»3.
In fondo, la “capacità di amare” sembra costituire - nella prospettiva kleiniana - il fine adeguato
della vita, ovvero il bene in senso propriamente morale e non più meramente economico. Se essa è,
in una certa misura, qualcosa di “innato”, è anche vero che lo sviluppo psichico può promuoverla,
ostacolarla o deviarla. Anche in questo caso, comunque, risulta decisivo il ruolo svolto dal senso di
colpa: «infatti, allorché la severità esorbitante del Super-Io diventa alquanto minore, le sue richieste
all’Io di dar conto delle aggressioni immaginarie fanno insorgere sensi di colpa che destano nel
bambino forti tendenze a riparare il danno immaginario inferto agli oggetti»; ed è proprio da queste
“tendenze riparatrici”, che si sviluppa un miglior rapporto col mondo sia esterno che interno4.
Del resto, la psicoanalisi mira ad una possibile convivenza dell’Io con i suoi sensi di colpa,
nonché ad una valorizzazione di questi ultimi come stimolo alla responsabilità. Lo stimolo dà luogo
a quelle fantasie riparatrici che, con un processo lungo quanto la vita psichica, consolidano le figure
oggettuali e parentali “buone”, già introiettate dal soggetto quali elementi del Super-Io. In
particolare, la “fiducia nel loro potere” e la “identificazione” con esse, rendono capace il bambino
di difendersi efficacemente dalla minaccia degli elementi “cattivi” del Super-Io, e di operare
“proiezioni di sentimenti buoni” verso l’esterno, operando di conseguenza investimenti libidici
ordinati e soddisfacenti in quella stessa direzione5.
«Se la madre è presa nel mondo interiore del bambino come un oggetto buono su cui si può
contare» - leggiamo -, «l’identificazione con le buone caratteristiche della madre diviene la base per
3
Cfr. M. Klein, Scritti 1921-1958, Boringhieri, Torino 1983, pp. 286-290.
Cfr. M. Klein, Scritti 1921-1958, cit., pp. 288-289, 521; Id., La psicoanalisi dei bambini, Psycho,
Firenze 1988, pp. 193, 297.
5 Cfr. M. Klein, La psicoanalisi dei bambini, cit., pp. 122, 134; Id., Scritti 1921-1958, cit., pp. 417,
469.
4
39
ulteriori utili identificazioni». Ad esempio, «una forte identificazione con la madre buona rende più
facile al bambino di identificarsi anche con il padre buono e più tardi con altre figure amichevoli.
Ne risulta che il suo mondo interiore viene a contenere prevalentemente oggetti e sentimenti
buoni», ciò che «contribuisce ad una personalità stabile»6. Si raggiunge per questa via «quella
ricchezza e pienezza affettiva che chiamiamo amore» e che «può rendere felici e liberi dal
risentimento e dall’invidia»7.
La dinamica del “consolidamento” delle figure “buone”, che conduce alla capacità di amare,
viene descritta dalla Klein anche nei termini di una “integrazione”. In fondo, una originaria
“integrazione tra libido e aggressività” è già operante nella genesi del senso di colpa, e quindi nel
motore stesso dello sviluppo psichico. Ora, se tale integrazione riesce ad evolversi in una capacità
di «sintesi degli aspetti buoni e cattivi dell'oggetto», e, più tardi, nella capacità di riconoscere le
“persone totali” e di amarle “a dispetto dei loro difetti”, allora si instaura un circolo virtuoso, per
cui l’integrazione spinge il bambino a cercare soddisfazioni nel mondo esterno, mentre i rinforzi
che la pulsione di vita riceve dal mondo, spingono ulteriormente verso l’integrazione8.
Parte II. Breve storia della passione.
3) Una annotazione storica sul tema della “passione”.
Sul tema delle passioni si confrontano nella storia della filosofia tre scuole di pensiero. La prima
è quella che presenta la relazione tra ragione e passione nei termini di una alleanza da realizzare; la
seconda presenta tale relazione nei termini del conflitto; la terza presenta i due fattori come tra loro
radicalmente disomogenei.
I) Il modello dell’alleanza.
Alla prima scuola di pensiero appartengono pensatori come Aristotele, Tommaso, Hegel. Il
modello dell’alleanza è quello che dà realmente conto della specificità umana del mondo passionale,
cioè della natura - sia pur implicitamente - razionale delle passioni.
1) La passione in Aristotele.
Per Aristotele la passionalità è un fattore costitutivo della vita umana, che attende di ricevere
ordine e forma dal giudizio razionale. Anzi, la vita dell’uomo ha come tema principale l’alternativa
tra virtù e vizio: cioè, rispettivamente, tra una felice alleanza tra passione e ragione, da una parte; e,
dall’altra, il prevalere della sregolatezza passionale sul giudizio razionale.
Cfr. M. Klein, Il mondo di noi adulti e le sue radici nell’infanzia, Vita e Pensiero, Milano 1967, p.
46.
7 Cfr. M. Klein, La psicoanalisi dei bambini, cit., p. 332; Id., Il mondo di noi adulti e le sue radici
nell’infanzia, cit., p. 49.
8 Cfr. M. Klein, Scritti 1921-1958, cit., pp. 447-472, 546; Id., Il mondo di noi adulti e le sue radici
nell’infanzia, cit., p. 49. Il processo di sintesi, così descritto, ha poi diverse ricadute sul mondo
interno del bambino: in primo luogo l’Io e il Super-Io acquistano entrambi una coerenza interna; in
secondo luogo si ha «un progressivo assorbimento del Super-Io da parte dell’Io», ovvero un
accordo tra i due, orientato a «stabilire delle norme generali che comprendono innanzitutto la
sottomissione dell’Es e l’assoggettamento dell’Es alle richieste degli oggetti e della realtà esterna».
(Cfr. Id., Scritti 1921-1958, cit., pp. 472-474; Id., La psicoanalisi dei bambini, cit., p. 223).
6
40
Nel Libro I dell’Etica Nicomachea, Aristotele annota che nell’anima umana è presente un fattore
razionale, e un fattore originariamente non razionale (to álogon). Essi non sono da intendersi
necessariamente come fattori reciprocamente estranei, benché certo siano reciprocamente non
omogenei9. Nel secondo libro dell’Etica Nicomachea, Aristotele parla di quei contenuti dell’álogon
che corrispondono al platonico epithymetikón. Si tratta, appunto, delle “passioni”: «chiamo passioni
la brama, la collera, la paura, l’ardimento, l’invidia, la gioia, l’amicizia, l’odio, il desiderio,
l’emulazione, la pietà, in generale ciò a cui fanno seguito piacere e dolore»10. Esse sono dotazioni
naturali dell’uomo, alle quali non è sensato attribuire, in prima battuta, valutazioni morali. Si
tratterà, semmai, di valutare moralmente che cosa l’uomo deliberatamente fa di esse11.
Aristotele chiama “virtù” e “vizio”, rispettivamente, la felice riuscita o la mancata riuscita della
alleanza tra passione e ragione. In particolare, tale alleanza assumerebbe l’aspetto di una
moderazione o mediazione delle passioni. Queste, infatti, non hanno misura, nel senso che spingono
il soggetto in modo non previdente, senza seguire un indirizzo finalistico chiaro e senza essere in
grado di dosare le proprie energie. Hanno dunque bisogno – per non distruggere l’uomo - di essere
governate da chi, in lui, sa dove vuole andare: la ragione.
Dunque, passione starebbe a ragione come materia a forma: almeno, tendenzialmente. La riuscita
del sinolo (sintesi di materia e forma) morale, sarebbe la virtù.
2) La passione secondo Tommaso d’Aquino.
Completamente diversa è la posizione di Tommaso, che – riprendendo e approfondendo la
lezione aristotelica - alle passioni dedica una trattazione molto articolata nella sua Summa
Theologiae. Anche per Tommaso l’uomo è soggetto a varie forme di passione, cioè di mutamento
involontario12, che possono essere distinte, usando un vocabolario di origine platonica, in “passioni
9
Se poi essi «siano distinti come le parti del corpo e come tutto ciò che è divisibile, o se siano due
perché hanno due definizioni diverse, ma per natura sono inseparabili come nella circonferenza il
convesso e il concavo, non ha nessuna importanza per la presente ricerca» (cfr. Aristotele, Etica
Nicomachea, I, 1102 a 27-32).
10 Cfr. Aristotele, Etica Nicomachea, II, 1005 b 21-23.
11 «Né le virtù (aretái) né i vizi (kakíai) sono passioni (páthe), poiché non siamo detti virtuosi o
perversi in ragione delle passioni, ma lo siamo in ragione delle virtù o dei vizi. Ed ancora perché per
le passioni non siamo né lodati né biasimati (infatti non è lodato chi prova paura o chi prova collera,
né è biasimato chi semplicemente prova collera, ma chi la prova in un certo modo), mentre per le
virtù e per i vizi siamo lodati e biasimati. Inoltre proviamo collera e paura indipendentemente dalla
nostra scelta (aproairétos), invece le virtù sono una sorta di scelta deliberata (proairéseis), o quanto
meno non esistono senza una scelta deliberata. Oltre a ciò, nell’ordine delle passioni di noi si dice
che siamo mossi, nell’ordine delle virtù e dei vizi si dice non che siamo mossi, ma che siamo
disposti in un certo modo. Per le ragioni seguenti le virtù non sono neppure facoltà. Infatti non siamo
detti né buoni né cattivi per il semplice fatto di essere capaci di provare le passioni, né siamo lodati
né biasimati» (cfr. Aristotele, Etica Nicomachea, II, 1105 b 28-1106 a 9).
12 Cfr. Tommaso d’Aquino, Summa Theologiae, I IIae, q. 22, a. 1.
41
della sfera concupiscibile”13 e della “sfera irascibile”14. Le prime sono le tendenze che hanno per
oggetto il bene e il male (in tutte le loro possibili forme), ma sotto un preciso aspetto: quello
sensibile del “piacevole e doloroso” (delectabile vel dolorosum); le seconde sono quelle che hanno
per oggetto il bene e il male in quanto difficili, rispettivamente, da raggiungere o da evitare. Alla
prima categoria apparterranno, ad esempio, “amore” e “odio”; alla seconda apparterranno, ad
esempio, “audacia” e “timore”15.
Ora, le passioni in sé considerate - in quanto cioè «tendenze di origine non razionale» -, non sono
moralmente buone o cattive. Lo diventano, invece, in quanto «cadono nella sfera della libertà», e
possono allora venir incoraggiate o frenate, guidate in un modo o in un altro16. Ma, in quanto già
plasmate dalla libertà, esse potranno più opportunamente essere chiamate, rispettivamente, virtù e
vizi17. L’errore degli Stoici fu proprio quello di considerare le passioni in quanto tali come qualcosa
di cattivo, mentre nessun dato di natura è intrinsecamente cattivo - neppure se ha luogo nell’uomo
senza aver origine dalla sua libera iniziativa18. Anzi, «se il bene proprio dell’uomo ha la sua radice
nella ragione, tanto più questo bene si compirà, quanto più andrà ad investire le diverse realtà che
appartengono all’uomo».
In questo senso, «non è indifferente alla perfezione morale di un atto, che l’uomo lo compia, non
solo guidato dalla volontà, ma anche da una attrazione sensibile (appetitus sensitivus)» - come dire:
con tutto se stesso. Bisogna - circa il rapporto volontà-passione - distinguere diversi casi19. (a)
Quello in cui la libertà assume, di fatto, come criterio di azione l’inerzia propria della passione
(come quando si aiuta un altro, solo perché ci dà fastidio vederlo in quello stato): in questo caso, la
bontà del gesto è diminuita dalla passione, perché esso è risultato in certo modo reattivo (tant’è vero
che, pur essendo un buon gesto, non mi educa ad essere altrettanto disponibile nei confronti di chi avendo magari più bisogno - non mi susciterà la stessa compassione). Per questo, «è più lodevole
che qualcuno compia l’atto di carità per semplice giudizio di ragione, che non per sola
compassione». Non che qui Tommaso voglia adottare in anticipo il rigorismo kantiano - che è
Che è quella dell’epithymetikón.
Che è quella dello thymoeidés.
15 Cfr. Tommaso d’Aquino, Summa Theologiae, I IIae, q. 23, a. 1.
16 Cfr. ivi, I IIae, q. 24, a. 1.
17 Nel trattato Le passioni dell’anima, Cartesio riprende la dottrina delle passioni, qualificandole
come “percezioni” (cioè realtà rispetto alle quali l’uomo è originariamente passivo), “sentimenti”
(cioè percezioni oscure e confuse), ed “emozioni” (cioè, fonte di turbamento e reazione) (cfr. nn. 2728). Anche Cartesio, come Tommaso, è convinto che l’uomo possa decidere di intervenire sulle
passioni, facendo valere i propri giudizi attraverso strategie opportune (ad esempio, rappresentandosi
con insistenza i vantaggi, anche sensibili, che vengono dal perseguire ciò che è bene) (cfr. nn. 45 e
48).
18 Cfr. ivi, I IIae, q. 24, a. 2.
19 Ci riferiamo qui, liberamente, a: ivi, I IIae, q. 24, a. 3, ad 1um.
13
14
42
piuttosto di matrice stoica -; egli semplicemente dice che, dovendo scegliere tra l’affermazione
(anche arida) di un giudizio moralmente fondato, e la pura reazione sentimentale, è meglio stare alla
prima. (b) Altro è il caso in cui il giudizio di coscienza sia formulato con tale convinzione da
coinvolgere anche le energie passionali. In questo caso, il gesto sarebbe di tutto l’uomo. Quando, ad
esempio, aiutiamo l’altro perché capiamo realmente che il nostro destino non può essere qualcosa di
privato, e che non possiamo camminare verso la felicità accettando l’infelicità altrui; allora le
energie passionali sono facilmente attratte, pur nel sacrificio, dalla prospettiva di realizzare il bene
comune. (c) Altro ancora è il caso in cui, per vincere la spontanea avversione verso un gesto che
richiede fatica, volontariamente mobilitiamo una serie di energie affettive (lavorando anche con
l’immaginazione), per indirizzarle alla conquista dello scopo che riconosciamo buono. È infatti
importante essere attenti a tutto ciò che arricchisce le circostanze di un atto buono: questo, al fine di
renderlo più piacevole e di compierlo quindi in modo più persuaso ed efficace: né si capisce perché come pensa Kant - la bontà del gesto debba essere direttamente proporzionale alla sua
sgradevolezza.
Il suggerimento che viene da Tommaso, è quello di non vedere nel mondo emotivo un nemico
potenziale, bensì un potenziale alleato della volontà: la volontà, infatti, non vive di vita propria, ma è
piuttosto l'intenzionalità intelligente che attraversa l’ad-petere, cioè la tensione di tutto l’uomo verso
il bene. Quindi, pur potendo dire “sì” o “no” anche sotto l’impeto delle passioni sfrenate, la volontà
diventerà tanto più potente nel condurre il suo “sì” o il suo “no” fino alla operatività concreta, quanto
più avrà mobilitato a proprio favore il mondo emotivo. Infatti, una volontà che non padroneggiasse
alcuna fonte energetica emotiva, girerebbe a vuoto sulle proprie, coscienti ma inefficaci, decisioni
(come un motore acceso, che rimanesse “in folle”).
3) La passione in Hegel.
Hegel riprende, a suo modo, la concezione classica della passione. Si consideri, anzitutto, la sua
dottrina dello “spirito soggettivo”, così come è proposta nella Enciclopedia delle scienze filosofiche.
La volontà umana, nel suo primitivo manifestarsi, appare come “volontà naturale”, cioè,
inizialmente, come volontà che segue gli “impulsi” (Triebe) e le “inclinazioni” (Neigungen) che
vengono dalla natura animale, e tende pertanto a realizzarsi nel conseguimento di appagamenti finiti
(ricerca della gioia, fuga dal dolore, ecc.). Quando poi la volontà insiste su di un certo tema (si trova
a coltivare in particolare un certo impulso o una certa inclinazione), allora essa diventa “passione”
in senso specifico (Leidenschaft). È chiaro dunque che Hegel - come Kant - riserva il termine
Leidenschaft ad indicare la passione in senso propriamente moderno, cioè la piega emotiva
43
dominante di un certo comportamento. Mentre i veri corrispettivi della classica passio sono per lui
Triebe e Neigungen20.
Con Hegel, comunque, l’ambito delle passioni torna ad essere considerato come qualcosa che, di
per sé, non è ancora né buono né cattivo, in senso morale. Semmai, «le passioni sono l’elemento
attivo; esse non sono affatto opposte costantemente alla moralità, bensì realizzano l’universale»21.
II) Il modello del conflitto.
Alla seconda scuola di pensiero appartengono, tipicamente, gli Stoici e Kant.
1) Le passioni nello Stoicismo.
Il termine “passione” (pathos) acquista un particolare rilievo nella storia della filosofia grazie agli
Stoici. Nella loro prospettiva, però, la passione è «una emozione (commotio) che si allontana dalla
ragione ed è contraria alla natura»22: essi dunque la identificano, non con un’energia che può essere
impiegata per il bene o per il male, bensì con un’energia che già è stata piegata verso il male da un
giudizio erroneo (posizione di Zenone), o più semplicemente la identificano con lo stesso giudizio
erroneo apportatore di disordine in chi lo concepisce (posizione di Crisippo). Chi, ad esempio, si
lascia abbagliare dalla ricchezza fino a sentirne la mancanza, potrà formarsi l’errata opinione che la
ricchezza sia indispensabile per la propria felicità, e potrà così liberare disordinatamente la tendenza
all’accumulo, che è già naturalmente presente in lui (con conseguenze disastrose, ad esempio, per la
sua vita di relazione). Se la passione è - in prospettiva stoica - il frutto di un errore di giudizio,
oppure è lo stesso giudizio erroneo (la norma formulata nell’ignoranza o nella distrazione), non si
potrà parlare di buono o cattivo impiego delle passioni: esse andranno infatti estirpate, per
raggiungere l’ “apatia” (apátheia) – l’assenza di passioni -, in cui consisterà stoicamente la vita
buona del saggio23.
2) La passione nella antropologia di Kant.
20
Cfr. Hegel, Enciclopedia delle scienze filosofiche, §§ 473-474.
Cfr. Hegel, Lezioni sulla filosofia della storia, trad. it., Firenze 1966, I, pp. 66-74.
22 Cfr. Cicerone, Tusculanae disputationes, IV, 6 e 21.
23 Uno dei principali testimoni della posizione stoica sulle passioni è il latino Cicerone. Di Cicerone
è opportuno considerare, al riguardo, il libro IV delle Tusculanae disputationes (44 a.C.). Cicerone,
qui, parte precisamente dal pregiudizio stoico, che identifica passioni e vizi; e, considerando che il
vizio non può essere moderato, ma solo estirpato, polemizza con gli Aristotelici (Peripatetici), i
quali invece sostengono che «la natura ci ha dato le passioni per il nostro bene», e che «non si può
mai far bene una cosa, se non c’è la passione che ci sospinge». In particolare, Cicerone ritiene
inverosimile che si possa tentare di elaborare in senso virtuoso l’ira (l’aggressività) – come
sostengono invece gli Aristotelici -, senza esserne trascinati verso le azioni più irragionevoli. Il
saggio sarà piuttosto colui che sa vivere lontano da ogni passione: dove “passione” è intesa come
sinonimo di “perturbazione” (perturbatio) dell’anima. Del resto, una volta identificata – stoicamente
- la causa delle passioni in errori di giudizio, dovuti al prevalere dell’immaginazione sulla ragione.
Cicerone non può far altro che contrapporre la ragione alle passioni, identificando nella prima il
medico che deve guarirci dalle seconde, intese come malattie dell’anima.
21
44
Kant condanna - alla maniera degli Stoici - la passione, intendendola come un «cancro per la
ragion pura pratica»24. Egli, infatti, assume senz’altro “passione” nel senso di “vizio”.
Più precisamente, nella sua Antropologia pragmatica (1798), Kant distingue tra “emozione” (der
Affect) e “passione” (die Leidenschaft). “Emozione” sarebbe una semplice e inevitabile reazione,
cioè un sentimento improvvisamente destato da un evento puntuale. Di fronte a certi accadimenti
improvvisi, insomma, non possiamo non provare – almeno sull’istante – vergogna, imbarazzo, ira
oppure meraviglia, e così via25. Le emozioni, comunque, non vanno coltivate, ma il più possibile
represse: «il principio della apatia, che cioè il saggio non deve mai subire l’emozione, neppure
quella della compassione per i mali del suo migliore amico, è un principio morale giusto e sublime
della scuola stoica, perché l’emozione rende (più o meno) ciechi»26. La “passione”, invece, sarebbe
«l’inclinazione (Neigung), in quanto impedisce alla ragione di paragonarla, per rispetto a una certa
scelta, con la somma di tutte le inclinazioni». Ora – annota Kant -, «se l’emozione è un’ebbrezza, la
passione è una malattia»: un turbamento permanente nell’ordine della vita27. Con quest’ultima,
dunque, non è lecito venire a patti: si cercherà o di estirparla o di isolarla.
III) Il modello dell’eterogeneità e dell’asservimento.
La terza impostazione del tema ragione/passione vede protagonisti, principalmente, Hume e
Freud.
1) Hume.
Con David Hume emerge una concezione della passione, secondo cui essa è totalmente sottratta
ad ogni rapporto diretto con la ragione. Sulle passioni sono efficaci solo altre passioni, così come i
ragionamenti possono essere confermati o smentiti solo da altri ragionamenti. Non solo la ragione è
impotente sul dinamismo delle passioni, ma anzi, essa «è, e deve solo essere, schiava delle passioni
e non può rivendicare in nessun caso una funzione diversa da quella di servire e obbedire ad esse»28.
In altri termini, le passioni avrebbero una dinamica parallela a quella razionale, e la ragione
potrebbe solo fornire ad esse una chiarificazione riguardante la natura e le circostanze delle
situazioni in cui esse si muovono.
2) Freud.
Qualcosa di analogo troviamo nel progetto psicoanalitico freudiano, dove il movimento
pulsionale dell’uomo è visto come del tutto autonomo e svincolato dalla ragione, la quale potrà –
tutt’al più – favorire il soddisfacimento delle pulsioni, e soprattutto evitare ad esse le più gravi
24
cfr. Kant, Antropologia pragmatica, § 81.
Cfr. ivi, §§ 73-74.
26 Cfr. ivi, § 75.
27 Cfr. ivi, § 80.
28 Cfr. D. Hume, Trattato sulla natura umana, Libro II, Parte III, Sez. III.
25
45
frustrazioni (ma anche trovare giustificazioni alle loro strategie): ma sempre in funzione di
servitrice del loro autonomo orientamento, e non di guida che le persuade e le orienta a sua volta.
Parte III. Alcuni casi notevoli di passione.
1) La passione per eccellenza: l’amore.
Nel pensiero classico, la passione più rappresentativa è l’amore.
Tommaso presenta l’amore come la passione radicale: infatti, «non c’è nessuna passione che non
presupponga qualche amore»29. L’amore è qui considerato in senso generalissimo e analogico:
amore è, in tal senso, ogni attrazione fondata - a diversi livelli - sulla “connaturalità” tra attraente e
attratto30. Quindi, se amore può dirsi, genericamente, anche la più semplice attrazione sensuale tra
persone (quella che in termini neurofisiologici può essere interpretata come una reazione del
“sistema limbico” alle stimolazioni ricevute), capacità propria dell’uomo sarà quella di accedere anche sulla base dell’attrazione sensuale - alla dilectio, cioè all’amore che si fonda sulla scelta
(electio, appunto) della persona amata. La differenza è chiara: la scelta è radicata in un giudizio di
valore (praesupponit judicium rationis), e può generare - se è la scelta per una persona e non solo
per una sua qualità - la fedeltà. Ulteriore è poi il livello dell’amore come gratuità (charitas), che
conduce alla perfezione dell’amore: il perdono31. È interessante, al riguardo, rilevare che Tommaso
non introduce qui la carità (o gratuità) in un contesto teologale, ma piuttosto nel contesto dell’amore
umano inteso senza diretto riferimento alla Grazia. In effetti la gratuità - benché non sembri alla
normale portata dell’uomo -, è di per sé richiesta dal rapporto tra le persone (e dallo stesso rapporto
di coppia): perché il rapporto resti fedele, occorre che si apra, dalla semplice attrazione passionale, al
giudizio di valore, e, di qui, al perdono di quella irriducibile provocazione che l’alterità dell’altro è
per l’io di ciascuno.
Il passaggio dalla semplice attrazione alla gratuità, non è un rinnegamento della base sensuale
dell’amore (amor concupiscentiae), ma una sua dilatazione d’orizzonte verso il voler bene (amor
amicitiae)32. Nell’«amore semplicemente sensuale, infatti, l’amante ama in fondo ancora se stesso,
quando vuole per sé quell’aspetto dell’altro che gli corrisponde»33; quindi l’amore sensuale, di per
sé, è sì il progetto di una fusione (inhaesio), ma nel senso di una assimilazione possessiva dell’altro
nella sua intimità. Nel voler bene, invece, la fusione è perseguita «secondo la via della reciprocità»
(per viam redamationis), per cui ciascuno dei due considera l’altro come un altro se stesso34. Si può
dire, allora, che aprirsi al voler bene, significa dilatare l’impulso che già è contenuto nella sensualità
Cfr. Tommaso d’Aquino, Summa Theologiae, I IIae, q. 27, a. 4.
Cfr. ivi, q. 26, aa. 1-2.
31 Cfr. ivi, q. 26, a. 3.
32 Cfr. ivi, q. 26, a. 4.
33 Cfr. ivi, q. 27, a. 3.
34 Cfr. ivi, q. 28, a. 2.
29
30
46
(«infatti, nell’amore sensuale l’amante è in qualche modo portato oltre se stesso», verso ciò di cui
sente la mancanza), correggendolo, però; cioè, non consentendogli - come sarebbe nella sua inerzia di curvarsi su di sé («quel tipo di affezione infatti non esce realmente da sé, ma si chiude alla fine
all’interno dell’amante»); ma portandolo veramente dove è intenzionato ad andare. La inhaesio cui
tende l’amore si realizza infatti solo in un reciproco “uscire da sé” (extasis) di coloro che si amano,
che si tradurrà nel reciproco “gesto della cura” (gerere curam)35.
Concludendo, osserviamo come sia significativo che l’analisi tommasiana dell’amore (che
abbiamo certo integrata, senza però mutarne il senso) metta in comunicazione - e non contrapponga la passione amorosa e la benevolenza; quasi ad indicare che la passionalità è comunque la fonte
energetica anche dei moti più alti e gratuiti di cui l’uomo è capace. Spiega infatti Tommaso che
«chiunque agisce, proprio in quanto opera in vista del fine e del bene, fa tutto quel che fa, per
amore», cioè spinto dalla attrattiva del bene36.
2) Il pudore.
a) Se la riflessione sull’amore può ben rappresentare un luogo classico della analisi delle
passioni, un luogo contemporaneo altrettanto espressivo ci è offerto dalla riflessione sul pudore. Il
pudore, infatti, appartiene anzitutto all’ambito passionale. Esso è anzitutto un moto spontaneo di
difesa della qualità razionale della nostra animalità: difesa dallo sguardo non rispettoso o dalle
reazioni sensuali che essa può suscitare negli altri. In quanto passione, il pudore può anche
manifestarsi nella variante paradossale della spudoratezza ostentata – che pure finisce per essere
una forma di autodifesa, tracciando tra lo spudorato e gli altri una certa linea di separazione.
Ma il pudore, come ogni passione, può essere educata in sentimento. Si parlerà allora del
“sentimento del pudore”, come della sensibilità che avremo sviluppato, in senso preventivo, verso
quelle situazioni in cui l’animalità che siamo potrebbe trovarsi facilmente esposta alla riduzione e al
fraintendimento.
b) Max Scheler, allievo di Husserl, ha dedicato un testo – pubblicato postumo - al pudore: Sul
pudore e il sentimento del pudore (Über Scham und Schamgefühl, 1933)37. Come si vede, già il
titolo del saggio distingue tra Scham (il pudore come passione) e Schamgefühl (il pudore educato in
sentimento).
«Nessun sentimento, come il sentimento del pudore» - annota Scheler nell’introduzione al saggio
- «esprime in modo così chiaro, incisivo e immediato la singolare posizione che l’uomo occupa
nella grande serie degli esseri, cioè la sua collocazione tra il divino e la sfera animale». Esso, infatti,
35
Cfr. ivi, q. 28, a. 3.
Cfr. ivi, q. 28, a. 6.
37 Cfr. M. Scheler, Gesammelte Werke, Band X, Bern 1957. Il testo è tradotto in italiano da A.
Lambertino, col titolo: Pudore e sentimento del pudore, Guida, Napoli 1979.
36
47
«per un verso rappresenta un fenomeno che sovrasta la totalità degli istinti e dei bisogni vitali, [...]
per un altro verso è, nello stesso tempo, esistenzialmente legato alla vita di un organismo e si riflette
sui suoi movimenti».
Il pudore – per come Scheler ci aiuta a comprenderlo – consiste in un «improvviso ripiegarsi
della attenzione umana, già rapita da valori sovrabiologici», sulla realtà del «corpo animale»,
proprio o altrui. È, insomma, un sorprendersi come animali, nel vivo di una dinamica spirituale; e il
disagio che ne nasce, sta a testimoniare, sì, la non pacificità dell’intreccio di animalità e razionalità,
ma anche – e soprattutto – la non accidentalità di esso.
Sia nel caso che il pudore accada di fronte allo sguardo altrui, sia che accada di fronte allo
sguardo proprio, esso è una forma di “difesa dell’individuo”, cioè è un modo per rifiutare che la
propria e l’altrui intimità singolare vengano captate e irretite quasi fossero realtà disponibili e
manipolabili alla stregua di una qualcosa di generico e di riproducibile. Scheler dice anche che il
pudore è «una sorta di angoscia che ha l’individuale di naufragare nell’universale e nel generale, o
che ha il soggetto portatore di valori superiori di perdersi tra i soggetti portatori di valori
inferiori»38.
Una particolare forma di pudore, è il pudore sessuale. Esso non nasce semplicemente dalla
esposizione del proprio corpo. Infatti, nel caso in cui fosse chiaro che si viene guardati, non in
quanto individui determinati, bensì in quanto portatori di valori o di significati universali, non si
proverebbe pudore: è questo il caso della modella, che, di fronte al pittore, rappresenta l’armonia e
la bellezza esemplari; o il caso del paziente che, di fronte al medico, si espone in quanto portatore di
una malattia. Neppure si prova pudore sessuale nello slancio d’amore, all’interno del quale è chiaro
che si è guardati, e insieme anche voluti, come individui determinati (il che determina il fenomeno
del “riassorbimento del pudore nell’amore”).
Il pudore sessuale, piuttosto, insorge quando si è guardati come individui determinati, ma si è
voluti come realtà intercambiabili, ovvero come oggetti di godimento universalizzabili, e quindi
sostituibili. In altre parole - non più scheleriane - il pudore sessuale insorge quando la persona
scopre, nell’altro o in sé, la mímesi degli atti dell’amore, come copertura di un semplice
soddisfacimento sensuale, di per sé indifferente alla singolarità dell’altro. Il contrappasso della
violazione del pudore sta nella esperienza della “nausea”, cioè nella condanna a vivere, nella
sessualità, il corpo prevalentemente come Körper (cioè come corpo-cosa) anziché come Leib (cioè
come corpo-io)39.
38
39
Cfr. ivi, cap.2.
Cfr. ivi.
48
L’esperienza del pudore è tanto significativa, proprio perché indica il corpo come luogo in cui
l’uomo si mostra e può offrirsi – fino al rischio di venir catturato e ridotto a qualcosa di meno -, ma
anche come luogo dal quale l’uomo può tendenzialmente ritrarsi, opponendo resistenza alla
captazione, e riaffermando la propria indisponibilità ad essa. “Tendenzialmente”, diciamo, perché in
realtà né il movimento della cattura né quello della fuga sono totalmente realizzabili.
c) Proprio al “conflitto degli sguardi” sono dedicate alcune delle migliori pagine di un altro
esponente della tradizione fenomenologica: Jean Paul Sartre. Questi ci offre una ricognizione molto
fine del rapporto che si instaura tra gli sguardi40.
Quando vengo guardato, io avverto chi mi guarda, non come oggetto animato, bensì
immediatamente come soggetto di una intenzione. Non solo, ma il restituire lo sguardo a chi ci
guarda – che è materialmente il guardare un corpo -, significa colpire direttamente la sua interiorità
(il suo cogito, la sua coscienza). Si instaura in tal modo un possibile “conflitto”, nel quale ciascun
guardante mirerà a “totalizzare” (cioè, a captare nel proprio mondo interiore) l’altro guardante.
Possibili esiti del conflitto saranno, o la resa di uno dei due (che abbasserà lo sguardo, sentendo
insopportabile di essere “totalizzato”), o la reciprocità dell’intesa (il guardarsi degli amici, o quello
degli innamorati); o anche, e più di frequente, la resa di entrambi41.
3) L’ira.
L’ “ira” è trattata dai classici come passione, prima che come vizio. La dotazione passionale
della aggressività va infatti considerata come una potenzialità sia per il vizio che per la virtù, a
seconda di come viene liberamente elaborata dal soggetto. Tommaso42 si chiede se l’oggetto dell’ira
siano il bene e il male; e risponde che chi si adira sente di doversi vendicare di qualcosa, cioè di
dover riaffermare un bene attraverso un male, ovvero di dover punire chi ha tolto – a lui o ad altri un certo bene. L’ira, dunque, è composta di amore e di odio. Più avanti Tommaso si chiede «se l’ira
accada con qualche ragione» (utrum ira sit cum ratione); e risponde che essa «non accade senza
ragione»: infatti, la reazione all’ingiustizia (reale o supposta che sia quest’ultima) presuppone un
implicito giudizio su quel che è accaduto43.
Conclusione.
Le “passioni” sono il modo classico di nominare quello che oggi, abitualmente, chiamiamo
“mondo emotivo”. Le passioni, in quanto sono costantemente orientate – su base organica – al
soddisfacimento di ciò che è necessario alla vita umana, assumono l’aspetto dei “bisogni”. Ma, in
Cfr. J.P. Sartre, L’être et le néant, Gallimard, Paris 1943, P.III, cap. I, § 4.
Altra possibilità è che uno dei due, o entrambi, assumano un atteggiamento strategico,
continuando a guardare, ma ritraendo la propria intenzionalità dallo sguardo: questo, a conferma di
quella ambiguità della corporeità animale, di cui parlavamo a riguardo del pudore.
42 Cfr. Tommaso d’Aquino, Summa Theologiae, I IIae, q. 46, a. 2.
43 Cfr. ivi, I IIae, q. 46, a. 4.
40
41
49
quanto sono in grado, se non “moderate” (cioè se non calibrate in relazione al mondo oggettuale), di
travalicare la via del bisogno, e di crescere di intensità a dismisura – o addirittura di spingere la loro
plasticità fino al perseguimento di oggetti che contraddicono i bisogni 44 -, le passioni possono anche
giungere a sconvolgere completamente il cammino di un uomo.
Se valesse la rappresentazione dualistica dell’uomo, le passioni non dovrebbero realmente
riguardare la nostra vita, se non lo volessimo noi. Invece, esse sono parte di noi, perché noi siamo
anche ed essenzialmente corporeità intenzionale (Leib). In tal senso, siamo anche originariamente
esposti al mondo. Si pensi, al riguardo, ai ricatti cui costantemente siamo esposti tramite il dolore e il
piacere (che mettono alla prova la nostra autonomia di giudizio); o si pensi anche alla paura o alla
temerarietà, che ci fanno tante volte agire in modo irriflesso. Ebbene, tutto questo non ci
riguarderebbe se non fossimo animali razionali; e se non avessimo, in quanto tali, una vita
passionale.
Appendice: Nota su di una possibile biologia delle passioni.
Quanto alla descrizione di ciò che accade in noi quando il mondo emotivo è in azione, occorre
rivolgersi agli esperti dell’ “uomo ghiandolare”. Rilevanti, in proposito, i testi del neurobiologo
francese Jean Didier Vincent45 (ricercatore del CNRS), i cui studi sono aperti al confronto con la
filosofia.
È possibile tracciare una specie di mappatura delle ghiandole che presiedono alla secrezione degli
ormoni, che in noi stimolano le reazioni fisiologiche associabili alla vita propriamente passionale.
Di tale mappatura fanno parte, ad esempio, le ghiandole surrenali, la cui parte midollare secerne
le catecolamine: adrenalina e noradrenalina; e la cui parte corticosurrenale secerne cortisolo.
L’adrenalina è un ormone che fa accelerare il battito cardiaco nelle situazioni in cui ci sembra di
aver perso il controllo, e mobilita gli zuccheri custoditi dal fegato. La noradrenalina è invece
l’ormone che determina il contrarsi dei vasi della cute (compresi i capillari superficiali),
determinando certi pallori improvvisi, e facendo affluire sangue ai muscoli, nelle situazioni in cui
tendiamo a riacquistare il controllo della situazione. I due tipi di secrezione procedono in senso
inversamente proporzionale tra loro.
Il cortisolo, invece, ha effetto depressivo, in quanto adatta l’organismo alla frustrazione e al
dolore, e lo predispone a ricostituire le proprie riserve per poter sostenere lotte di lunga durata. Tra i
suoi effetti, si segnala un certo ottundimento nella percezione delle situazioni esterne.
L’ipofisi e la ghiandola surrenale (midollare) producono le endorfine: sostanze a struttura
amminoacidica che inibiscono l’avvertenza del dolore, in modo simile alla morfina, e che
intervengono in modo significativo anche in occasione dell’orgasmo sessuale.
Senonché, l’azione delle suddette ghiandole è governata a sua volta da stimoli elaborati e inviati
in loco a cura della corteccia prefrontale. I cosiddetti “lobi prefrontali” sono le aree della corteccia
cerebrale che si possono ritenere più stabilmente aperte alla interazione con l’io che pensa e che si
misura razionalmente con la realtà46. Gli stimoli che vengono dalla corteccia prefrontale possono
mettere in gioco in maniera preferenziale, o l’ “asse simpatico” o l’ “asse corticosurrenale”: due vie
Si pensi al caso drammatico del consumo di “droghe”.
Cfr. La biologia delle passioni (1986), Einaudi, Torino 1988.
46 Su questi temi, si veda: J.C. Eccles, Evoluzione del cervello e creazione dell’io, Armando, Roma
1990.
44
45
50
di comunicazione del sistema neurovegetativo. Lungo il primo, le due “amígdale” 47 vanno ad
attivare la produzione di catecolamine da parte della componente midollare delle ghiandole
surrenali. Lungo il secondo, l’ippocampo – mediante l’ipotalamo e l’ipofisi – comanda la secrezione
del cortisolo da parte della componente corticale delle ghiandole surrenali.
47
La lesione delle amigdale (in seguito a depositi calcarei, ad esempio) determina nel soggetto
incapacità di avvertire in sé o nell’altro paura o collera (cfr. Adolphs-Tranel-Damasio 1994).
51