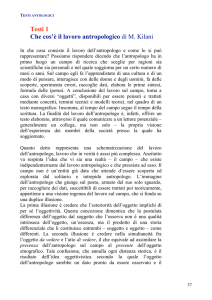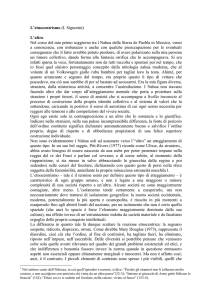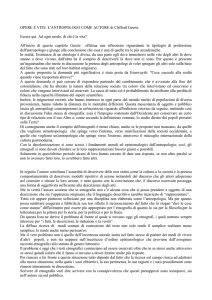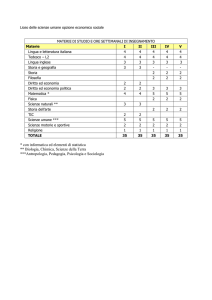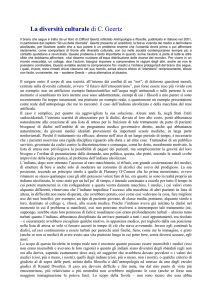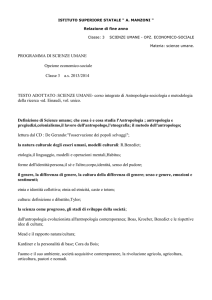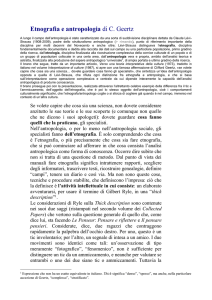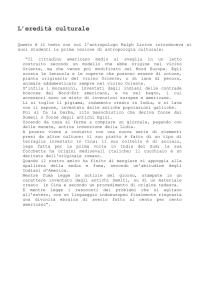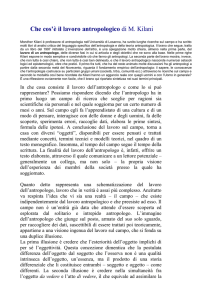1. Che cos’è il lavoro antropologico
In che cosa consiste il lavoro dell’antropologo e come lo si può
rappresentare? Possiamo rispondere dicendo che l’antropologo ha in primo
luogo un campo di ricerca che sceglie per ragioni sia scientifiche sia
personali e nel quale soggiorna per un certo numero di mesi o anni. Sul
campo egli fa l’apprendistato di una cultura e di un modo di pensare,
interagisce con delle donne e degli uomini, fa delle scoperte, sperimenta
errori, raccoglie dati, elabora le prime sintesi, formula delle ipotesi. A
conclusione del lavoro sul campo, torna a casa con diversi “oggetti”,
disponibili per essere pensati e trattati mediante concetti, termini tecnici e
modelli teorici, nel quadro di un testo monografico. Insomma, al tempo del
campo segue il tempo della scrittura. La finalità del lavoro dell’antropologo
è, infatti, offrire un testo elaborato, attraverso il quale comunicare a un
lettore potenziale – generalmente un collega, ma non solo – la propria
visione dell’esperienza dei membri della società presso la quale ha
soggiornato.
Quanto detto rappresenta una schematizzazione del lavoro
dell’antropologo, lavoro che in verità è assai più complesso. Anzitutto va
respinta l’idea che vi sia una realtà – il campo – che esiste
indipendentemente dal lavoro antropologico e che preesiste ad esso. Il
campo non è un’entità già data che attende d’essere scoperta ed esplorata
dal solitario e intrepido antropologo. L’immagine dell’antropologo che
giunge sul posto, armato del suo solo sguardo, per raccogliere dei dati,
suscettibili di essere trattati poi teoricamente, appartiene a una visione
ingenua del lavoro sul campo, che si fonda su una duplice illusione.
La prima illusione è credere che l’esteriorità dell’oggetto implichi di per sé
l’oggettività. Questa concezione dimentica che la postulata differenza
dell’oggetto dal soggetto che l’osserva non è una qualità intrinseca
dell’oggetto, un’essenza, ma il prodotto di una storia differenziale che li
costituisce entrambi – soggetto e oggetto – come differenti. La seconda
illusione è credere nella simultaneità fra l’oggetto da vedere e l’atto di
vedere, il che equivale ad assimilare la presenza dell’antropologo sul
campo al presente dell’oggetto etnografico. Tale confusione, che annulla
ogni distanza storica, è il risultato dell’idea oggettivistica secondo la quale
l’oggetto dell’antropologo sarebbe un dato pronto da essere osservato e il
discorso dell’antropologo sarebbe identificabile con il linguaggio
dell’osservatore neutro.
Ma, se il rapporto con il campo non è un rapporto tecnico neutro, ancor
meno è un rapporto di fusione simpatetica con l’oggetto di studio:
l’antropologo non deve confondersi con l’altro al punto da diventare egli
stesso l’altro. Se procede in tal modo, se parla lo stesso linguaggio
dell’indigeno, non è più in una situazione dialogica, non ha la possibilità di
tradurre nel proprio codice e ancor meno di riferirci la sua esperienza.
Insomma, la conoscenza antropologica è un lavoro di mediazione con la
distanza e la differenza, lavoro che comincia già sul campo. In altri termini,
il campo si definisce subito ed essenzialmente come un lavoro simbolico di
costruzione di senso, nel quadro di un’interazione discorsiva, di una
negoziazione di punti di vista fra l’antropologo e i suoi informatori.
M. Kilani, L’invenzione dell’altro, Dedalo, Bari 1997, 51-52
2. Etnografia e antropologia di C. Geertz
Se volete capire che cosa sia una scienza, non dovete considerare anzitutto
le sue teorie e le sue scoperte (e comunque non quello che ne dicono i suoi
apologeti): dovete guardare cosa fanno quelli che la praticano, gli
specialisti.
Nell’antropologia, o per lo meno nell’antropologia sociale, gli specialisti
fanno dell’etnografia. È solo comprendendo che cosa è l’etnografia, o più
precisamente che cosa sia fare etnografia, che si può cominciare ad
afferrare in che cosa consista l’analisi antropologica come forma di
conoscenza. Occorre dire subito che non si tratta di una questione di
metodo. Dal punto di vista dei manuali fare etnografia significa intrattenere
rapporti, scegliere degli informatori, trascrivere testi, ricostruire genealogie,
definire “campi”, tenere un diario e così via. Ma non sono queste cose,
tecniche e procedure stabilite, che definiscono l’impresa: ciò che la
definisce è l’attività intellettuale in cui consiste: un elaborato
avventurarsi, per usare il termine di Gilbert Ryle, in una “thick
description”1.
Le considerazioni di Ryle sulla Thick description sono contenute nei suoi
due saggi (ristampati nel secondo volume dei Collected Papers) che
vertono sulla questione generale di quello che, come dice lui, sta facendo
Le Penseur: Pensare e riflettere e Il pensare pensieri. Considerate, dice,
due ragazzi che contraggono rapidamente la palpebra dell’occhio destro.
Per uno, questo è un tic involontario; per l’altro, un segnale di intesa a un
amico. I due movimenti sono identici come tali: un’osservazione di tipo
meramente “fotografico”, “fenomenico”, non è sufficiente per distinguere
un tic da un ammiccamento, e neanche per valutare se entrambi o uno dei
due siano tic o ammiccamenti. Tuttavia la differenza tra un tic e un
ammiccamento, per quanto non fotografabile, è grande, come sa chiunque è
abbastanza sfortunato da aver scambiato l’uno per l’altro. Chi ammicca sta
comunicando, e in un modo molto preciso e particolare: a) deliberatamente,
b) con qualcuno in particolare, c) per trasmettere un particolare messaggio,
d) secondo un codice socialmente stabilito ed e) senza che il resto dei
presenti lo sappia. Come fa notare Ryle, non è che chi ammicca ha fatto
due cose, contratto le palpebre e ammiccato, mentre chi ha un tic ne ha
fatto solo una, ha contratto le palpebre. Contrarre le palpebre apposta
quando esiste un codice pubblico in cui farlo equivale a un segnale di
intesa, è ammiccare. Vi è tutto questo: un briciolo di comportamento, un
granello di cultura e – voilà – un gesto.
Questo tuttavia è solo il principio. Supponete, continua, che ci sia un terzo
ragazzo che “per divertire maliziosamente i suoi amici” faccia la parodia
Espressione che non ha un esatto equivalente in italiano. Thick significa “denso”, “spesso”, ma anche, nella particolare
accezione di Geertz, “complesso”, “stratificato”.
1
della strizzata d’occhio del primo ragazzo perché dilettantesca, goffa,
banale e così via. Naturalmente lo fa nell’identico modo in cui il secondo
ragazzo ha ammiccato e il primo ha avuto un tic involontario, contraendo
cioè la palpebra destra: soltanto che questo ragazzo non sta né ammiccando
né strizzando l’occhio involontariamente; sta parodiando il tentativo di
qualcun altro, ridicolo a parer suo, di ammiccare. Anche qui esiste un
codice stabilito socialmente (“ammiccherà” in modo laborioso, fin troppo
apertamente, forse aggiungendo una smorfia: i soliti artifici del clown) ed
esiste anche un messaggio. Solo che in questo caso non si tratta di intesa,
ma di ridicolo. Se gli altri credono che stia effettivamente ammiccando,
tutto il suo progetto fallisce completamente, benché con risultati un po’
diversi, come se pensassero che ha uno spasmo involontario. Si può andare
oltre: incerto sulle sue abilità mimiche, l’aspirante comico può far pratica a
casa davanti allo specchio, nel qual caso non ha un tic, non ammicca, non
prende in giro, ma fa le prove; benché, per quello che registrerebbe una
macchina fotografia, un comportamentista radicale o uno che crede nelle
proposizioni protocollari2, stia solo contraendo rapidamente la palpebra
destra come tutti gli altri. Dal punto di vista logico, se non pratico, sono
possibili complicazioni senza fine.
[…] Ma l’importante è che tra quella che Ryle chiama thin description di
ciò che il personaggio (parodista, ammiccatore, ragazzo con il tic…) sta
facendo (“contrarre rapidamente la palpebra destra”) e la thick description
(“sta facendo la parodia di un amico che finge un ammiccamento per
ingannare un innocente e fargli credere che ci sia un complotto”) risiede
l’oggetto dell’etnografia: una gerarchia stratificata di strutture
significative nei cui termini sono prodotti, percepiti e interpretati tic,
ammiccamenti, falsi ammiccamenti, parodie, prove di parodie e senza le
quali di fatto non esisterebbero (neppure tic nudi e crudi che come
categoria culturale sono tanto non-ammiccamenti quanto gli ammiccamenti
sono non-tic).
C. Geertz, Interpretazione di culture, Il Mulino, Bologna 1987, 41-44
2
Cioè un positivista logico (N.d.C.).
3. Il concetto di cultura di C. Geertz
La nascita di un concetto scientifico di cultura corrispose, o almeno fu
collegata, al rovesciamento della concezione della natura umana
dominante nell’illuminismo – una concezione che con i suoi pregi e difetti
era chiara e semplice – e alla sostituzione di una concezione non solo più
complicata, ma molto meno chiara. Il tentativo di chiarirla, di ricostruire
una descrizione comprensibile di che cosa è l’uomo, è stato da allora il
fondamento del pensiero scientifico sulla cultura. Dopo aver cercato la
complessità, e dopo averla trovata su una scala più vasta di quanto avessero
mai immaginato, gli antropologi restarono irretiti in un tortuoso sforzo per
darle un ordine. E non se ne intravede ancora la fine. La concezione
illuministica della cultura sosteneva del resto che egli era tutt’uno con la
natura e ne condivideva un’uniformità generale di composizione, scoperta
dalla scienza naturale sotto l’impulso di Bacone e la guida di Newton. Si
tratta, in breve, di una natura umana regolarmente organizzata,
completamente immutabile e meravigliosamente semplice come l’universo
di Newton. Forse alcune sue leggi sono diverse ma esistono delle leggi;
forse qualcosa della sua immutabilità è oscurata dalle complicazioni della
moda locale, ma è immutabile.
[…]
Lo scenario (in tempi e luoghi diversi) è alterato, gli attori cambiano le
vesti e l’aspetto, ma i loro moti interiori sorgono dagli stessi desideri e
passioni umane, e producono i loro effetti nelle vicissitudini dei regni e dei
popoli3.
Questa opinione non si può certo disprezzare, né si può dire che sia
scomparsa dal pensiero antropologico contemporaneo, nonostante i miei
facili riferimenti a un “rovesciamento” di un momento fa. L’idea che gli
uomini siano uomini, qualunque sia il loro aspetto e il loro ambiente, non è
stata sostituita da “altri costumi altri animali”.
[…]
Il guaio con questo tipo di concezione […] è che l’immagine di una
natura umana costante, indipendente da tempo, luogo e circostanze,
dagli studi e dalle professioni, dalle mode passeggere e dalle opinioni
temporanee, è forse un’illusione, e che ciò che l’uomo è può intrecciarsi
talmente con il luogo in cui si trova, con la sua identità locale e con le
sue credenze da diventare inseparabile. È proprio la considerazione di
una tale possibilità che portò alla nascita del concetto di cultura e al declino
della concezione uniforme. L’antropologia moderna, indipendentemente da
quali altre cose affermi – e pare che abbia affermato quasi tutto in diverse
occasioni – è salda nella convinzione che uomini non modificati dalle
3
A. O. Lovejoy, L’albero della conoscenza. Saggi di storia delle idee, Il Mulino, Bologna 1982.
usanze di luoghi particolari non esistono, non sono mai esistiti e, cosa
assai importante, non potrebbero esistere per la natura stessa del caso. Non
esiste, né può esistere un retroscena dove si possa andare a gettare
un’occhiata agli attori di Mascou come “persone vere”, che si aggirano con
i loro abiti di strada, estraniati dalla loro professione, mentre esibiscono con
franchezza priva di artifici i loro spontanei desideri e le loro sincere
passioni. Possono cambiare la parte, lo stile di recitazione, anche il dramma
in cui recitano, ma – come osservò Shakespeare stesso – stanno sempre
recitando.
[…]
Consideriamo la trance balinese. I Balinesi cadono in stati di estrema
dissociazione in cui compiono tutti i generi di attività spettacolari –
staccare la testa a polli vivi con un morso, colpirsi con pugnali, contorcersi
selvaggiamente, parlare lingue strane, compiere prodigi di equilibrismo,
mimare il rapporto sessuale, mangiare gli escrementi e così via – più
facilmente e più in fretta di quanto la maggior parte di noi non si
addormenti. Gli stati di trance sono una parte fondamentale di ogni
persona. A volte vi possono cadere 50 o 60 persone, una dopo l’altra
(“come una fila di petardi che scoppiano”, a detta di un osservatore)
venendone fuori dopo cinque minuti o magari parecchie ore, totalmente
inconsapevoli di quello che hanno fatto e convinti, nonostante l’amnesia, di
aver avuto l’esperienza più straordinaria e profondamente soddisfacente
che un uomo possa avere. Che si impara sulla natura umana da questo
genere di cose e da mille altre ugualmente particolari che gli antropologi
descrivono? Che i Balinesi sono creature di tipo speciale? Marziani dei
mari del Sud? Che sono proprio come noi alla base, ma con delle usanze
particolari, ancorché incidentali, che noi per caso non abbiamo assimilato?
Che sono dotati per nascita o spinti per istinto in certe direzioni piuttosto
che in altre? O che la natura umana non esiste e gli uomini sono
puramente e semplicemente come li fa la cultura?
C. Geertz, Interpretazione di culture, Il Mulino, Bologna 1987, 75Testi 4
4. La cultura come rete di significati di U. Hannerz
L’homo sapiens è la creatura che produce senso. Lo fa attraverso
l’esperienza, l’interpretazione, la contemplazione e l’immaginazione, e non
può vivere senza queste attività. L’importanza della produzione di senso
per la vita umana è riflessa in un campo concettuale affollato: idee,
significato, informazione, saggezza, capacità di comprendere, intelligenza,
consapevolezza, capacità di apprendere, fantasia, opinione, conoscenza,
credenze, mito, tradizione...
A questo gruppo di parole ne appartiene ancora un’altra, cara agli
antropologi: cultura. In passato il termine è stato inteso in un’accezione più
vasta, ma recentemente è inteso soprattutto come una questione di
significato. Studiare la cultura significa studiare le idee, le esperienze e i
sentimenti, e insieme le forme esteriori che questi aspetti interiori
assumono quando diventano pubblici, a portata dei sensi e dunque
realmente sociali. Per cultura gli antropologi intendono dunque i significati
che le persone creano, e che a loro volta creano le persone come membri di
una società. La cultura è in questo senso collettiva. Dal mio punto di vista
la cultura ha due tipi di loci, e il processo culturale avviene grazie alle loro
continue interrelazioni. Da un lato, essa risiede in una serie di forme
significanti pubbliche che solitamente possono essere viste o ascoltate, o
meno frequentemente conosciute attraverso il tatto, l’olfatto o il gusto, o
attraverso una combinazione di sensi. D’altro canto, queste forme esplicite
(overt forms) assumono significato solo in quanto le menti umane
contengono gli strumenti per interpretarle. Il flusso culturale consiste
dunque nelle esternazioni di significati che gli individui producono
attraverso adattamenti di forme generali, e nelle interpretazioni che gli
individui forniscono di tali manifestazioni. Forse l’immagine del flusso è
un po’ ingannevole, perché suggerisce un semplice trasferimento, piuttosto
che gli infiniti e problematici processi di trasformazione che intervengono
tra loci interni ed esterni. Nonostante ciò trovo utile la metafora del flusso –
se non altro perché coglie uno dei paradossi della cultura. Quando
osserviamo un fiume da lontano questo appare come una linea blu che
attraversa il paesaggio; qualcosa che possiede una suggestiva immobilità.
Ma allo stesso tempo, “non ci si bagna due volte nello stesso fiume”,
perché questo scorre in continuazione, e soltanto in tal modo mantiene la
sua continuità nel tempo. Così accade per la cultura: anche quando se ne
percepisce la struttura, questa è interamente dipendente da un processo
continuo.
U. Hannerz, La complessità culturale, Il Mulino, Bologna 1998, 5-7
5. L’etnocentrismo di I. Signorini
L’altro
Nel corso del mio primo soggiorno tra i Nahua della Sierra de Puebla in
Messico, venni a conoscenza, con imbarazzo e anche con qualche
preoccupazione per le eventuali conseguenze che il fatto avrebbe potuto
produrre, di avere polarizzato sulla mia persona un timore collettivo, dando
forma alla fantasia orrifica che lo accompagnava. Si era infatti sparsa la
voce, fortunatamente non da tutti raccolta e spentasi poi nel tempo, che io
fossi quel sinistro personaggio concepito dalla mitologia nahua moderna,
che al volante di un Volkswagen giallo ruba bambini per tagliar loro la
testa. Ahimé, per quanto arrancante e segnato dal tempo, era proprio questo
il tipo di vettura che possedevo, ma ciò non sarebbe di per sé bastato ad
accusarmi. Era la mia figura diversa, straniera, dalla misteriosa attività, a
consentire l’assimilazione. I Nahua non stavano facendo altro che dar corpo
all’atteggiamento mentale che porta a proiettare sulla straniero i propri
timori, il senso di ansietà che si accompagna a livello inconscio al processo
di costruzione della propria identità collettiva e al sistema di valori che la
sottendono, caricando in positivo il senso di autostima di cui ogni uomo
necessita per reggere alle tensioni e alle competizioni del vivere sociale.
Ogni ego esiste solo in contrapposizione a un altro che lo sostanzia e lo
giustifica. Indicare nello straniero, nella sua palese incomprensibile
differenza, la fonte di pericolo dell’ordine costituito significa dichiarare
automaticamente buono e salvifico l’ordine proprio, degno di rispetto e di
obbedienza propiziatori di una felice superiore costruzione individuale.
Non sono evidentemente i Nahua soli ad assumere verso l’“altro” un
atteggiamento di questo tipo. In un suo bel saggio, Pitt-Rivers (1977)
ricorda come Ulisse, da straniero,, abbia avuto bisogno di essere nascosto
da una nube per poter penetrare impune nella reggia del re dei Feaci e
parlare col sovrano; e di come subito, al momento della riapparizione, si sia
messo in salvo abbracciando le ginocchia della regina e poi sedendosi sulle
ceneri del focolare, dichiarando con questo gesto di porsi nella sfera
soggetta della femminilità, annullante la propria minacciosa estraneità
maschile4.
L’etnocentrismo – tale è il termine usato per definire questo tipo di
atteggiamento – è caratteristico di ogni gruppo umano, e non è legato a una
maggiore o minore complessità di una società rispetto a un’altra. Alcune
società ne sono maggiormente contagiate, altre meno. L’isolamento tende
certamente a esasperarlo, ma non necessariamente deve trattarsi di
isolamento geografico: la nostra società occidentale, moderna,
Nel settimo canto dell’Odissea, in cui quell’episodio è narrato, si dice: “Perché gli stranieri non li tollerano molto
costoro, e non accolgono con amicizia chi viene da un altro paese”(32-3); “Introno ai ginocchi di Arete gettò Odisseo le
braccia” (142); “Disse così e si sedette sul focolare, nella cenere, vicino al fuoco” (153-4).
4
potenzialmente la più aperta e cosmopolita, è riuscita in più momenti a
esasperarlo fino agli abietti limiti del nazismo, per un isolamento che non è
certo quello spaziale (che anzi lo spazio è forse l’elemento maggiormente
dominato dalla sua cultura), ma effetto invece di un’estraniazione indotta
da sazietà materiale e da faustiano orgoglio delle proprie conquiste
intellettuali.
La differenza in quanto tale fa dunque scattare la reazione etnocentrica: la
segnano sospetto, ridicolo, disprezzo, orrore. Come direbbe Mary Douglas
(1973), rappresenta il disordine, cioè ciò che l’ordine, al fine di costituirsi,
ha tagliato fuori, ha eliminato, riposto nell’impuro, nell’esecrabile. Delle
diversità si potrebbe pensare che venissero colte solo quelle aventi
rilevanza nel quadro dei grandi problemi esistenziali ed etici, e che
indifferenza e bonomia fossero invece la norma quando in questione
entrassero aspetti non essenziali oppure chiaramente marginali e innocenti.
Ma non è affatto così; anzi, è il contrario. I piccoli elementi di contrasto
sono spesso i più visibili, quelli che più direttamente espongono la
diversità, toccando la sfera del gusto e della quotidianità. Ecco che il cibo,
per esempio, viene a risultare uno dei settori privilegiati dell’atteggiamento
etnocentrico. Ogni modo culinario differente, ogni cibo non contemplato
dall’ordine chiuso delle proprie regole alimentari scatena riso o repulsione
e “segna” i suoi fruitori con un marchio che ne suggella l’inferiorità
culturale e, di rimbalzo, l’inferiorità della loro condizione umana.
[…]
Natura imperfetta, cultura imperfetta, dunque, e questo gioco di passaggi
dalla natura alla cultura e viceversa trova ampi e continuamente rinnovati
spazi.
Su questa che potremmo dire un’inclinazione dell’animo culturalmente
forgiata, la riflessione etnologica ha fissato la propria attenzione,
elaborando a difesa la nozione di “relativismo culturale”, nutrita da una
sempre più estesa e al contempo approfondita conoscenza delle culture
altre. Una nozione che si fonda sulla giusta idea che ogni cultura dovrebbe
essere compresa e vagliata assumendo quali parametri solo quelli in essa
vigenti e non i propri. Ma da idea guida capace di contrarrestare le
distorsioni conoscitive provocate dall’etnocentrismo, di evitare in qualche
modo gli effetti di ciò che Marx indicava comete mistificazioni della mente
e della coscienza nei confronti di se stesse, il relativismo culturale ha finito
per divenire, in certe correnti di pensiero antropologico – nel culturalismo
americano in particolare – e per molti giovani, giustamente ma anche
ingenuamente schierati in difesa dell’alterità, un dogma; e come ogni
dogma, per essere messo in pratica in modo del tutto acritico, nel rifiuto
incondizionato e assoluto di giudizi di valore su culture diverse, in base al
presupposto dell’eguaglianza di tutte le culture e quindi della validità di
qualunque costume, atteggiamento, istituzione da esse elaborati […].
Non essere etnocentrici non significa ovviamente “diventare” l’Altro:
abbiamo tutto il diritto di seguire il cammino indicatoci dalla cultura in cui
siamo nati (come d’altra parte anche di distanziarcene se ci garba), e anche
di non amare certi modelli diversi; ma ciò che di essi non ci è consentito, è
l’ignoranza, madre intellettuale e morale della stupidità, della
prevaricazione, del razzismo […].
Signorini, I modi della cultura, La Nuova Italia, Roma 1992,11-13
6. La diversità culturale di C. Geertz
Il sorgere entro il corpo di una società, all’interno dei confini di un “noi”,
di dolorose questioni morali, centrate sulla diversità culturale, ovvero “il
futuro dell’etnocentrismo”, può forse essere reso più vivido con un
esempio: non un artificioso esempio fantascientifico sull’acqua negli
antimondi o sulle persone le cui memorie si scambiano tra loro mentre esse
sono addormentate, esempi di cui i filosofi a mio parere si sono
recentemente fin troppo innamorati, ma piuttosto un esempio reale, o
quantomeno un esempio presentatomi come reale dall’antropologo che me
lo raccontò: il caso dell’indiano alcolizzato e della macchina del rene
artificiale.
Il caso è semplice, per quanto sia aggrovigliata la sua soluzione. Alcuni
anni fa, negli Stati Uniti sudoccidentali, l’estrema scarsità di attrezzature
per la dialisi, dovuta al loro alto costo, portò abbastanza naturalmente alla
creazione di una lista di attesa per la fruizione di tale trattamento da parte
di pazienti bisognosi di dialisi nell’ambito di un programma medico
governativo diretto, anche qui abbastanza naturalmente, da giovani medici
idealisti provenienti da importanti scuole mediche, in larga parte
nordorientali. Perché il trattamento sia efficace, almeno nell’arco di un
lungo periodo di tempo, è necessario che i pazienti osservino una rigida
disciplina riguardo alla dieta e ad altre cose. Trattandosi di un pubblico
servizio, governato da codici contro la discriminazione e comunque, come
ho detto, moralmente motivato, la lista di attesa non privilegiava la
possibilità di pagare dei pazienti, ma semplicemente la gravità del loro
bisogno e l’ordine di presentazione delle domande, una politica, questa, che
portò, secondo le usuali svolte impreviste della logica pratica, al problema
dell’indiano alcolizzato.
L’indiano, dopo aver ottenuto l’accesso al raro macchinario, si rifiutò, con
grande costernazione dei medici, di smettere di bere o anche solo di
moderare un consumo di alcolici che aveva del prodigioso. La sua
posizione, secondo un principio simile a quello di Flannery O’Connor che
ho prima menzionato, ovvero rimanere se stesso qualunque cosa gli altri
potessero volere fare di lui, era questa: io sono in realtà proprio un indiano
alcolizzato, lo sono stato per un bel po’ di tempo, e intendo continuare a
esserlo per tutto il tempo in cui potete mantenermi in vita collegandomi a
questa vostra dannata macchina. I medici, i cui valori erano alquanto
differenti, ritenevano che l’indiano impedisse l’accesso alla macchina di
altri pazienti in lista di attesa, in difficoltà non meno disperate, che
avrebbero potuto, così come essi vedevano la cosa, fare migliore uso dei
suoi benefici: per esempio, un tipo di paziente giovane, di classe media,
poniamo, alquanto simile a loro, destinato al college e, chissà, alla scuola
medica. Poiché l’indiano aveva già iniziato la dialisi nel momento in cui il
problema si manifestò, essi non potevano risolversi a interrompere tale
trattamento (né, suppongo, sarebbe stato loro permesso di farlo);
nondimeno essi erano profondamente turbati – almeno tanto turbati quanto
l’indiano, abbastanza disciplinato da arrivare puntuale a tutti i suoi
appuntamenti, era risoluto – e sicuramente avrebbero escogitato qualche
motivo, in apparenza medico, per toglierlo dalla sua posizione nella lista di
attesa se solo si fossero accorti in tempo di ciò che stava avvenendo. Invece
egli continuò la dialisi, ed essi continuarono a essere turbati per parecchi
anni finché, fiero, come me lo immagino, e grato (anche se non ai medici)
di avere avuto una vita piuttosto lunga in cui poter bere, senza doversi
scusare, egli morì.
Lo scopo di questa favoletta in tempo reale non è mostrare quanto possano
essere insensibili i medici (essi non erano insensibili e avevano le loro
ragioni) o quanto gli indiani siano diventati degli sbandati (egli non era alla
deriva, sapendo esattamente dove era); né suggerire che avrebbero dovuto
prevalere o i valori dei medici (cioè, più o meno, i nostri), quelli degli
indiani (cioè, più o meno, non i nostri), o qualche criterio di giudizio al di
sopra delle parti, attinto dalla filosofia o dall’antropologia ed emesso da
uno degli erculei giudici di Ronald Dworkin. Il caso era davvero difficile e
finì male, ma dal mio punto di vista più etnocentrismo, più relativismo o
più neutralità non avrebbero migliorato le cose (anche se forse una
maggiore immaginazione lo poteva fare). Lo scopo della favola – non sono
sicuro che essa abbia propriamente una morale – è mostrare che questo
genere di fatti, e non la remota tribù ripiegata su se stessa in una coerente
differenza (gli azande o gli ik che affascinano i filosofi quasi quanto le
fantasie della fantascienza, forse perché essi possono essere trasformati in
marziani sublunari e considerati di conseguenza), meglio rappresenta,
anche se melodrammaticamente, la forma generale che oggi assume il
conflitto di valori che sorge dalla diversità culturale.
Gli antagonisti in questo caso, se tali erano, non rappresentavano totalità
sociali richiuse in se stesse che si incontravano accidentalmente lungo i
margini delle loro credenze. Gli indiani che tengono a bada il destino con
l’alcol fanno parte dell’America contemporanea quanto i medici che lo
correggono con le loro macchine; volendo vedere come, almeno nel caso
degli indiani (presumo che nel caso dei medici si sappia) si può leggere lo
sconvolgente romanzo di James Welch, Winter in the Blood, dove gli effetti
di contrasto risaltano piuttosto singolarmente. Se vi fu un fallimento, e, per
essere giusti, a distanza è difficile dire precisamente quanto ve ne fu, fu un
fallimento nella disponibilità a capire, da entrambe le parti, che cosa
significava trovarsi dall’altra parte e quindi che cosa significava essere
dalla propria.
C. Geertz, Antropologia e filosofia, Il Mulino, Bologna 2001, 97-99
7. Ralph Linton - Il processo di diffusione della cultura
Il cittadino americano medio (…) si sveglia la mattina in un letto costruito
secondo un modello che ebbe origine nel Vicino Oriente ma che venne poi
modificato nel Nord Europa prima di essere importato in America. Egli
scosta le lenzuola e le coperte che possono essere di cotone, pianta
originaria dell’India; o di lino, pianta originaria del Vicino Oriente; o di
lana di pecora, animale originariamente addomesticato nel Vicino Oriente;
o di seta, il cui uso fu scoperto in Cina. Tutti questi materiali sono stati filati
e tessuti secondo procedimenti inventati nel Vicino Oriente. Si infila i
mocassini, inventati dagli Indiani delle boscose contrade dell’est, e va nel
bagno, i cui accessori sono un misto di invenzioni europee e americane, di
data recente. Si leva il pigiama, indumento inventato in India, e si lava con
il sapone, inventato dalle antiche popolazioni galliche. Poi si fa la barba,
rito masochistico che sembra derivato dai Sumeri o dagli antichi Egizi.
Prima di andare a fare colazione, guarda fuori dalla finestra, fatta con il
vetro inventato in Egitto e, se piove, si mette le soprascarpe fatte di gomma
scoperta dagli Indiani dell’America centrale e prende un ombrello,
inventato nell’Asia sud-orientale. Andando a fare colazione si ferma a
comperare un giornale, pagando con delle monete che sono un’antica
invenzione della Lidia. Al ristorante viene a contatto con tutta una serie di
elementi presi da altre culture: il suo piatto è fatto di un tipo di terraglia
inventato in Cina; il suo coltello è d’acciaio, lega fatta per la prima volta
nell’India del Sud; la sua forchetta ha origini medievali italiane; il cucchiaio
è derivato dall’originale romano.
Quando il nostro amico ha finito di mangiare si appoggia alla spalliera della
sedia e fuma, secondo un’abitudine degli Indiani d’America.
Mentre fuma legge le notizie del giorno, stampate in un carattere inventato
dagli antichi Semiti, su di un materiale inventato in Cina e secondo un
procedimento inventato in Germania. Mentre legge i resoconti dei problemi
che s’aggirano all’estero, se è un buon cittadino conservatore, con un
linguaggio indo-europeo, ringrazierà una divinità ebraica, di averlo fatto al
cento per cento americano.
8. La sozzura gettata sul volto dell’umanità
Oggi che Isole Polinesiane, soffocate dal cemento armato, sono trasformate
in portaerei pesantemente ancorate al fondo dei Mari del Sud, che l’intera
Asia prende l’aspetto di una zona malaticcia e le bidonvilles rodono
l’Africa […] come potrà la pretesa evasione dei viaggi riuscire ad altro che
a manifestarci le forme più infelici della nostra esistenza storica? […]. Ciò
che per prima cosa ci mostrate, o viaggi, è la nostra sozzura gettata sul
volto dell’umanità. Capisco allora la passione, la follia, l’inganno dei
racconti di viaggio. Essi danno l’illusione di cose che non esistono più e
che dovrebbero esistere ancora per farci sfuggire alla desolante certezza che
20.000 anni di storia sono andati perduti. Non c’è più nulla da fare: la
civiltà non è più quel fragile fiore che, per svilupparsi a fatica, occorreva
preservare in angoli riparati di terreni ricchi di specie selvatiche,
indubbiamente minacciose per il loro rigoglio, ma che permettevano anche
di variare e di rinvigorire le sementi. L’umanità si cristallizza nella
monocoltura, si prepara a produrre la civiltà in massa, come la
barbabietola. La sua mensa non offrirà ormai più che questa vivanda (LéviStrauss, Tristi tropici, 1960, p. 36).
8. Sozzume o fertilizzante?
Il «sozzume» che un Occidente espansivo, secondo il disilluso viaggiatore
di Tristi Tropici, ha gettato in volto alle società del mondo appare come
materia prima, fertilizzante per nuovi ordini di differenza. (…). E’
anche sozzume. I contatti culturali moderni non hanno bisogno di essere
romanticizzati, cancellando la violenza dell’impero e delle pertinenti forme
di dominazione neocoloniale. La storia caraibica (…) è una storia di
degradazione, mimetismo, violenza e possibilità bloccate. (…) [però] è
anche ribelle, sincretica e creativa. Tale sorta di ambivalenza mantiene i
futuri locali del pianeta incerti e aperti.
In tutto il mondo le popolazioni indigene hanno dovuto fare i conti con le
forze del «progresso» e dell’unificazione «nazionale». I risultati sono stati
sia distruttivi, sia inventivi. Molte tradizioni, lingue, cosmologie e valori
sono andati perduti, in certi casi letteralmente assassinati; molto, però, è
stato in pari tempo inventato e fatto rivivere in contesti complessi,
contraddittori.
(Clifford, I frutti puri impazziscono, Bollati Boringhieri, 1993)
9. La monocultura
(…) le malinconiche premonizioni levistraussiane sulla “monocultura”,
[…] sapevano più di romanticismo occidentale che di acume etnografico.
Quando dei turisti americani o tedeschi a Bangkok o a Lagos vedranno un
film indiano e lo discuteranno esattamente negli stessi termini, o
proveranno esattamente le stesse reazioni di coloro che hanno intorno,
allora la monocultura sarà arrivata.
Ma è probabile che la monocultura affliggerà soltanto quelli che sono
disposti a scambiare una patina di superficie per la totalità della cultura in
generale: gli Archi d’Oro di McDonald’s piuttosto che le tensioni politiche
che essi provocano e mascherano; l’universalismo delle politiche
ambientali piuttosto che le argomentazioni delle vittime locali del
cosiddetto sviluppo; i “valori della famiglia” anziché la disordinata
complessità delle vite reali e delle loro infinite trasformazioni.
C’è da sperare che perfino quanti da poco sono arrivati al potere possano
apprezzare e rispettare queste complessità. Ma ascolteranno le intime voci
rivelate dagli etnografi, che rivelano un mondo di desideri e di speranze?”
(M. Herzfeld, Antropologia, 2006, Seid)