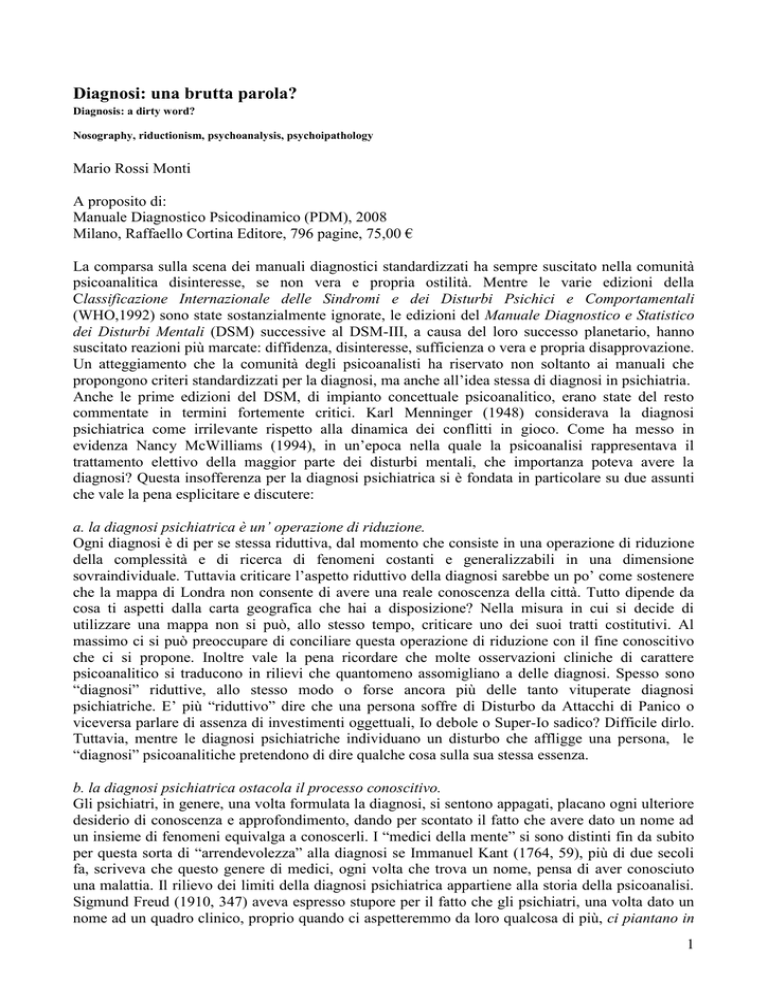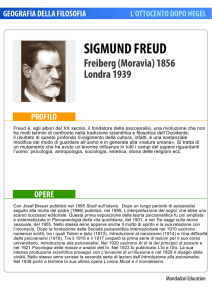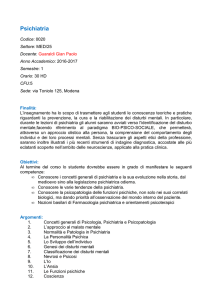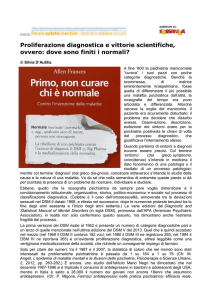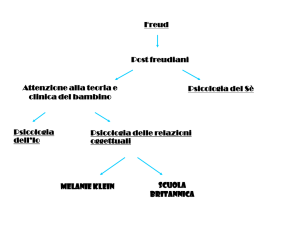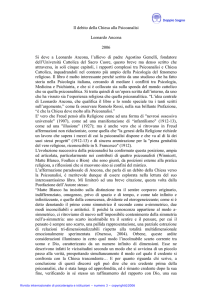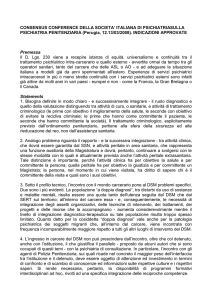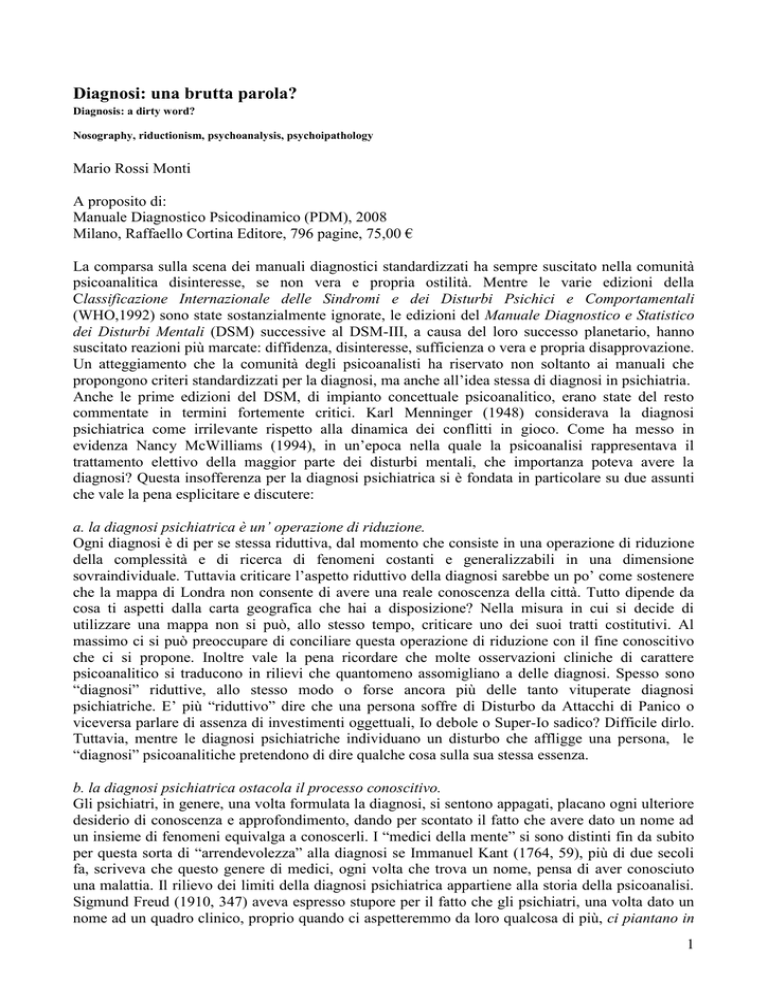
Diagnosi: una brutta parola?
Diagnosis: a dirty word?
Nosography, riductionism, psychoanalysis, psychoipathology
Mario Rossi Monti
A proposito di:
Manuale Diagnostico Psicodinamico (PDM), 2008
Milano, Raffaello Cortina Editore, 796 pagine, 75,00 €
La comparsa sulla scena dei manuali diagnostici standardizzati ha sempre suscitato nella comunità
psicoanalitica disinteresse, se non vera e propria ostilità. Mentre le varie edizioni della
Classificazione Internazionale delle Sindromi e dei Disturbi Psichici e Comportamentali
(WHO,1992) sono state sostanzialmente ignorate, le edizioni del Manuale Diagnostico e Statistico
dei Disturbi Mentali (DSM) successive al DSM-III, a causa del loro successo planetario, hanno
suscitato reazioni più marcate: diffidenza, disinteresse, sufficienza o vera e propria disapprovazione.
Un atteggiamento che la comunità degli psicoanalisti ha riservato non soltanto ai manuali che
propongono criteri standardizzati per la diagnosi, ma anche all’idea stessa di diagnosi in psichiatria.
Anche le prime edizioni del DSM, di impianto concettuale psicoanalitico, erano state del resto
commentate in termini fortemente critici. Karl Menninger (1948) considerava la diagnosi
psichiatrica come irrilevante rispetto alla dinamica dei conflitti in gioco. Come ha messo in
evidenza Nancy McWilliams (1994), in un’epoca nella quale la psicoanalisi rappresentava il
trattamento elettivo della maggior parte dei disturbi mentali, che importanza poteva avere la
diagnosi? Questa insofferenza per la diagnosi psichiatrica si è fondata in particolare su due assunti
che vale la pena esplicitare e discutere:
a. la diagnosi psichiatrica è un’ operazione di riduzione.
Ogni diagnosi è di per se stessa riduttiva, dal momento che consiste in una operazione di riduzione
della complessità e di ricerca di fenomeni costanti e generalizzabili in una dimensione
sovraindividuale. Tuttavia criticare l’aspetto riduttivo della diagnosi sarebbe un po’ come sostenere
che la mappa di Londra non consente di avere una reale conoscenza della città. Tutto dipende da
cosa ti aspetti dalla carta geografica che hai a disposizione? Nella misura in cui si decide di
utilizzare una mappa non si può, allo stesso tempo, criticare uno dei suoi tratti costitutivi. Al
massimo ci si può preoccupare di conciliare questa operazione di riduzione con il fine conoscitivo
che ci si propone. Inoltre vale la pena ricordare che molte osservazioni cliniche di carattere
psicoanalitico si traducono in rilievi che quantomeno assomigliano a delle diagnosi. Spesso sono
“diagnosi” riduttive, allo stesso modo o forse ancora più delle tanto vituperate diagnosi
psichiatriche. E’ più “riduttivo” dire che una persona soffre di Disturbo da Attacchi di Panico o
viceversa parlare di assenza di investimenti oggettuali, Io debole o Super-Io sadico? Difficile dirlo.
Tuttavia, mentre le diagnosi psichiatriche individuano un disturbo che affligge una persona, le
“diagnosi” psicoanalitiche pretendono di dire qualche cosa sulla sua stessa essenza.
b. la diagnosi psichiatrica ostacola il processo conoscitivo.
Gli psichiatri, in genere, una volta formulata la diagnosi, si sentono appagati, placano ogni ulteriore
desiderio di conoscenza e approfondimento, dando per scontato il fatto che avere dato un nome ad
un insieme di fenomeni equivalga a conoscerli. I “medici della mente” si sono distinti fin da subito
per questa sorta di “arrendevolezza” alla diagnosi se Immanuel Kant (1764, 59), più di due secoli
fa, scriveva che questo genere di medici, ogni volta che trova un nome, pensa di aver conosciuto
una malattia. Il rilievo dei limiti della diagnosi psichiatrica appartiene alla storia della psicoanalisi.
Sigmund Freud (1910, 347) aveva espresso stupore per il fatto che gli psichiatri, una volta dato un
nome ad un quadro clinico, proprio quando ci aspetteremmo da loro qualcosa di più, ci piantano in
1
asso. Al massimo, continua Freud, si mettono a discettare di qualche altra ipotesi lontana dai fatti
clinici osservati. La diagnosi psichiatrica – questo il timore degli psicoanalisti – non è dunque una
tappa in un percorso di approfondimento anche psico-patologico ma una pietra tombale che
seppellisce la dimensione psicologico-dinamica del disturbo sotto una etichetta comunicabile e
condivisa dalla comunità degli esperti. Questo stesso atteggiamento di stupore per una superficiale
adesione alla diagnosi era condiviso dal fondatore della moderna psicopatologia. Karl Jaspers
(1913, 22) non perdeva occasione per ricordare che la diagnosi deve essere l’ultima preoccupazione
dello psicopatologo. Intendendo con ciò che la diagnosi è certamente una operazione necessaria ed
importante. Ma non deve precocemente occludere un processo conoscitivo. Il diagnosticare –
continua Jaspers - si traduce spesso in uno “sterile giostrare”. Basta pensare all’uso quantomeno
ipocrita del concetto di comorbidità nella attuale nomenclatura psichiatrica. La preoccupazione, più
che legittima, che la diagnosi psichiatrica rappresenti un ostacolo alla conoscenza, tuttavia, non
riguarda tanto il processo diagnostico di per se stesso quanto piuttosto l’uso che del prodotto finito
di questo processo (la diagnosi, appunto) viene fatto. Che la diagnosi sia il risultato di un processo
di riduzione è assolutamente scontato. Una diagnosi non può essere nient’altro che questo. Ma il
problema è che cosa ci si attende dalla diagnosi e che uso se ne fa. Una diagnosi che addormenta
ogni ulteriore possibilità di conoscenza si pone come ostacolo nella relazione terapeutica. E’
necessario che la capacità di stupirsi del clinico di fronte ai fenomeni che osserva resti viva. Quella
“l” che marca la differenza tra approccio “clinico” ed approccio “cinico” va difesa ad ogni costo.
Questo il progetto freudiano: fare della diagnosi una tappa di un percorso conoscitivo. Che cosa
vuol dire? In primo luogo che la diagnosi non è tanto quel un nome statico sotto il quale riuniamo
una serie di fenomeni dispersi ma è, anche e soprattutto, un processo dinamico (il “diagnosticare”)
che si dispiega nel tempo (ciò che oggi chiamiamo Assessment). In secondo luogo che la diagnosi
intesa come processo diagnostico conoscitivo si pone in rapporto di continuità con lo sviluppo del
processo terapeutico.
Non ha senso quindi considerare la diagnosi un male in se stesso, né perseverare nel considerare la
diagnosi “una brutta parola” (McWilliams,1994 27). La diagnosi deve essere inserita in un
processo, un processo diagnostico che potremmo vedere come una clessidra. La ricognizione dei
dati clinici conduce ad una sintesi ipotetica e provvisoria (la diagnosi descrittiva della psichiatria
clinica). Questa sintesi, che coincide con il punto di strozzatura della clessidra, prelude tuttavia ad
espansione, che recuperi il senso di quell’insieme di sintomi in quella specifica persona, nella sua
storia, nella storia delle sue relazioni, etc. , secondo un modello al quale in Italia ha dato importanti
contributi Fausto Petrella (1993).
Ma se la psicoanalisi ha avversato la diagnosi in quanto tale, allo stesso tempo ha mantenuto con
essa, fin dagli inizi, un rapporto di carattere anaclitico. Molte osservazioni e costruzioni
psicoanalitiche si sono appoggiate alla terminologia diagnostica della psichiatria. Freud ad esempio
adotta fin dal titolo di molte sue opere, termini che appartengono alla nosografia dell’epoca. Ancora
più evidente è il fenomeno nei lavori di Karl Abraham che parla nel titolo di dementia praecox,
ebefrenia, psicosi maniaco-depressiva. Freud (1915-1917, 574) non si limita ad appoggiare le sue
analisi cliniche ai termini della nosografia psichiatrica. Prende posizione nel dibattito nosografico
dell’epoca con “la proposta di riunire la paranoia e la demenza precoce sotto la comune
denominazione di parafrenia”. Le motivazioni addotte appartengono logica della nosografia
psichiatrica ma, come è noto, l’indicazione freudiana cadono nel vuoto. La psicoanalisi tuttavia
continuerà a tenere in piedi un rapporto stretto e per molti versi ambiguo con la nosografia
psichiatrica. Da un lato ignorando gli sviluppi della nosografia psichiatrica, dall’altro appoggiandosi
ad essa come ad un ineludibile termine di paragone. Anche in modi molto indiretti. Come
dimenticare, ad esempio, l’adozione da parte di Melanie Klein di una terminologia tipica della
nosografia psichiatrica per indicare “posizioni” precoci dello sviluppo?
La diagnosi psichiatrica si configura così – per la psicoanalisi - come prima tappa di un processo
conoscitivo che deve portare al di là del riconoscimento di un disturbo sul piano descrittivo. Privata
2
di questo retroterra, una diagnosi psichiatrica che si fermi alla descrizione dei sintomi appare “uno
sforzo enorme per ottenere l’impossibile” (Winnicott, 1959, 167). Vale per la diagnosi quanto Freud
scriveva sul rapporto tra psichiatria e psicoanalisi. Se paragoniamo l’approccio psichiatrico
tradizionale alla anatomia macroscopica, la psicoanalisi costituisce un proseguimento dell’indagine
con strumenti più fini, propri della anatomia microscopica. Ciò che è dato osservare, per così dire,
in superficie, nei comportamenti come anche nella esperienza consapevole delle persone, sarebbe
poco affidabile. La verità sta altrove, poiché l’uomo non è padrone nemmeno in casa propria. In
questa prospettiva i resoconti clinici oggettivi del DSM, ma anche quelli soggettivi dei nostri
pazienti sarebbero in buona parte inaffidabili e necessiterebbero di essere interrogati ad un altro
livello. Ma questi due diversi livelli sono in competizione tra loro? O viceversa rappresentano due
diversi modi di intenzionare il nostro oggetto di studio? Ritornando alla metafora “anatomica”
freudiana con le parole di Richard Rorty (1982), è fuorviante sostenere che le descrizioni
microscopiche e macroscopiche degli organismi viventi siano modalità opposte di fare biologia. In
molte applicazioni le descrizioni biochimiche sono utili. In altre costituiscono un fattore di disturbo.
Allo stesso modo, nell’avvicinare e conoscere i disturbi mentali, le descrizioni in terza persona
possono svolgere una funzione utile. In altre occasioni sono invece inutili o addirittura di ostacolo.
Se gli psichiatri hanno fatto della diagnosi-praecox la loro principale malattia, gli psicoanalisti, al
contrario, hanno preteso di collocare la diagnosi alla fine di un percorso interminabile. La vera
diagnosi in psicoanalisi sembra essere una diagnosi “posticipata”, simile – scriveva Freud (1912,
569) - “alla "prova della strega" del re scozzese, di cui ho letto in Victor Hugo”: gli analisti si
comportano “come quel re scozzese di un romanzo di Victor Hugo, il quale si vantava di possedere
un metodo infallibile per riconoscere la stregoneria. Faceva immergere l'accusata in acqua bollente
e quindi assaggiava il brodo. Poi giudicava secondo il sapore: ‘sì, era una strega’, oppure: ‘no, non
era una strega’”.
Solo una ristretta minoranza di psicoanalisti ha sviluppato un differente approccio alla diagnosi
psichiatrica, a partire dal riconoscimento del valore del suo livello descrittivo. Un livello al quale il
processo diagnostico non si può fermare ma che, allo stesso tempo, ne è parte necessaria ed
integrante. E’ inutile nascondersi che ogni clinico (anche psicoanalista), nel corso del suo lavoro,
oscilla continuamente tra due momenti di natura radicalmente diversa. Tutta l’ambiguità della
psichiatria, ha scritto magistralmente Danilo Cargnello (1980), sta nella continua oscillazione tra
l'essere-con-qualcuno e l'avere-qualcosa-di-fronte. Tra il valorizzare il sentire e conoscere l’altro
nella relazione e il considerare ciò che si osserva in termini più distaccati ed oggettivi. I “fatti della
psicoanalisi” – scrive Modell (1984,191) - possono essere collocati all’interno di due diverse
categorie a seconda del rapporto che l'osservatore intrattiene con la «cosa» osservata: una
configurazione di rapporto Io-tu o una configurazione Io-ciò. Il momento della oggettivazione è
insomma parte ineludibile di ogni operazione conoscitiva. Nel caso dei disturbi mentali non ci si
può certo fermare qui. Ma nemmeno negarne il senso. O non tenere conto del fatto che qualsiasi
clinico ha bisogno di passare (e ripassare) attraverso questo momento di riduzione e sintesi per
lavorare in maniera proficua.
Glen Gabbard (1990) si è fatto alfiere del riconoscimento di questa istanza. Invece di squalificare il
DSM, ha raccolto la sfida misurandosi sul suo stesso terreno. Ne è nato un volume (Psichiatria
Psicodinamica) che ha avuto enorme successo proprio perché veniva incontro alla domanda di aiuto
degli psichiatri che, arrivati ad “avere-qualcosa-di-fronte” avvertivano i limiti di questo approccio,
soprattutto quando si trattava di tradurre quell’approccio in un progetto terapeutico. Molti psichiatri
– scrive Gabbard – raccontavano di sentirsi “bloccati” di fronte al disturbo, quando – per dirla
ancora con le parole di Freud – il DSM li piantava in asso. Questa è la conseguenza di un radicale e
colpevole fraintendimento: la maggior parte degli psichiatri si forma sul DSM, nel senso che adotta
il DSM non tanto come Manuale per la diagnosi standardizzata, quanto piuttosto come Manuale di
studio della psicopatologia. In luogo della conoscenza di un mondo, di un particolare rapporto con
la realtà e con se stessi, finiscono per scambiare i pochi dati “operazionalizzabili” in base ai quali si
3
può fare diagnosi con il mondo psicopatologico di cui quei dati sono (nella migliore delle ipotesi)
gli indicatori. Ciò li condanna ad assumere un’unica posizione: “avere-di-fronte-qualcosa” o
“rapporto Io-ciò”. Grazie questo fraintendimento, tutte le volte che non accettano supinamente il
valore degli item descrittivi o si fanno delle domande su come utilizzare la diagnosi nella relazione
e nel progetto terapeutico, si trovano in mano un pugno di mosche. Il merito di Gabbard è quello di
essere stato capace di andare loro incontro, raggiungendoli proprio là dove essi si trovavano, senza
pretendere di attirarli con il canto delle sirene della metapsicologia psicoanalitica. In maniera
analoga Nancy Mc Williams (1994), sulla scia del lavoro pionieristico di Kernberg sui disturbi di
personalità, ha sviluppato un accurato sistema diagnostico di carattere psicodinamico nel quale la
diagnosi viene intesa come un processo che ha non ha i tempi infiniti di un intero trattamento e che
fin dall’inizio svolge un ruolo importante nella formazione della alleanza terapeutica.
Un nuovo capitolo, all’interno di questa linea di tendenza, si è aperto con la pubblicazione dello
Psychodynamic Diagnostic Manual (PDM) nel 2006. Una Task Force composta dalle più
prestigiose associazioni psicoanalitiche statunitensi ha messo in cantiere e realizzato un Manuale
Diagnostico capace di mettere in crisi l’Impero DSM. Questo Manuale Diagnostico Psicodinamico
(PDM) è stato pubblicato nel 2008 in Italia, grazie al lavoro di Vittorio Lingiardi e Franco del
Corno per conto della Raffaello Cortina Editore. Nella Presentazione dell’edizione italiana Vittorio
Lingiardi e Franco del Corno ripercorrono i conflitti ma anche i dialoghi che hanno caratterizzato il
rapporto tra psichiatria e psicoanalisi. Un intricato rapporto dal quale tuttavia erano già nati tentativi
(anche ben riusciti) di operazionalizzare la diagnosi psicodinamica: l’OPD (Diagnosi
Psicodinamica Operazionalizzata), uno strumento diagnostico sviluppato in Germania alla fine
degli anni ’90 (De Coro,2002) e la Shedler-Westen Assessment Procedure (SWAP) per la diagnosi
della personalità (Western, Shedler, Lingiardi, 2003).
Questi strumenti sottolineano il forte interesse del mondo psicoanalitico internazionale, soprattutto
anglosassone, alla diagnosi. Diagnosi –forse– non è più una brutta parola per gli psicoanalisti. Mi
domando quanto questo possa valere per il nostro paese, nel quale le resistenze ad un impegno sul
piano della ricerca empirica sono ancora abbastanza consistenti. La struttura del PDM è complessa.
Non è immediatamente facile calarsi nelle pieghe del percorso diagnostico. Sono invece chiare e
salde le premesse.
La diagnosi che interessa al clinico deve riguardare non tanto il disturbo in se stesso quando la
persona che “vive” quel disturbo. Per questo il PDM prende le mosse da una critica radicale ad una
eccessiva restrizione della attenzione (da parte del DSM) ai sintomi “osservabili”,
indipendentemente dal contesto più generale di vita della persona (contesto personale, storicoevolutivo, relazionale, ambientale). Il desiderio di conformasi con troppa fretta ai metodi delle altre
discipline mediche ha impedito di sviluppare procedure empiriche appropriate al campo studiato. Il
misconoscimento radicale della esperienza soggettiva, al quale è ricorso il DSM, ha forgiato
categorie di disturbo artificiali: certamente non idonee alla progettazione del trattamento ma
insoddisfacenti anche per la ricerca empirica. Per questi motivi la ricerca empirica, ad esempio nel
campo delle psicosi, si è dovuta ritagliare vere e proprie nicchie psicopatologiche. Mi riferisco ad
esempio alla straordinaria rilevanza che ha assunto negli ultimi anni la sindrome di Capgras. Una
rara sindrome descritta da Capgras nel 1924 che, nonostante la sua rarità, è diventata il terreno di
confronto e verifica, sul piano della ricerca empirica, di diversi modelli del delirio. Questo è
accaduto perché le grandi categorie diagnostiche del DSM si sono rivelate assolutamente eterogenee
ed aspecifiche, inidonee a ritagliare una popolazione clinica accomunata da una stessa serie di
esperienze soggettive. Solo la adozione di un criterio psicopatologico, centrato sul vissuto
soggettivo, ha consentito di individuare popolazioni omogenee, sulle portare avanti la ricerca.
Il PDM parte proprio dal rilievo che, nonostante il paziente cerchi un trattamento spinto dalla
propria sofferenza soggettiva, questo aspetto non è tenuto in conto dai tradizionali manuali
diagnostici. Un approccio alla valutazione diagnostica e al trattamento deve invece partire proprio
dalle parole dei pazienti.
4
Per tenere fede a questa impostazione il PDM struttura un sistema a tre assi:un primo asse dedicato
alla diagnosi dei pattern e disturbi di personalità, un secondo asse dedicato alla valutazione globale
del funzionamento mentale; un terzo asse, dedicato ai sintomi manifesti. I primi due assi adottano lo
schema di riferimento ormai classico proposto in ambito psicodinamico da Kernberg: all’interno di
un unico continuum si distingue un livello di organizzazione di personalità normale, nevrotico e
borderline. Rispetto alla proposta di Kernberg viene tuttavia soppressa la organizzazione psicotica.
Per due ragioni: i) esistono poche ricerche in grado di sostenere l’ipotesi di una organizzazione
psicotica; ii) questa formulazione induce una confusione terminologica tra la patologia
schizofrenica franca e i disturbi di personalità. Una preoccupazione, quest’ultima, più che fondata:
basti pensare all’uso ambiguo che parte degli psicoanalisti ha sempre fatto del termine “psicosi”,
mettendo sullo stesso piano un livello di funzionamento mentale e la espressività clinica di una
psicosi manifesta.
Due notazioni conclusive. La prima. Il PDM recupera il senso della diagnosi recuperando anche il
bisogno di oggettività. Ma questa esigenza, che appartiene all’uso clinico della diagnosi, si accoppia
ad una seconda esigenza: fare della diagnosi un elemento portante nella ricerca empirica sulle
psicoterapie. Processo diagnostico e processo terapeutico si collocano lungo un continuum e la
messa a fuoco dell’uno si riverbera sulla conoscenza dell’altro. Da questo accoppiamento non può
che derivare un beneficio per la ricerca.
La seconda. Il terzo asse, dedicato ai pattern sintomatici, mette al centro della attenzione l’
esperienza soggettiva, basandosi sulla premessa che i sintomi non sono disturbi a sé stanti, ma
espressioni esplicite dei modi in cui i pazienti affrontano le esperienze. Nonostante queste
premesse, l’analisi della esperienza interna proposta da questo asse appare deludente: troppo legata
alla descrizione del sintomo in terza persona, non riesce a cogliere gli aspetti essenziali del vissuto
soggettivo, mancando della possibilità di organizzare le esperienze interne intorno a organizzatori di
senso che non possono certo essere rappresentati dai sintomi descritti dal DSM. E’ un vero peccato
che sia ancora una volta fallito l’innesto, a questo livello, della grande messe di conoscenze che
oltre un secolo di psicopatologia fenomenologica ha sviluppato sulle esperienza soggettiva nella
psicosi. Nella storia del rapporto tra psicoanalisi e psicopatologia fenomenologia, un’altra occasione
di incontro venuta a mancare (Barale, Ucelli,2001)
-------------------------------------BIBLIOGRAFIA
BARALE F., UCELLI S. (2001). Alle fonti delle concezioni psicodinamiche delle psicosi. Karl
Abraham e la psichiatria del suo tempo. Riv.Psicoanal., 4, 693-709.
CAPGRAS, J., LUCCHINI, P., SHIFF, P. (1924). Du sentiment d’étrangeté à l’illusion des sosies..
Bull Soc Clin Méd Ment,12,210-217.
CARGNELLO D. (1980). Ambiguità della psichiatria. Comprendre, 9,7-48,1999
DE CORO A. (a cura di) (1996). OPD – Diagnosi psicodinamica operazionalizzata. Masson,
Milano, 2002.
FREUD S. (1910). Osservazioni psicoanalitiche su un caso di paranoia (dementia paranoides)
descritto autobiograficamente (Caso clinico del presidente Schreber). O.S.F.,6
FREUD S. (1912). Contributi a una discussione sull'onanismo. O.S.F., 6
GABBARD G. (1990). Psichiatria psicodinamica. Raffaello Cortina, Milano,1995
JASPERS K. (1913). Psicopatologia generale. Il Pensiero Scientifico, Roma, 1964
KANT I. (1764). Saggio sulle malattie della mente. Ibis, Como-Pavia, 1992.
MCWILLIAMS N. (1994). La diagnosi psicoanalitica. Struttura della personalità e processo
clinico. Astrolabio, Roma, 1999.
MENNINGER, K. (1948). Changing concepts of disease. Annals of Internal Medicine, 29,318-330.
MODELL A.H. (1984). Psicoanalisi in un nuovo contesto. Raffaello Cortina, Milano,1992.
5
PETRELLA, F. (1993). Sull'istanza nosografica in psichiatria e nella psicoanalisi. In: Petrella, F.,
Turbamenti affettivi e alterazioni dell'esperienza. Raffaello Cortina, Milano.
RORTY R.(1982). Metodo, scienza sociale e speranza sociale. In: Conseguenze del pragmatismo.
Feltrinelli, Milano, 1986.
WESTEN D., SHEDLER J., LINGIARDI V. (2003). La valutazione della personalità con la
SWAP-200. Raffaello Cortina, Milano.
WINNICOTT DW. (1959). Classificazione: esiste un contributo psicoanalitico alla classificazione
psichiatrica? In: Sviluppo affettivo e ambiente. Armando, Roma,1970
WORLD HEALTH ORGANIZATION (1992). Decima revisione della classificazione
internazionale delle sindromi e dei disturbi psichici e comportamentali. Masson, Milano, 1992.
6