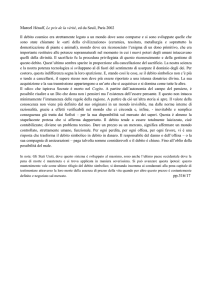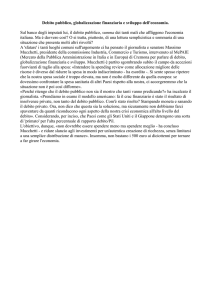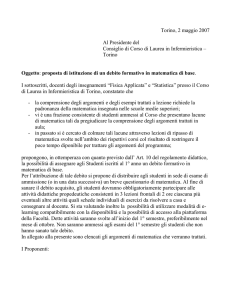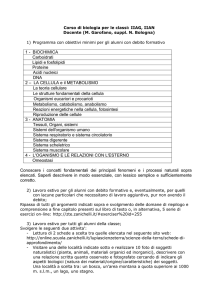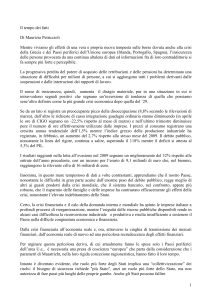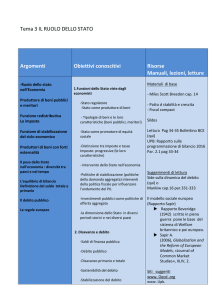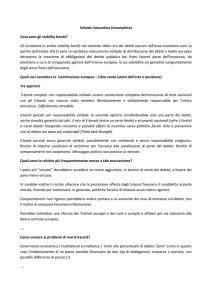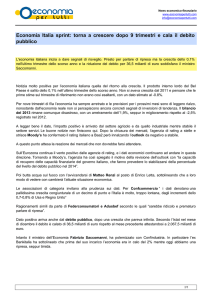La peste nera del debito pubblico
di lanfranco caminiti
Alla fine del 2010, secondo l'Organizzazione internazionale del lavoro, nel mondo si contavano
trentaquattro milioni di disoccupati in più rispetto al 2007, l’inizio della crisi finanziaria. È una
strage impressionante di lavoro, numeri da epidemia, da peste nera, da spagnola. Cifre di caduti
da guerre mondiali. È una distruzione colossale di capacità produttiva, di creatività, di
abnegazione, di speranze, di ricchezza, di vite, come il mondo ha visto solo nei momenti peggiori,
nei secoli più bui. E è così che dobbiamo pensare quando parliamo di crisi e di ristrutturazioni del
debito pubblico, come alle tremende devastazioni che un conflitto bellico ha lasciato e a una
minaccia di ulteriore distruzione che mette in forse la stessa civiltà, la stessa umanità.
Nel 1919, a Versailles, si tenne la Conferenza di pace dei paesi vincitori della Prima guerra
mondiale. Vi partecipò anche John Maynard Keynes, giovane e brillante funzionario del Tesoro
britannico. La sua proposta alla Conferenza era che questa avrebbe dovuto porre le basi per un
rilancio dell'economia; invece essa s’interessò principalmente delle riparazioni dei danni di guerra
imponendo alla Germania condizioni gravosissime. Keynes riteneva che dovesse esserci un
annullamento dei debiti di guerra, cosa che avrebbe agevolato soprattutto la stessa Gran
Bretagna, attraverso gli scambi commerciali. Lo spirito di rivalsa dei vincitori ebbe invece la meglio,
e Keynes, deluso e amareggiato, si dimise, tornandosene a Cambridge. La Germania si ritrovò in
una spirale da cui uscì il nazismo.
Qui e ora in occidente non ci sono nazioni che hanno vinto e nazioni che hanno perso. Dalla crisi
ne usciamo tutti con le ossa ammaccate. Anche gli Stati uniti, la più grande potenza il mondo
abbia mai avuto corre tecnicamente il rischio di un default, con un debito pubblico impazzito. Il
prodotto interno lordo (PIL) degli Stati Uniti è di 14.000 miliardi di dollari l’anno e il loro debito
pubblico ha ormai raggiunto il tetto di legge, i 14.292 miliardi. Ogni anno gli Stati uniti producono
e volatilizzano la loro stessa immensa ricchezza. Il prossimo anno dovranno indebitarsi di nuovo,
poi pagare più di quanto hanno prodotto e via così all’infinito, in un cerchio della morte. Sembra
l’orribile tunnel di un commerciante caduto nelle mani dell’usura, da cui non riuscirà a sottrarsi
mai. E dico degli Stati uniti per la monumentalità della questione, non perché noi si stia meglio
messi.
Le condizioni capestro poste contro chi ha abusato dei bilanci pubblici, ha giocato
“creativamente” coi numeri, ha appesantito la spesa statale per guadagnare immediato consenso
a spese di ogni generazione futura, si ritorcono pesantemente contro chi vuole esercitare la
punizione. Cosa potranno comprare i greci, di quello che noi produciamo, di quello che i tedeschi
esportano, di quello che i francesi vendono, se non hanno i soldi neppure per pagare i loro debiti?
La Banca centrale europea non è il Tribunale dell’Aja, anche se spesso sembra atteggiarsi così, e
neppure il Fondo monetario internazionale lo è. E quando parliamo del debito pubblico del
Portogallo o dell’Irlanda non stiamo giudicando crimini contro l’umanità. I greci non sono Mladic.
L’economia non funziona con i verdetti e le condanne a senso unico, funziona con gli scambi.
Certo, è necessario tagliare privilegi, disboscare evasioni e detrazioni, rimboccarci le maniche e
dare ciascuno secondo quel che può, chi più ha, più dà. Ma se in economia non si ricostruisce un
punto di vista umano, dopo le ferite della crisi, dentro l’epidemia del debito pubblico, se le grandi
potenze del mondo – una vera e propria Conferenza di pace – non si siedono intorno a un tavolo
riprendendo il primato della politica sullo strapotere del denaro, se gli Stati uniti, l’Europa, il Bric
non costruiscono un progetto unitario di salvezza, ben più che di salvataggio, ogni nazione sarà
abbandonata a se stessa, lazzaretto di appestati, ostaggio e preda degli andamenti dei mercati
finanziari. Sarà preda delle convulsioni più estreme, dei populismi più radicali, di una aggressività
interna e verso l’esterno che può solo ulteriormente distruggere. Alla fine, il conto lo pagheremo
tutti. Lo stiamo già pagando. O riscopriamo le radici comuni di un progetto d’umanità, o è il
mondo intero che va in default.
Non che la finanza vada mortificata, paralizzata. Senza leva finanziaria non si creano investimenti e
non si produce ricchezza; che la finanza giri freneticamente il mondo in cerca di opportunità, è una
buona cosa; i Credit swaps e i futures, assicurazioni contro i rischi di investimento, sono una buona
invenzione. Ma la leva finanziaria è uno strumento virtuale, un puro indice: matematizzarlo
all’inverosimile finisce sempre col costruire uno schema Ponzi-Madoff in cui agli ultimi resterà il
cerino in mano. L’incendio in mano. Solo la forza comune della politica mondiale può fare fronte
contro l’enorme forza dei mercati finanziari. Non c’è più un singolo impero, una singola potenza
industriale, una singola area geoeconomica in grado di tenerle testa.
La democrazia occidentale – cresciuta e rafforzata attraverso il debito pubblico, che è stata la
forma della sua progressiva postindustrializzazione: meno lavoro, più servizi – sembra stia
perdendo i suoi fondamenti. Ovunque, perché ovunque il modello di crescita è stato lo stesso. Il
postindustrialismo – l’eccedenza di lavoro manuale – non è una crisi ciclica di sovrapproduzione, o
una fase recessiva su cui intervenire attraverso la domanda aggregata né un’invenzione malefica
del Bildeberg Group: è il progresso della tecnica. Così, le misure di austerity di Cameron somigliano
a quelle di Papandreou e a quelle di Obama e di Tremonti: da subito si bloccano pensioni e
stipendi, si tagliano spese sociali. Il debito pubblico ci fa tutti conservatori. Con le misure di
austerity la regressione del debito pubblico produce la regressione della democrazia. Dalla crisi
liberista sembriamo volerne uscire più liberisti di prima – la ristrutturazione del debito pubblico
attraverso i tagli sociali è una ricetta liberista – come se da una guerra devastante uscissimo più
guerrafondai di come ci siamo entrati. È inimmaginabile che la ristrutturazione del debito pubblico
funzioni da demoltiplicatore della democrazia: la democrazia non è un algoritmo. Dobbiamo far
progredire la democrazia per far regredire il debito pubblico. È questa la vera sfida di civiltà. Per il
futuro, il mondo ha bisogno di più spesa sociale, non di meno. Il liberismo di questi ultimi
trent’anni non ha diminuito lo Stato, nonostante le sue predicazioni: per esercitare controllo
interno e per incamerare consenso, per proteggersi dalle minacce e rafforzarsi militarmente, al
contrario lo ha ingigantito, lo Stato, lo ha moltiplicato. L’eccedenza di lavoro è stata impiegata
tutta dal lato della governance, piuttosto che da quello della society. È la democrazia che va
ristrutturata in senso progressivo, in senso di prosperity.
Non c’è modo di immaginare una grande Conferenza di pace che ristrutturi il debito pubblico
dell’occidente e lanci grandi progetti di infrastrutture, di investimenti, di occupazione occupazione
e occupazione senza affiancare una manovra monetaria mondiale. Il dollaro non può più
funzionare da valuta mondiale di riserva. Va presa in reale considerazione la creazione di una
moneta mondiale di conto. Keynes andò a Versailles pensando al bancor, a me piacerebbe si
chiamasse il global.
Esiste già una moneta virtuale di conto di riferimento mondiale, i Diritti speciali di prelievo del
Fondo monetario internazionale che sono sostanzialmente un paniere di monete. È una
architettura ormai vecchia, il renmimbi cinese, a esempio, ne è escluso. Negli anni si è fatta strada
l’idea di monete di aree regionali sul modello dell’euro. Ma basta guardare lo spread tra il Bund
tedesco e i Btp italiani per capire che un euro tedesco vale di più di un euro italiano o portoghese
o greco. È, peraltro, proprio questo il motivo per cui non si fanno gli Eurobond. E così accadrebbe
per il real brasiliano contro il bolivar venezuelano, o per il renmimbi contro il dong vietnamita. Non
è questa, la regionalizzazione monetaria, la strada per progetti universali. Per il punto a cui siamo
arrivati. Il debito pubblico del mondo minaccia ormai le nostre democrazie. La sovranità politica di
una nazione o di un’area è sotto costante tiro delle manovre speculative.
La Germania ha finito di pagare solo l’anno scorso i debiti della Prima guerra mondiale, quasi
cent’anni dopo. La dilazione fu decisa nel 1924, ma era ormai troppo tardi. Cent’anni da oggi, un
secolo: questa è la misura con la quale si dovrebbero ristrutturare i debiti pubblici delle nazioni.
Azzerarli, quasi. E ricominciare con le linee di credito. In global. Non è per nulla più concreto chi
pensa a sistemare la partita doppia contabile mentre le merci in magazzino stanno prendendo
fuoco.
Dobbiamo agire adesso. Per prepararci al futuro della democrazia universale.
Nicotera, 3 luglio 2011