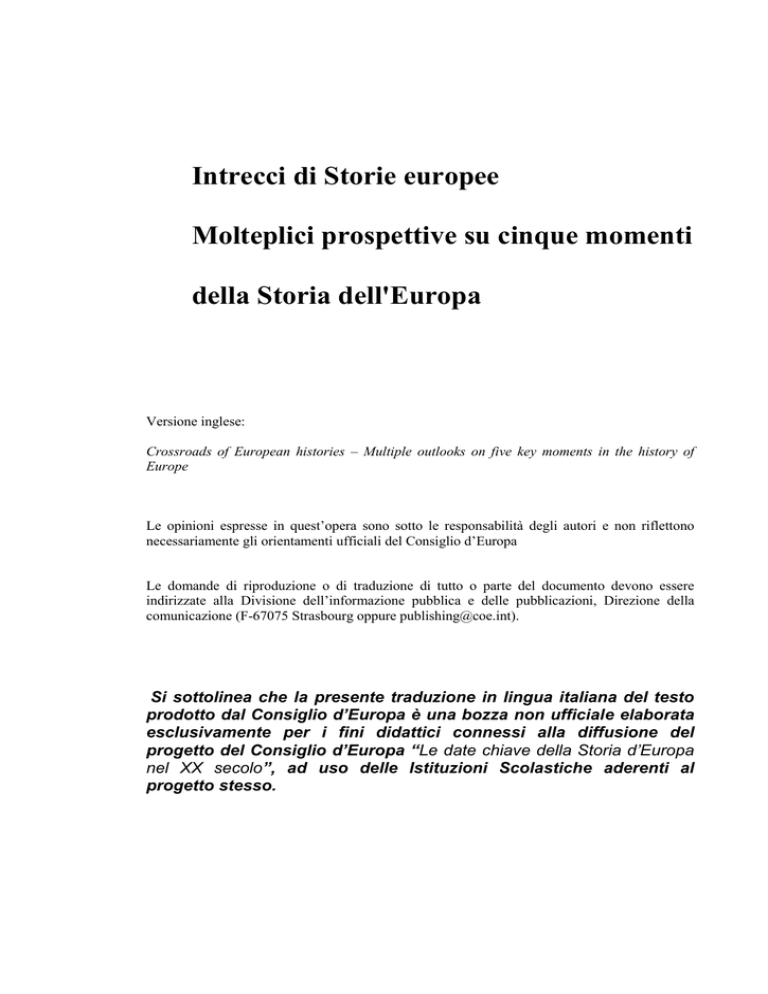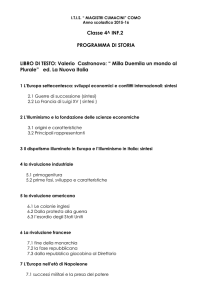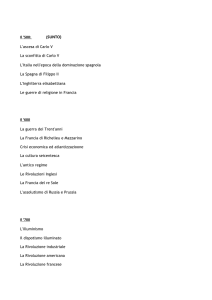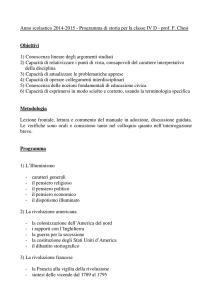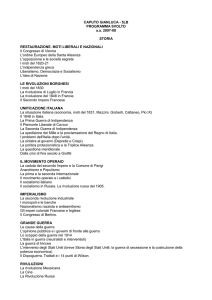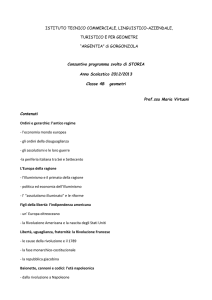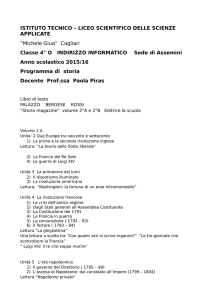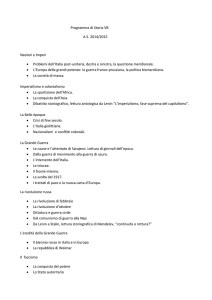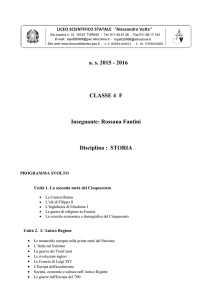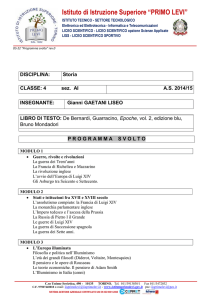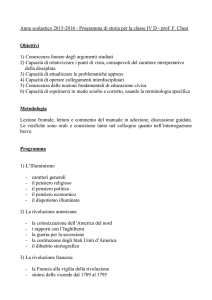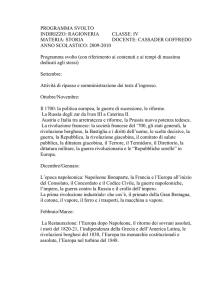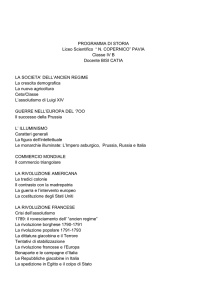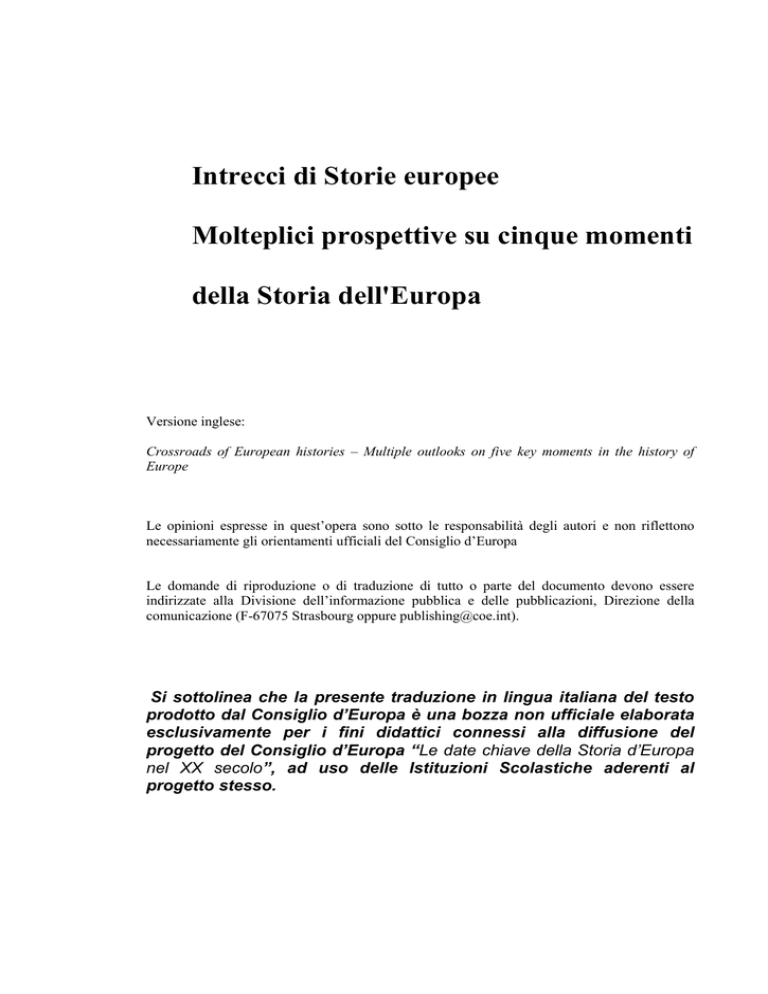
Intrecci di Storie europee
Molteplici prospettive su cinque momenti
della Storia dell'Europa
Versione inglese:
Crossroads of European histories – Multiple outlooks on five key moments in the history of
Europe
Le opinioni espresse in quest’opera sono sotto le responsabilità degli autori e non riflettono
necessariamente gli orientamenti ufficiali del Consiglio d’Europa
Le domande di riproduzione o di traduzione di tutto o parte del documento devono essere
indirizzate alla Divisione dell’informazione pubblica e delle pubblicazioni, Direzione della
comunicazione (F-67075 Strasbourg oppure [email protected]).
Si sottolinea che la presente traduzione in lingua italiana del testo
prodotto dal Consiglio d’Europa è una bozza non ufficiale elaborata
esclusivamente per i fini didattici connessi alla diffusione del
progetto del Consiglio d’Europa “Le date chiave della Storia d’Europa
nel XX secolo”, ad uso delle Istituzioni Scolastiche aderenti al
progetto stesso.
La traduzione in lingua italiana è stata realizzata grazie alla
collaborazione dei Dirigenti Scolatici e dei Docenti sottoelencati,
ai quali vanno i più sentiti ringraziamenti della Direzione Generale
per gli Affari Internazionali, Ufficio IV, per il prezioso contributo
alla disseminazione nazionale delle attività del Consiglio
d’Europa.
Intrecci di Storie europee
Molteplici prospettive su cinque momenti della Storia d'Europa
Traduzione in lingua italiana a cura dei docenti:
Patrizia Aratano - I.I.S.S.”Einaudi-Casaregis-Galilei” - Genova
Gabriella Benzi - I.I.S.S.”Einaudi-Casaregis-Galilei” - Genova
Marilena Caselli - I.I.S.S.”Einaudi-Casaregis-Galilei” - Genova
Elisabeth Casteels (I.I.S.S. “D. Fioritto” di San Nicandro Garganico - Foggia
Monica Crociani- I.I.S.S.”Einaudi-Casaregis-Galilei” - Genova
Gabriella De Palma- I.I.S.S.”Einaudi-Casaregis-Galilei” - Genova
Ivana Ferraro - I.T.C. “Cosentino” di Rende - Cosenza
Maria Luisa Ghirardo - I.I.S.S.”Einaudi-Casaregis-Galilei” - Genova
Luciana Guido - I.I.S.S.”Einaudi-Casaregis-Galilei” - Genova
Andrea Manus - I.T.C.T.G. “S. Satta” di Macomer - Nuoro
Cosimo Mercuri - I.T.C. “Cosentino” di Rende – Cosenza
Giovanna Pira - I.T.C.T.G. “S. Satta” di Macomer - Nuoro
Carmela Pititu - I.T.C.T.G. “S. Satta” di Macomer - Nuoro
Chiara Puggioni- I.I.S.S.”Einaudi-Casaregis-Galilei” - Genova
Anna Russo - I.I.S.S. “D. Fioritto” di San Nicandro Garganico - Foggia
Teresa Scanzano - I.I.S.S. “D. Fioritto” di San Nicandro Garganico - Foggia
Rosella Sisto - I.I.S.S.”Einaudi-Casaregis-Galilei” - Genova
Rosa Torre - I.I.S.S.”Einaudi-Casaregis-Galilei” - Genova
Giovanna Trazzi - I.T.C.T.G. “S. Satta” di Macomer - Nuoro
Coordinamento a cura di:
Giuseppe De Cato- Dirigente scolastico I.I.S.S. “D.Fioritto” di San Nicandro Garganico -Foggia
Raffaele Franzese - Dirigente scolastico I.T.C.T.G. “S. Satta” di Macomer - Nuoro
Mario Nardi – Dirigente scolastico I.T.C. “Cosentino” di Rende - Cosenza
Roberto Olmi - Dirigente scolastico I.I.S.S.”Einaudi-Casaregis-Galilei” – Genova
3
Sommario
Gli autori .................................................................................................................................. 6
Introduzione............................................................................................................................. 8
PARTE I ....................................................................................................................................... 10
Il 1848 nella storia europea ....................................................................................................... 10
1. Introduzione all’anno 1948 ................................................................................................ 12
2 - La Dimensione europea nel 1848: dalla democrazia allo Stato-nazione ........................ 13
3 - La visione francese del 1848 verso l'Europa ................................................................... 22
La Seconda Repubblica .......................................................................................... 22
4- La Germania e la Monarchia degli Asburgo 1848-1849 .................................................. 30
5.
La Rivoluzione ungherese del 1848 e le sue conseguenze ........................................ 40
6. La Rivoluzione del 1848 nei Principati rumeni: continuità e discontinuità ....................... 52
7. Libertà e unità: un matrimonio impossibile. Le feste pubbliche del centenario del 1848" in
Germania nel 1948 ................................................................................................................ 60
PARTE II ...................................................................................................................................... 68
1912-13 nella storia europea .................................................................................................... 68
8. Introduzione all'anno 1913 ................................................................................................ 70
9. Le grandi potenze ed i Balcani: 1878-1914 ...................................................................... 71
10 Le ripercussioni delle guerre balcaniche del 1912-1913 sulla vita quotidiana dei civili ... 79
11 Le guerre balcaniche: valutazioni e previsioni dal servizio di informazioni dell’armata
russa. (Nuovo quadro della situazione stabilito a partire dalle varianti delle opinioni antiche).
.............................................................................................................................................. 89
12 Le guerre balcaniche nella storiografia e i manuali bulgari recenti. ................................ 99
13. Le guerre balcaniche del 1912-1913: il punto di vista turco ......................................... 106
14 Le guerre balcaniche (1912-1913): il punto di vista austriaco ................................... 117
PARTE III ................................................................................................................................... 130
Il 1919 nella storia europea ..................................................................................................... 130
15. Introduzione all’anno 1919 ............................................................................................ 132
16. L’indomani della “Grande Guerra”: la Francia ed i Francesi nel 1919 .......................... 133
17. La Repubblica di Weimar: il peso della Grande Guerra ............................................... 137
18. Immagini di sconfitta: l’Ungheria dopo la guerra persa, la rivoluzioni ed il trattato di pace
di Trianon ............................................................................................................................ 142
19. Dall’equilibrio delle forze alla sicurezza collettiva? La Società delle Nazioni e la
diplomazia internazionale .................................................................................................... 148
20. Gli Iugoslavi alla conferenza di pace di Parigi e l’eredità della prima guerra mondiale 158
21. La “Grande Guerra” ed il trattato di Neuilly – sur – Seine- Retaggio reale ed immaginario
nel dibattito pubblico in Bulgaria ......................................................................................... 166
22. L’immagine della donna dal 1914 al 1920. Miti e realtà ................................................ 171
23. 1919: La dimensione globale ........................................................................................ 179
24. La Grande Guerra: una rottura culturale? ..................................................................... 185
PARTE IV .................................................................................................................................. 194
IL 1945 NELLA STORIA EUROPEA ........................................................................................ 194
25. Introduzione all’anno 1945 ........................................................................................... 196
26. La conferenza di Yalta e l’emergenza della guerra fredda .......................................... 197
27. Yalta, Potsdam e l’emergenza della guerra fredda: la visione del Regno Unito alla luce
di recenti ricerche ................................................................................................................ 203
28. La conferenza di Crimea e le origini della guerra fredda ........................................... 213
29. Yalta, nella prospettiva polacca .................................................................................. 220
30. Yalta, Potsdam e l’emergenza della Guerra fredda: la visione della Germania dopo le
recenti ricerche. ................................................................................................................... 228
31. Note: una visione ucraina ......................................................................................... 237
PARTE V ................................................................................................................................... 241
4
IL 1989 NELLA STORIA EUROPEA ....................................................................................... 241
32. Introduzione all’anno 1989 .......................................................................................... 243
33. 1989: in retrospettiva, l’anno dei miracoli. .................................................................... 244
Le rivoluzioni del 1989 .......................................................................................... 245
La Guerra Fredda. Le Grandi Linee ...................................................................... 247
Un Continente che Cambia : L’Europa Degli Anni 1980 ....................................... 248
L’Europa occidentale e il progetto europeo negli anni 1980 ................................. 249
L’Europa orientale I: il ristagno economico ........................................................... 249
Come spiegare questa situazione? ....................................................................... 250
Conclusione : esame retrospettivo dell’anno 1989 ............................................... 253
34. 1989: la fine della guerra fredda ed il crollo dell’Unione Sovietica ............................... 255
35 Eroi, “passati”, protagonisti e popolazione L’Ungheria nel 1989 Janos Rainer ........ 265
36 - La storia della caduta del comunismo – cantiere delle scienze socio-umane ......... 272
Il piano di ricerca: studio del caso - “la rivoluzione rumena” del 1989 .................. 272
Applicazione pratica: l'effetto “groupthink” nella rivoluzione rumena .................... 273
Conclusioni ............................................................................................................ 276
37. La risposta degli Stati Uniti agli eventi del 1989 ........................................................... 278
Conclusioni ............................................................................................................ 286
38. La riunificazione della Germania .................................................................................. 288
39. Il manifestarsi delle differenze nazionali, 1989 – 1992: la divisione della Cecoslovacchia
............................................................................................................................................ 301
Sfondo storico circa la questione Slovacca .......................................................... 301
La Rivoluzione di Velluto e la questione slovacca ................................................ 303
La Guerra del “Trattino di Congiunzione” e la nuova divisione del potere............ 303
Conclusione .......................................................................................................... 312
40. Media, partiti e transizione politica: approcci contrastanti di discipline sorelle ........... 314
5
Gli autori
6
7
Introduzione
Il 31 ottobre del 2001, il Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa ha adottato la
Raccomandazione (2001) 15 relativa all’insegnamento della storia d’Europa del XX secolo.
Il testo è il risultato di una lunga serie di lavori e di progetti posti in essere dal Consiglio
D’Europa fin dal 1950 nel campo dell’insegnamento della storia. Dalla sua adozione, e fino ad
oggi, è l’unico strumento di questa natura in Europa.
La raccomandazione affronta differenti questioni, con particolare riferimento ai contenuti dei
programmi, ai metodi di apprendimento, alla formazione degli insegnanti, all’utilizzazione delle
nuove tecnologie ma soprattutto definisce chiaramente quali dovranno essere gli obiettivi
dell’insegnamento della storia nel XXI secolo.
Due obiettivi sono particolarmente sottolineati:
-
l’insegnamento della storia occupa un posto esenziale nella formazione del cittadino
responsabile e attivo, aperto all’altro e rispettoso di tutte le diversità in una società
democratica;
-
l’insegnamento della storia deve permettere di sviluppare negli allievi la capacità
intellettiva di analizzare e interpretare l’informazione in maniera critica e responsabile
attraverso il dialogo, la ricerca dei fatti storici grazie a un confronto aperto su una
visione plurale, in particolare sulle questioni controverse e sensibili.
Lanciando nel 2002 il Progetto “La dimensione europea nell’insegnamento della storia”, il
Comitato dell’istruzione ha deciso di mettere a disposizione dei formatori degli insegnanti, degli
insegnanti e degli allievi un insieme di risorse relative a un certo numero di avvenimenti storici,
di proposte metodologiche e di esempi di approcci multidisciplinari. Ciò al fine di permettere in
particolare ai docenti di tradurre nella pratica pedagogica i principi generali contenuti nella
Raccomandazione (2001)15.
La messa in opera di questi principi generali presuppone che sia introdotto e sviluppato il
concetto di multiprospettività nella presentazione di avvenimenti o di fatti storici.
In effetti qualsiasi avvenimento storico può essere l’oggetto di approcci differenti, di concetti
convergenti o divergenti o di interpretazioni particolari secondo il punto di vista, l’obiettivo
fissato, il contesto storico e politico di coloro che li spiegano, li descrivono o li presentano.
Non si tratta solamente di differenze o di sfumature nell’esposizione e nell’interpretazione dei
fatti dal punto di vista nazionale ma anche di diversi legami con la filosofia o la concezione
della storia, con l’evoluzione continua della ricerca, con l’evoluzione delle concezioni nel
tempo, dei contesti e dei punti di vista propri di certi gruppi sociali.
Questo concetto è stato l’oggetto di numerose riflessioni e analisi nel quadro dei lavori
precedenti le cui conclusioni figurano nel manuale “La multiprospettiva nell’insegnamento della
storia” redatto dal Referente del Progetto, il Dott. Robert Stradling.
Il risultato finale del Progetto è rappresentato da tre elementi strettamente legati: l’insieme dei
contributi presentati durante le conferenze che hanno avuto luogo sui cinque momenti-chiave
della storia recente dell’Europa, un DVD che presenta documenti originali relativi a queste
cinque date e un manuale pratico per l’utilizzatore.
L’opera “Incrocio di Storie europee – Prospettive multiple su cinque momenti della storia
dell’Europa” costituisce il primo elemento. I contributi presentati durante le cinque conferenze
8
non rappresentano evidentemente l’esaustività dei punti di vista e non costituiscono che qualche
esempio che l’insegnante potrà chiaramente arricchire.
Questi contributi non costituiscono nemmeno la posizione ufficiale degli stati di cui gli autori
sono rappresentanti né quella del consiglio d’Europa. Perciò nella loro diversità esse non
impegnano che i loro autori.
Occorre sottolineare che quest’opera non ha finalità in quanto tale e che essa ha senso solo se
utilizzata congiuntamente agli altri due strumenti (DVD, manuale pedagogico) nella
preparazione di un corso o di una lezione. Ciò implica anche, tenuto conto del programma, degli
obiettivi pedagogici e delle risorse e dei mezzi messi a disposizione degli insegnanti, che siano
fatte aggiunte e ricerche complementari.
Questo insieme di strumenti è messo a disposizione degli attori dell’insegnamento della storia al
fine di aiutarli nel raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Raccomandazione (20001)15. non
mette in discussione le prerogative degli Stati membri nella definizione dei programmi di storia.
Gli strumenti così proposti non hanno la finalità di sostituire i manuali di storia dei rispettivi
curricula. Essi sono proposti in quanto risorse complementari.
Però nel dibattito in corso sull’insegnamento della storia nella maggior parte degli stati membri,
la metodologia e l’approccio plurale qui proposti dovrebbero permettere di arricchire la ricerca
di nuove strade.
Esso permetterà all’insegnamento della storia – come sottolinea la raccomandazione, di giocare
un ruolo di riconciliazione, di riconoscenza, di comprensione e di mutua fiducia tra i popoli e di
contribuire a una ricostruzione europea liberamente consentita basata su un patrimonio storico e
culturale comune arricchito delle sue diversità anche nei suoi aspetti conflittuali e qualche volta
drammatici.
9
PARTE I
Il 1848 nella storia europea
10
11
1. Introduzione all’anno 1948
Il 1848 è un anno movimentato. In febbraio, viene pubblicato il Manifesto del Partito
Comunista. Un'epidemia di colera, causata dall'ingestione di acqua contaminata, si propaga a
tutta l'Europa e provoca numerose vittime, adulti e bambini, già indeboliti da due anni di magri
raccolti. Si assiste anche alla fine brutale della schiavitù e di altre manifestazioni del
feudalesismo praticamente in tutta l'Europa centrale ed orientale. Ma il 1848 resta innanzitutto
l’" anno delle rivoluzioni", il popolo dietro le barricate in Francia, negli Stati tedeschi ed
italiani, in Austria, in Ungheria ed in quasi tutta l'Europa centrale ed orientale.
Queste sommosse non arrivano a sorpresa. I tre decenni precedenti sono già stati segnati dalle
ondate di agitazione politica, di disordini civili e di rivolte in diverse zone del continente. In
Portogallo, a Napoli e in Spagna ci sono stati dei colpi di stato militari e delle guerre civili. Nel
1821, i greci si sono ribellati contro il dominio ottomano e hanno finito per ottenere la loro
indipendenza nel 1829. In questo stesso anno, l’Impero ottomano è stato costretto ad accordare
l'autonomia alla Serbia e ai principati danubiani. La rivoluzione del 1830, in Francia, ha causato
delle manifestazioni a Bruxelles e ha portato il Belgio a proclamare la sua indipendenza. Da
parte sua, la Polonia è in preda a delle agitazioni popolari, represse dalle truppe russe.
Nell'ottobre 1847, Metternich commenta in questi termini la situazione in Europa: "sono un
vecchio medico, so fare la differenza tra un’ affezione passeggera e un male mortale... ci siamo
ridotti a questo stadio." Quattro mesi più tardi, altri pensano, come lui, che per il vecchio ordine
europeo suona ormai il rintocco funebre.
Tuttavia, appena un anno dopo, le vecchie forze conservatrici ritornano al potere. Lo storico
britannico G. M. Trevelyan più tardi descriverà l'anno 1848 come una svolta "che l'Europa non
ha saputo prendere." Le rivoluzioni del 1848 non ne hanno nemmenolasciato tracce il cui
impatto ha avuto ripercussioni a lungo praticamente in tutta l'Europa. La restaurazione del
potere degli Absburgo non ha completamente messo fine alle aspirazioni nazionaliste dei popoli
che componevano il loro Stato, costituito da una moltitudine di nazioni e di lingue. L'idea
dell'unificazione non avrebbe più abbandonato gli Stati italiani e tedesci. Anche le monarchie
più tradizionali cominciano a riconoscere che le riforme costituzionali sono necessarie.
Inoltre, in tutti i paesi in cui ci sono state delle rivoluzioni, la cultura politica comincia a
trasformarsi. Numerosi individui, avendo acquisito una coscienza politica, si organizzano in
partiti politici, in sindacati e in associazioni professionali, incaricati di difendere i loro interessi.
Sono sempre più numerose le donne che si impegnano nella vita pubblica. Si stringono sempre
più legami tra partiti politici e classi sociali e la stampa politica ha un rapido sviluppo. In certi
paesi, il panorama politico si troverà riplasmato per più di un secolo, poiché certi settori della
società restano radicali o conservanti, come lo erano nel 1848. In conclusione, le rivoluzioni del
1848 hanno contribuito a stabilire l'ordine del giorno politico e sociale di una gran parte
dell'Europa per il resto del XIX secolo ed oltre.
12
2 - La Dimensione europea nel 1848: dalla democrazia allo Statonazione
Dieter Langewiesche
Il 150° anniversario della rivoluzione del 1848 si è celebrato cinque anni fa in pompa magna.
Soprattutto la Germania si è distinta per suo entusiasmo festoso, ma anche per il carattere
commerciale delle manifestazioni organizzate in quell’occasione. Non mancava niente,dal
“Heckerhut", cugino del berretto frigio, al " vino dei ribelli", dall’ " escursione della
rivoluzione" alla birra preparata secondo una ricetta del 1848.
L'attuale ritorno di popolarità della rivoluzione del 1848 contrasta fortemente con lo scarso
interesse che ha suscitato nel XIX secolo, in cui era considerata ingiustamente come una
semplice rivolta borghese fallita. Certo, la rivoluzione non ha raggiunto gli obiettivi che si era
fissata in parecchi paesi europei, ma ha tuttavia influenzato profondamente il corso degli eventi.
Si può affermare che la rivoluzione del 1848 segna una svolta nella storia dell'Europa. Tenterò
di spiegare questa svolta alla luce di due aspetti: la democratizzazione e il nazionalismo.
Per afferrare tutta l'ampiezza degli avvenimenti dell'epoca, dobbiamo soffermarci innanzitutto
sull'orizzonte di notizie di cui disponevano allora gli Europei, e sulla propagazione spettacolare
che ha avuto.
L'europeizzazione dell’informazione
La rivoluzione, ma anche la repressione della rivolta e la contro-rivoluzione, hanno creato
un'unità europea che non esisteva prima del 1848. Il continente europeo è diventato così uno
spazio unico di comunicazione e di azione, uno spazio di informazione di una densità senza
precedenti, eliminando i confini geografici, sociali e politici e anche le barriere che tenevano
tradizionalmente le donne fuori dallo spazio pubblico maschile. Sotto l'effetto della rivoluzione,
le possibilità di informazione hanno migliorato velocemente per tutta la popolazione, presa dalla
sete di sapere. Mai prima, una rete di informazione così capillare aveva coperto l'Europa.
L’informazione era oramai, in teoria, accessibile a tutti.
L’ europeizzazione dell’informazione permette il cambiamento radicale dell'Europa. Il segnale
viene dato dalle sommosse del febbraio 1848 a Parigi che creano un pubblico europeo. In tutte
le regioni d'Europa, gli sguardi si girano verso Parigi, questo" cuore eterno dell'Europa" come
scriveva Fanny Lewald. Appena si diffondono le prime notizie sull'insurrezione di febbraio,
questo scrittore tedesco si reca a Parigi per assistere agli avvenimenti (Lewald, 1969, p.7). La
capitale europea della rivoluzione è il punto di convergenza di tutte le speranze e di tutti i
timori, sia dei rivoluzionari che dei loro avversari. Solo quattro mesi dopo la vittoria della
rivoluzione politica di febbraio, la rivolta sociale firma il suo fallimento nel giugno del 1848. L’
una e l'altro, la vittoria e il fallimento, sono degli avvenimenti importanti per tutta l’Europa.
Se Parigi dà il segnale, le rivoluzioni che si sviluppano dovunque in Europa hanno tuttavia delle
cause e delle mire differenti, anche se la trama è identica. Esse hanno in comune due obiettivi
principali: in primo luogo, democratizzare l'ordine politico e l'ordine sociale; in secondo luogo,
instaurare l'autodeterminazione nazionale nei paesi europei che non sono, ancora organizzati in
Stati-nazione, cioè, in quel tempo, nella maggior parte delle società europee. Le forze all’opera
in questi due campi si sostengono reciprocamente, ormai nelle regioni reclamate da più nazioni,
in cui esse si oppongono violentemente.
Democratizzazione e nazionalismo, queste due grandi speranze del 1848fondano così un’Europa
che prende coscienza della sua identità oltre le frontiere, fanno nascere uno spazio pubblico
europeo, stabiliscono uno spazio di informazione alla scala del continente. Parallelamente,
13
l'Europa rivoluzionaria aspira ad una Europa di nazioni, di Stati-nazione. Democratizzazione e
nazionalismo sono due obiettivi che si completano ma diventano presto contraddittori.
1848: una serie di rivoluzioni costituzionali
Che cosa s’ intende per "democratizzazione" nel 1848?
Tutti i movimenti rivoluzionari hanno per principali rivendicazioni, tra l’ altro, la
democratizzazione e la parlamentarizzazione dello Stato. La richiesta di sapere quale deve
essere l’ampiezza delle riforme dà luogo, invece, ad accese discussioni sull'ordine costituzionale
del futuro. La polemica culmina nella polarizzazione intorno a due simboli: repubblica da un
lato, monarchia parlamentare dall'altro. Il dibattito finisce per dividere i movimenti rivoluzionari
in due campi accanitamente opposti.
La prima metà del XIX secolo ha visto la monarchia costituzionale insediarsi come sistema
costituzionale predominante sul continente europeo. Nel 1948, numerosi riformatori vogliono
andare oltre ed esigono di accrescere i poteri del parlamento a spese della monarchia. La
monarchia parlamentare è all'epoca l'appannaggio del Regno Unito, e quelli che sperano di
instaurarla sul continente devono lottare su due fronti: contro i monarchici che vogliono
conservare il potere e contro i repubblicani che pensano che questo capovolgimento non andrà
molto lontano.
Dopo la Rivoluzione francese del 1789, la repubblica in quanto forma di organizzazione dello
Stato scatena delle passioni contraddittorie in tutta l'Europa. È difficile oggi comprendere che
per i contemporanei della rivoluzione, la repubblica è molto più di una semplice forma di
governo. Essa porta in sé sia la speranza della felicità che il timore del cedimento. Nell'
Education sentimentale, Gustave Flaubert ha colto in alcune parole l'aura che spira nel 1848
intorno alla parola repubblica: " È stata proclamata la Repubblica! Tutti saranno felici adesso!
(...) libereremo la Polonia e l'Italia! Non più re, capite? Tutta la terra libera! Tutta la terra
libera!" All'entusiasmo di un combattente delle barricate, bisogna opporre lo spavento che
assale i conservatori, i liberali e molti altri all'evocazione della repubblica. Numerosi sono i
democratici per i quali la repubblica evoca innanzitutto lo spettro del 1793 e del Terrore
rivoluzionario. Per riprendere le parole di Flaubert, " la mannaia della ghigliottina [vibrava] in
tutte le sillabe della parola Repubblica" (Flaubert, 1869).
Solo in Francia si sa, nel 1848, che la repubblica non deve condurre necessariamente al terrore
come è successo dopo il 1789. Per gli altri Stati europei, l'esperienza di una repubblica borghese
e dominata resta ancora da fare. Agli occhi dei suoi detrattori, la repubblica è "rossa" e significa
la “libertà dei predatori e degli assassini" (Der Grânzbote, 29 novembre 1851, in: D.
Langewiesche, 1993, p. 38). Quanto ai suoi difensori, la coprono di speranze illusorie. Così la
repubblica nutre al tempo stesso la visione di un riscatto quasi religioso e il timore vano di una
caduta agli inferi.
Nel 1848, democratizzare il regime significa ampliare innanzitutto le possibilità di
partecipazione della popolazione. Per fare ciò occorre restringere le competenze delle dinastie al
potere e soffocare l'influenza delle “élite” politiche tradizionali. Una delle principali
caratteristiche della rivoluzione del 1848 è di avere tentato di giungervi appoggiandosi sui
mezzi dello Stato di diritto. Il principale strumento adoperato per avvicinarsi all'ideale di
uguaglianza dei cittadini non è né la ghigliottina né la barricata ma la Costituzione. Questo è il
motivo per il quale la rivoluzione del 1848 può essere chiamata una rivoluzione costituzionale una rivoluzione il cui scopo è di stabilire, obbligatoriamente, un nuovo ordine liberale e
democratico.
Tutti gli Stati coinvolti dalla rivoluzione o trascinati nella sua corrente riformistica si dotano
allora di una costituzione o cominciano a liberalizzare la loro costituzione esistente. Le
costituzioni adottate negli anni 1848/1849 non sono più dettate dalle autorità ma elaborate da
parlamenti regolarmente eletti, incarnando così il principio della sovranità del popolo. Di
14
conseguenza, i parlamenti occupano il centro dell'attualità politica. Mai prima, il pubblico si è
interessato così attivamente alla politica, mai prima un movimento popolare ha avuto una tale
dimensione europea, mai prima, il pubblico si è organizzato così per far valere le sue
rivendicazioni, mai prima, le città europee hanno visto pubblicare tanti giornali come nel 1848.
La stampa di opinione si inserisce nella vita pubblica e aiuta a organizzarla. I giornali sono un
mezzo di comunicazione indispensabile per costituire degli organismi di pressione
interregionale. Una stampa di una grande diversità e un tessuto associativo di un grande
spessore: queste due strutture strettamente legate sono al tempo stesso un risultato e un motore
della rivoluzione. La popolazione in generale e l'elettorato in particolare ne escono trasformati,
democratizzati dagli anni rivoluzionari, durante i quali il raggio delle categorie sociali che
godono del diritto di voto si allarga considerevolmente.
La società cittadina che prende forma resta tuttavia una società maschile – anche questa è una
caratteristica comune a tutta l’Europa. Solo gli uomini hanno il diritto di voto e di eleggibilità,
solo loro possono assumere delle funzioni in seno alle istanze dello Stato o dei comuni. Ma, a
parte questi due principi, la rivoluzione ha stravolto profondamente i rapporti politici tra i sessi.
Nel 1848, le donne leggono la stampa e pubblicano dei giornali, partecipano alle riunioni
politiche, ascoltano i dibattiti parlamentari, e si esprimono sulle questioni politiche di attualità,
in privato, nelle riunioni politiche e sulle barricate. Si, poiché le donne scendono in strada e si
appoggiano sul principale vettore di sensibilizzazione politica dell'epoca: il tessuto associativo.
Nascono numerose associazioni di donne e appaiono anche negli Stati dove questa forma di
collettività era fino ad allora sconosciuta.
Le donne approfittano, quindi, delle nuove possibilità di partecipazione politica senza tuttavia
godere dei diritti uguali a quelli degli uomini. A sinistra come a destra, pochi sono gli uomini
disposti a considerare le donne come dei cittadini uguali. Numerosi libelli aggressivi sono la
testimonianza del fastidio provato dagli uomini quando durante la rivoluzione vedono le donne
liberarsi dei loro ruoli tradizionali.
Nel 1848 diventa percettibile, in tutta la sua ampiezza, ciò che mi sembra essere una costante
dell'emancipazione delle donne nel corso del XIX secolo: man mano che il processo politico si
istituzionalizza, le possibilità per le donne di parteciparvi si riducono, e per molto tempo.
Bisognerà aspettare il XX secolo perché questa tendenza si concluda. Tutti i riformatori del
1848 hanno uno scopo comune nonostante le separazioni politiche: esigono delle riforme
strutturali puntellate dalle garanzie costituzionali e dal rinnovo delle istituzioni dello Stato. Le
istituzioni devono essere il focolare duraturo della società cittadina e democratica del futuro.
Ora, queste istituzioni sono il campo esclusivo degli uomini. Nel 1848 esse si aprono
ampiamente a nuove categorie sociali – ormai le donne. Le istituzioni politiche restano, tuttavia,
il campo riservato agli uomini.
Ciò non impedisce che la rivoluzione allarghi lo spazio di espressione politica di tutti,
rafforzando così la politicizzazione della società nel suo insieme. Ormai possono nascere ,
anche nei paesi dove erano vietati, dei partiti di concezione moderna che hanno una struttura
duratura, elaborano dei programmi, tentano di convincere il pubblico, nominano dei candidati
alle elezioni, e si sforzano di stringere dei legami tra l'associazione extraparlamentare e il
gruppo parlamentare. Le associazioni diventano dei centri di formazione politica. Si
concentrano nelle città ma si propagano anche nelle campagne. La forte partecipazione della
popolazione rurale alla fase conclusiva della rivoluzione rivela un processo di sensibilizzazione
politica che non sarebbe possibile senza l'esistenza di un tessuto associativo ben impiantato.
Dopo la rivoluzione, la repressione dello Stato riesce certo a neutralizzare il processo di
strutturazione politica della società, ma il suo successo non è che di breve durata.
L'organizzazione e la politicizzazione in profondità della società sono dei risultati duraturi della
rivoluzione del 1848.
Con una forza certamente variabile, il vento della rivoluzione spira su tutte le categorie sociali
delle società europee. Le donne, la popolazione rurale, gli operai fanno il loro ingresso in
15
politica nel 1848. Si potrebbe dire altrettanto degli ebrei, del clero, degli insegnanti universitari
e delle scuole, degli studenti. Ma non tutti partecipano con la stessa intensità alle riunioni
politiche, petizioni, organizzazioni, dibattiti ed altre attività rivoluzionarie di quegli anni:
generalmente gli uomini sono più interessati delle donne, i cittadini più dei campagnoli, gli
artigiani più dei contadini. i borghesi più degli aristocratici. E tutti ne escono più politicizzati di
prima. Chiunque vuole affermarsi sulla scena politica o in seno alle istituzioni dello Stato deve
agire in un quadro politico. Anche questo è un risultato durevole della rivoluzione del 1848.
Per ogni uomo politico l'obbligo di andare incontro all'opinione pubblica si impone anche alle
élite tradizionali che non possono più affidarsi ai meccanismi di conservazione delle loro
prerogative. Nascono nuovi centri di potere e nuove forme di azione politica. Per la prima volta,
la democrazia rappresentativa sembra imporsi sul continente europeo. I liberali e i democratici
si sforzano di promuoverla, ma anche i conservatori vanno incontro al pubblico, fondano delle
associazioni e dei giornali, e organizzano delle petizioni per non essere esclusi della scena
politica. Gli avversari della rivoluzione sono costretti a far ricorso alle armi. Anche la violenza
fa parte di queste armi che la contro-rivoluzione non è l'unica a usare. In tutta l'Europa, vengono
spiegate delle truppe regolari per opporsi alla rivoluzione, ma i governi rivoluzionari stessi non
avevano esitato, prima, a far ricorso all'esercito o alle milizie cittadine quando certi movimenti
rivoluzionari sembravano mettere in pericolo i loro progetti politici. Consideriamo ora la
rivoluzione nazionale, cioè la seconda fase della rivoluzione dopo la rivoluzione costituzionale
imperniata sulla riforma dello stato.
1848: una serie di rivoluzioni nazionali
Sono numerosi coloro per quali la rivoluzione è simile inizialmente a un dolce sogno, quello
della" primavera dei popoli" in Europa. Costoro aspirano a un’ Europa pacifica composta di
nazioni con uguali diritti. La realtà cambierà radicalmente dopo alcuni mesi. Il sentimento
nazionalista diventa sicuramente il collante più potente dei movimenti rivoluzionari europei,
riunendo sotto una stessa bandiera i difensori di cause diverse, ma questo forte ideale conduce
anche le nazioni a difendere ciecamente i loro interessi e a impegnarsi in alleanze contrarie ai
loro obiettivi democratici. Quando nel 1848 la rivoluzione infrange la cappa di piombo
reazionaria, la primavera dei popoli tanto attesa non fiorisce. I conflitti di territorio sono
numerosi in Europa, e in tutti i paesi interessati, la nazione, di una comunità che aspira alla
conquista della libertà, diventa una comunità di combattimento.
Ora la rivoluzione deve rilanciare un'immensa sfida per mettere in pratica i progetti
rivoluzionari dei popoli europei. Si tratta di dividere le confederazioni per riunire le nazioni
disperse su più Stati. Dovunque i problemi si pongono in modo diverso, e dovunque la guerra
minaccia. Nel 1848 tutti i principali paesi rivoluzionari si impegnano in guerre nazionali
rivoluzionarie di unificazione e di secessione. Solo la Francia, patria dei rivoluzionari, fa
eccezione a questa regola. Il suo statuto di Stato- nazione è già ben stabilito, e nessuno lo
rimette in causa. È per questo motivo che il programma della Rivoluzione francese non
comporta rivendicazioni nazionali. E tuttavia, la Repubblica francese stessa, nel 1849, prende le
armi per intervenire in Italia contro la nuova Repubblica romana.
Per comprendere tutta l'ampiezza degli sconvolgimenti indotti dalla democratizzazione e la
prospettiva di riorganizzazione nazionale dell’Europa, per l'emergenza di un’ Europa delle
nazioni e degli Stati-nazione, vorrei esporvi brevemente il contesto nel quale i differenti
movimenti nazionali sono emersi.
Cominciamo dall'Impero degli Asburgo. La quasi totalità delle linee di conflitto che lacerano
l’Europa del 1848 attraversano questo territorio multietnico. Insieme di stati e di nazioni, l’
Impero si oppose alla riorganizzazione nazionale dell’Europa. Per questo motivo,
inevitabilmente, esso diventa un focolaio di conflitti nazionalisti. Nessuna delle nazioni che lo
compongono è maggioritario, e numerose regioni sono abitate da un mosaico di popoli diversi, e
16
ciò dà adito a rivendicazioni territoriali concorrenti. L'Impero diventa così un campo di
esperienza del nazionalismo nel quale non ci possono essere semplici soluzioni.
Uno studente viennese, militante rivoluzionario e tuttavia monarchico, percepisce molto bene il
dilemma che si pone alla rivoluzione. Dobbiamo a questo tedesco della Bucovina che si
dichiara cittadino appartenente alla Grande Austria, delle osservazioni molto istruttive sullo
svolgimento della rivoluzione e i problemi nazionali. Si legge nella corrispondenza che
intrattiene con suo padre il quale rimane a Czernowitz: "Se è vero che la libertà di un paese può
significare l'oppressione dell'altro, questa è la situazione in Italia, dove la libertà degli italiani va
di pari passo con la messa in pericolo del Tirolo tedesco. Queste questioni di politica e di
filosofia sono un temibile rompicapo. Ciò che alcuni creano nelle migliori intenzioni, la dura
legge della politica può trasformarlo in maniera mostruosa "(Langewiesche, 1993, p. 104ff.
Questo studente originario della Galizia, provincia multietnica dell'Impero asburgico, pone le
sue speranze in una monarchia democratizzata e osserva con benevolenza lo slancio
rivoluzionario delle altre nazionali senza tuttavia rimettere in questione l'unità dell'Impero, che
deve naturalmente - questo è ovvio per lui - restare sotto il potere tedesco.
Il comportamento dei gruppi nazionali non tedeschi presenti a Vienna lascia già presagire ,
all'inizio della rivoluzione, che il sogno della primavera dei popoli rischia di sprofondare in un
incubo delle nazionalità. È nella capitale stessa che questo futuro prende forma prima e più
chiaramente. Alla fine del mese di marzo 1848, delle delegazioni di tutte le nazioni slave si
recano a Vienna per esporre i loro punti di vista al pubblico e alle istituzioni dello Stato.
Slovacchi, Serbi, Croati, Cechi e Polacchi celebrano la fratellanza austro-slava ma riescono ad
intendersi solo su un doppio rifiuto: rifiuto delle ambizioni di egemonia della nazione ungherese
e rifiuto delle rivendicazioni nazionali-rivoluzionarie tedesche che mirano alla creazione di uno
Stato-nazione. Nei confini della Confederazione germanica (Deutscher Bund), cioè che
includeva la Boemia, la Moravia e la Slesia austriaca. La comunità austro-slava, confrontata alla
sfida di liberare spazi di autonomia nazionale tra le due nazioni dominanti che formano i
Tedeschi e gli Ungheresi controllando comunque i conflitti di territorio tra nazionalità slave,
non arriva a unirsi al di là di questo fronte comune.
I libri di storia hanno generalmente uno sguardo critico sul congresso slavo che si riunisce nel
giugno del 1848 a Praga per dibattere questioni fondamentali delle nazionali nella monarchia
degli Asburgo. Bisogna tuttavia rendere giustizia a questo congresso per il fatto che propone
delle soluzioni pacifiche; le altre generazioni cercano rifugio nelle soluzioni militari che tentano
di "nazionalizzare" con la forza -vale a dire con l'oppressione o l'espulsione delle minoranze
nazionali - le regioni multinazionali. I nostri contemporanei hanno inventato l'eufemismo
"pulizia etnica" per designare questo modo di operare.
Il congresso slavo mira, nelle decisioni che si propone di adottare, a stabilire una monarchia
federativa degli Asburgo nella quale tutte le nazionalità godrebbero degli stessi diritti. Secondo
il Manifesto dei popoli europei, "la questione delle nazionalità è una questione vitale per
l'Austria" e l’uguaglianza di diritti e di statuto di tutte le nazioni deve essere il principio di base
di ogni Costituzione austriaca in mancanza della quale dei conflitti razziali in seno alla
monarchia e, di conseguenza, il deperimento cioè la caduta dello Stato sarebbero inevitabili"
(Manifesto, citata da Josef Kolejka.
Il congresso slavo mette in luce i problemi di nazionalità che agitano l'Europa del 1848. Esso
difende certamente la riorganizzazione della monarchia asburgica secondo dei principi
federativi, ma le modalità di questa riorganizzazione e il senso che bisogna dare
all’"uguaglianza di statuto" sono oggetto di una vivissima controversia. Numerosi cechi
sognano innanzitutto l'autonomia dei tre paesi della corona di Boemia ( Boemia, Moravia e
Slesia austriaca) nel quadro della monarchia asburgica e rifiutano categoricamente la loro
integrazione in uno Stato-nazione tedesco. I Croati aspirano a uno statuto di autonomia
paragonabile per il loro "regno tripartitico" (Croazia, Slavonia e Dalmazia) nel quadro della
17
monarchia asburgica; parallelamente, si allontanano dal loro alleato tradizionale, la corona
ungherese, andando fino a contestare apertamente i rapporti storici tra i due regni e schierandosi
con l'imperatore austriaco fin dall'inizio della guerra di indipendenza ungherese.
Il regno dell'Ungheria è, a immagine della monarchia asburgica di cui fa parte, uno Stato
multietnico composto da diverse nazionalità che vogliono liberarsi della dominazione magiara. I
croati rivendicano un rafforzamento dei loro diritti, persino la secessione dall'Ungheria. I serbi
dell'Ungheria del sud vogliono disporre delle loro proprie istituzioni politiche, in particolare di
un parlamento. Anche gli Slovacchi formano un movimento nazionale ed esigono di poter
beneficiare di diritti allargati. La rivoluzione nazionale ungherese non è disposta ha accettare
queste rivendicazioni. Si mostra pronta a fare delle concessioni solo nella fase finale della
rivoluzione, quando comincia a stagliarsi il fallimento generale dei movimenti rivoluzionari.
Tenuto conto delle rivalità nazionali, il mantenimento del monarchia asburgica in quanto unità
dello Stato era probabilmente il solo modo per evitare che scoppiasse una guerra tra tutte le
nazioni. Ma per tutto ciò ci sarebbe stato bisogno di riorganizzare la monarchia secondo dei
principi federativi. Questo era l'obiettivo del congresso slavo di Praga, e quello della Dieta
austriaca nel suo progetto di costituzione. Tutti e due, il congresso slavo e la Dieta, devono il
loro insuccesso non solo alla contro-rivoluzione ma anche al disaccordo tra le nazioni. Le
”élite” tradizionali vicine alla corte asburgica condividono coi movimenti nazionali il rifiuto di
qualsiasi progetto federativo conseguente. In quanto, al di là dell'allargamento del suo campo di
autonomia, un'organizzazione federale significa per la nazionalità maggioritaria la perdita dei
poteri delegati alle altre entità. Forse l'elaborazione delle regole di funzionamento della
federazione avrebbe permesso di risolvere questi problemi. Una parte, se non tutti i movimenti
nazionali sono disposti ad attraversare un tale processo di apprendimento, come prevede anche
la Dieta austriaca nel progetto costituzionale adottato a Kremsier. La vittoria della controrivoluzione conclude questi progetti.
Sarebbe tuttavia troppo semplice imputare all'unica controrivoluzione le rivalità che nascono tra
le nazioni europee all'indomani del risveglio democratico. Lo studio della rivoluzione polacca
svela quanti democratici e liberali sono anch’ essi implicati nel conflitto. Nel 1848, questo paese
diviso in tre territori spera di compiere un primo passo verso il rinnovamento dello Stato nella
regione di Poznan. La popolazione di Poznan è principalmente polacca, ma i Tedeschi sono più
numerosi nei distretti occidentali. Si può quindi prevedere facilmente che la "riorganizzazione
nazionale" auspicata inizialmente, nel 1848, dal nuovo governo prussiano e il parlamento
regionale, darà luogo a gravi difficoltà. I movimenti di liberazione europea non avevano pensato
a questi problemi quando avevano scritto con enfasi la restaurazione della Polonia sulle loro
bandiere, parecchi decenni prima della rivoluzione. Dopo il fallimento della rivoluzione polacca
nel 1831, sono state create numerose associazioni polacche in seno alla Confederazione
germanica che offrivano un sostegno morale e finanziario agli esiliati polacchi. Ma la solidarietà
dei popoli si trasforma in rivalità alla prima prova della verità politica, cioè nel 1848. I
rappresentanti della vecchia Prussia e della nazione tedesca finiscono per far fronte comune
contro la restaurazione dello Stato polacco, e l'esercito prussiano mette in pratica la loro politica
di rifiuto verso i movimenti nazionali-rivoluzionari polacchi. Per la rivoluzione polacca, il
fallimento è totale. A Poznan, dove la "nazionalizzazione" prosegue, i rapporti tra Tedeschi e
Polacchi si sono rovinati definitivamente.
Nel 1848 e 1849, anche l'Italia è scossa da gravi conflitti che culminano nella guerra. Gli
Asburgo che possiedono la Lombardia e il Veneto, e la Confederazione germanica, proprietaria
di alcune regioni del nord, non saprebbero accettare la creazione dello Stato-nazione auspicato
dal movimento nazionale italiano. I conflitti di nazionalità sono inevitabili e culminano in una
guerra tra la monarchia asburgica e l’ Italia. Di fronte ai combattimenti, il movimento nazionalerivoluzionario italiano si unisce con l'esercito senza creare un vero potere centrale e
rappresentativo. La sua azione si iscrive così in un quadro molto diverso dalla situazione negli
altri paesi europei. Il punto di unione dei nazionalisti italiani non è il parlamento ma il campo di
battaglia della guerra contro l'Austria.
18
Non approfondirò questo aspetto, nemmeno i dibattimenti e le lotte di nazionalità tra la
Germania e la Danimarca. Bisognava concludere, nel 1848, la lunga trasformazione dell'impero
nordico in uno Stato-nazione danese? La nazione danese poteva includere nel suo Stato i ducati
di Schleswig e di Holstein, popolati principalmente dai Tedeschi? Queste domande danno il via
a vivaci dissensi in seno ai movimenti rivoluzionari danesi e tedeschi. Scoppia la guerra: il re
della Prussia fa appello all'esercito per far valere le rivendicazioni territoriali della nazione
tedesca verso la Danimarca. Ma le grandi potenze europee intervengono, e la decisione
sanguinosa è aggiornata fino alla guerra dei Ducati, che oppone nel 1864 la Danimarca alla
Prussia.
Alla luce di tutto ciò, la disputa tra il movimento nazionale tedesco e i Paesi Bassi per quanto
riguarda l'appartenenza nazionale del ducato di Limbourg che fa parte della Confederazione
germanica, si svolge senza grandi problemi. Anzi, essa illustra il carattere esplosivo della messa
in pratica del principio di stato-nazione nel XIX secolo: in tutte le regioni i conflitti appaiono
rivendicati da più nazioni. Nemmeno la Norvegia è risparmiata. È governata dal re della Svezia
e, nel 1848, i sostenitori dell'indipendenza alzano il tono verso questo paese. Nel corso di un
secolo segnato dai movimenti nazionalisti e l'emergenza dello stato-nazione, nel 1905 la
Norvegia e la Svezia offrono il solo esempio di una separazione pacifica di due Stati. è la prima
e l’ ultima volta che una tale separazione non è preceduta da una guerra di secessione.
Per i democratici, il bilancio delle rivoluzioni europee del 1848 può sembrare, quindi, molto
negativo. Portata da uno slancio democratico, la primavera dei popoli tanto auspicata diventa un
campo di battaglia sin da quando si affrontano le rivendicazioni territoriali concorrenti. Ma il
quadro sarebbe incompleto se non si evocassero anche molti aspetti positivi.
Nel 1849, il movimento nazionale ungherese tenta di andare incontro alle rivendicazioni delle
altre nazioni. Non si può dire oggi quale sarebbe potuto essere il risultato di questi sforzi: la
vittoria della controrivoluzione li ha annientati. Parimenti la Dieta austriaca, confrontata alle
rivendicazioni di autonomia delle sue nazionalità, cerca di riorganizzare la monarchia secondo
dei principi federativi mantenendo l'unità dello Stato; anche qui la controrivoluzione vittoriosa
ha fatto svanire questi progetti.
Anche il movimento nazionale tedesco fa prova di tanta resistenza. Certo, il Parlamento di
Francoforte si lascia andare a spaventose utopie di potere imperiale. Si immagina l’impero
pangermanico estendersi dal mare del Nord all'Adriatico, dal mar Baltico al mar Nero. Ma il
Parlamento resta misurato nelle sue politiche concrete. Esso deve far fronte a un compito
enorme, una doppia sfida senza precedenti: secessione ed integrazione simultanea da un lato,
democratizzazione forzata dello Stato e della società dall’ altro. Il movimento nazionalrivoluzionario tedesco alla fine decide di rinunciare all'idea della Grande Germania, adottando
così una posizione accettabile per i paesi vicini. Il suo insuccesso scaturisce dal rifiuto dei
principi tedeschi più potenti di ammettere la soluzione auspicata che ritorna a spossessarli dei
loro poteri.
Conclusione
Permettetemi di concludere con un brevissimo bilancio. Nel 1848, la rinascita rivoluzionaria che
attraversa l'Europa ne fa un vasto spazio di comunicazione. Presa di coscienza europea e
riorganizzazione nazionale dei sistemi politici vanno di pari passo. La rivoluzione unisce
l'Europa, ma gli Europei ne traggono esperienze diverse, positive e negative. Il movimento
democratico, poi la controrivoluzione e la ricostruzione nazionale di una gran parte del
continente si inserisce ormai in un contesto europeo. Nel 1848, il movimento nazionalrivoluzionario vede nel suo principio centrale, la nazione, una promessa di democrazia e di
progresso, ma cominciano anche a stagliarsi gli aspetti più oscuri di questo principio:
esclusione, xenofobia, bellicismo. Se la rivoluzione non ha creato questo rovescio della
19
medaglia nazionale, ha sicuramente contribuito a definirlo e a divulgarlo in numerose regioni e
categorie sociali in Europa. Anche questo fa parte dell'eredità della rivoluzione del 1848.
20
Bibliografia
Flaubert, Gustave, “Education sentimentale, Parigi, 1869.
Kolejka, Josef, "Der Slawenkongress in Prag im Juni 1848. Die slawische Variante einer
ôsterreichischen Fôderation" in Rudolf Jaworski and Robert Luft (eds), 1848149 Revolutionen
in Ostmitteleuropa, Oldenbourg, Monaco, 1996.
Langewiesche, Dieter, Republik und Republikaner, Von der historischen Entwertung eines
politischen Begriffes, Stoccarda, 1993.
Lewald, Fanny, Erinnerungen aus dem Jahr 1848, brani pubblicati da Dietrich Schâfer,
Francoforte, 1969.
21
3 - La visione francese del 1848 verso l'Europa
Pierre Barral
Dopo gli sconvolgimenti della Rivoluzione e le conquiste dell'Impero, la Francia è stata
guardata dai suoi vicini come l’ “enfant terrible” dell’ Europa. Dopo il 1815, sotto il monarchia
censuaria, essa si è stabilizzata all'interno, ammansita all'estero. L'esplosione inattesa del 1848
scatena in tutto il paese la volontà di costruire una società di libertà. Questa avventura
febbricitante, instabile, effimera, suscita oggi negli storici una simpatia benevola, sebbene un
po’ sprezzante.
La Seconda Repubblica
Nel corso di un anno ricco di grandissimi avvicendamenti, possiamo cogliere prima di tutto tre
tempi importanti, in cui si affrontano le correnti di opinione, in cui si manifestano le forze
profonde della società, in cui si orienta la politica della nazione. Febbraio è radioso, giugno è
tragico, dicembre è ambiguo.
Nel febbraio 1848, un'insurrezione parigina rovescia la Monarchia di Luglio, nata da un'altra
insurrezione parigina, diciotto anni prima. Questo regime che voleva conciliare l’Ordine e la
Libertà, si è di fatto sclerotizzato nell'immobilismo conservatore detto ironicamente del "giusto
mezzo". Dopo parecchi mesi, il governo diretto dallo storico François Guizot è tormentato da
una campagna di banchetti, in cui l'opposizione reclama senza successo l'allargamento del
diritto di voto censuario ("la riforma elettorale") e l'incompatibilità dell'alta funzione pubblica
con la deputazione ("la riforma parlamentare"). Il divieto del banchetto colossale previsto a
Parigi il 22 febbraio non basta a controllare un'effervescenza disordinata. La guardia nazionale,
milizia cittadina fino ad allora sicura, grida anch’essa “Viva la Riforma!” Alcuni soldati
spaventati sparano sulla folla, la manifestazione si trasforma in sommossa. Le dimissioni di
Guizot non riporta la calma, i tentativi dei suoi rivali Molé e Thiers falliscono. La città si
riempie di barricate e il maresciallo Bugeaud, nominato comandante delle truppe, non domina
più la situazione. Il re Luigi Filippo sconvolto abdica la mattina del 24, un programma di
reggenza a nome di suo nipote è annullato .Si insedia un governo provvisorio al quale, come nel
1830, la provincia aderisce docilmente.
Si apre così una primavera di "illusione lirica" è stato detto, di ottimismo generoso e di
sensibilità romantica, in cui i francesi si abbandonano al loro gusto dell’ assoluto. La
Repubblica, proclamata a immagine di quella del 1792, si vuole questa volta esente dal sangue
del Terrore: abolisce la pena di morte in materia politica. Il suffragio universale al quale
sognavano soltanto alcuni esaltati, è adottato in uno slancio unanime. Nonostante sia limitato
agli uomini, come sembra allora andare da sé, porta di colpo il numero degli elettori da 250 000
a nove milioni. Un salto di grandissima portata , mentre il liberismo britannico realizzerà questa
riforma in quattro tappe, dal 1832 al 1918. In una nota pagina, Alexis de Tocqueville ha
descritto il corteo dei cittadini verso il luogo del voto"secondo l'ordine alfabetico: io volli
camminare nella fila che mi assegnava il mio nome, perché sapevo che in tutti i paesi e i tempi
democratici, bisogna farsi mettere a capo del popolo e non mettersi da soli". Si insedia la
Costituente e una commissione esecutiva sostituisce il governo provvisorio. Le libertà pubbliche
si esercitano senza ostacoli, i giornali si moltiplicano, i club discutono animatamente. E la
schiavitù è abolita nelle colonie (quindici anni dopo la monarchia britannica).
La nuova Repubblica vuole essere anche sociale e l'operaio Albert (un meccanico) occupa un
seggio simbolico a lato dei borghesi che compongono il governo provvisorio. Se rifiuta la
bandiera rossa, come segno del disordine, “egli si impegna a garantire l'esistenza dell'operaio
per il lavoro". Ma come mettere in pratica "l'organizzazione del lavoro", secondo uno slogan
alla moda? I nuclei che si riferiscono al "socialismo" non costituiscono ancora un vero partito e
il loro programma è la conseguenza della costruzione di un'utopia. In mancanza di un Ministero
22
del Progresso, proposto da alcuni impazienti, viene insediata al palazzo del Lussemburgo, al
posto dei pari di Francia, una commissione di operai delegati per studiare delle soluzioni. Ma
ciò non basta a placare gli animi. Mentre fermentano qua e là agitazioni agrarie e forestali, le
manifestazioni parigine si succedono con crescente turbolenza: il 17 marzo ancora
pacificamente, il 16 aprile sotto il controllo della guardia nazionale, il 15 maggio con
un'invasione temporanea dell'assemblea.
In giugno, il fuoco che cova infiamma la capitale, quando, sotto la pressione dei deputati, la
commissione esecutiva se la prende con lo sviluppo disordinato dei Gruppi di lavoro nazionali.
La Francia vive da due anni una grave crisi economica che combina, diceva il mio maestro
Ernesto Labrousse, una crisi agraria di vecchio tipo e una crisi industriale di nuovo tipo. I
disoccupati sono numerosi e non usufruiscono di nessuna assicurazione. Per venir loro incontro,
sono stati aperti dei cantieri di lavori pubblici, ma i loro effettivi aumentano e la loro gestione
non è sufficiente. Louis Girard li definisce giustamente come "un insieme di cassa di
disoccupazione e di laboratorio di carità". Con l'intenzione di correggere gli abusi, un'ordinanza
ministeriale invita il 21 giugno i più giovani beneficiari ad arruolarsi nell'esercito o a partire in
provincia. Questa prima decisione è intesa come una provocazione per gli operai, disoccupati e
non, che insorgono in massa. Insurrezione spontanea, senza capi, senza programma, spinta alla
violenza dalla disperazione. Un conciliatore di buona volontà si fa dire sulle barricate: "Ah,
signor Arago, voi non avete mai avuto fame"!
La commissione esecutiva affida la missione di ristabilire l'ordine al generale Cavaignac,
ministro della Guerra. È "un militare di sinistra" (un esemplare più frequente in Francia che in
Europa centrale): il figlio di un Convenzionale del 93, il fratello di un militante repubblicano
scomparso prematuramente, ma anche un ufficiale di carriera che si è distinto nella conquista
dell'Algeria. Dispone di una guarnigione rinforzata, della guardia nazionale dei quartieri
borghesi e di volontari di provincia e riconquista con le armi i quartieri popolari della zona est
di Parigi. Questa battaglia di quattro giorni (23-26 giugno) impegna sia da una parte che dall’
altra da quaranta a cinquantamila uomini; provoca 1 600 morti nel campo governativo (mentre
in febbraio il numero delle vittime non superava alcune decine).
È il secondo tempo forte dell'anno che infrange nel sangue l'unità morale della nazione. I
proprietari, repubblicani o monarchici, vi vedono con Tocqueville, aristocratico liberale, "un
combattimento di classe, una guerra servile" che "non ebbe per scopo di cambiare la forma di
governo, ma di alterare l'ordine della società". Gli operai, che siano o no socialisti, hanno l’
impressione di essere abbandonati nella disgrazia e schiacciati dalla repressione. La romanziera
George Sand mormora con emozione: "Non credo più nell'esistenza di una Repubblica che
comincia con l’uccidere i suoi proletari."
La Costituzione dibattuta durante l'estate mette in atto i principi dei repubblicani moderati
maggioritari nell'assemblea. Le uniche Repubbliche che esistono allora, la Confederazione
elvetica e gli Stati Uniti d’America, sono degli Stati federali. Nella Francia "una e indivisibile",
le timide proposte di decentramento sono scartate, come ha mostrato la tesi documentata del
nostro amico Rainer Riemenschneider (Dezentralisation und Regionalismus in, Frankreich um
die Mitte des19. Jahrhunderts, Bonn, 1985). Una rigorosa separazione dei poteri è istituita tra il
legislativo, esercitato da un'assemblea unica, e l'esecutivo, affidato al Presidente della
Repubblica. La scelta di quest’ultimo è affidata al suffragio universale, dopo una famosa
controversia, dove l'appassionato Lamartine prevale sul pacato Grévy. Il posto sembra destinato
al generale Cavaignac che assume da giugno una dittatura di fatto con un saggio legalismo.
Tuttavia le correnti di destra, inibite in primavera, si sono riprese progressivamente. In Francia,
non sono in grado di riprendere il potere con la forza (come in Austria o in Prussia) perché
l'esercito serve lealmente la Repubblica, tanto per disciplina quanto per convinzione. D’altra parte,
si sono divisi tra legittimisti, fedeli ai Borboni del ramo primogenito, e orleanisti che hanno
sostenuto il regime di Luglio. Se questa scissione esclude una restaurazione monarchica, i
dirigenti giocano il gioco parlamentare e si ritrovano nel " partito dell’Ordine", "la via di Poitiers",
23
dal programma conservatore. Ma chi proporre per la presidenza? I nomi che sono avanzati
suscitano le obiezioni degli uni e degli altri.
Una nuova stella spunta allora all’orizzonte: il principe Luigi Napoleone. Questo nipote del
grande Imperatore ha tentato poco tempo prima due colpi di stato che sono stati un fallimento.
Riunisce intorno a sé un modesto nucleo bonapartista, alcuni ufficiali in pensione e alcuni
avventurieri. Nutrendo idee vagamente progressiste, fa delle “avances” agli uomini di ordine.
Molti di questi immaginano che potranno manovrarlo e si schierano per la sua candidatura
presidenziale. Il 10 dicembre 1848, è il terzo tempo importante. Un fallimento cocente per i
concorrenti: 1500 000 voti per Cavaignac, 370 000 per Ledru Rollin, l'uomo dei repubblicani
radicali, 17 000 appena per Lamartine, ora stanco. Un trionfo per il principe: 5 500 000 voti.
Trionfo eccezionale nella lunga storia delle elezioni francesi (l’unico equivalente è il nostro
recentissimo secondo turno del 2002! ). L'accordo degli stati maggiori è stato ratificato da
un'adesione di massa alla quale ha contribuito certamente la trasfigurazione della leggenda
napoleonica.
La Fratellanza dei Popoli
Se la politica interna è oscillante e agitata, i francesi del 1848 sono anche attenti ai movimenti
nazionali che sollevano parallelamente i popoli vicini e che possono anche rivendicare il
primato in Polonia o in Italia. Dai monarchici, scrive l'ex ministro Rémusat, "questa improvvisa
agitazione di tutta l'Europa ci toccò solo come una garanzia del mantenimento della pace". I
repubblicani, in compenso, non limitano all’Esagono la loro esaltazione della libertà. Aspirano a
vedere le altre nazioni emanciparsi anche loro dai loro regimi reazionari.
Victor Hugo, poeta già illustre, vibra di fervore il 2 marzo 1848, quando viene piantato davanti
al suo domicilio parigino in places des Vosges un albero della Libertà: "Siamo tutti degli uomini
di buona volontà, non risparmiamo né la nostra pena né le nostre fatiche. Spargiamo sul mondo
che ci circonda, e da qui sul mondo intero, la simpatia, la carità, la fratellanza".
Il tono è più rivoluzionario e più bellicoso nel popolare Canto dei soldati, composto da Pierre
Dupont,:
“Le Repubbliche nostre vicine
Della Francia invocano il nome
Che le Alpi siano delle colline
Per i cavalli ed i cannoni.
Alle armi, corriamo alle frontiere!
Che si mettano davanti ai nostri fucili
Gli oppressori di ogni paese
I petti dei Radeski!
I popoli sono per noi dei fratelli
E i tiranni dei nemici.”
Questi slanci generosi, rileva Maurice Agulhon, non escludono gesti xenofobi contro degli
operai belgi a Douai, contro degli operai italiani a Marsiglia. Le colonie straniere sono molto
numerose nelle grandi città che sono sempre state in Francia dei focolai di immigrazione. Nella
primavera del 1848, l'effervescenza generale li assale e la passione politica, aumentata dalla
crisi economica, suscita delle spedizioni avventurose verso il paese di origine. Il 25 marzo, dei
gruppi belgi superano la frontiera del nord, sono fermati facilmente dalla gendarmeria, nella
frazione di Rischiamo tutto, dal nome predestinato. Il 30 marzo, dei Savoiardi, appoggiati da
militanti lionesi, occupano velocemente Chambéry che appartiene ancora al regno di PiemonteSardegna. Una legione tedesca, costituita da operai che lavorano a Parigi e da simpatizzanti
polacchi, in aprile penetra già attraverso Strasburgo nel grande ducato di Bade insorto. La sua
azione tardiva e disordinata, mal condotta dal poeta Georg Herwegh, non impedire l'insuccesso
della sommossa. Mai la scintilla gettata dalla Francia provoca l'incendio. Se l'esempio parigino
24
incoraggia i rivoluzionari dell’ Europa centrale, la loro azione che ha un grande sviluppo, è
pienamente autonoma.
I Francesi del 1848 portano la più viva simpatia alla causa della "Polonia martire". Questa si
basa sul ricordo di un'alleanza ancestrale, sull'indignazione di vedere una nazione divisa tra tre
Imperi avidi, sulla partecipazione di volontari durante la Rivoluzione e l'Impero. Più
recentemente, l'opinione francese ha sostenuto con i suoi auspici l'insurrezione del novembre
1830 a Varsavia. Dopo il suo annientamento, sono accorse alcune migliaia di ufficiali patrioti.
Mentre, per precauzione, queste schiere turbolente venivano confinate in provincia, la società
della capitale ha fatto festa ai grandi nomi: al principe Czartoryski, al musicista Chopin, al poeta
Mickiewicz. Nell'aprile 1848, l'argomento ritorna in auge, quando Berlino rifiuta l'autonomia al
granducato di Posen. Un club parigino lancia una petizione in favore dell’ "eroica e sfortunata
nazione", che si recherà in massa all'Assemblea, il 15 maggio. Se è piuttosto un pretesto che una
rivendicazione, la scelta del tema è significativa "Il nome altisonante della Polonia, commenta
Pierre del Gorce, era d’altronde azzeccato per portare in strada questa folla innocua e idiota che,
in tutte le sommosse, copre i provocatori e paralizza la repressione."
Si segue parimenti con favore il movimento liberale e unitario negli Stati italiani, lo slancio di
emancipazione dei Cechi in Boemia e, meno unanimemente, la lotta degli Ungheresi per
restaurare la loro indipendenza. Ascoltiamo di nuovo Pierre Dupont, che fa appello alla
solidarietà contro i sovrani dell’ Ancien Régime,
"Da Pest a Roma le tappe
Sarebbero dei roghi di martiri.
I cosacchi, orrendi satrapi,
Sazierebbero i loro desideri. [...]
Soldati, fermiamo questa orda! [...
Cannoni, con le vostre bocche giganti
Respingete la marcia dello Zar! ".
Quanto alla Rivoluzione tedesca, la sua approvazione di principio si sfuma di perplessità e di
apprensione. I francesi non hanno dimenticato lo scontro passionale delle opinioni durante la
crisi internazionale del 1840, e il dialogo dei canti composti allora sul tema del "Reno tedesco",
o francese? Si preoccupano, nota Rainer Riemenschneider, di dichiarazioni sentite alla
Paulskirche sulla cultura germanica dell'Alsazia. "L'alsaziano", afferma il 18 ottobre Charles
Dupin, personaggio in vista, "prenderebbe le armi contro la Dieta di Francoforte, se questa dieta
gli dicesse che deve essere tedesco di fatto, per il diritto del suo dialetto". In un'ottica globale,
Jules Dufaure che farà una bella carriera ministeriale, invita i deputati dell’Assemblea
costituente a tenere ampiamente conto di questo dato "che un grande paese alle nostre porte si
sforza di costituire uno Stato di 50 milioni di uomini."
Davanti a questa fermentazione dei popoli, i nuovi dirigenti di Parigi conservano del resto il
sangue freddo. In seno al governo provvisorio, Lamartine che possiede solo una notorietà
europea, ha ricevuto la responsabilità degli Affari Esteri. In una circolare agli ambasciatori,
scrive il 4 marzo: "Se l'ora della ricostruzione di alcune nazioni oppresse in Europa, o altrove, ci
sembrasse essere suonata nei decreti della Provvidenza", se negli Stati dell'Italia "si contestasse
a mano armata il diritto di allearsi tra di loro per consolidare una patria italiana, la Repubblica
francese crederebbe di avere il diritto di armare lei stessa per proteggere questi movimenti
legittimi di crescita e di nazionalità dei popoli". Slancio retorico, subito completato per
allontanare ogni sospetto di messianismo rivoluzionario: la Repubblica ” non farà affatto
propaganda sorda o incendiaria presso i suoi vicini. Sa che le libertà durature sono solo quelle
che nascono da sole sul proprio suolo". Rémusat, un uomo del regime precedente, commenta
con malizia. Lamartine "copriva con un fragore di eloquenza umanitaria una politica prudente e
pacifica. Egli era la poesia di cui Guizot era la prosa".
25
Sotto la risonanza di queste belle frasi, il comportamento concreto è molto trattenuto. In favore
dei Polacchi di Posnania, Lamartine si accontenta di un intervento discreto a Berlino che delude
gli spiriti focosi. Manda a Francoforte solo un rappresentante ufficioso, in missione di
osservazione. Il suo fedele Jules Bastide, giornalista giacobino serio e scialbo, deplora da parte
sua "il potere temibile" del Reich che prende forma e "lo spirito di invasione che si manifesta in
Germania". Contrario all'unione del regno lombardo-veneto al Piemonte-Sardegna, preferirebbe
nella penisola "una confederazione di Stati sovrani" alla " formazione di una monarchia
italiana". Il principe Luigi Napoleone certo non ha dimenticato il suo passato da militante
carbonaro a Modena, ma all'inizio del suo mandato non è ancora abbastanza forte per imporre le
sue vedute ai suoi ministri conservatori.
Tra questi ministri, il prudente Tocqueville, brevemente incaricato agli Affari Esteri nell'estate
1849, fa sue le due massime " rompere senza riserve col partito rivoluzionario ", ma "senza mai
entrare nelle passioni dei vecchi poteri". Resta passivo davanti al fallimento della democrazia
unitaria in Germania come davanti all’ annientamento dei sostenitori dell'indipendenza in
Ungheria. In Italia, tenta in buona fede una mediazione pacifica tra i campi opposti. Con questo
intento, un corpo di spedizione è stato mandato a Roma, dove i repubblicani trascinati da
Mazzini hanno rovesciato il potere temporale del Papa. Ma, sotto la pressione dei cattolici, il
corpo di spedizione lo ristabilisce finalmente con le armi, contro la volontà del ministro, e la
protesta indignata della sinistra francese resta assolutamente vana.
La visione francese dell'Europa
La Repubblica francese si ravviva nel quadro dell’ ordine internazionale che caratterizza
l'epoca. Per l'espansione oltremare, quello è un momento di pausa, tra le spinte imperialistiche
del 1760 e del 1880. L'attenzione dei poteri si concentra sul vecchio continente. Esiste un
sistema diplomatico, che viene qualificato correntemente come "concerto europeo". Alla caduta
di Napoleone, i sovrani di Russia, Austria e Prussia hanno firmato un proclama di ordine
ideologico, "la Santa Alleanza"; soprattutto, hanno preso l'impegno di solidarietà che proponeva
loro il governo della Gran Bretagna, il 20 novembre 1815. All’inizio posta sotto sorveglianza, la
Francia monarchica è stata ammessa successivamente in questo direttorio supremo. Per tre
decenni, si sono sviluppate rivalità e si sono manifestati disaccordi: così tra Parigi e Londra a
proposito dei matrimoni nella famiglia reale della Spagna. Domina tuttavia la volontà di
mantenere lo status quo dell'equilibrio. Il perno di questo orientamento conservatore è il vecchio
cancelliere austriaco Metternich che resta al suo posto fino all'insurrezione viennese del 15
marzo 1848.
Prendendo le sue funzioni, Lamartine cerca al tempo stesso di soddisfare l'amor proprio
nazionale e di rassicurare i paesi stranieri. Nelle sue istruzioni agli ambasciatori, tenta con
acutezza di conciliare i contrari. Da una parte, "i trattati del 1815 non esistono più di diritto agli
occhi della Repubblica francese". Dall’altra parte, "tuttavia le circoscrizioni territoriali di questi
trattati sono un fatto che ammette come base e come punto di partenza nei suoi rapporti con le
altre nazioni". Così "i trattati del 1815 esistono solo come fatti per modificare un accordo
comune". dandosi per "missione di arrivare regolarmente e pacificamente a queste modifiche",
la Repubblica francese, insiste Lamartine, desidera "entrare nella famiglia dei governi istituiti
come una potenza regolare, e non come un fenomeno perturbatore dell'ordine europeo".
Dichiarazioni credibili, poiché pronunciate, nota Rémusat, da un ministro "poco sensibile alla
gloria militare, ostile ai ricordi dell'Impero e i cui modi e tono non potevano scagliarsi contro la
diplomazia straniera". Ora, "ciò conveniva al temperamento dell'assemblea che non era affatto
bellicosa e che, in tutte le sue parti, anche sulle altezze della Montagna [a sinistra], si
interessava poco alla politica estera". Questo perché in fondo "lo spirito di propaganda bellicosa
che aveva così tanto agitato il popolo del 1830 si era molto raffreddato nel popolo del 1848."
Ciò non cambia col potere personale di Cavaignac. Per Rémusat, "all'estero, dove né la
necessità, né il dovere, né l'opinione gli chiedeva cosa fosse, non fece niente, o così poca cosa
che si può dire che non avesse politica estera". E al Quai d’Orsay, Tocqueville si fisserà per
26
obiettivo "di non aspirare, in una parola, al posto che avevamo potuto occupare in altre epoche e
che lo stato attuale del mondo non ci permetteva più di tenere, ma di occupare fieramente il
posto che ci restava ancora."
L'opinione pubblica è molto più vibrante. Ai suoi occhi, l'emancipazione delle nazioni, che
spera di vedere realizzarsi, metterà fine alle guerre, che si attribuisce ben schematicamente ai
soli appetiti dei monarchi. La democrazia, si vuole credere, introdurrà uno spirito nuovo nelle
relazioni internazionali. Il 21 agosto 1849, Victor Hugo apre così un Congresso della Pace:
"Gentili Signori, esclama con eloquenza, questo pensiero religioso, la pace universale, tutte le
nazioni legate tra loro da un legame comune, il Vangelo per legge suprema, la mediazione
sostituita alla guerra, questo pensiero religioso è un pensiero pratico, questa idea santa è un'idea
realizzabile"?. "Io, rispondo con voi, rispondo senza esitare: Sì! ". "E Francesi, Inglesi, Belgi,
Tedeschi, Russi, Slavi, Europei, Americani, che cosa dobbiamo fare per arrivare il più presto
possibile a questo grande giorno? Amarci."
Il poeta si entusiasma sul progresso tecnico: “Come svaniscono le cause della guerra con le
cause della sofferenza! Come si toccano popoli lontani! Come si accorciano le distanze! E
l’avvicinamento, è l’inizio della fratellanza!” Speranza idilliaca sicuramente, illusione di cui la
storia del XX secolo svelerà l’ingenuità: i conflitti scatenati dal nazionalismo dei popoli
verseranno molto più sangue delle piccole guerre dei re dell’ Ancien Régime.
In questo slancio, Victor Hugo propone una visione profetica del destino dell'Europa.
All'Assemblea legislativa, il 17 luglio 1851, egli profetizza: "Il popolo francese ha tagliato in un
granito indistruttibile e posato proprio nel mezzo del vecchio continente monarchico la prima
base di questo immenso edificio dell'avvenire che si chiamerà un giorno gli Stati Uniti
d'Europa"! La formula, calcata sul modello americano, denota dell’ utopia sognata più che della
politica concreta. Secondo il processo verbale dei dibattimenti, suscita un gran "Movimento" nel
pubblico e "una lunga risata a destra."
Questo non è che uno slogan vuoto. In esilio, in un banchetto del mese di febbraio 1855, il suo
autore preciserà la filosofia che lo ispira: "Il continente sarebbe un solo popolo; le nazionalità
vivrebbero della loro vita propria nella vita comune: l'Italia apparterrebbe all'Italia, la Polonia
apparterrebbe alla Polonia, l'Ungheria apparterrebbe all'Ungheria, [rileviamo la scelta degli
esempi, rivelatori delle sue simpatie] la Francia apparterrebbe all'Europa, l'Europa apparterrebbe
all’Umanità". Ormai, "poiché il gruppo europeo non è che una nazione, la Germania starebbe
alla Francia, la Francia starebbe all’Italia ciò che oggi la Normandia è alla Picardia e la Picardia
alla Lorena". Conclusione ottimista: "non più guerra, di conseguenza non più esercito". Perché
non si considera assolutamente che i pericoli potrebbero venire ancora dall’estero.
Il quadro di questa futura Europa, abbozzato a grandi tratti, contiene un'audace predizione, che
noi vediamo realizzarsi dopo centocinquant'anni. Nel quadro continentale, "i fiumi liberi, gli
stretti liberi, gli oceani liberi". Sul piano economico, "non più frontiere, non più dogane, non più
imposte, il libero scambio". Anche "una moneta continentale, a doppia base metallica e
fiduciaria, che ha per punto di appoggio il capitale Europa tutto intero e per motore l'attività
libera di duecento milioni di uomini". Sul piano politico, "l'Assemblea degli Stati Uniti
d’Europa uscita dal suffragio universale di tutti i popoli del continente". è indicato che regolerà
"tutte le questioni dell'Umanità", perché il profeta non ha previsto affatto la preponderanza a
venire dall'America e dalla Russia. Fin dal 1835 il suo contemporaneo Tocqueville vedeva
invece questi due popoli chiamati "da un decreto segreto della Provvidenza a tenere un giorno
nelle sue mani i destini della metà del mondo": l’uno ha per principale mezzo di azione la
libertà, l'altro la schiavitù."
L'Europa di Victor Hugo, aggiungiamolo, fisserà la sua capitale a Parigi. Fin dal 2 marzo 1848,
dichiarava senza nessuno complesso: "Da tre secoli, la Francia è la prima delle nazioni". "
Amici miei, fratelli miei, cari concittadini, instauriamo nel mondo intero, attraverso la
grandezza dei nostri esempi, l'impero delle nostre idee. Che ogni nazione sia felice e fiera di
27
somigliare alla Francia". "La Grande nazione", come si qualificava lei stessa nel 1792, si
considera come un modello. Se non pensa più certamente a un'espansione conquistatrice con le
armi, crede sempre con arroganza alla sua superiorità sulle altre nazioni nel campo della lingua,
della cultura, delle idee. Con Maurice Agulhon, il migliore esperto del periodo, riconosciamo
semplicemente "che lo spirito quarantottino, in questo campo, copriva di una formulazione
umanitaria la perpetuazione del nazionalismo francese suscitato in reazione ai trattati del 1815."
28
Riferimenti e selezione bibliografica
Agulhon, Maurice, 1848 ou l'apprentissage de la République, Seuil, 1972.
Agulhon, Maurice, Les Quarante-huitards, Julliard, 1975.
De La Screpolo, Pierre, Histoire de la Seconde République française, Plon, 1886.
De Remusat, Charles, Mémoires de ma vie, Plon, Vol. IV, 1962.
De Tocqueville, Alexis, Souvenirs (Opere complete, Vol. XII, 1964.
Girard, Louis, La II République, Calmann Lévy, 1968,.
Pena Ruiz, Henri, e Scot, Jean Paul, Un poète en politique. Les combats de Victor Hugo,
Flammarion, 2002.
Pouthas, C., Démocratie, réaction, capitalisme, PUF, 1983,.
Renouvin, Pierre, Histoire des relations internationals, Hachette, Vol. V, 1954, pp. 193-218.
Riemenschneider, Rainer, Dezentralisation und Regionalismus in Frankreich um: die Mitte des
19. Jahrhunderts, Bonn, 1985.
Vigier, Philippe, La vie quotidienne en province et à Paris pendant lesjournées de 1848,
Hachette 1982.
29
4- La Germania e la Monarchia degli Asburgo 1848-1849
Wolfram Siemann
Il presente articolo tratta la questione della Germania e della monarchia degli Asburgo sotto
quattro angolature diverse. Esso esamina innanzitutto in quale misura le relazioni della
Germania e della monarchia degli Asburgo hanno presentato nel momento della Rivoluzione
europea del 1848-49 un carattere particolare e difficile; successivamente si interroga sulla
partecipazione della monarchia asburgica allo slancio nazionale in Germania e in Europa
centrale; la terza parte tratta dell'insuccesso della Rivoluzione, mentre il quarto ed ultimo punto
si sforza di procedere ad una classificazione storica, portando un'attenzione particolare al ruolo
della monarchia degli Asburgo.
I rapporti della Germania con la Monarchia degli Asburgo 1848-1849
Lo storico praghese Jiřï Kofalka, autore dell'opera monumentale Die Habsburgermonarchie, (
La monarchia degli Asburgo), tratta dell'Impero in seno al sistema delle relazioni internazionali
nel tomo intitolato Deutschland und die Habsburgermonarchie 1848-1918 ( La Germania e la
Monarchia degli Asburgo dal 1848 al 1918, Kořalka, 1993 ed.). La formulazione stessa del
titolo pone già problemi in sé, perché lascia supporre che "la Germania" e la monarchia degli
Asburgo formavano due entità distinte i cui rapporti si situano sul piano delle relazioni
internazionali. Ecco che non manca di sorprendere, perché la monarchia asburgica faceva parte
fino al 1866 , per una parte importante dei suoi territori, della Confederazione germanica di cui
assicurava la presidenza in seno ai trentotto Stati tedeschi della Dieta di Francoforte. Lo storico
viennese Heinrich Lutz pone il problema in un' altra maniera, intitolando il suo studio generale
del XIX secolo Zwischen Habsburg und Preuβen Deutschland 1815-1866 (Tra Asburgo e
Prussia - La Germania dal 1815 al 1866, Lutz 1985). Non sarebbe stato più logico preferirgli il
titolo "Tra Austria e Prussia"?. E che cosa si intente per "la Germania"?. Si pone davvero " tra
Asburgo e Prussia?"
Questo dilemma non è nuovo; i contemporanei della Rivoluzione del 1848 ne avevano
particolarmente coscienza. Franz Grillparzer scrive così il 18 aprile 1848 nel suo giornale
viennese: "Questi cari Austriaci! Ecco che riflettono sul modo di unirsi alla Germania, senza
unirsi alla Germania! Questo progetto sarà molto difficile da realizzare, tanto difficile come per
due persone volersi abbracciare girandosi la schiena"! , citato da Siemann, in Haider e Hye,
2003.
Kořalka lo descrive come "il dilemma esistenziale dell'Austria riguardo alla questione tedesca"
che si è delineata al momento della Rivoluzione del 1848; è in effetti in questo momento che si
è posta, non più unicamente sotto forma di riflessione teorica di cui era oggetto prima delle
giornate di marzo 1848, ma nella pratica politica della rivoluzione civile, la domanda di sapere
"se, e se sì in quale misura, l'Austria era parte costituente della Germania". Si trattava difatti
solo di determinare "se conveniva mantenere, dividere o distruggere lo stato imperiale degli
Asburgo" (Kořalka, op. cit. p. 4).
Una caricatura pubblicata dal quotidiano democratico Reichstags-Zeitung scinde l'aquila
imperiale bicefala, sormontata da una corona imperiale sospesa, in due parti che rappresentano
la Prussia e l'Austria; la prima incarna Heinrich von Gagern, Presidente dell'Assemblea
nazionale di Francoforte, e la seconda si presenta sotto i tratti di Anton Ritter von Schmerling,
Primo, ministro imperiale. Essi appaiono come due siamesi che si girano la schiena,
indissolubilmente legati l’uno all'altro. Ci piacerebbe credere che Grillparzer abbia preso
conoscenza di questa litografia. L'allusione fatta dalla legenda scritta sotto la caricatura, "Oreste
e Pilade", era comprensibile solo da un lettore studioso di lettere classiche: essa significava
difatti che, come Oreste aveva assassinato la propria madre con l'aiuto di Pilade, Gagern
metteva fine alla speranza di una Germania democratica col sostegno di Schmerling.
30
La Rivoluzione del 1848-49 segnò l'inizio dell'era degli Stati-nazione in Europa centrale. Per le
nazioni che componevano gli insiemi di poteri sovranazionali ( in Prussia, nella monarchia degli
Asburgo e nella Russia zarista), l'obiettivo era obbligatoriamente di vedere i fuoriusciti della
loro nazione riuniti in uno Stato sovrano, dotato di una costituzione moderna elaborata sul
modello dell'Europa occidentale. Oltre i Tedeschi, questa ambizione animava in particolare i
Polacchi, gli Ungheresi e gli Italiani. I Cechi, gli Slovacchi, gli Sloveni, i Croati e i Ruteni
rimanevano per il momento disposti ad accontentarsi di un'autonomia posta sotto la sovranità
degli Asburgo. I Cechi e gli Italiani del Sud-Tirolo avrebbero d’altronde dovuto partecipare alla
formazione di uno Stato nazionale a Francoforte, in virtù della loro appartenenza ancestrale alla
Confederazione germanica; ma essi gli opposero un rifiuto categorico.
Il dilemma tra una forma di Stato sovranazionale e un orientamento nazionale esisteva
dall'adozione dell’ "atto costitutivo della Confederazione germanica", all'epoca del Congresso di
Vienna l’ 8 giugno 1815. Nel suo preambolo, "i principi sovrani e le città libere della
Germania" sono d’accordo sull’obiettivo confederale comune di concludere un'alleanza solida e
duratura "per la sicurezza e l'indipendenza della Germania, così come la pace e l'equilibrio
dell'Europa" e di voler stabilire tra essi "una confederazione continua" (Huber, 1978, p. 84M. La
Confederazione germanica e la monarchia degli Asburgo si consideravano insieme come una
costruzione prenazionale, una sorta di corpo ereditario generato dal Sacro-Impero romano
germanico. Quest’ultimo rappresentava un agglomerato di territori sovrani, diretti da principi e
patriziati municipali poco preoccupati delle particolarità nazionali. Se si sovrappone la
superficie territoriale che presentava il Sacro-Impero fino al 1806 ai confini della
Confederazione germanica sancita nel 1815, si può constatare che ad eccezione dei Paesi Bassi
belgi e delle minime differenze il tracciato della seconda riprende fedelmente quello del primo.
Ciò spiega perché la Confederazione germanica accoglieva un così grande numero di
nazionalità non tedesche; è anche questo il motivo per il quale la monarchia degli Asburgo era
annessa di diritto pubblico, dalla parte occidentale dell'Impero che inglobava delle popolazioni
di nazionalità italiana, ceca, slovena e croata, alla Confederazione germanica. Questa eredità del
Sacro-Impero spiega nello stesso modo che il Ducato di Schleswig, così come le province
prussiane di Posnania, della Prussia orientale e della Prussia occidentale, non facessero più parte
della Confederazione germanica, sebbene le rivendicazioni in questo senso siano state forti
all’epoca dell'agitazione nazionale del 1848 ed abbiano portato il potere centrale provvisorio
associato alla Prussia, a causa della questione dello Schleswig, alla guerra contro la Danimarca.
Inoltre, la Confederazione germanica non offriva un quadro adeguato a uno Stato- nazione
tedesco unificato sin dal momento in cui non si ricercava un modello federale come quello della
Svizzera, ma un insieme etnico omogeneo.
Il ruolo della Monarchia degli Asburgo nel rinnovamento nazionale in Germania e in
Europa centrale
Tenuto conto della moltitudine di orientamenti statali e nazionali che regnava in Germania, non
è facile comprendere perché il monarchia asburgica ha in un primo momento preso parte
attivamente allo slancio nazionale tedesco o, più precisamente, perché i Tedeschi della
monarchia hanno considerato Francoforte, e non Vienna, come il centro nazionale della sua
rifusione sottoforma di uno Stato costituzionale; perciò è necessario un chiarimento. Da un
punto di vista attuale, è difficile determinare quanto l'impronta delle vecchie strutture, in
particolare quelle della Confederazione germanica, rimanesse viva, malgrado la pressione degli
avvenimenti rivoluzionari. La Costituzione generata dalla rivoluzione riprende le norme della
Confederazione germanica, basandosi sulla sua definizione delle circoscrizioni elettorali e,
naturalmente, sulle regioni tradizionali del territorio confederale. Fu così fino alla fine del
processo costituzionale, poiché l’Assemblea nazionale costituente iscrisse, a dispetto di tutte le
esperienze dell'anno rivoluzionario, nell'articolo primo della "Costituzione dell'impero tedesco"
del 28 marzo 1849: "l’Impero tedesco è costituito dal territorio della vecchia Confederazione
germanica" (Huber, 1978, p. 375).
31
La partecipazione inizialmente attiva della popolazione germanofona della monarchia degli
Asburgo allo slancio nazionale tedesco e ai lavori costituzionali di Francoforte che gli hanno
fatto seguito si spiega per cinque importanti ragioni.
1. Una nuova libertà
L'immagine di un "sistema Metternich" concepito come repressivo per l'insieme della vita
sociale si era imposta, con più o meno forza a seconda del periodo, nello spirito della
popolazione austriaca della Restaurazione e del periodo precedente alle giornate del marzo
1848. Anche se la storiografia più recente considera molto più questa transizione verso i tempi
moderni come un periodo ben più contrastato e complesso di quanto lo si credeva una volta e
sfuma molto il suo giudizio sul cancelliere austriaco, i contemporanei di quest’ ultimo
rappresentavano tuttavia questo sistema come un meccanismo pesante e fisso il cui cedimento
avrebbe dato vita a un'era di libertà e di prosperità. La borghesia illuminata e la nobiltà liberale
avevano forgiato questa immagine, che la stampa libera doveva amplificare verso il popolo.
Questa enorme speranza nell'avvenire, associata alla caduta di Metternich, non aveva
guadagnato le sole popolazioni tedesche della monarchia. Una caricatura ceca ne è la
testimonianza in modo molto netto: si vede Mettemich in fuga, posto su due piccole locomotive,
mentre un volo di corvi che gracchiano rotea sopra alla sua testa e in lontananza si erge un arco
di trionfo sormontato dal gonfalone della Costituzione. La particolarità della Rivoluzione che
infiammò tutta l'Europa fu di propagandare un programma comune essenziale che andava oltre
tutte le particolarità regionali e territoriali, che diffuse con una rapidità incredibile ed uno stesso
obiettivo. Da Mannheim, dove avevano esordito le "rivendicazioni di marzo", aveva guadagnato
non solo gli Stati della Confederazione germanica, ma anche gli ultimi recessi della monarchia
degli Asburgo, come la lontana città moldava di Kronstadt, e richiesto il diritto alla nazionalità,
alla rappresentazione politica incarnata dai parlamenti eletti e ad una Costituzione scritta che
garantisse le libertà pubbliche. La Rivoluzione non si propagò in modo unidimensionale, ma
evolvendosi da Parigi fino al sud della Germania, da Milano e Vienna a Berlino, dalle numerose
città dove aveva sede il potere verso la periferia, poi da quest’ ultima di nuovo verso le capitali,
di modo che mise temporaneamente in piedi una rete di comunicazione che comprendeva tutta
l'Europa . (Vedere, per esempio, Dowe, Haupt e Langewiesche, 1998,; Jaworski e Luft, 1996,; e
Haider e Hye, 2003). Questo movimento trasse la sua forza particolare nel fatto che trovò, al di
là degli strati borghesi della società, un'accoglienza favorevole presso una gran parte dalla
popolazione contadina che associava innanzitutto le sue aspirazioni libertarie all'abolizione delle
corvé, schiavitù e dipendenze eccessive alle quali era sottoposta.
2. La "primavera dei popoli"
Il sentimento di appartenere a un fronte di opposizione comune e di prendere parte a un
gigantesco movimento di liberazione dell' intera Europa fu rafforzato ancora di più quando i
"popoli" presero coscienza della loro identità nazionale e realizzarono che questi erano gli
argomenti della storia. Questa esperienza raggiunse il suo punto culminante con l'utopia della
"Primavera dei Popoli" che dilagò in particolare nelle nazionalità "oppresse" che costituivano i
Polacchi, i Cechi, gli Ungheresi e gli Italiani. La sua rappresentazione immaginosa più celebre è
quella del litografo francese Frédéric Sorrieu. Egli presenta l'utopia dell'amicizia dei popoli in
una serie di incisioni, dove i popoli si uniscono in un ordine mondiale pacifico, una "Repubblica
universale democratica e sociale". La prima tavola è la più conosciuta; essa si intitola "Il patto".
Il corteo lunghissimo dei popoli si avvicina verso la statua della Libertà, simboleggiata da
un'allegoria femminile. Essa tiene nella sua mano sinistra la fiaccola della luce e si appoggia
con la sua mano diritta sulla Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo. I simboli infranti delle
monarchie europee animano il primo piano; il Cristo, incarnazione della fratellanza, sovrasta la
scena. Una "santa alleanza" dei popoli viene a sostituire la Santa Alleanza dei principi.
L'utopia della "Primavera dei Popoli" fu comune in tutta l'Europa e gli storici successivi a
questo periodo non possono far altro che stupirsi che gli attori della Rivoluzione abbiano
32
giudicato, nei primi tempi del movimento, questa fede nel futuro naturalmente compatibile con
l'esistenza della monarchia degli Asburgo. I dirigenti politici e militari della monarchia si resero
invece conto fin dall’ inizio della minaccia fondamentale che rappresentava la Rivoluzione per
il mantenimento dello Stato multinazionale. Quattro esempi attraverso le immagini che
rappresentano diverse nazioni all’inizio della Rivoluzione permettono di constatare che l'enfasi
del movimento di liberazione (contro il vecchio sistema) sembrava includere un'intesa pacifica
tra le nazioni. Queste testimonianze immaginose provengono da Presbourg, Milano, Praga e
Berlino.
Un'illustrazione stilizzata glorifica l'eroe nazionale e poeta ungherese Sándor Petöfi, che
declama a Pest il 15 marzo 1848 la sua poesia "In piedi, Magiari…”Questa litografia
contemporanea è considerata come il punto di partenza dell’ insurrezione nazionale ungherese.
La litografia a colori stampata a Milano, "Il Risorgimento d’ Italia 1848", crede ancora
fermamente in un'associazione compatibile della "risurrezione dell'Italia" con i rappresentanti
del vecchio Regime, poiché l'allegoria dell'Italia, elevata nei cieli dove è in compagnia dei
monarchi che avevano promulgato una Costituzione nei loro Stati, cioè Pio IX, Carlo Alberto di
Piemonte-Sardegna e il granduca di Toscana, Leopoldo d’Asburgo, scaraventa col suo bastone
le truppe austriache negli inferi.
Lo stesso messaggio traspare in una litografia la cui legenda è stampata in tedesco e in ceco,
"Die Slawenmesse am Pfingstmontag in Prag 1848" ( La messa slava del lunedì di Pentecoste a
Praga nel 1848), che, attraverso questa grande manifestazione che riunì il 12 giugno 1848 tutti
gli strati della popolazione, illustra in modo vivace l'atmosfera di partenza, piena di speranza
che si espresse il giorno stesso nella proclamazione del Congresso slavo di Praga. I delegati
convinti della "Primavera dei Popoli" vi presentarono la loro proposta di "trasformare lo stato
imperiale in una Confederazione di nazioni con gli stessi diritti" e di convocare a tal fine un
"Congresso generale europeo dei popoli per il regolamento di tutte le questioni internazionali",
poiché "i popoli liberi si comprendono più facilmente dei diplomatici remunerati."
La preoccupazione di dominare il problema che rappresentava il fatto di poter essere compreso
dalla popolazione grazie all'impiego di diverse lingue è illustrata perfettamente dalla
Proclamazione di Berlino del 3 aprile 1848, che invita a recarsi a una grande riunione
repubblicana" (…) "in onore della grande Rivoluzione europea"; i discorsi si erano infatti tenuti
in tedesco, inglese e francese. Queste dichiarazioni devono essere prese sul serio, come
l'espressione di una volontà annunciata di giungere a un’ intesa pacifica tra le nazioni. Non è
affatto necessario sottolineare che questa utopia della Primavera dei Popoli non rispondeva alla
complessità delle motivazioni contrarie alla Rivoluzione europea. La stampa liberata smascherò,
nel corso dell’anno rivoluzionario, l'utopia irrealistica che si nascondeva dietro a questa pratica
politica e non risparmiò i suoi sarcasmi - motori propizi ad attivare la formazione dei partiti. Le
contraddizioni emersero quando i deputati dei diversi parlamenti si prepararono a creare degli
Stati-nazione e a definire il tracciato delle loro frontiere. Il tracciato delle frontiere significava
tuttavia tanto la guerra quanto le dislocazioni. I Tedeschi e Danesi dello Schleswig, i Polacchi di
Posnania, i Cechi di Boemia e Moravia, gli Ungheresi e gli Italiani dei territori della monarchia
asburgica ne fecero le spese. La gravità con la quale furono descritti i rapporti tra l’ impero
austriaco e la Germania traspaiono anche nelle caricature. Una caricatura viennese prese così
per tema il carattere esplosivo della questione delle nazionalità e la posizione delicata
dell'Austria in seno alla Confederazione germanica. Appariva chiaramente che questa questione
doveva far scoppiare l'unità tedesca: "Calma signori, se si strappasse potreste cadere! ".
3. La possibilità per l’Austria di prendere una via tedesca
La terza spiegazione di questa breve speranza nazionale tedesca posta nella monarchia degli
Asburgo giunge ad una fase particolare, nel corso del quale il grande Stato sembrò smembrarsi e
33
la fortuna di una "via tedesca" per l'Austria sembrò sorridere ai contemporanei. Questa
opportunità si presentò quando il più fedele sostenitore di Metternich, il conte Franz Hartig, si
pronunciò a favore di un ritiro della Lombardia in Italia del Nord; il granduca Giovanni
vi fu
ancora appena disposto nell'ottobre 1848. A ciò si aggiunse il fatto che in estate l'Ungheria
sembrò totalmente persa per la monarchia. Il Primo ministro Wessenberg tenne per probabile la
perdita della Galizia che Franz Stadion, il governatore austriaco di Lemberg, non dichiarò il 6
maggio 1848 di non poter tenere ( per maggiori dettagli cf. Hôbelt, 1998). In questo periodo di
apparente cedimento dell’intera monarchia, sembrò plausibile ai suoi rifugiati tedeschi che
avrebbero preso parte attiva all'opera di unificazione nazionale di Francoforte.
4. Il mito delle barricate
Inoltre, il "mito delle barricate" contribuì a sopravvalutare le forze della Rivoluzione. La quasi
totalità delle immagini di barricate diffuse a Berlino, Vienna, Parigi e Francoforte facevano
credere che esse rappresentavano il modo di resistere alle vecchie forze militari e di vincere
l'esercito tradizionale durante la Rivoluzione. Questo mito delle barricate, andando di pari passo
con le attese delle milizie cittadine, era, per la prima volta sottolineata da Langewiesche, in
Bachofer e Fischer, 1983. Gli unici due dagherrotipi probabilmente conservati delle barricate
del 1848 stabiliscono chiaramente che la realtà era ben più amara di quanto lasciavano intendere
le litografie colorate e stilizzate che ne riproducevano le immagini.
Si scopre così, priva della stilizzazione eroica propria del giornalismo illustrato, una strada
sbarrata da un ammasso di pietre, di mobili e di utensili, che appare, nella seconda immagine,
sgombra al termine dei "combattimenti di giugno".
5. Elezioni
Infine, le prime elezioni generali tedesche sul suolo della Confederazione germanica e la
designazione del granduca Giovanni d'Austria come "vicario d’Impero" il 29 giugno 1848 non
spinse immediatamente gli Austriaci a manifestazioni traboccanti di favore della loro
partecipazione a un processo di costituzione di uno Stato tedesco comune. Conviene tuttavia
osservare a questo proposito che il granduca Giovanni era stato nominato poco tempo prima, il
16 giugno 1848, rappresentante dell'Imperatore. In un certo modo, malgrado le proteste levate
dai democratici e in particolare i prussiani nella chiesa di San Paolo, questi avvenimenti
apparvero così come un’ anticipazione della forma futura di un Impero tedesco che avrebbe
inglobato l'Austria.
Una litografia anonima restituisce, nello stile affascinante dell'epoca Biedermeier, il sentimento
di concordia che prevaleva nell'estate 1848. Intorno al medaglione del vicario dell’Impero, il
granduca Giovanni, e davanti alle due allegorie femminili della Germania e della Libertà che si
tengono in piedi, si inginocchiano o si inclinano il prete, l'ufficiale, la guardia nazionale, il
soldato, il contadino, il commerciante, l'artigiano e l'operaio, cioè tutti gli strati della
popolazione ad eccezione della sua componente femminile). Sotto l'immagine appare il motto
"Niente più Prussia né Austria, una Germania unita, forte e maestosa, solida come le sue
montagne". Questo insieme doveva essere unito sottoforma di una confederazione di Stato,
dotata di una flotta e di un esercito tedesco, fondata sulla libertà di stampa, la nazione armata e
il diritto di associazione. L'ingresso del vicario dell’Impero a Francoforte l’ 11 luglio 1848 diede
luogo a una festa di unità nazionale conforme alla gioia che faceva nascere il futuro.
Quest’ingresso fu messo in scena riprendendo tutte le forme della tradizionale consacrazione
imperiale, come si svolgeva a Francoforte ai tempi del Sacro Impero romano germanico.
La paralisi della rivoluzione
L'evoluzione della Rivoluzione in tutta l'Europa, i fatti avvenuti a Berlino e Vienna, così come
alla sede del potere centrale provvisorio a Francoforte e in seno ai corpi legislativi, permettono
di comprendere perché il tentativo di consolidare le relazioni germano-austriache su una nuova
34
base costituzionale, alle condizioni fissate dalla Rivoluzione, finisce per fallire. Se si fa
astrazione di tutte le contraddizioni sociali interne che esistevano sul piano materiale, legale e
psicologico e che partecipavano dalla transizione del corporativismo verso un sistema di classi
economiche definite, il fattore cruciale rimane la sottovalutazione del potere degli eserciti che
condusse al fallimento della Rivoluzione europea (Langewiesche, in Dowe, Haupt e
Langewiesche, pp. 915 932). le operazioni militari del 1848-49 si leggono come un indicatore
del consolidamento del potere detenuto dalle vecchie élite aristocratiche.
L'esame della situazione nella sola monarchia asburgica evidenzia un certo numero di date
decisive: il 26 aprile 1848 col bombardamento di Cracovia, il 13 giugno col bombardamento di
Praga da parte di Windischgrätz, il 6 agosto con l'entrata di Radetzky a Milano, il periodo dal 6
ottobre al I° novembre, punto culminante della Rivoluzione a Vienna che crollò sotto il
bombardamento ordinato da Windischgrätz. L’esecuzione di Robert Blum il 9 novembre ebbe
valore simbolico. I contemporanei percepirono fin da quell’ istante che con l'esecuzione di
Blum, non era un semplice rivoluzionario che era caduto: attraverso la sua persona, quella di un
deputato della chiesa di San Paolo che si era esposto, tutta l’opera di unificazione di Francoforte
era stata condannata dall'esercito austriaco. Blum fucilato simboleggiò in modo lampante, il
fallimento della partecipazione della monarchia degli Asburgo ai lavori costituzionali
pangermanici.
Il programma del nuovo Primo ministro Schwarzenberg, presentato il 27 novembre 1848
davanti al Reichstag trasferito nella città morava di Kremsier, proclama senza mezzi termini: "la
grandezza e il rafforzamento della Germania non consistono nella dislocazione né
nell'indebolimento della monarchia. Il mantenimento dell'unità dello Stato dell'Austria è al
tempo stesso una necessità per la Germania e per l'Europa" (Huber, 1978, p. 360. L'Assemblea
nazionale di Francoforte perseverò in un senso, nella sua Costituzione del 28 marzo 1849, a
prendere il contropiede di questa posizione sulla questione precisa della dislocazione della
monarchia; il suo articolo 2 vietava difatti espressamente che un paese tedesco e un paese non
tedesco fossero diretti insieme da uno stesso capo di Stato, sul fondamento di una Costituzione,
di un governo e di un'amministrazione comune.
La monarchia degli Asburgo era ridotta all’ordine di doppio territorio: la sua parte tedesca era
sottomessa alla Costituzione e alla legislazione dell'Impero, mentre le sue parti "non tedesche"
dovevano essere trattate come dei territori a sé stanti.
Tuttavia, quello che nella bocca di Schwarzenberg poteva passare per una "dislocazione della
monarchia" non era affatto una novità, poiché questa posizione era conforme a quella che la
monarchia degli Asburgo aveva adottato in seno alla Confederazione germanica. Anche in
questo quadro era difatti sottoposta alle decisioni confederali solo per quelle dei suoi territori
che facevano parte della Confederazione; del resto l'Impero procedette, in modo intrastatico, ad
un'applicazione più rigorosa del modello definito dall'Assemblea di Francoforte nel 1849,
quando adottò il compromesso austro-ungarico del 1867. Quest’ ultimo diede l’avvio alla
doppia monarchia. Al di là dell'insieme delle azioni individuali, lo Stato e la fedeltà dell'esercito
austriaco, dove si mescolavano le nazionalità, furono decisive per il fallimento della
Rivoluzione. L'esame delle autorità territoriali militari e della ripartizione delle truppe sul
territorio della monarchia in febbraio 1848 mostra chiaramente che ad eccezione del nucleo
ungherese l'esercito era rimasto alla periferia dell'Impero, nelle regioni instabili a causa delle
loro popolazioni non tedesche che rappresentavano la Lombardia e il Veneto, la Boemia, la
Moravie e la Galizia (Kořalka, 1993, vol. 5, p. 204). L'abdicazione dell'imperatore Ferdinando il
2 dicembre e l'avvento del giovane Francesco Giuseppe formavano la chiave di volta di questo
edificio che scivolava ormai verso un neo-assolutismo sostenuto dall'esercito. Il fallimento della
Rivoluzione in seguito alle operazioni militari non costituì affatto un avvenimento
esclusivamente austriaco; riguardò anche l'insieme della Germania, se si tiene conto
dell'intervento delle truppe imperiali che annientarono finalmente i rivoluzionari in Germania
del sud-ovest con l'aiuto di reggimenti prussiani, bavaresi, di Baden, e di Wurtember .. Una
domanda rimane di certo in sospeso: l'esercito austriaco sarebbe riuscito a reprimere la rivolta
35
ungherese col sostegno, in particolar modo, dei reggimenti croati se le truppe russe non fossero
venute in suo soccorso?
L'esclusione crescente dell'Austria
La classificazione storica della Rivoluzione tedesca e austriaca del 1848-49 non saprebbe
beninteso limitarsi all'esame di questi due anni memorabili. È di gran lunga preferibile tener
conto del fatto che, parallelamente al processo di esclusione dell'Austria che raggiunse il suo
punto culminante nel 1866, si sviluppò un processo simile di autoesclusione, nonostante questa
evoluzione in direzioni opposte fosse già in nuce molto prima del 1848. Lo storico americano
Peter J. Katzenstein l'ha messo molto presto in luce (Katzenstein, 1976). Dieter Langewiesche,
particolarmente, ha messo in evidenza, allo studio della Rivoluzione, l'esistenza di tendenze
assopite.
L'esame dell'evoluzione di questo assopimento su un lungo periodo cronologico porta a una
serie di osservazioni. Mentre le riforme intraprese da Giuseppe II si arenavano prematuramente
e lo stato austriaco era in fallimento nel 1811, la Prussia e la Confederazione del Reno
compivano le loro riforme; la monarchia degli Asburgo riuscì a recuperare questo ritardo solo
all'epoca del neoassolutismo. Si tenne così in disparte, e ciò la privò, soprattutto, di
un'educazione politica costituzionale precedente alle giornate di marzo. Quest’ ultima costituì
un fermento politico, ignorato per molto tempo, che legava tra loro i diversi Stati tedeschi,
attraverso il regolamento collettivo dei litigi in seno ai Landtage di opposizione, la vita
parlamentare quotidiana e dei rituali comuni, le cui ripercussioni giungevano fino ai campi
extraparlamentari della società. La Prussia non era sicuramente uno Stato costituzionale nel
senso moderno del termine; ma disponeva di assemblee provinciali molto animate, soprattutto in
Renania, in Westfalia e in Prussia orientale.
La monarchia degli Asburgo si tenne in disparte durante la Rivoluzione di giugno 1830, quando
un nuovo impulso costituzionale si diffuse negli ultimi Stati confederati tedeschi. L’istituzione
dell'unione doganale (Zollverein) senza l'Austria fu già avvertita da Metternich come
un'esclusione "della Germania". L'evoluzione della società della monarchia rimase negli anni
1830 e 1840 lontana dal nazionalismo tedesco organizzato che trovò nei ginnasti, cantanti e
cattolici tedeschi altrettanti sostituti del dibattito pubblico. Nello stesso modo, le élite politiche
austriache dell'opposizione non raggiunsero le reti delle organizzazioni liberali e democratiche,
non solo prima del 1848, ma anche, come ha mostrato Langewiesche, durante l'anno
rivoluzionario (Langewiesche, 1991, p. 763). Le organizzazioni nazionali che erano a capo delle
diverse associazioni stabilite a Francoforte, Berlino o Lipsia, non raggiunsero più in linea di
massima gli Austriaci. La monarchia non fu toccata oltre dalla campagna in favore della
Costituzione dell’Impero nella primavera del 1849 e l'esame del processo di formazione
dell'Assemblea nazionale di Francoforte rivela, ancora una volta, l'esistenza di una tendenza al
ritiro. L'elezione di Federico Guglielmo IV alla dignità imperiale dedica senza ambiguità, alla
luce dell'atteggiamento elettorale dei deputati austriaci, questa separazione. La rottura fu ancora
più evidente al momento dello scioglimento dell'Assemblea nazionale di Francoforte, come
mostra lo studio delle circoscrizioni dei membri del parlamento secondario di Stoccarda e
dell'Assemblea di Gotha ( Best e Weege, 1996, pp. 484 493). I deputati delle circoscrizioni
austriache vi sedevano solo in numero esiguo.
In definitiva, trattandosi della delicata "questione tedesca" nelle condizioni che prevalevano nel
1848-49 ( Gehler e al., 1996) si impone una constatazione, che si riassume innanzitutto con la
seguente formula: "dei partner male assortiti". Aggiungiamo che il successo della costituzione
di una nazione risiede nell’ istituzione di una memoria storica collettiva: essa fonda la sua
leggenda originaria che si impone a tutti, così come il suo "complesso di valori" e il suo
universo simbolico comune in un certo numero di avvenimenti maggiori e di tradizioni.
L'eredità storica che legava l'Austria e la Germania - l'ancestrale tradizione imperiale - non era
più di attualità sotto gli auspici dello Stato-nazione moderno. La nuova tradizione, scaturita
dalla Rivoluzione del 1848-49, trovò tuttavia la sua dimensione, sicuramente differente da
36
quella della "gloriosa" Rivoluzione del 1789, ma proprio a commuovere le folle e a far nascere
l'avventura, nel fallimento: il culto dei morti caduti durante le giornate di marzo e la memoria di
Robert Blum. Il richiamo al 1848-49 conservò tuttavia un tono contrario sui luoghi stessi della
costituzione di una nuova eredità: nella "Piccola Germania" imperiale del 1871, come in
Austria, che ne era stata divisa a partire dal 1866 (Siemann, 1999)
37
Bibliografia
Best, Heinrich, e Wilhehm Weege (ed), Biographisches Handbuch der Abgeordneten der
Frankfurter Nationalversammlung 1848149, Düsseldorf, 1996.
Dowe, Dieter, Heinz-Gerhard Haupt et Dieter Langewiesche (éd), Europa 1848: Revolution und
Reform, Bonn, 1998.
Gehler, Michael, Rainer F. Schmidt, Harm-Hinrich Brandt e Rolf Steininger (ed), Ungleiche
Partner? Österreich und Deutschland in ihrer gegenseitigen Wahrnehmung. Historische
Analysen und Vergleiche aus dem 19. und 20. Jahrhundert, Stoccarda, 1996.
Haider, Barbara, e Hans Peter Hye (ed), 1848: Ereignis und Erinnerung in den politischen
Kulturen Mitteleuropas, Vienna, 2003.
Höbelt, Lothar, 1848. Österreich und die deutsche Revolution, Vienna e Monaco, 1998.
Huber, Ernst Rudolf (ed.), Dokumente zur deutschen Verfassungsgeschichte, Vol. 1, Stoccarda e
al., 1978, p. 84 ff.
Jaworsky, Rudolf, e Robert Luft (ed), 1848149. Revolutionen in Ostmitteleuropa, Monaco,
1996.
Katzenstein, Peter J., Disjoined partners: Austria and Germany since 1815, Berkeley, CA,
1976.
Kořalka, Jiří, Deutschland und die Habsburgermonarchie, 1848-1918, Vol. 6.2 of Die
Habsburgermonarchie, 1848-1918, ed. Adam Wandruszka e Peter Urbanitsch, Vienna, 1993,
pp. 1- 158.
Langewiesche, Dieter, "Die Rolle des Militärs in den europäischen Revolutionen von 1848/49"
in Wolfgang Bachofer et Holger Fischer (ed), Ungarn - Deutschland. Studien zu Sprache,
Kultur, Geographie und Geschichte, Monaco, 1983, pp. 273-288.
Langewiesche, Dieter, "Deutschland und Österreich: Nationswerdung und Staatsbildung in
Mitteleuropa ira 19. Jahrhundert”in Geschichte in Wissenschaft und UnTerricht, No. 42,1991,
pp. 754-66.
Lutz, Heinrich, Zwischen Habsburg und Preuβen: Deutschland 1815-1866, Berlino, 1985.
Siernann, Wolfram, "Der Streit der Erben - deutsche Revolutionserinnerungen" in Dieter
Langewiesçhe (ed.), Die Revolutionen von 1848 in der europäischen Geschichte: Ergebnisse
und Nachwirkungen; Beiträge des Symposions in der Paulskirche vom 21. bis 23. Juni 1998,
Monaco, 2000 (Supplemento No. 29 of the Historische Zeitschrift), pp. 123-54.
Siemann, Wolfram, "Groβdeutsch - kleindeutsch? Österreich in der deutschen Erinnerung zu
1848/49", p. 97 in Barbara Haider e Hans Peter Hye (ed), 1848: Ereignis und Erinnerung in den
politischen Kulturen Mitteleuropas, Vienna, 2003, pp. 97-111.
38
Illustrazioni
Nn. 1, 2, 5, 8, 9 provenienti da Germanisches Nationalmuseum (ed.), 1848: Das Europa der
Bilder. 2 voll., Nuremberg, 1998.
Nn. 3, 6, 7 provenienti da Lothar Gall (ed.), 1848, Ausbruch zur Freiheit, Francfort, 1998.
N. 4 proveniente da "Freiheit, schöoner Götterfunken! Europa und die Revolution 1848/49",
Zeit-Punkte, 1, Amburgo, 1998
39
5.
La Rivoluzione ungherese del 1848 e le sue conseguenze
Peter Bihari
"Gli Ungheresi sono i francesi del XIX secolo “
George Weerth, Neue Rheinische Zeitung, 19 maggio 1849
Tradizioni
Si sente dire spesso che c’è troppa storia al chilometro quadrato nella nostra regione dell'Europa
orientale o, secondo le parole dello scrittore italiano Claudio Magris, che i popoli dell'Europa
orientale non conoscono l'arte del dimenticare. Queste osservazioni molto giuste fanno
riferimento al "peso della storia" in questa parte del continente europeo: le ferite e i pregiudizi
del passato impediscono troppo spesso ai popoli e ai paesi di costruire il loro presente e il loro
avvenire, un'impressione che si prova molto fortemente anche in Ungheria, dove quelli che
dividono la stessa visione del futuro possono avere delle vedute totalmente divergenti per
quanto riguarda il passato ( e non resistono sempre alla tentazione di rievocare le vecchie
battaglie in costumi d’ epoca) mentre in altri paesi, più fortunati, succede normalmente il
contrario.
Anche se penso che Magris abbia ragione, mi propongo di mostrare, in questo testo che la storia
può essere anche una forza costruttiva e liberatrice, al servizio del presente e del futuro. Qui il
problema non è di trattare gli avvenimenti del 1848/49 in quanto tali ma della commemorazione
dell'anno rivoluzionario. La mia principale preoccupazione è di mostrare come e perché gli anni
1848/1849 sono diventati i più importanti nell'eredità storica dell'Ungheria e di far risaltare il
tipo di coscienza storica che essi hanno contribuito a creare. Non ho affatto intenzione di
lasciare da parte i miti, le leggende e i culti che circondano la più grande rivoluzione che gli
ungheresi abbiano conosciuto.
In Ungheria, i ricercatori sono unanimi nel considerare che gli avvenimenti del 1848/49
rappresentano una svolta decisiva nella storia del paese paragonabile alla fondazione da parte di
Santo Stefano del regno cristiano intorno all'anno mille. Due sono gli aspetti che caratterizzano
il cambiamento che si è operato allora: la modernizzazione e la nazionalità, che vedremo più
avanti. Non è,quindi, sorprendente che oggi la maggioranza degli Ungheresi indichi il 1848
come il periodo della loro storia di cui sono più fieri, come rivelano tutti i recenti sondaggi di
opinione.
Numerosi esempi tratti dalla vita quotidiana confermano l'importanza di questa data. Dei tre
giorni festivi ungheresi, il 15 marzo, giorno della rivoluzione del 1848, è indiscutibilmente il più
apprezzato. Egli coincide inoltre con l'arrivo della primavera, e ciò facilita l'associazione alla
"primavera dei popoli". Passeggiando oggi in qualsiasi via principale di paese o di cittadina in
Ungheria, si osserverà che porta abitualmente il nome di Lajos Kossuth o di Sándor Petöfi, le
due figure principali dell'epoca. La piazza del paese si chiama generalmente piazza Széchenyi o
Deák, rispettivamente “il più grande degli Ungheresi" e il "saggio del paese", tutti e due membri
del primo governo ungherese, nato nel 1848. Esaminando una piantina della città di Budapest,
ho notato non meno di 75 vie e piazze chiamate secondo i nove membri del governo del Conte
Battyány, probabilmente il miglior governo che il paese abbia mai avuto. Infine, sedici altre
strade o piazze devono il loro nome al poeta rivoluzionario Sándor Petöfi,e ciò porta a parecchie
centinaia, solo a Budapest, il numero di piazze e di istituzioni che commemorano gli attori della
rivoluzione e della guerra di indipendenza che ne seguì.
Ultimo esempio: il giorno della festa nazionale, il 15 marzo, le radio pubbliche, radio Kossuth o
Petöfi, citano le personalità ungheresi decorate dei premi più prestigiosi, il premio Kossuth e il
premio Széchenyi. E ultimo dato: nel 1998, per il 150° anniversario della rivoluzione, sono state
40
pubblicate più di 250 pubblicazioni dedicate alla rivoluzione, in ungherese ovviamente,
testimoniando così l'enorme interesse dei professionisti e del pubblico per l'argomento.
Il primo anniversario della rivoluzione fu celebrato già il 15 marzo 1849 sotto l'egida della
bandiera tricolore, creata dalle Leggi fondamentali del mese di aprile 1848, come l'emblema
nazionale. Quel giorno,
"dei giovani entusiasti e dei soldati giurarono solennemente che i tiranni asburgici non
avrebbero mai invaso l’amatissima patria che avevano riscattato col loro sangue per
fondare uno degli Stati i più liberali d’Europa.”
Dopo la disfatta del 1849, un gran numero di banconote, di biglietti Kossuth, e di bandiere
tricolori furono nascoste, i primi in quantità talmente esagerate che ora sono prive di grande
valore nei negozi di antiquariato. Nei cimiteri si trovano anche vecchie pietre tombali che
portano l'iscrizione "Honvéd"(membro dell'esercito rivoluzionario nel 1848/49).Evidentemente
questo episodio rappresentava, il solo fatto ragguardevole di cui il defunto sia stato non solo
fiero ma che sperava di far passare ai posteri.
Col passare del tempo, queste forme di commemorazione e di lutto hanno generato diversi culti
e miti. Si pensi soprattutto a Petöfi che intonava il suo "Canto alla nazione", "Ungherese,
sollevati! ", una sorta di Marsigliese ungherese, sui gradini del Museo nazionale il 15 marzo.
Qui si possono trovare la targa commemorativa e la corona di fiori ma è poco probabile che sia
il luogo preciso dove il poeta rivoluzionario ha cantato questo inno. Si potrebbero citare anche i
titoli che incoronavano già da vivo Kossuth: "il nostro padre Kossuth", "il Mosé ungherese", "il
grande esiliato", "il Messia della nazione", "il santo uomo", "il nuovo Washington", ecc. Poco
tempo dopo la sua morte, nel 1894, furono erette in suo onore numerose statue. Nel 1914, si
contavano 75 sculture (di cui 32 lo rappresentavano in piedi), e ciò rende il suo culto
paragonabile( mutatis mutandis) a quello di Bismarck nella Germania imperiale.
Commemorazioni
Per i bisogni di questa parte, ho selezionato alcuni momenti-chiave della storia del paese per
mettere in evidenza le diverse forme di commemorazione degli avvenimenti del 1848 alle quali
hanno dato luogo. Dopo il periodo di assolutismo degli anni 1850, la prima celebrazione
pubblica della rivoluzione, non ufficiale ovviamente, ebbe luogo nel 1860. Si svolse in un clima
di esaltazione e uno studente fu ucciso dalla polizia. Quell’anno, la coccarda tricolore e il nastro
nero diventarono già il doppio "simbolo nazionale" di quella giornata.
Il cinquantenario della rivoluzione, nel 1898, si rivelò un affare delicato poiché coincideva col
50° anniversario dell'ascensione al trono dell'Austria di Francesco Giuseppe, e ciò diede luogo a
una strana "azione parallela". Ferenc Kossuth, figlio di Lajos Kossuth e capofila del partito
indipendentista nel 1848, dichiarò che "la nazione vuole vivere e commemorare col suo re". e
propose che la commemorazione degli avvenimenti del 15 marzo facesse oggetto di una legge.
Al termine di burrascose discussioni, i membri del Parlamento giunsero a un compromesso: ci
sarebbe stata una legge ma il nuovo giorno festivo sarebbe stato spostato all’ 11 aprile, giorno in
cui il re aveva approvato le Leggi di aprile.
Questa decisione era ben in linea con la "rivoluzione legale" del 1848 ma il compromesso
suscitò il malcontento di una gran parte dell'opinione pubblica. Così si è potuto leggere nella
maggior parte dei giornali che a partire da quel momento, ci sarebbe stato un giorno festivo
ufficiale, l’ 11 aprile, ma che la vera festa nazionale sarebbe rimasta fissata al 15 marzo.
Conviene precisare che il proletariato" di Budapest organizzò quell’ anno, per la prima volta, le
sue celebrazioni con la bandiera rossa e formulò in quell’ occasione, delle rivendicazioni
radicali. (Il partito socialdemocratico, non rappresentato al Parlamento, fu l'unica forza politica
di levatura a rigettare il consenso nazionalista, sull'interpretazione degli avvenimenti del 1848 di
cui fece una commemorazione separata.
41
Durante la Prima Guerra mondiale, la reinterpretazione dell'eredità del 1848 prese nettamente
una piega anti-russa e anti-slava, ispirata, probabilmente, da sentimenti di rivincita nati dalla
disfatta del 1849. Tuttavia, all'indomani della nuova disfatta del 1918, il vecchio modello della
"rivoluzione ungherese legale" poteva essere gettato alle ortiche. Il 15 marzo sostituì l’ 11 aprile
perché "questa giornata non potesse essere strappata dal cuore del popolo ungherese". Inoltre, il
trionfo effimero dei Bolscevichi ungheresi nel 1919 contribuì a favorire l'identificazione delle
masse proletarie coi rivoluzionari del 1848. L'oratore socialista proclamò:
“Ci saranno solo due nazioni faccia a faccia sulla Terra, è Petöfi che parla [!],quella del
bene e quella del male. E noi calpesteremo con i piedi il male, quell’ incarnazione del
male che è il capitalismo. Giuriamo insieme che noi non saremo gli ultimi in questo
combattimento."
Si sentivano qui i primi accenti guerrieri della rivoluzione socialista mondiale.
Con la perdita della Grande Ungheria si aprì nella storia del paese un nuovo capitolo, la vittoria
della controrivoluzione e l'instaurazione di un regime di destra tra le due guerre. Il 1848 restava
una data importante ma fu privata di qualsiasi connotazione liberale e democratica. La nuova
interpretazione radicalmente nazionalista e antiliberale appariva chiaramente nel discorso
pronunciato in occasione della festa nazionale da Endre Bajcsy-Zsilinszky, un uomo politico
razzista che diventò, nel 1944, una delle rare vittime della resistenza ungherese contro il
nazismo. Nel 1923, egli si rivolgeva così a un pubblico composto, senza sorpresa, di unionisti
paramilitari:
“Oggi possiamo dire che la nostra economia e la Borsa, la nostra letteratura e la stampa
siano veramente nelle nostre mani? No, occorre riguadagnare il terreno perso su tutti i
fronti. Noi abbiamo bisogno di una nazione forte, di uno Stato forte, non è di più libertà
che abbiamo bisogno ma di più interventi dello Stato."
Curiosamente, verso lo stesso periodo, all'approssimarsi dell’ 80° anniversario della rivoluzione
, il 15 marzo diventò ufficialmente il giorno della festa nazionale dopo l'adozione di una
risoluzione parlamentare in questo senso (nel 1927/28). Ma, in questi anni, tra le due guerre, il
clima rimase sensibilmente lo stesso: la catastrofe del trattato di pace di Trianon (1920) fu
paragonata alla catastrofe di Arad (1849); la tristezza provata per le vittime e la necessità per il
paese di riprendersi e di preparare la resurrezione dell'Ungheria furono le note dominanti delle
manifestazioni commemorative.
Durante la Seconda Guerra mondiale, la linea ufficiale era sempre anti-russa e anticomunista
ma, a causa della timida opposizione della sinistra, l'eredità del 1848/49 era opportuna poiché
permetteva di unire i sentimenti anti-germanici ed anti-nazisti.
Questa connotazione anti-tedesca continuò in maniera significativa per i venti-trent’anni
successivi perché niente era più semplice di identificare gli Asburgo con i Tedeschi e di renderli
collettivamente responsabili di tutti i mali sopraggiunti nella storia del paese.(Mi viene in mente
a questo proposito un libro, ripubblicato più volte, intitolato "400 anni di lotta per una Ungheria
indipendente", di lotta, bisogna precisare, contro gli Asburgo e i Tedeschi. Dopo il 1945, fu
relativamente facile basare le nuove commemorazioni sulle vecchie tradizioni indipendentiste
del XIX secolo).
L'anno 1945 ha sconvolto i dati in Ungheria come altrove. La liberazione del fascismo ha aperto
la strada a una reinterpretazione gauchista della storia. Solo allora circa cento anni dopo il
glorioso anno 1848, il vero obiettivo della rivoluzione era finalmente raggiunto sottoforma di
un’ Ungheria indipendente e democratica, tale era il nuovo credo. Non era il caso di essere
incerti sulla natura reale di questa nuova democrazia, non parliamo dell’ indipendenza. La linea
anti-germanica ed anti-asburgica si indurì mentre l'intervento russo del 1849 si spiegava
42
comodamente attraverso lo zarismo, regime intrinsecamente deleterio che il grande partito
comunista aveva definitivamente annientato.
Questa corrente si era considerevolmente rinforzata nel 1948, all'epoca del centenario della
rivoluzione che coincideva questa volta con l'inizio della guerra fredda e il completamento del
sistema del partito unico in Ungheria. I comunisti non risparmiarono i loro sforzi per controllare
le commemorazioni. Si proclamarono i soli veri eredi del 1848. Petöfi fu riabilitato in quanto
eroe principale della rivoluzione. Oggi, il poeta sarebbe membro del partito comunista o lo
sarebbe stato nel 1848, se il partito fosse esistito. Grazie all'isteria scatenata dalla guerra fredda,
non si esitò a superare alcuni passi supplementari: il capo del partito, Mátyás Rákosi, fu
descritto come una reincarnazione, ancora più perfetta, di Lajos Kossuth e Tito, l'infame
traditore, si ritrovò in perfetta uguaglianza con il croato Jelacic, esule. Sotto il giogo delle
dittature totalitarie, tutto accadde come se il partito dirigente si fosse impadronito della memoria
del 1848. Ma non era tutto. Un nuovo decreto abolì il 15 marzo come festa nazionale a partire
dal 1950. La giornata restava festiva per gli istituti scolastici ma diventava un giorno lavorativo
per il resto della popolazione. La memoria del 1848 rimaneva potenzialmente pericolosa.
La rivoluzione anti stalinista del 1956 si fece sul modello di quella del 1848. La restituzione di
ciò che si chiamava l'emblema di Kossuth" e il ripristino della festa nazionale del 15 marzo e
della giornata di lutto nazionale del 6 ottobre figuravano invariabilmente tra le rivendicazioni
formulate dai manifestanti. Neanche l'oratore comunista potette negare questo legame dopo la
ripresa in mano del regime.
"Le idee del 1848 sono state più di una volta falsificate nel corso degli ultimi 110 anni",
disse il 15 marzo 1958, "ma mai come lo sono state nel 1956". "La controrivoluzione
del 1956 è venuta avanti mascherata, travestita degli orpelli del 1848.... [Ma] noi
cancelleremo la vergogna che, da allora, sporca la bandiera di Kossuth, Petöfi e
Táncsics." .(Quest’ ultimo era un contadino impegnato in politica nel 1848).
Dopo alcune tergiversazioni, lo statuto del 15 marzo rimase immutato: un giorno festivo per i
bambini e un giorno lavorativo per gli adulti. Dopo la repressione della rivoluzione, il periodo di
"consolidamento" sotto Kádár ("quelli che non sono contro di noi sono con noi") ha permesso di
ricollocare l'autorità dei comunisti per una buona decina di anni. Le prime incrinature apparvero
all'inizio degli anni ‘70. La nuova generazione, meno timorata della precedente, rifiutò di
lasciarsi chiudere in questo tacito consenso alla "dittatura dolce". La prima manifestazione non
ufficiale ebbe luogo nel 1972 ma passò quasi inosservata. Solo Radio Europa libera ne rese
conto. In compenso, l’ anno successivo, l'organo ufficiale del partito, "Népszabadság” pubblicò
un comunicato succinto in ultima pagina, dal titolo,
"Hooligans arrestati dalla polizia": Dopo le cerimonie commemorative ufficiali tenute
in occasione della festa nazionale del 15 marzo, alcune centinaia di irresponsabili hanno
tentato di organizzare una manifestazione nazionalista nel centro di Budapest.
L'assembramento è stato disperso. Durante le operazioni di ristabilimento dell'ordine,
hanno avuto luogo dei controlli di identità e 41 persone che erano considerati gli
istigatori dell'operazione, sono state portate nei locali della polizia a Budapest."
Dopo il 1972, pochi anniversari del 15 marzo si svolsero senza una forma di manifestazione. Lo
scenario abituale era quello del 1956: piccoli raggruppamenti intorno alla statua di Petöfi poi
marcia in direzione della piazza Jözef Bem (generale polacco del 1848/49), scopo mai raggiunto
poiché la polizia fermava il corteo molto prima. Il mese di marzo restava un mese pericoloso,
anche negli anni ‘70.
Infine, si verificò un nuovo ribaltamento, l'ultimo speriamo, col cedimento del socialismo di
Stato. In un tentativo di acquietamento, il Politburo raccomandò nel dicembre 1987 il ripristino
ufficiale della festa nazionale del 15 marzo, e ciò fu fatto nel 1988 ma fu troppo poco e troppo
tardi. Una delle più grandi manifestazioni del tempo ebbe luogo il 15 marzo 1989. Di nuovo, si
43
era nella situazione del 1956 e la nuova rivendicazione era oramai la riconoscenza ufficiale della
rivoluzione del 1956. Uno dei cartelli proclamava: Imre Nagy (primo ministro)=Lajos
Batthyány (primo ministro), Kádár Haynau (il sanguinario generale austriaco del 1849). Ancora
una volta, le due rivoluzioni erano inestricabilmente legate e la loro eredità si rinforzava
reciprocamente nel perseguimento degli obiettivi politici del momento.
Se si vogliono differenziare i tre grandi periodi storici che abbiamo appena ricordato, si nota che
tra il 1867 e il 1918, si trattava soprattutto di differenze di intensità: la tradizione rivoluzionaria
simboleggiata dal 15 marzo e la tradizione contrattuale incarnata dall’ 11 aprile esprimevano
tutti e due l’essenza del 1848. Più tardi, nel 1920 poi nel 1944, la rottura tra la sinistra e la destra
rifletteva l'opposizione fondamentale tra valori liberali e democratici da un lato e idee
nazionali(ste) dell'altro. Infine, dopo gli anni 1945/1948, l'eredità di marzo fu svuotato
totalmente della sua sostanza e riservato all'uso esclusivo di un regime totalitario che mancava
di legittimazione politica, impresa condotta con un'assicurazione e un successo decrescente
dopo il 1956). Prima di trattare la situazione attuale, vorrei trarre delle conseguenze più generali
di ciò che è stato appena detto.
Conclusioni
Anche il grande storico conservatore e pro-Asburgo Gyula Szekfü ha dovuto riconoscere che il
1848 aveva finito per diventare l'anno di riferimento di tutte le tradizioni rivoluzionarie nella
storia dell'Ungheria. In un certo modo, prolungava la lotta per l'indipendenza condotta contro gli
Asburgo nel XVII secolo alla quale si trovava legata e costituiva un tipo di modello per tutti gli
ulteriori combattimenti condotti nel nome di un’ Ungheria libera e indipendente. "Le masse
smisero di analizzare il senso degli avvenimenti del 1848 semplicemente per provarli e temerli
attraverso il loro cuore e i loro sentimenti piuttosto che con il loro spirito", ha scritto. Da qui
l'importanza presa dai simboli del 1848 - la bandiera tricolore, la coccarda, il "Canto alla
nazione" di Petöfi - ad ogni svolta della storia, dal 1850 ai nostri giorni. Ciò che emerge anche
da questi culti o simboli, sono i “12 punti", l'elenco delle domande formulate dai rivoluzionari
nel marzo 1848. Difatti, nel corso del secolo scorso, le rivendicazioni hanno più di una volta
preso questa forma dei 12 punti, con un contenuto similare o attualizzato, come fu il caso nel
1918, 1945, 1956, 1988 e 1989. ( Sarebbe interessante paragonare questi due ultimi anni con i
due successivi).
Come avrete probabilmente notato in questo intervento, il 15 marzo è sempre stato un giorno
festivo per l'opposizione. Ciò non ha niente di sorprendente in un paese che ha conosciuto solo
raramente la libertà e l'indipendenza. La primavera, la gioventù, la libertà e l'indipendenza sono
diventate delle nozioni intimamente legate nello spirito e nel cuore delle persone. Niente di
sorprendente neanche per il fatto che i dirigenti hanno sempre fatto l'impossibile per
strumentalizzare il 1848 a loro vantaggio e tentare di legittimare il loro governo o il loro sistema
politico, spesso, con magrissimi risultati, come si è visto. Il "potere di marzo" era, in linea di
massima, più forte del "Marzo del potere", secondo le parole di uno storico.
Una domanda fondamentale resta tuttavia in sospeso: come spiegare l'enorme importanza del
1848 nella storia dell'Ungheria? Se ne possono trovare le ragioni nell'anno rivoluzionario stesso,
bisogna attribuirlo agli avvenimenti ulteriori o, come tenderei a credere, a dei fattori sia"interni"
che "esterni"?. Forse non è inutile ricordare che, nella domanda che ci interessa, i miti e gli
stereotipi giocano un ruolo cruciale, "non deformano" la realtà, la modellano.
L'abbiamo visto, il 1848 condensato nelle Leggi fondamentali di aprile, fu principalmente un
anno determinante in Ungheria. Tuttavia, non segnò una rottura artificiale col passato ma
piuttosto un cambiamento nella continuità, ad avvicinare al l'"era delle riforme", iniziata alcuni
decenni prima da Széchenyi e Kossuth. A questo titolo, il 1848 può essere qualificato sia
riformista che rivoluzionario. Alcuni osservatori contemporanei vi avevano già scoperto una le
prime transizioni liberali/patriottiche che si dovevano verificare in seguito in questa parte del
continente europeo.
44
In secondo luogo, e il fatto è piuttosto raro nella storia delle rivoluzioni, gli avvenimenti di
marzo si svolsero senza spargimento di sangue, addirittura senza reale violenza. Non si potrebbe
dire altrettanto della guerra di indipendenza che seguì ma l'insieme del processo ha largamente
contribuito a fissare le mie tre seguenti nozioni: l'ungherese è pacifico e rispettoso della legge, è
un soldato coraggioso e sa battersi in caso di necessità; infine, e questo può essere il punto più
importante, sia la rivoluzione pacifica che la guerra di indipendenza difensiva hanno rafforzato
tanto bene l'unità nazionale che fu al tempo stesso una delle condizioni e il risultato dell'anno
rivoluzionario.(Pur essendoci similitudini tra l’ Ungheria del 1848 e la Francia del 1789, non
c'era la ghigliottina in Ungheria e non c’era vera divisione in seno alla popolazione ungherese
durante questa rivoluzione). L'unità nazionale non ne uscì indebolita ma rinforzata per il ruolo
giocato da Budapest ( era la prima volta che le città gemelle di Buda e di Pest furono chiamate
ufficialmente Budapest) – è nel 1848 che la città diventò veramente la capitale dell'Ungheria.
In terzo luogo, e ancora una volta, fenomeno raro in questa regione dell'Europa, il 1848 aveva al
tempo stesso connotazioni nazionali e liberal-democratiche. Benché mi sia sforzato di
dimostrare che queste due componenti o forze principali si fossero schierate spesso l’una contro
l'altra, una semplice occhiata ai 12 punti o alle Leggi di aprile basta per accorgersi che i due
andavano mano nella mano. La constatazione può sembrare strana in molti paesi di questo
continente, ma in Europa centrale e orientale, le cose non andavano da sé.
In quarto luogo, la rivoluzione ebbe successo? Non è facile rispondere sì o no a tale domanda.
Essa fu certamente schiacciata dall'esercito più potente del mondo ma resistette a tutti gli altri
tentativi che miravano a soffocarla. A questo riguardo, non solo la rivoluzione ma anche la
guerra di indipendenza furono delle quasi vittorie, Neanche l'Austria trionfante ha osato
cancellare tutte le conquiste del 1848 dopo la disfatta ungherese del 1849. È anche certo che il
famoso Compromesso (Ausgleich) del 1867 non si sarebbe potuto concludere se non ci fosse
stato il 1848 perché la rivoluzione aveva dato all'élite politica ungherese un'incontestabile
sicurezza, senza contare il sostegno dell'opinione pubblica.
Riassumendo, il 1848 fu il momento fondatore nel processo di costruzione della nazione e vide
nascere allo stesso tempo il nazionalismo ungherese, anche se non si può ignorare, che questi
avvenimenti hanno necessariamente contribuito a ravvivare altri nazionalismi in Europa centrale
e orientale. La mia presentazione sarebbe tuttavia incompleta se non menzionassi velocemente il
contrasto che esiste tra il XIX e il XX secolo nella storia dell'Ungheria. Diciamo, per andare
rapidamente, che l'immagine è più o meno la stessa di quella presentata dalla Germania: un XIX
secolo glorioso seguito da un XX secolo disastroso. È per questo contrasto, a mio avviso, che si
spiega il posto considerevole che la rivoluzione del 1848 continua ad occupare nella coscienza
storica ungherese. Solo i liberali, i rivoluzionari o i nazionalisti hanno trovato ciò che volevano
nel 1848 ma anche tutti quelli che hanno cercato di identificare almeno un'epoca gloriosa nella
storia moderna dell'Ungheria. Che cosa potevano trovare d’ altro del 1848? - la rivoluzione e il
mito che aveva generato permettevano di credere in un futuro migliore.
Sarebbe allettante concludere questa comunicazione affermando che dopo i cambiamenti
avvenuti nel 1989/90, gli avvenimenti del 1848/49 sono riposti definitivamente nelle segrete
della storia, che la politica ogni giorno non può più superare la storia. Ma, come ho già indicato
prima, non è sempre il caso. L'anno 1848, le sue coccarde, le sue dichiarazioni e i suoi simboli,
conservano il loro potere mobilizzatore e i politici non si ingannano e non perdono mai
l'occasione di sfruttare il "potere di marzo", come si è potuto constatare ancora recentemente,
nella campagna elettorale del 2002.
Di conseguenza, preferisco terminare con una citazione che trovo ammirevole. Per farvela
comprendere meglio, mi riferirò a una recente visione della storia dell'Ungheria, recentemente
ripresa dallo scrittore austro- ungherese Paul Lendvai secondo la quale la storia ungherese
sarebbe "Un millennio di vittorie nella disfatta", (Die Ungarn,: ein Jahrtausend Sieger in
Niederlagen). Lendvai non nasconde che egli trae questo titolo dal meraviglioso romanzo di
45
Géza Ottlik, La scuola della frontiera, pubblicato nel 1959. "Ottlik ha reso conto in modo
notevole di questo rapporto unico che hanno gli Ungheresi con le loro sconfitte attraverso
l'esempio di una classe", scrive Lendvai. E adesso, ascoltiamo Ottlik stesso:
"Stava arrivando il 400° anniversario della battaglia di Mohács. Può sembrare
inadeguato celebrare una disfatta ma il potente Impero ottomano che avrebbe potuto
celebrare la sua vittoria, non esisteva più. Non restava più neanche la minima traccia del
passaggio dei Mongoli, sono spariti, davanti ai nostri propri occhi per così dire, quella
dell'Impero degli Asburgo, tuttavia così solidamente radicato. È così che abbiamo preso
l'abitudine di celebrare da soli le grandi battaglie perse alle quali siamo sopravvissuti.
Siamo forse anche arrivati a considerare la sconfitta come un risultato più tangibile
della vittoria epiù importante di essa, in ogni caso come qualcosa che ci appartiene
realmente."
Ottlik aveva evidentemente in mente il grande Impero sovietico quando scrisse il suo romanzo.
È morto nel 1990, l'anno delle prime elezioni libere dopo decenni di comunismo. L'Impero
sovietico doveva crollare l’anno seguente.
46
Tendenze attuali nella ricerca storica sulla Rivoluzione del 1848/49 in Ungheria
I lavori storici dedicati alla rivoluzione del 1848/49 in Ungheria hanno continuato a essere
pubblicati in gran numero negli ultimi decenni. Io mi limiterò a rilevare qui cinque grandi campi
nei quali la ricerca ha permesso di giungere a nuovi risultati e/o di sollevare nuove domande.
Questi campi sono i seguenti:
-
la rivoluzione ungherese e il contesto internazionale;
il problema dei rapporti con l'Austria;
la questione delle nazionalità ungheresi;
la politica del governo Batthyány e
l'organizzazione e la composizione dell'esercito dei "Honvéd."
1.
Il contesto internazionale. Esempio di paragone
Un certo numero di ricercatori (Domokos Kosáry, András Gergely, Géza Herczeg, Gábor
Erdödy, tra gli altri) hanno attirato l'attenzione sull'influenza della rivoluzione tedesca e il
progetto di un'unione tra i due movimenti rivoluzionari. I liberali ungheresi – in particolare i
membri del governo Batthyány - erano coscienti di questa possibilità e lavoravano ad
un'alleanza con Francoforte. Questo legame si rivelò inizialmente promettente, alcuni liberali
tedeschi si accorsero anche dei vantaggi che poteva comportare un'alleanza germano-ungherese
- soprattutto se era diretta contro certi popoli slavi e la Russia. Solo più tardi, con gli indugi
dell'Assemblea di Francoforte e il ritorno in forza delle dinastie, le prospettive di una
cooperazione tra Francoforte e Budapest furono annientate.
Il professor Gergely ha stabilito un paragone, veloce ma interessante, tra due leader politici
liberali del 1848 Heinrich von Gagern e Lajos Kossuth. Questi nuovi elementi mostrano bene
che la storia delle rivoluzioni "nazionali" guadagna sempre ad essere situata in un contesto più
vasto.
2.
L'Austria e gli Asburgo
Qui sottolineerò solo un aspetto principale delle ricerche. Fino agli anni 1980, tutti gli storici
ungheresi erano d’accordo nel sostenere che i liberali di Budapest dovevano far fronte a una
cellula controrivoluzionaria a Vienna, incarnata principalmente dal Conte Latour e più tardi dal
generale Windischgrätz e e il duca Schwarzenberg. L'esistenza e l'influenza nefasta di questo
"maledetto camarilla" alla Corte degli Asburgo erano chiare. Dopo l’uscita della monografia di
István Deák (Università di New York) che apre delle nuove piste, sembra che questa idea fosse
non solo semplicistica ma falsa. In realtà, non c'è mai stato complotto contro-rivoluzionario
organizzato contro l'Ungheria, e certamente non fin dall'origine, nel 1848. Sarebbe più giusto
dire che le forze rivali erano all'opera alla Corte così come nei circoli vicini al potere e il
governo Batthyány, che si attivò non senza successo fino a luglio 1848, era una di esse. Questa
interpretazione - è un caso se è stata avanzata fuori dall'Ungheria? - è ora accettata dalla
maggior parte dei ricercatori (tuttavia, in più versioni differenti,) e contribuì largamente a
sdrammatizzare il dibattito sugli avvenimenti dell’anno rivoluzionario: non si vedranno più,
quindi, i buoni rivoluzionari (ungheresi) battersi contro i cattivi reazionari (stranieri) ma delle
forze di origini diverse evolversi in situazioni sempre fluttuanti.
3.
La questione delle nazionalità
47
Altra domanda spinosa, se si può considerare tale, la pretesa questione delle nazionalità. In
questo campo ci sono due modi di vedere le cose: dal punto di vista dell'insieme dei popoli
riuniti in seno alla monarchia austriaca o da quello del regno ungherese multietnico. ( Nel 1848,
il Conte Széchenyi ha parlato dell'Ungheria come di un tessuto - di "nazionalità" - che compone,
con altri, un tessuto più vasto). Questa questione delle nazionalità è sempre stata, o lo è,
rivelatrice perché faceva risaltare nella storia dei paesi il partito preso nazionale che era stato
accuratamente occultato durante gli anni del socialismo dello Stato. Era anche la questione che
dava regolarmente luogo, negli storici occidentali, a delle presentazioni errate, essenzialmente a
causa della disinformazione. Oggi, è stato pubblicato un certo numero di lavori innovatori i cui
autori cercano manifestamente di evitare la trappola dei pregiudizi perché piuttosto che rendere
responsabile l'altra (nazione), si sforzano di ricostituire e di comprendere le situazioni
dell'epoca.( E qui ritornano in mente i nomi di D. Kosáry, I. Deák, forse Gy. Spira). Anche in
questo caso il professor Deák fu il primo a innalzarsi contro le interpretazioni parziali. Non
sarebbe forse inutile citarlo qui. La prima citazione ha sfruttato lo sfondo intellettuale sul quale
si è sviluppato il pensiero dei liberali ungheresi che non aveva niente di inedito nell'Europa del
XIX secolo):
"I liberali ungheresi furono semplicemente incapaci di concepire la profondità dei
sentimenti che animavano i non magiari. Perché dei cittadini liberi, fuoriusciti di un
paese libero dovrebbero improvvisamente beneficiare di uno statuto speciale? Perché
dei privilegi collettivi dovrebbero essere concessi a una nazionale in particolare mentre
tutti i privilegi di rango e di classe erano stati aboliti? ( Qui egli cita Kossuth...) Né
Kossuth né nessun’altro liberale o radicale ungherese hanno voluto mai ammettere che
l'agitazione delle minoranze nazionali non poteva essere altro che reazionaria" (Deák,
1979, p. 129).
Ed ecco come István Deák rende giustizia ai due campi antagonisti:
"Affermare che nella primavera del 1848, gli Ungheresi hanno lasciato passare
l'opportunità di un'intesa tra tutte le loro nazionalità, e che quindi potevano solo perdere
tutto, sarebbe falso quanto sostenere che una tale possibilità non era mai esistita. Non ci
si poteva affatto aspettare che l'Ungheria che aveva appena ottenuto una vittoria, si
fosse prodigata a dividere il regno in territori autonomi che sarebbero caduti
inevitabilmente nelle mani della maggioranza non magiara. Invece, il governo sarebbe
potuto arrivare a un modus vivendi con alcune nazioni. L’eliminazione del movimento
slovacco, sebbene immorale, fu un successo; la guerra contro i serbi ed i croati (…) era
necessaria, ma tentare di vincere i Rumeni, fu un errore grossolano" (Deák, 1979, p.
129.
Non voglio dire con questo che - e nemmeno Deák - che un'interpretazione giusta degli
avvenimenti storici implichi necessariamente la ricerca di una via di mezzo, da qualche parte tra
due estremità. Ma ciò che Deák cerca di far comprendere, invece di rafforzare il lato manicheo
dei miti, converrebbe analizzare e interpretare le situazioni concrete e le mentalità del tempo nel
loro contesto. Precisiamo tuttavia che le tesi di Deák riguardanti la questione delle nazionalità
non incontrarono la stessa fama, almeno in Ungheria, di quelle che ha avanzato sulla "maledetta
camarilla". Ciò non toglie che oggi si ammette volentieri che tutte le nazionali hanno diritto alla
loro propria versione del 1848, e che ciascuna di esse è "legittima", anche se queste varianti si
basano su delle visioni e dei miti differenti - ogni storico degno di questo nome deve esserne
cosciente.
Noto che le concezioni datate hanno sempre diritto di essere citate e che si aprono una strada
anche nel più breve dei riassunti. Citerò un solo esempio, tedesco,: Immanuel Geiss ha dedicato
alcuni passaggi del suo libro, Der Lange Weg in die Katastrophe [La lunga strada verso la
catastrofe], Monaco, 1990, al problema ungherese. Egli scrive. "Das Scheitern der Ungarischen
Revolution am gross-magyarischen Chauvinismus 1848/49 und der Ausgleich von 1967 schufen
wesentliche Bedingungen von 1914" (Geiss, 1990, p. 70). Per cominciare, viene spontaneo
48
chiedersi se la rivoluzione ungherese fu realmente un insuccesso e, in questo caso, se la causa
principale o unica di questo fallimento è effettivamente lo "sciovinismo della Grande
Ungheria". Geiss stesso sembra confutare in parte una tale interpretazione: "Tatsächlich geriet
Österreich durch den Erfolg der Ungarischen Revolution in eine schwere Existenzkrise von der
es sich nie wieder erholte" (ibid, p. 80. Senza dubbio Geiss si è ispirato alla brillante monografia
di A.J.P Taylor sulla monarchia degli Asburgo, lavoro che ha incontrato molti successi ma di
cui oggi si stenta a trovare le tesi superate e il punto di vista falsato. Taylor vi presenta
particolarmente lo sciovinista Kossuth come il vero fomentatore delle agitazioni nei Carpazi.
Così, è con sollievo che ho accolto l'ultimo libro di Manfred Botzenhart, 1848/49,: Europa im
Umbruch [L'Europa in piena mutazione]. Ciò che lo differenzia di primo acchito da tutti gli altri
lavori anteriori, è che i nomi ungheresi sono scritti correttamente. Ciò sembra augurare un'intesa
reciproca per il futuro.
4.
La politica del governo Battyány
Altri risultati inediti e importanti sono stati anche pubblicati nel quadro dei lavori dedicati alla
persona e alla politica del primo ministro ungherese del 1848, il Conte Lajos Batthyány che
doveva anche diventare una vittima della rivoluzione e che era caduto quasi nell'oblio. Se, per
caso, ci si ricordava di lui, era per farne il rivale opportunista dell'autentico rivoluzionario che
era Kossuth. Tuttavia, il suo governo fu il solo governo rivoluzionario a mantenersi al potere per
un anno e mezzo, dall’ aprile 1848 all'ottobre 1849). Oggi, dopo la pubblicazione della
voluminosa biografia di Aladár Urbán, appare chiaramente che Batthyány non ha smesso di
ricercare un compromesso con gli Asburgo pur mostrandosi sempre pronto a difendere gli
interessi sovrani del suo paese. Si rivela anche che la sua visione delle cose e la sua strategia
erano vicine a quelle di Kossuth, sebbene ci siano state delle differenze nella loro tattica e i loro
rapporti con l'opinione pubblica. ( Contrariamente a Kossuth, oratore senza pari, Batthyány
l’arstocratico non giudicava utile spiegare alla popolazione la politica condotta dal suo
governo). Oggi si sa che se l'Ungheria ha potuto contare su un esercito di Honvéd ben attrezzato
nel 1848, è davvero grazie agli sforzi spiegati da Batthyány. È la sua politica che ha permesso al
paese di opporre una spietata resistenza ai suoi nemici per tutto un anno. Egli si è dimesso
solamente quando si è reso conto dell'inutilità dei suoi sforzi in favore di un compromesso o di
una riconciliazione. Il suo martirio e un giudizio più equilibrato da parte della posterità merita
sicuramente’un'attenzione maggiore.
5.
L'esercito degli "Honvéd"
Infine, grazie ai lavori e agli articoli pubblicati dal professore Urbán, Tamás Katona e Robert
Hermann, tra gli altri, oggi sappiamo molto di più sull'esercito ungherese degli Honvéd. Il mito
tenace del "tradimento" del generale Görgei è morto e sepolto poiché quest’uomo è ora
considerato come il più grande comandante ungherese del XIX secolo.
Non si può non essere colpiti dal carattere multietnico dell'esercito ungherese e dei suoi capi.
Citerò solamente un esempio tra questi ultimi: sui 13 generali ungheresi fucilati per ordine del
generale Haynau al castello di Arad, c’era un duca tedesco non originario dell'Austria, un
tedesco dell'Austria, tre tedeschi dell'Ungheria, un croato, un serbo, (ricordiamo che i serbi e i
croati erano i nemici più accaniti della rivoluzione ungherese del 1848), due di origine armena
(!) e quattro ungheresi "di razza" di cui uno non parlava per così non dire l'ungherese. La stessa
constatazione vale per il resto dell'esercito rivoluzionario, e ciò illustra ancora una volta la
complessità delle situazioni che prevalevano nel 1848 e la necessità, per tutti gli storici, di
trattare con la più grande prudenza le questioni etniche e nazionali.
Il nostro rapido esame storico sarebbe incompleto se tacessi sui dibattimenti attuali e le lacune
persistenti nella nostra conoscenza degli avvenimenti del 1848. Cominciamo dalle lacune:
l'assenza di ogni storia locale, o la negligenza di cui è oggetto, è una costante della nostra
storiografia. Occorre forse vederci l'influenza del centralismo ungherese. Trattandosi degli
49
avvenimenti del 1848, ci sono alcuni studi su Budapest (Debrecen, la "seconda" capitale della
rivoluzione) e sul territorio della Transilvania ma ce ne sono di meno su Pozsony (Bratislava,
Pressburg) e rare sono quelle dedicate ad altre parti del paese. A meno che questi lavori non
rimangano nascosti nelle loro località, rendendo ancora più difficile la nostra comprensione
degli avvenimenti del 1848/49.
Molte questioni suscitano dei dibattiti ma l’argomento che ritorna più frequentemente, è
l’interpretazione delle ”Leggi fondamentali di aprile”. Esse hanno potuto avere come effetto
l’instaurazione di un’unione personale tra l’Austria e l’Ungheria o il rafforzamento di
un’alleanza tra i due paesi?
Il sistema così organizzato era produttivo per cominciare? Se così non era, bisogna attribuire il
suo insuccesso alla diffidenza reciproca di regola tra le due parti di lunga data o alla piega
inaspettata degli avvenimenti, che ha annientato ogni speranza di compromesso duraturo tra
esse? Lo si vede, le domande diventano sempre più acute e gli storici restano sulle loro
posizioni. Non c’è dubbio che la storia della rivoluzione continuerà a mobilitare gli storici,
speriamo che sia per il bene del pubblico.
50
Bibliografia
Deák, István, The lawful revolution. Lajos Kossuth and the Hungarians in 1848, New York,
1979.
Geiss, Immanuel, Der lange Weg in die Katastroph, Monaco, 1990.
51
6. La Rivoluzione del 1848 nei Principati rumeni: continuità e
discontinuità
Carol Capita, Alin Ciupala e Maria Ochescu
Introduzione
Per molte tradizioni storiografiche, la rivoluzione rappresenta il termine di un periodo storico e
al tempo stesso il principio di un altro. Avvenimento unico e spettacolare, essa è un fatto storico
che difatti si può utilizzare in particolare come "punto-base cronologico" nelle cronologie più o
meno scientifiche. Tuttavia, risulta dalle ricerche condotte nel corso degli ultimi decenni che la
rivoluzione non segna né la fine né il principio dei periodi storici: i nuovi fattori sono equilibrati
dalle evoluzioni a lungo termine, l'eredità può andare di pari passo con l'innovazione - sia in
materia culturale (nel senso più ampio del termine) politico o sociale.
Questa evoluzione degli studi storici fu messa in secondo piano, addirittura ignorata nei vecchi
paesi comunisti. La gogna ideologica dei regimi che hanno segnato l'evoluzione dei paesi
dell'Europa dell'est durante la seconda metà del XX secolo è all'origine dell'immagine
particolare attribuita alle rivoluzioni, considerate come gli avvenimenti fondatori e come i fatti
che attestano senza dubbio l'esistenza e il carattere ineluttabile della lotta delle classi. Si
considerava che la rivoluzione apportasse una prova della lotta che oppone la borghesia (una
classe che era associata ancora alla nozione di progresso nel XIX secolo, e il proletariato
(talvolta ancora nascente) alla classe feudale. Tutta questa costruzione si basava su una lettura
piuttosto singolare dei testi marxisti e procedeva meno dalla ricerca scientifica che dalle
pressioni ideologiche del momento. La concezione secondo la quale le rivoluzioni del XIX
secolo erano dei processi autonomi, senza grande rapporto col progresso e l'affermazione
continua della classe operaia, era o un'eresia o una falsa idea. Un'analisi onesta potrà dimostrare
facilmente i limiti da questo punto di vista sulla storia. In effetti, i fattori di continuità giocano
un ruolo tanto importante quanto gli elementi di innovazione.
La rivoluzione del 1848 nella storiografia rumena
La storiografia rumena sotto il regime comunista si inserisce bene nel modello prima descritto,
poiché la situazione è probabilmente più disastrosa che in altri paesi della regione, e questo per
parecchie ragioni. Prima di tutto,molti rivoluzionari del 1848-1849 hanno esercitato, quasi una
profonda influenza sulla politica rumena quasi fino alla fine dell'XIX secolo. Questa
generazione è di conseguenza sinonimo dell'evoluzione della Romania moderna; in un caso
almeno, quello della famiglia Bratianu, la rivoluzione gli avrà permesso di consolidare la sua
supremazia sulla politica rumena fino alla presa di potere dei comunisti, poiché i suoi membri
avevano dominato il partito liberale dalla sua creazione fino al 1947. In secondo luogo la
generazione del 1848 si costituiva principalmente di intellettuali che influenzarono
profondamente la cultura rumena. Con Rosenthal, Balcescu, Alecsandri e molti altri, l'arte e la
letteratura rumena si sono integrate alla cornice generale della cultura europea moderna. Terzo,
la storiografia della fine del XIX secolo - di ispirazione romantica e nazionalista (simile in ciò
all'insieme dei testi storici dell'epoca) - ha trasformato questa generazione in un modello di
azione politica.
Ultimo punto, ma non il minore, da citare: le pressioni esercitate dal regime comunista. La
rottura sopraggiunta tra Bucarest e Mosca - sul piano delle dichiarazioni - esercitò un'influenza
singolare sugli studi storici. L'indipendenza conquistata sul centro del mondo comunista, (così
come sulla sua influenza e il suo "ruolo" di paese guida dello sviluppo socialista) chiedeva in
compenso la "scoperta" delle radici locali delle organizzazioni politiche della classe operaia,
l’aggiornamento di un contrappeso di natura particolare dal carattere considerato unico
dall'URSS e all’ internazionalismo proletario. Ne conseguì che la quasi totalità delle agitazioni
sociali fu trasformata in azioni in seno alle quali il proletariato era, se non la punta di diamante,
52
almeno uno dei gruppi che li aveva ispirati. Ciò spiega perché certi testi del periodo anteriore al
1989 considerano che i primi scioperi operai sono accaduti fin dal XVIII secolo in un paese
dove, al termine della Seconda Guerra mondiale, la maggior parte della popolazione lavorava
ancora nel settore agricolo e dove una proporzione non trascurabile di operai qualificati era
straniera.
Il risultato è piuttosto scoraggiante quando si attinge ai testi storici tradizionali. Gli avvenimenti,
certo importanti, rimangono il centro di interesse principale, le evoluzioni sociali sono
trascurate. Succede lo stesso per ciò che riguarda la storia culturale. A nostro parere, le migliori
analisi sono state effettuate dagli storici della letteratura rumena e non dagli storici di
formazione classica.
Tuttavia, una nuova generazione di storici in questi ultimi anni ha cominciato a riferirsi ai nuovi
tipi di fonti, a introdurre nel dibattito storico nuovi campi di ricerca (come per esempio lo studio
delle questioni legate alle specificità di ogni sesso, la storia della vita privata, delle minoranze,
dell’ abbigliamento e del tempo libero, ecc.), e ciò si è tradotto in una considerevole
rivalutazione del lavoro già effettuato che si è sforzata di differenziare i risultati positivi da
quelli che era meno che accettabili.
Le continuità
I fattori di continuità sono evidenti. Si osserva innanzitutto una continuità relativa alle persone
che presero parte agli avvenimenti del 1848, le associazioni più o meno segrete che miravano a
riformare la società rumena essendo stato infatti il luogo privilegiato dell' “esercizio della
politica" per tutta una generazione. Per esempio, l'associazione Fratia ("Fraternità"), in attività
all'inizio degli anni ‘40, raggruppa la maggior parte dei membri del futuro governo
rivoluzionario della Valacchia. Nicolae Balcescu e Christian Tell sono annoverati tra le
personalità che hanno già un'esperienza in politica. Questa continuità è tuttavia più profonda. A
dire il vero, i dirigenti rivoluzionari provenivano da grandi famiglie rumene, da quelle famiglie
aristocratiche che avevano lavorato nella politica locale in passato. I loro membri della giovane
generazione consideravano ormai che era giunta l'ora di una nuova politica. Uno stesso
ambiente naturale familiare, un'altra politica, ecco quale fu la conseguenza dei contatti con i
circoli romantici francesi e italiani. Ma fu anche il corollario di un'evoluzione di natura più
strutturale avendo esordito nel XVIII secolo. La borghesia, formata dal raggruppamento di
rappresentanti della piccola nobiltà, di negozianti arrivati dai Balcani e da altre regioni del mar
Nero (gli Armeni ne sono a questo titolo un buon esempio)così come di intellettuali originari
della Transilvania, è anche una forza che partecipa al cambiamento degli orientamenti e delle
abitudini. Viene adottata una nuova moda per quanto riguarda l’abbigliamento parallelamente
alle nuove attività e nuove forme di divertimento come la stampa e il teatro. È un nuovo mondo.
I primi giornali e i primi musei (di oggetti di arte antica e di scienze naturali) sono, come la
fondazione degli archivi dello Stato, altrettanti segni di una modernità che offre accesso
all’informazione. Questo interesse per la conoscenza dei paesi e degli altri popoli spiegano
anche perché certi rivoluzionari consideravano che la rivoluzione del 1848 nei principati rumeni
era stata ispirata dagli avvenimenti sopraggiunti in Francia ( ammettendo tuttavia che le
rivoluzioni europee offrirono l'opportunità, senza esserne la causa, delle rivoluzioni che
scoppiarono nei principati). Ma, lo sottolineiamo di nuovo, queste evoluzioni erano cominciate
almeno una generazione prima.
Questo modello è riprodotto da un'altra situazione persistente. A prima vista, niente potrebbe
sembrare più lontano della nozione di continuità nel 1848 della questione del linguaggio (vale a
dire dei concetti e della terminologia) utilizzati per comunicare il messaggio e l’ ideologia
rivoluzionari. Osservando più da vicino, si nota che è possibile trattare la questione da un’ altra
angolatura. Attraverso tutta l'Europa, l'ideologia del 1848 era essenzialmente liberale. A questa
si aggiungevano, in certi casi e particolarmente nei principati rumeni, degli aspetti nazionali. I
rivoluzionari rumeni, così come i loro colleghi in altri paesi, usavano un linguaggio che fu
53
creato - a partire dal 1789,si potrebbe dire - per esprimere la nuova ideologia. La necessità di
modificare questo linguaggio in funzione di coloro a cui si rivolgeva, del loro livello di
istruzione e delle loro convenzioni culturali costituiva il fattore rumeno, di fatto dell'insieme del
sud-est. A causa delle difficoltà sollevate dalla relazione tra le fonti del messaggio e i suoi
destinatari, la generazione del 1848 ha potuto utilizzare il linguaggio che era disponibile e
riconosciuto dai suoi contemporanei. Le idee erano nuove, ma affinché fossero comprensibili
nella maggior parte dei principati, il linguaggio con il quale queste novità furono trasmesse era
vecchio. Conservata ogni proporzione, si potrebbe affermare che, nel contesto del periodo, la
nuova ideologia era tanto straordinaria quanto la malleabilità del linguaggio utilizzato per
comunicare dei concetti inediti e i loro significati. Di ciò si troverà l'esempio più esplicito nel
ricorso costante al cristianesimo ortodosso e al sentimento religioso, così importante in una
società ancora tradizionale. Non è un puro caso se dei preti hanno giocato un ruolo tanto
capitale nell'evoluzione degli avvenimenti che segnarono l'anno 1848, sia in Transilvania (nel
caso dei cattolici greci e dei rumeni ortodossi) che nei principati rumeni. Il clero fu costretto
frequentemente a partecipare suo malgrado agli avvenimenti, a causa della chiamata permanente
alla sfera religiosa e dei suoi legami con la nuova società.
Nel caso della Valacchia, si invita il prete Radu Sapca a spiegare alla popolazione riunita ad
Islaz (il luogo dove esordì la rivoluzione) gli obiettivi della suddetta rivoluzione e il metropolita
Neofit fu anche nominato a capo del governo rivoluzionario alcuni giorni più tardi. Una
situazione identica si riscontrava in Transilvania, dove i due metropoliti rumeni (ortodosso e
cattolico greco) presero parte agli avvenimenti a fianco della popolazione. "La rivoluzione è la
volontà di Dio" - questa è l'interpretazione che si potrebbe dare del simbolismo della
rivoluzione del 1848 nei principati rumeni, un simbolismo saturo di filosofia cristiana. Di
conseguenza, gli avversari della rivoluzione diventavano i nemici di Dio, la croce e il Vangelo
degli strumenti della guerra ideologica tanto efficace quanto le barricate e la polvere da sparo.
Un altro elemento di continuità era l'idea di trarre profitto dal gioco diplomatico per raggiungere
degli obiettivi nazionali. A partire dal XVIII secolo, i rumeni hanno chiesto alle potenze
occidentali di intervenire in favore dei principati per controbilanciare l'influenza ottomana. Al
tempo delle conferenze di pace che sperano un termine alle guerre regionali che oppongono la
Russia, l'Impero degli Asburgo e l'Impero ottomano, delle delegazioni di aristocratici rumeni
espressero la speranza che i grandi poteri conferissero ai principati rumeni uno statuto di
neutralità o che garantissero la loro autonomia. Poiché l'Impero ottomano rappresentava la
minaccia principale (dove il fattore religioso aveva anche un ruolo da giocare), si considerava
che le relazioni con i poteri cristiani offrissero una soluzione migliore. Questo orientamento fu
percettibile negli sforzi che fecero i rivoluzionario del 1848 per collegare alle loro cause le
opinioni pubbliche della Francia o degli Stati tedeschi.
Le discontinuità
Il primo cambiamento, il più evidente, si è verificato in politica. La rivoluzione del 1848 incarna
nella sfera pubblica la prima manifestazione di sostegno attivo dei cittadini (della popolazione
in senso largo) alle proposte dei dirigenti politici. È vero che, per la storiografia rumena,
l'insurrezione del 1821 capeggiata da Tudor Vladimirescu era una rivoluzione, ma a parte il
fatto che il dibattito che portava sulla natura di questo movimento non è chiuso, a nostro avviso
essa era troppo legata alla guerra di indipendenza del popolo greco per essere considerata come
strettamente rumena. Nel XVIII secolo, la politica rimaneva ancora l'occupazione di piccoli
gruppi di aristocratici che rappresentavano l'insieme del paese. Tuttavia, nel 1848, la situazione
era differente. A Iasi, la capitale della Moldavia, i rivoluzionari pubblicarono un testo che
menzionava le riforme considerate necessarie per garantire il progresso del paese. Questo
documento, chiamato Petitiune-Proclamatiune, (“ petizione-proclama"), era l'opera di una
commissione eletta all’interno di uno scrutino che riuniva un migliaio di partecipanti; esso fu
sottoposto al principe regnante, Mihail Sturdza, da una delegazione che considerava che egli
rappresentasse il volere dell'intera popolazione. La situazione era molto simile in Valacchia e in
54
Transilvania. Gli assembramenti che raggruppavano talvolta come in Transilvania decine di
migliaia di persone, diventarono l'argomento che legittimava un passo politico che era, dal
punto di vista del sistema politico ancora in piedi, fondamentalmente illegale. Nel sud dei
Carpazi, in Valacchia, i partecipanti al raduno di Islaz approvarono un documento intitolato
"Proclama di Islaz" che diventò il programma del governo rivoluzionario a Bucarest. In
Transilvania, i rivoluzionari rumeni agirono conformemente alle decisioni adottate nella
riunione di Blaj (uno dei centri religiosi dei Rumeni della Transilvania) che confermavano
soprattutto la loro opposizione alla rivoluzione ungherese. Se dei piccoli gruppi conducevano
nei fatti la politica rivoluzionaria, è significativo che era con l'assenso di queste riunioni di
cittadini. I rumeni scoprivano la "voce del popolo", un dato che avrebbe esercitato un'influenza
sulla politica almeno fino alla Prima Guerra mondiale.
La rottura probabilmente più significativa col periodo che precedette la rivoluzione del 1848 fu
la definizione data al concetto di nazione, idea decisiva che stava per segnare con la sua
impronta il periodo successivo, anche se gli sforzi per attribuirgli un contenuto politico rimasero
infruttuosi. I giovani intellettuali rumeni ( per la maggior parte provenienti da famiglie almeno
agiate se non aristocratiche) membri della corrente romantica, concepivano la nazione come una
comunità che doveva riunire tutti i loro compatrioti, gli aristocratici e i plebei, i ricchi e i poveri,
gli intellettuali o la gente del popolo. Il nuovo criterio che permetteva di raggiungere questa
solidarietà era la cittadinanza e le nuove sottomissioni erano fatte ormai alla nazione, alle sue
prerogative e alla sua esistenza politica, e non più a qualche principe, re o imperatore. Lo Stato
rumeno moderno che nasce dall'unificazione nel 1859 della Valacchia e della Moldavia, doveva
porre la nazione nel suo centro, ma questo modello non era senza limiti né contraddizioni. Già
all’inizio del XIX secolo, i rappresentanti della Romania progressista si erano riferiti alla patria
e avevano lanciato appelli al patriottismo, ma il significato che davano a questi concetti era
molto diverso da quello della generazione del 1848.
La vecchia generazione considerava difatti che la patria apparteneva all'aristocrazia, a quelli che
formavano l'élite intellettuale ed economica, ai proprietari delle terre e ai detentori di incarichi
pubblici, in virtù di una tradizione secolare ancora potente. Le conquiste culturali e intellettuali
del secolo delle Luci non furono sufficienti per offrire una nuova prospettiva alla struttura della
società, fu così per una generazione dopo. Il patriottismo era una reazione diretta contro i
principi greci collocati dall'impero ottomano sui troni rispettivi della Valacchia e della Moldavia
a partire dall'inizio del XVIII secolo, e che furono degli strumenti efficaci di assoggettamento di
una regione dall'instabilità crescente. Dopo un periodo di coabitazione, l'aristocrazia greca che
si era stabilita nei principati entrò in conflitto con la nobiltà rumena per l’esercizio della
supremazia su questa regione. Ma questo fenomeno, favorito dall'arrivo delle nuove idee
provenienti dall'Europa occidentale, si sviluppò quasi esclusivamente a livello delle élite. Un
cambiamento sarebbe sopraggiunto due decenni più tardi. La generazione del 1848 ruppe con
questa tradizione e dedicò tutta la sua attività al chiarimento di questo concetto. Per essere
compreso da tutti, Nicolae Balcescu, l'ideologo probabilmente più importante della rivoluzione
in Valacchia, elaborò anche un "manuale" del cittadino. Dopo il fallimento della rivoluzione nei
principati rumeni e in Transilvania, la nazione continuò a rappresentare il principale modello di
coordinamento degli sforzi dei rumeni.
Un'altra discontinuità significativa si riferiva alle prospettive offerte dalla politica europea. Fino
al 1848, una parte considerevole di partecipanti e di responsabili politici aveva intenzione di
stringere con la Russia un'alleanza che, sebbene piuttosto costosa, sarebbe stata suscettibile di
contrastare l'influenza dell’Impero ottomano. Se è vero che la perdita della Bessarabia nel 1812
fu la conseguenza dell'espansionismo russo verso i Balcani, la decisione degli ottomani di
accettare questo indebolimento territoriale fu presa tuttavia sotto l'influenza dei diplomatici
rumeni che lavoravano al servizio della Porta Sublime. Inoltre, la perdita dei territori fu
percepita come un segno del fallimento degli ottomani. Peraltro, gli interventi più o meno diretti
nella vita politica rumena della Russia, anche se questa giocò un ruolo importante mettendo in
opera degli elementi riformistici (nella sua capacità di potenza protettrice di forza di
occupazione che conseguì al trattato di Adrianopoli) convinsero le élite locali ad adottare un
55
punto di vista differente sull'alleanza con la Russia. L'intervento dell'esercito russo contro le
rivoluzioni rumene (nei principati e in Transylvania, confermò le peggiori inquietudini dei
Rumeni. A partire da quest’epoca, la vita politica rumena andava a scindersi tra, da una parte, i
sostenitori di un'alleanza con la Russia e, dall’altra parte, gli oppositori ad una tale intesa. Solo
l'alleanza franco russa conclusa alla fine dell'XIX secolo permise ai rumeni di avere un'opinione
appena differente sul loro potente vicino.
Tuttavia, la rivoluzione fu all'origine della manifestazione di un'altra discontinuità, quella che
esiste tra le generazioni. I giovani aristocratici e intellettuali che, dal 1840, avevano cominciato
a farsi conoscere partecipando alle azioni più o meno pacifiche condotte in favore della riforma
trovarono nella rivoluzione l'opportunità di affermarsi in quanto generazione. Se per la maggior
parte avevano dai venti ai venticinque anni, alcuni di loro (come Ion Heliade Radulescu)
avevano superato la quarantina. Ciò che li univa, non erano solamente i loro obiettivi e i loro
ideali comuni, ma anche i loro studi, effettuati nelle università francesi, tedesche e italiane dove
venivano a contatto con le nuove idee che circolavano in Europa e dove furono iniziati alla
franco-massoneria dai loro professori e i loro compagni. L'importanza che davano alle nuove
idee era tale che essi ritornarono nel loro paese con il desiderio di modernizzare la società
rumena e diventarono, naturalmente, tanti indiziati agli occhi della polizia locale e delle autorità.
Tuttavia, chiamati anche ironicamente i "bonjouristes", adottarono senza esitare un nuovo stile
di vita che si manifestava in tutti i campi, dai vestiti alle buone maniere, della letteratura alle
idee politiche. Conseguenza della loro azione, la politica diventò un'attività quotidiana,
perfettamente dissimulata sotto la copertura di associazioni culturali che pubblicavano delle
opere dall'orientamento politico marcato. Ben presto, si evidenziarono delle tensioni, non solo
nella sfera pubblica, ma anche in seno alle famiglie di questi giovani intellettuali. Un fossato
sempre più profondo si scavava tra i figli e i loro padri in un mondo in cui una scissione
crescente nasceva in termini di stile di vita, di linguaggio e di inspirazioni. In quanto ai padri,
considerevolmente dipendenti dai loro campi agricoli, che vivevano alla moda orientale
(conseguenza delle influenze ottomane e greche) e tributari di un sistema politico che garantiva i
loro privilegi, non comprendevano i loro figli e deploravano il fatto che abbandonavano le
tradizioni. L'origine sociale - questi giovani rivoluzionari erano tutti degli aristocratici) e i
legami di sangue non potevano garantire la stabilità di una società che era cambiata. Questa
situazione è evocata dal monumento eretto alla memoria della famiglia Golescu, a Bucarest,: il
vecchio Dinicu Golescu, grande viaggiatore durante gli anni 1824-1826, è rappresentato nella
magnificenza di un abito orientale e porta una lunga barba, segno del suo status sociale. È
circondato dai busti dei suoi quattro figli che furono tutti delle figure centrali della rivoluzione
del 1848 in Valacchia, vestiti all'occidentale, che portavano favoriti e barbe tagliate corte.
In questo "conflitto" intergenerazionale, i padri e i figli cercarono degli alleati nella figura delle
donne, delle madri e delle spose. Durante il decennio che precedette la rivoluzione, la giovane
generazione aveva scoperto l'influenza che esercitavano le donne in politica e in materia
culturale, ruolo che la vecchia generazione dovette ammettere, anche se con reticenza.
L'elemento innovatore era che, a differenza del periodo precedente durante il quale le donne
erano state totalmente (anche simbolicamente) escluse dalla sfera politica, il messaggio della
generazione del 1848 dimostrava che facevano anche loro parte della nazione. Ciò che si
produsse dopo la fondazione dello Stato nazionale, cioè che si accordò alle donne solo uno
statuto di cittadini passivi (di second’ ordine) è un'altra questione. Nel 1848, le donne facevano
parte integrante della nazione e i politici romantici del 1848 avevano molto da dire su questo
argomento. Per creare la "Romania rivoluzionaria", il pittore Costantino Rosenthal prese per
modello una donna avvolta nella bandiera tricolore (rosso, giallo e blu), che non era altro che la
moglie del dirigente rivoluzionario C. A. Rosetti. La rivoluzione si preparò anche nelle sale da
ballo e i club letterari dell'aristocrazia, dove la donna occupava una funzione centrale che era
lontana dai suoi semplici doveri di padrona di casa, come attestano le memorie e la
corrispondenza dei rivoluzionari del 1848. La storiografia rumena che non è prolissa
sull'atteggiamento e l'impegno delle spose, delle sorelle e delle madri degli uomini del 1848, si
interessa solamente del loro ruolo. Ora, le donne giocarono un ruolo attivo durante la
rivoluzione – sia che si tratti di personalità individuali, come Ana Ipătescu che ha quasi salvato
56
il governo rivoluzionario, che delle anonime nate dalla classe media. I loro contemporanei
maschili, come J. Michelet e G. Garibaldi, riferirono il loro spirito di sacrificio, ma di numerosi
storici non riuscirono a comprendere questo messaggio. Non è esagerato affermare che le donne
fecero il loro ingresso nella vita pubblica e in politica durante la rivoluzione del 1848, ma le loro
responsabilità furono limitate dopo il 1859 e l'inizio del processo pacifico di modernizzazione.
Esse conservarono il loro ruolo di animatrici di salotti letterari e politici, di opere di beneficenza
e, ultimo punto ma non il minore, dell'azione sociale, considerata come una componente
importante della sfera pubblica durante la seconda metà del XIX secolo.
Conclusione
Esaminando la rivoluzione del 1848, ci sembra che il significato di questo avvenimento consista
precisamente nella combinazione degli elementi innovatori e dei vecchi elementi che
compongono la politica rumena nella metà del XIX secolo. Le nuove prospettive che si aprono
sull'esercizio della politica sono indissolubili da un nuovo punto di vista sulla società rumena
considerata come un tutto - anche se non si tratta di un mondo interamente nuovo. La fusione di
questi elementi, il modo di utilizzare il vecchio e il nuovo, costituisce forse il primo segno di
modernità nella politica rumena.
57
Bibliografia selettiva
Albini, S., 1848 in Principatele Romane ("1848 nei principati rumeni"), Bucarest, Ed. Albatros,
1998.
Berindei, D., Revolutia romana din 1848-1849: consideratii si reflexii, ("La rivoluzione rumena
del 1848-1849considerazioni e riflessioni"), Cluj-Napoca, Centrul de Studii Transilvane, 1997.
Maior, L 1848-1849: romani si unguri in revolutie (“1848-1849: Rumeni e Ungheresi nella
rivoluzione"), Bucarest, Ed. Enciclopedica, 1998.
Platon, Gh., Geneza revolutiei romane de la 1848 ("La Genesi della rivoluzione rumena del
1848"), lasi, Ed. Universitatii "AI. 1. Cuza", 1999.
Stan, Ap., Revolutia romana de la 1848 ("La Rivoluzione rumena del 1848"), Bucarest, Ed.
Albatros, 1992.
58
59
7. Libertà e unità: un matrimonio impossibile. Le feste pubbliche del
centenario del 1848" in Germania nel 1948
Rainer Riemenschneider
Introduzione
Il presente contributo si basa su uno studio che ho fatto una quindicina di anni fa. Esso fu
pubblicato in una raccolta dedicata alle commemorazioni del Centenario nel 1989
(Riemenschneider, 1989). A quell’ epoca, la ricerca storica tedesca aveva appena scoperto
l'interesse scientifico della storia delle commemorazioni, della politica della memoria
(Geschichtspolitik), dei luoghi di memoria. I pionieri della ricerca sulla tradizione di
commemorare il 1848 sono, insindacabilmente, Dieter Langewiesche e Wolfram Siemann. Al
loro seguito, assistiamo alla nascita di tutto un florilegio di pubblicazioni, soprattutto nel
contesto del 150° anniversario del 1848 nel 1998 - anniversario che ha visto moltiplicarsi, in
tutta l’Europa, i festeggiamenti e le esposizioni che davano luogo a pubblicazioni di librimemorie e di cataloghi che è impossibile citare qui (vedere, per esempio, Siemann, 2000,;
Hettling, 2000,; Gildea, 2001,; Tacke, 2001). L'edizione scolastica ha evidentemente
approfittato di questa congiuntura favorevole. Per menzionare solamente la produzione tedesca,
la bibliografia dei dossiers pedagogici predisposti per il Georg Eckert Istitut in occasione della
nostra Conferenza conta decine di titoli (2003).
Il nostro studio è basato su una lettura estensiva di periodici quotidiani e settimanali, locali e
nazionali, così come di libri-anniversario, pubblicati nel 1948 in Germania, in occasione delle
commemorazioni del 1848. Dalla lettura emerge che le condizioni generali dell'anno 1948 non
erano propizie alla commemorazione. I molteplici problemi causati dalle distruzioni della guerra
e la mancanza di fondi pesavano troppo sulla vita quotidiana per permettere una vista
retrospettiva serena in un lontano passato nazionale. La preoccupazione massacrante di sapere
cosa ne sarebbe stato del domani, imprimeva tutte le esistenze. I giornali dell'epoca sono pieni
di fatti di cronaca che riferiscono il mercato nero, il contrabbando, la ricettazione,: la piccola
criminalità pullulava a causa delle restrizioni e del razionamento. Quest’ultimo era piuttosto
drastico e fu causa di scioperi molto duri nella primavera del 1948. Ecco ciò che scriveva un
giornale locale dal titolo " Uova di Pasqua": "La razione mensile del consumatore adulto sarà
costituita in aprile da: 1 350 g di pasta alimentare, 9 000 g di patate, 425 g di carne, 600 g di
pesce, 265 g di grasso, 62,5 g di formaggio, tre litri di latte, 1500 g di zucchero, 500 g di frutta
secca. [...] Secondo l'amministrazione delle sussistenze, la razione di pane fissata a 7 000 g
dovrebbe, per quanto possibile, essere aumentata di 1000 g in Bassa Sassonia", Braunschweiger
Zeitung, 18 marzo 1948.
Malgrado queste faticose condizioni della vita quotidiana, appena tre anni dopo la fine di una
guerra "totale" che si era abbattuta con forza sulla Germania, ci si apprestava a commemorare la
Rivoluzione del 1848 - e le attività festive furono ben più numerose in tutto il paese di come si
era comunemente pensato (Sieman, 2000, p. 139). Dei tre anniversari del 1948, cioè il terzo
centenario della Pace di Westfalia del 1648, comprendendo la Guerra dei Trent’ Anni, e il
cinquantenario della morte di Bismarck nel 1898, solo il "1848" incontrò un interesse politico e
pubblico notevole, come sottolinea Edgard Wolfrum. nel suo libro magistrale (Wolfrum, 1999,
p. 396). Si aveva intenzione di fare una grande dimostrazione in favore dell'unità tedesca, ma in
effetti lo svolgimento dei festeggiamenti portò la prova eclatante della divisione sempre più
irreversibile delle due Germanie: la Guerra Fredda nascente cominciò a gelare tutto. Wolfrum
mostra che era precisamente in occasione dei festeggiamenti commemorativi del 1848,
concorrenti nel 1948 a Ovest e a Est che si instaurò il conflitto delle due tradizioni
storiografiche germano-tedesche, caratteristica del dopo-guerra. È ciò che aveva già illustrato
con forza la lettura dei tre momenti forti dei festeggiamenti: le manifestazioni di Berlino il 18
marzo 1948, ricordando le barricate del 1848; la corsa a staffetta a forma di stella che solca le
zone occidentali a metà maggio e che converge su Francoforte- sul-Main; e infine il festival di
60
Francoforte dal 16 al 22 maggio 1948. Nelle pagine che seguono, rivolgeremo la nostra
attenzione a questi tre avvenimenti maggiori delle commemorazioni tedesche.
Nelle rovine ma nella dignità: La commemorazione del 1848 nel 1948
1. Berlino, 18 marzo 1948,
Nella sua seduta del 9 gennaio 1948, il Consiglio comunale della Grande Berlino,
rappresentando la popolazione dei quattro settori della vecchia capitale, aveva discusso del
progetto di festeggiare il 1848 ma non si era potuto mettere d’ accordo sull'organizzazione di
una manifestazione comune. Perciò il 18 marzo 1948, si vissero due manifestazioni distinte che
commemoravano lo stesso avvenimento, cioè il centenario dei combattimenti delle strade che
iniziarono la rivoluzione berlinese. Da una parte, Socialisti (SPD), Cristiano-democratici
(CDU), e Liberali (FDP), avevano scelto di convocare i Berlinesi nella piazza situata davanti
all'edificio del vecchio Reichstag, il Parlamento nazionale,; dall'altra parte, il SED, fusione del
partito comunista e socialista in zona sovietica, teneva uno spiegamento di Gendarmi sulla
piazza. Questa doppia manifestazione fu considerata dai contemporanei come "lo spettacolo più
impressionante della lacerazione tedesca dalla fine della guerra", perché essa era stata preceduta
da dichiarazioni rivali ed ostili sotto l'occhio complice dellePotenze di occupazione (Spiegel, 20
marzo 1948). Berlino aveva due versioni del Centenario del 1848 perfino nel modo di preparare
i luoghi. Per sgombrare le macerie sulla piazza dei Gendarmi, delle squadre della Gioventù
organizzate lavorarono per diversi mesi, con l’uso della pala, incoraggiati dal suono dei pifferi.
In compenso, sulla piazza della Repubblica, davanti al Reichstag in rovina, "dominava la
tecnica". dei bulldozer prestati dall'esercito americano e inglese facevano sparire i frantumi in
una stazione di metropolitana disabilitata. Trentamila metri cubi di rovine sparirono così in dieci
giorni.
Due versioni anche nel modo di recarsi sui luoghi delle manifestazioni: a Ovest, decine di
migliaia di persone si recarono individualmente, alla chiamata del posto radio RIAS Berlino, ad
ascoltare sotto la pioggia battente i discorsi dei rappresentanti dei tre partiti politici. Ad Est,
nello stesso momento, trentamila lavoratori delle fabbriche marciavano al passo, "in lunghe
colonne" dietro alla bandiera rossa del SED e al suono della "Internazionale", verso la piazza dei
Gendarmi. Secondo Spiegel, "è la paura in marcia", ibid.
In queste condizioni, il ricordo del 1848 doveva essere solamente un pallido riflesso, appena un
pretesto per uno scontro retorico più attuale. È ciò che si evidenzia almeno nel modo con cui i
giornali hanno coperto l’avvenimento. Si ha l’impressione che Berlino diventi la posta in gioco
di un conflitto dove si affrontano i due super- grandi: "Dopo il soffocamento delle libertà
democratiche a Bucarest, Budapest e Praga, scrive il Sozialdemokrat, giornale berlinese, Berlino
resta l’ultimo avanposto e la testa di ponte della democrazia nel mondo". Difatti, Berlino è
presentata come il teatro dell'antagonismo Est-Ovest. Il 18 marzo appare come "il giorno del
combattimento decisivo tra la Libertà democratica e le barbarie medioevali", e il giornale
prosegue:
“ sulla piazza della Repubblica si raduneranno le forze che tengono alla cultura e alla
civiltà dell'occidente, alla libertà della persona, al progresso sociale e all'uguaglianza dei
popoli,; sulla piazza dei Gendarmi, coloro che vogliono liquidare i nostri diritti
democratici e la nostra civiltà"( Braunschweiger Zeitung, 18 marzo 1948).
Mentre la parola d’ordine nei discorsi ad Ovest era "per la Libertà - contro la democrazia
popolare"( ibid) la parola d’ ordine a Est era "per l'Unità e la pace giusta" (Spiegel, 20 marzo
1948). "Democratici occidentali" e "democratici popolari", come lo Spiegel li distingue già, si
sono posizionati con l'aiuto dei termini "Libertà" e "Unità". Rivendicando la Libertà, l'Ovest
intende opporsi ai tentativi del SED per la riunificazione della Germania occupata. Il SED
intende dare una legittimazione storica a questo progetto dichiarando: "Cento anni di lotta per la
Repubblica popolare tedesca unita: il Congresso del Popolo dovrà terminare l'opera
61
(Braunschweiger Zeitung, ibid). E Wilhefin Pieck, uno dei capi più in vista del SED, definisce
così l'attualità del 1848: "Siamo il completamento della Rivoluzione incompiuta" (Spiegel, ibid).
Ma questa concezione dell'unità non è consensuale: "Noi non abbiamo il diritto di realizzare
l'unità della nostra patria facendone buon mercato della nostra libertà", dichiarò sulla piazza
della Repubblica il liberale Karl Hubert Schwennicke (Spiegel, ibid). Così iniziano, a partire
dalle nozioni-chiave ma incompatibili di "Libertà" e di "Unità", due visioni della storia tedesca
che daranno adito a interpretazioni inconciliabili del "1848". La divisione politica e ideologica
del 1948 dominava le prospettive storiche, e l'effetto del Centenario fu, a mio avviso, rivelatore.
Lo Spiegel lo diceva con una chiaroveggenza sorprendente e profetica: "A causa della polemica
da una parte e dall’ altra, le barricate del 18 marzo 1848 hanno preso la consistenza di un muro
del 18 marzo 1948". (Spiegel, ibid). Questa sottile ironia non era altro che due storiografie sul
1848 stavano nascendo, tutte due comandate dal Magistrato della Grande Berlino.
Delle manifestazioni identiche a quelle di Berlino del 18 marzo 1948 si moltiplicarono in tutta
la Germania. Numerose città imitarono l'esempio dell'ex capitale. A Braunschweig e a
Norimberga, per esempio, furono anche i partiti politici che presero in carica le attività - nelle
due versioni, evidentemente. Come a Berlino, partito comunista e partito socialista procedettero
a manifestazioni separate ma, a differenza di Berlino, a date diverse ( Braunschweiger Zeitung,
ibid). In queste riunioni che talvolta avevano luogo in locali di fortuna - depositi di tram, per
Braunschweig, debitamente decorati, come sottolineano i giornali - si sentivano discorsi di
celebrità locali, talvolta di deputati del parlamento regionale che riprendevano variandoli i temi
che il loro partito aveva sviluppato a Berlino. Tutte queste manifestazioni si sono svolte
apparentemente senza disordini, in una calma non priva di una certa solennità. Come se tutti
avessero rispettato l'ammonimento di Otto Suhr, presidente del Consiglio comunale di Berlino:
"Questa giornata richiede dignità.”
2. La corsa a staffetta
Se è difficile valutare il numero delle persone che hanno fatto spostare le manifestazioni nelle
varie città nel marzo 1948 - per Berlino, lo Spiegel parla di "decine di migliaia" a Ovest, di
trentamila a Est, mentre un'altra testimonianza parla di 50 000 persone da ogni lato - , sappiamo
almeno che la corsa a staffetta organizzata la metà di maggio mobilitò 20 000 partecipanti,
senza contare i numerosi spettatori che i corridori hanno incontrato sulla loro strada. La corsa
era organizzata a forma di stella, chiamata "Stemstaffellauf”. Essa formava sette rami principali
che partivano per la maggior parte da una città o da un luogo localizzato ai confini della
Germania: Zugspitze, Ulm, Karlsruhe, Kassel, Berlino, Bremerhaven, Flensburg,. Aveva il suo
centro a Francoforte dove convergevano i sette rami che avevano ciascuno delle ramificazioni
laterali. La corsa partì il 15 maggio dai punti estremi; toccando la quasi totalità delle città, si
concluse il 18 a Francoforte, data anniversario della riunione dell'assemblea Nazionale tedesca
del 1848. Tra i 20 000 corridori figuravano campioni dello sport, come a Brema la campionessa
dei100 m Marga Petersen. Il loro compito era di portare i testimoni sottoforma di tubi che
ricevevano, nelle città percorse, dei messaggi che testimoniavano la simpatia delle popolazioni
per Francoforte e la sua Assemblea del 1848. Gli organizzatori di questa corsa che, secondo la
stampa, superò tutte le manifestazioni di massa del dopoguerra (Hannoversche Presse, 15
maggio 1948) erano le municipalità e le associazioni sportive e di canto. La finalità della corsa
sembra essere stata doppia: da un lato, doveva sottolineare il Centenario della riunione
dell'Assemblea Nazionale a Francoforte nel 1848 (Overesch, 1998); dell'altro, doveva essere
"una grande manifestazione in favore dell'unità tedesca" così fu presentata alla popolazione
(Hannoversche Presse, ibid). Il sindaco di Braunschweig, in una dichiarazione alla popolazione,
associò i due obiettivi: il ricordo del 1848 doveva produrre lo slancio per la ricostruzione
politica della Germania. Il passaggio del testimone nelle città dava luogo a una piccola
cerimonia davanti al municipio: allocuzione del sindaco circondato dalle autorità,
rappresentazione ginnica eseguita dalle associazioni sportive, canti dei cori. con il concorso di
queste associazioni molto frequentate, le autorità speravano di rendere probabilmente la
commemorazione del 1848 più popolare. Si ricordava volentieri che il movimento nazionale e
62
unitario del 1848 si basava in parte del movimento associativo. "Cantanti e atleti furono il
simbolo dell'ideale di libertà nel 1848” (Hannoversche Presse, ibid). E il presidente di una
federazione comunale dello sport esclamò con lo stesso spirito: "Che la democrazia diventi
oggigiorno, come allora, per gli sportivi, una faccenda di tutto un popolo"( Hannoversche
Presse, 19 maggio 1948).
Concludere una corsa di tale portata, includendo ventimila partecipanti e coprendo migliaia di
chilometri, implicava un'organizzazione a tutta prova e una disciplina perfetta. Ma i Tedeschi
erano forti in questo campo: c’era bisogno di affermare, come faceva un giornale locale, che il
testimone arrivò "pünktlich", alle 11 precise, davanti al municipio di Braunschweig la domenica
della Pentecoste (Braunschweiger Zeitung, 19 maggio 1948)? E tuttavia, ci furono delle
sbavature. A Flensburg, nel nord dello Schleswig-Holstein girato verso la molto democratica
Danimarca, la corsa ebbe delle difficoltà a iniziare. Il campione dei 400 m siepi Kohlhoff
dovette rinunciare a una grande messa in scena della partenza, una fila di automobili che
clacsonavano furiosamente e un tram che suonava con insistenza, richiedendo imperiosamente il
diritto di passare. In diverse tappe, i corridori previsti mancavano, facendosi scusare per motivi
di lavoro. Si affidò finalmente il testimone a un motociclista che venne obbligato a pranzare in
strada affinché non arrivasse a Schleswig troppo presto. Poiché la cattedrale di questa città era
chiusa a chiave, si festeggiò la cerimonia della tappa in un altro luogo. Una volta superata Kiel,
la corsa continuò a un ritmo regolare verso Francoforte (Spiegel, 22 maggio 1948).
La corsa era solo parzialmente una manifestazione per l'unità tedesca: copriva le sole zone
americane e britanniche. Nella zona francese, la corsa fu vietata perché le autorità di
occupazione francese si opposero per ragioni politiche: "La corsa della Germania miniolimpica, ironizzava lo Spiegel, faceva male al loro occhio sensibile che sorvegliava la
suddivisione federalista della Germania. Essi fiutavano delle dimostrazioni unitarie." (Spiegel,
ibid) E anche i Sovietici la vietarono. Pertanto il testimone di Berlino non potette attraversare la
zona sovietica per via terrestre. Così, dopo aver percorso il settore americano e quello britannico
della vecchia capitale, il testimone dovette essere trasportato per via aerea a Francoforte, e il
ramo della corsa che passava da Braunschweig esordì solamente a Helrnsledf, sulla linea di
demarcazione tra le zone britanniche e sovietiche. Il SED divideva la riprovazione russa: per
Wilhelm Pieck, il centenario a Francoforte non era che l’apparenza della formazione di uno
Stato occidentale (Spiegel, ibid). Così la versione Ovest del movimento verso l'unità nazionale,
nel maggio 1948, era inaccettabile anche per l'Est come era stato il tentativo unitario del SED
per l'Ovest nel marzo 1948.
3. Il festival di Francoforte, 16 22 maggio 1948
Il punto culminante della commemorazione del 1848 fu la "settimana della festa e della cultura",
come l'aveva intitolata ufficialmente il suo organizzatore, il comune di Francoforte, "capitale
provvisoria della Germania occidentale" secondo lo Spiegel (Spiegel, ibid). Questo festival era
dovuto all'impegno personale del sindaco di Francoforte, Walter Kolb che, all’improvviso,
diventava "il sindaco più in vista di tutta la Germania". Una settimana molto piena di molteplici
attività. Menzioniamo qui solo le più importanti: per inaugurarla, l'apertura di un'esposizione sul
1848 presso la Società culturale della città, domenica 16 maggio; la sera, rappresentazione del
Flauto magico di Mozart sotto la direzione di Bruno Vondenhoff. Il 17, il sindaco Kolb, Louise
Schroeder, sindaco di Berlino e Paul Loebe, ex presidente del Reichstag sotto Weimar,
depongono delle corone alla memoria dei morti sulle barricate durante i combattimenti di
settembre 1848 a Francoforte. La sera, Adolf Grimme, ministro dell'Educazione della Bassa
Sassonia, si rivolge alla gioventù sul Römerberg.
Il 18 è il giorno più importante. Dopo un ricevimento, organizzato dall'Università che riunisce
rappresentanti del mondo universitario di diversi paesi occidentali così come i rettori delle
università tedesche - tranne quelli della zona sovietica (Hannoversche Presse, 19 maggio
19448) si celebrò il Centenario della riunione dell’Assembla nazionale nella chiesa di San
Paolo. In una giornata splendida, la folla si accalcava nel centro della città per veder arrivare i
63
corridori rievocati precedentemente. Poi alle 15hl5 precise, il corteo formato degli invitati d’
onore partì dai "Römerhallen" per recarsi, come avevano fatto i deputati nel 1848, al suono di
tutte le campane della città, alla chiesa di San Paolo, sede storica dell'Assemblea del 1848. Alla
testa del corteo, il sindaco di Francoforte, Walter Kolb,; accanto a lui, lo scrittore Fritz von
Unruh che doveva pronunciare il discorso principale e che, a questo scopo, aveva lasciato il suo
esilio negli Stati Uniti d'America. Vennero poi i ministri-presidenti e i ministri di tutti i
"Länder" seguiti dai rappresentanti delle Chiese e i rettori delle Università in grande pompa. Poi
alcune uniformi del governo militare.
Nello spirito degli organizzatori, il corteo che attraversava il centro della città in mezzo ad una
folla numerosa e la cerimonia a San Paolo dovevano riprodurre un po’ dell'ambiente di festa e di
speranza solenne che aveva regnato nel 1848. Ci si era preparati da lungo tempo, soprattutto per
la ricostruzione della chiesa di San Paolo distrutta da un raid aereo che, nel marzo 1944, aveva
lasciato in piedi solo i muri esterni. Considerata come "la casa e il simbolo della democrazia
tedesca", la chiesa doveva essere ricostruita in precedenza. Questo lavoro era presentato dal
sindaco come l'opera di tutto il popolo tedesco, "fatto col legno delle foreste di Turingia,
dell’Est e del Sud,; con le pietre della Hesse e della Renania; col ferro e l’acciaio della Ruhr;
con l'obolo degli operai di Berlino, di Amburgo, di Hannover, di Monaco e di altre città
tedesche"( Braunschweiger Zeltung, ibid).
Qui sono da rilevare due aspetti essenziali: il carattere religioso di cui si sentiva impregnata la
"democrazia tedesca" e l'idea che l'edificazione della Casa comune - nel senso proprio e nel
senso figurato - il risultato dello sforzo di tutta la Germania - almeno in principio. I due aspetti
erano presentati dai contemporanei come appartenenti a un'attualità vivente, che bisognava
ancora sviluppare, e che trovava la sua legittimità nel fatto che riallacciava con l’avvenimento
fondatore che era il “1848". Tutto ciò doveva essere simboleggiato da San Paolo ricostruita nel
1948. Il carattere religioso della politica tedesca si esprimeva attraverso la doppia destinazione
dell'edificio.Esso era "Volkshaus und Gotteshaus", casa del popolo e casa di Dio: "la croce
posta sopra l'edificio ricostruito, apporrà il suo sigillo sia all'azione politica che all'azione
religiosa”.per quanto riguarda il secondo aspetto dell'edificio ricostruito, il concorso di tutta la
Germania sottolineata dal sindaco, bisogna aggiungere che tra le campane di San Paolo che
suonavano fin dalle 8 del mattino il 18 maggio, tre erano state offerte dalla chiesa Evangelica
della Turingia. Atto di fede e gesto politico evidente di una provincia incorporata dal 1945 nella
zona di occupazione russa. Le tre campane provenienti dalla Turingia arrivarono a Francoforte il
20 marzo 1948, il giorno stesso in cui il Consiglio di Controllo Alleato a Berlino si divise in
completo disaccordo. Poteva esserci più grande scarto tra il desideri di unione e la realtà della
divisione?
Malgrado gli sforzi profusi dagli organizzatori per dare alla giornata un'aria di festa, la
recentissima catastrofe si faceva ancora troppo sentire. Il sindaco si sforzava di qualificare il 18
marzo 1848 come la"nascita della democrazia tedesca" alla quale doveva nuovamente
protendere tutte le energie. Non potette trattenersi dal constatare, nella sua allocuzione
inaugurale della chiesa di San Paolo che invece delle belle case a graticcio del "Römer" che
erano state l’orgoglio della città, il corteo costeggiava dei campi di rovine il cui triste aspetto
aveva potuto essere solo in parte dissimulato dalle bandiere e dai rami di abete (Braunschweiger
Zeitung, ibid). Lo Spiegel rilevava il contrasto tra l’ingranaggio ben oleato della festa e la realtà
disastrosa che un'evocazione sdolcinata del passato doveva far dimenticare: "La vista delle
rovine del presente fu velata dalla retorica della commemorazione che faceva vedere solo troppo
spesso la radice del male tedesco, europeo, mondiale" (Spiegel, 22 maggio 1948). Fritz von
Unruh che era andato in fondo alle cose stigmatizzando le responsabilità di quelli che accettano
di servire senza contestare sotto i regimi più diversi, fu colpito da un malessere e dovette
interrompere il suo discorso ( Braunschweiger Zeitung, 19 maggio 1948).
L'indomani, il 19 maggio, il festival proseguì con il Congresso degli scrittori tedeschi che
riuniva circa 400 poeti e scrittori e con la Giornata dell’Unione dell'Europa in cui Henri
Brugmans, dei Paesi Bassi, pronunciò il discorso principale (Hannoversche Presse, 20 maggio
64
1948). Il venerdì 21, una partita di calcio organizzata dal futuro allenatore della squadra
federale, Sepp Herberger, oppose una squadra del Sud a una squadra del Nord (meno la zona
francese e la zona russa): questa "mezza competizione nazionale" attirò 50 000 spettatori allo
Stadio di Francoforte (Spiegel, ibid). Il 22 maggio un "congresso interzonale delle donne "
chiuse il festival, coronato da fuochi d’ artificio al termine di una grande festa dei divertimenti.
Conclusione: La festa introvabile
Si parlò molto del 1848 nel 1948. Si commemorò il Centenario in moltissimi modi e in
numerosi luoghi. La stampa e la radio lo amplificarono. Le iniziative furono prese dai partiti
politici e dai comuni. I sindaci delle grandi città, mi sembra, ebbero un ruolo determinante nella
preparazione e lo svolgimento dei festeggiamenti, più dei capi di governo dei Länder, spesso
ancora mal seduti al potere a causa della creazione recente e largamente astorica di questi nuovi
Stati, e in assenza di un potere centrale. La classe politica in ricostituzione vive nelle diverse
forme di commemorazione del 1848 un'opportunità di farsi conoscere maggiormente e,
attraverso l'evocazione del passato democratico del “1848", un mezzo per contribuire a fare
attecchire di nuovo la democrazia nella società tedesca disorientata da un decennio di dittatura e
di terrore. Il "1848', aveva la funzione di modello pedagogico, e le attività per commemorarlo
somigliarono più a una dimostrazione di psicologia politica che a una festa tradizionale di
anniversario.
La lezione fu compresa, il messaggio ascoltato? Certo, c'era una grande folla a Berlino in marzo
- almeno, ad Ovest la gente era accorsa spontaneamente, ad Est era comandata e non aveva la
scelta di restare a casa propria- e a Francoforte in maggio. Ma essa si era spostata per ascoltare
degli uomini e delle donne politiche dissertare sulle barricate di un tempo? Niente è meno
sicuro, perché il "1848" non sembra essere stato molto popolare. All'università popolare di
Norimberga, cinque persone si erano iscritte al corso sulla " Rivoluzione del 1848-1849",
mentre quello sul Faust di Goethe attirava 250 auditori.
Si è spiegato questo squilibrio tra le infatuazioni per le belle lettere e il disinteresse del 1848
come il segno di una certa apoliticità (Overesch, 1986). La spiegazione mi sembra eccessiva; le
ragioni del disinteresse devono essere cercate altrove. Esse consistono piuttosto nel modo in cui
si è avvertito il 1848. Mi sembra infatti che il sentimento che prevaleva nel 1948 era quello di
una rivoluzione incompiuta, e - più importante – nasceva l’ idea che le conseguenze
dell'incompiutezza della rivoluzione erano state nefaste per l' ulteriore evoluzione. Un
commento non firmato sulla cerimonia di Francoforte, pubblicato l'indomani su un giornale
regionale, è abbastanza rappresentativo di questo sentimento. Sotto il titolo "Libertà
indivisibile", afferma: "Che il popolo tedesco abbia mancato la sua rivoluzione decisiva, è il lato
tragico della nostra storia." E l'autore anonimo continua che la storia tedesca è, di fatto, una
catena di rivoluzioni mancate o fallite che segnano la strada "sulla quale il nostro popolo ha
seguito da lontano le orme di nazioni più felici nella conquista della libertà e della democrazia"
( Hannoversche Presse, ibid).
Argomento sottoforma di programma già sviluppato in un altro giornale in marzo. Col titolo:
"Libertà subito, unità poi", l'autore anonimo constata la lacerazione tedesca causata dalla guerra
fredda nascente, e analizza poi le cause, molteplici, del fallimento della rivoluzione del 1848.
Successivamente passa alle conseguenze dell'insuccesso che, secondo l’autore, hanno sacrificato
la libertà a vantaggio dell'unità, e questo, fatalmente, doveva portare al "precipizio in fondo al
quale ci troviamo". In questa prospettiva, la commemorazione del 1848 non era un motivo di
gioia: "Sarebbero spostati i festeggiamenti del centenario del 1848 in un sentimento di fierezza e
di soddisfazione, come se si trattasse di una tradizione che va da sé ("selbstverständliche
Tradizion"), come il 14 luglio in Francia" (Braunschweiger Zeilung, 18 marzo 1948).
Non si festeggia una rivoluzione fallita dunque, nemmeno del resto una guerra persa. Il
Centenario del 1848 era l'opportunità non tanto di rivisitare la storia tedesca - di ciò, i
professionisti della ricerca storica si erano incaricati fin dalla "catastrofe tedesca" del 1945 - ma
65
di portare, attraverso i media, questa revisione davanti a un pubblico molto più ampio di quanto
non fosse la cerchia limitata dei professionisti della storia. I commenti pubblicati sulla stampa
mostrano a che punto le preoccupazioni del presente determinavano la visione del passato.
L'interpretazione storica è funzione del vissuto al presente e del progetto del futuro: questa
constatazione, banale per lo storico, trova ancora una volta un'illustrazione sorprendente nel
racconto dei festeggiamenti del Centenario del 1848.
66
Bibliografia
Georg Eckert Institute, Braunschweig, Germania, Thematische Auswahllisten von
Unterrichtsmaterialien, No. 24: Von der Restauration bis zur Revolution 1848, 2° ed, aprile
2003.
Gildea, Robert, "1848 in European collective memory" in Dieter Dowe, Heinz-Gerhard Haupt,
Dieter Langewiesche et Jonathan Sperber (ed), Europe in 1848. Revolution and Reform, New
York e Oxford, 2001, pp. 916-37.
Hettling, Manfred, "Shattered mirror. German memory of 1848: From. spectacle to event” in
Charlotte Tacke (ed.), 1848 - Memory and oblivion in Europe, Bruxelles, 2000 (Euroclio No.
19), pp. 79-98.
Overesch, M., Chronik deutscher Zeitgeschichte, Part 3/II, Düsseldorf, 1986.
Riemenschneider, Rainer, '1848 / 1948. Liberté et unité: un mariage impossible. Le centenaire
de « 1848» en Allemagne, 1948', tratto da: «Histoires de Centenaires ou le devenir des
révolutions. Contributions à l'histoire des centenaires des révolutions de 1830, 1848,1870 et
1871 en France et en Europe», in Bulletin de la Société d'Histoire de la Révolution de 1848,
Paris, 1989, pp. 65-75.
Siemann, Wolfram, "Der Streit der Erben - deutsche Revolutionserinnerungen" in Dieter
Langewiesche (ed.), Die Revolutionen von 1848 in der europäischen Geschichte: Ergebnisse
und Nachwirkungen;Beiträge des Symposions in der Paulskirche vom 21. bis 23. Juni 1998,
Munich 2000 (Supplemento No. 29, Historische Zeitschrift) , pp. 123-54.
Tacke, Charlotte, "1848. Memory and oblivion in Europe" in Charlotte Tacke (ed.), 1848 Memory and oblivion in Europe, Bruxelles, 2000 (Euroclio No. 19), pp. 13-27.
Wolfrum, Edgar, Geschichtspolitik in der Bundesrepublik Deutschland. Der Weg zur
bundesrepublikanischen Erinnerung 1948-1990, Darmstadt, 1999.
67
PARTE II
1912-13 nella storia europea
68
69
8. Introduzione all'anno 1913
Può sembrare strano, a prima vista, considerare il 1913 piuttosto che il 1914 come cerniera
potenziale nella Storia europea recente. Numerosi manuali di Storia contemporanea, in
particolare quelli pubblicati in Europa occidentale e negli Stati Uniti, menzionano le guerre
balcaniche del 1912 e del 1913 solamente per i fattori e per le forze che hanno contribuito allo
scoppio della Prima Guerra mondiale.
Tuttavia, la ragione per la quale abbiamo incluso gli eventi del 1912-1913 in questa serie dei
momenti chiave della storia recente dell'Europa è che la prima e la seconda guerra balcanica
sono un elemento importante di un ciclo di liberazione nazionale nei Balcani, ciclo che si è
svolto su due secoli: iniziato nel 1804 con il primo sollevamento serbo contro la dominazione
ottomana, si completerà nel sanguinoso conflitto che ha dilaniato l'ex Jugoslavia dal 1991 a
1995. In quanto tali, queste guerre si inscrivono, dunque, nella storia che vede coincidere il
desiderio di liberazione nazionale e le ideologie nazionaliste, che hanno alimentato queste
aspirazioni sul modello della carta politica dell'Europa del Sud-Est.
Nel 1817, la Serbia conquista una certa autonomia. Nel 1832, la Grecia finisce per liberarsi dal
giogo ottomano ed accede all'indipendenza. Nel 1848, tutta la regione è in preda a sollevamenti
nazionalisti. Al congresso di Berlino, nel 1878, la Serbia e la Romania ottengono l’indipendenza
totale, mentre la Bulgaria diventa una provincia auto-amministrata e l’Impero degli Asbourgo
assume il controllo della Bosnia, dell'Erzegovina e del sandjak di Novibazar. Da allora, la
presenza ottomana nei Balcani si limita all'Albania, alla Macedonia ed alla Tracia, essendo
alcune parti di questi territori cedute alla Grecia, nel 1881, ed alla Bulgaria nel 1885.
Evidentemente, la crescita demografica rapida e tutta una serie di problemi strutturali interni
spingono i dirigenti dei nuovi Stati dei Balcani a voler estendere i loro territori e ad ambire a ciò
che resta dei possessi ottomani in Europa. Ma, ogni volta, l'argomentazione avanzata per
giustificare l'aggressione e la resistenza interna è la volontà di liberare la nazione
dall’oppressione straniera. Il Montenegro, la Serbia, la Grecia e la Bulgaria giustificano la prima
guerra balcanica con il desiderio di liberare il Kosovo e la Macedonia dal giogo ottomano. La
Bulgaria, insoddisfatta dei risultati della divisione della Macedonia, giustifica la seconda guerra
balcanica con la motivazione che la popolazione dei territori macedoni che essa rivendica è
bulgara. All'inizio della Prima Guerra mondiale, la Serbia dichiara che il suo primo obiettivo è
di liberare le terre degli Slavi del sud dalla dominazione degli Asburgo. Ma non appena
quest'obiettivo sembra raggiunto, con la creazione del regno dei Serbi, dei Croati e degli
Sloveni, nel 1918, nuovi disordini si annunciano: gli Albanesi del Kosovo si ribellano, i
nazionalisti macedoni creano l'Organizzazione rivoluzionaria macedone interna, numerosi
Croati e Sloveni cominciano a percepire i Serbi come nuovi dominatori stranieri e movimenti di
liberazione nazionale emergono. Queste divisioni diventano ancora più visibili quando le
potenze dell'Asse occupano la Iugoslavia, nel 1941.
Se il dopoguerra, con il regime comunista di Tito, soffoca queste aspirazioni nazionali, non è
affatto sorprendente che i responsabili politici arrivati al potere in Yugoslavia nel 1990 abbiano
adottato programmi nazionalisti. Il problema, proprio come era accaduto per quasi tutto il 19°
ed il 20° secolo, era che essi non cercavano soltanto di creare degli Stati-nazione, ma anche di
dominare altri gruppi nazionali presenti nei territori che si disputavano.
70
9. Le grandi potenze ed i Balcani: 1878-1914
Ioannis KOLIOPOULOS
Le grandi potenze ed i Balcani fino allo scoppio delle guerre
L'estremità sud-orientale dell'Europa, che formò per secoli la metà occidentale dell'Impero
romano d'Oriente o dell'Impero bizantino, prese il nome di “Balcani” dopo che i Turchi
ottomani presero piede sul continente e divenne il limite occidentale del loro impero tentacolare.
Dei modi di vita primitivi, un nazionalismo militante, l'instabilità e la guerra costituirono
altrettante immagini associate a questa regione; diciamo piuttosto che l'Occidente decise di
descriverla così, per soddisfare le sue inclinazioni e necessità intellettuali e politiche (Todorava,
1997). I feroci e turbolenti Albanesi, Serbi, Greci o Bulgari ebbero tuttavia i loro equivalenti in
Europa occidentale non molto tempo fa; quanto ai conflitti religiosi o nazionali dei Balcani,
essi non ebbero mai la violenza di quelli che sconvolsero l'Occidente nel corso del XVI e XVII
secolo o più ancora nel XXe secolo. Gli atti di brutalità tra le comunità e la pratica della pulizia
religiosa o nazionale sono stati perpetrati con uguale intensità all'est e all'ovest del continente.
Quest'immagine di una punta sudorientale dell'Europa agitata da disordini influenzò i servitori
di Clio nella ricerca della verità e della realtà che presiedeva alla loro analisi degli avvenimenti
e delle evoluzioni storiche a tal punto che il principio di autodeterminazione nazionale (che
l'Occidente aveva accettato come una motivazione principale e legittima per i coloni americani
insorti contro il re d'Inghilterra e per le popolazioni italiane o tedesche dell'impero degli
Asburgo opposte al loro monarca) non fu ammesso così volentieri riguardo Greci, Serbi,
Albanesi o Bulgari del sultano ottomano. Nel 1912, le grandi potenze europee non erano
disposte, per ragioni che erano loro proprie, a lasciare gli Stati-nazione della regione, spogliare
il sultano ottomano e l'imperatore asburgico di territori come l'Albania, il Kosovo, la Bosnia,
l'Epiro, la Macedonia o la Thrace. Questi vecchi imperi in declino furono così mantenuti in vita
per paura che la loro scomparsa creasse un vuoto di potere e determinasse dei dissensi tra gli
Stati-nazione che sarebbero loro succeduti e le grandi potenze che li sostenevano.
Questi timori non erano illegittimi e non preoccupavano soltanto Francesco-Ferdinando ed
Abdul Hamid. L'impero multietnico non rappresentava un modello così inutile o superato come
sostenevano i partigiani dello Stato-nazione; questo era il punto di vista di individui i cui
progetti differivano da quelli dell'imperatore asburgico o del sultano ottomano. I seguaci di
questi imperi, benché non fossero esattamente dei rappresentanti de "l’ancien régime" o
ammiratori del principe KIement von Metternich, giudicavano gli imperi dell'Europa centrale ed
orientale utili e anche indispensabili al mantenimento di una forma di pace e di ordine pubblico
in una regione che comportava una moltitudine di popolazioni dalle confessioni, lingue o
identità diverse. Quest'idea aveva spinto i due imperi a fare degli sforzi considerevoli per
riformare e consolidare le strutture deboli; le riforme in corso rafforzarono ancora la posizione
di quelli che difendevano questo punto di vista. Quelle che aveva intrapreso la monarchia
austro-ungarica miravano a consolidare i due imperi vacillanti ed a convincere le province non
tedesche che la loro adesione all'impero attraeva più della prospettiva di un'appartenenza ad uno
Stato degli Slavi del sud, che offrivano loro i Serbi; fu anche il caso delle riforme liberali
annunciate dai Giovani Turchi nel 1908. Delle opinioni simili, motivate da altre preoccupazioni
e che servivano dei progetti diversi, furono difese in Grecia da sradicati come Ione Dragoumis
ed un cénacolo di pari sensibilità. Delusi dai risultati e dal bilancio dello Stato-nazione ellenico,
essi erano in cerca di una "soluzione" diversa da quella dello Stato-nazione, sotto la forma di un
Impero ottomano rimaneggiato, nel quale il patriarca ecumenico greco ortodosso avrebbe
esercitato la sua autorità su tutti i cristiani greci ortodossi dell'impero.
Questa posizione a favore del rafforzamento di questi Imperi multietnici dell'Europa centrale ed
orientale che erano allora in pieno declino, adottata durante il primo decennio dello XX secolo
da diverse parti, sembrava abbastanza moderna agli occhi di quelli che stigmatizzavano lo Stato-
71
nazione, nel quale vedevano la causa di tutte le guerre disastrose che insanguinarono il XX
secolo. Per i detrattori postmodernisti dello Stato-nazione, partigiani della formazione di società
e di Stati multiculturali e multietnici, questa concezione favorevole agli imperi multinazionali
della regione, che era stata avanzata all'inizio del XX secolo, prometteva una ristrutturazione
salutare di questi ultimi e delle diverse comunità che essi accoglievano.
La Grecia
Dal lato greco della frontiera con i territori rivendicati dagli Stati-nazione che esistevano allora,
cioè la Grecia, la Serbia, Montenegro e la Bulgaria, quegli stessi che formarono nel 1912 la
Lega balcanica e spogliarono il sultano ottomano della maggior parte dei suoi possessi
territoriali dell'Europa, non esisteva alcun reale dibattito sulla questione di detti territori; gli
ambienti intellettuali e politici provavano piuttosto un certo disagio e qualche timore sul futuro
riservato ai Greci. Il disastro e l’umiliazione della guerra del 1897 contro la Turchia avevano
rivelato i limiti della capacità della nazione greca di affrontare da sola la Turchia.
La guerra prolungata tra le fazioni greche e bulgare o contro le forze di cui disponevano i Turchi
in Macedonia contribuì molto poco ad alleviare i timori che suscitava in Grecia il futuro della
Macedonia e dei territori adiacenti. Ion Dragoumis ed un certo numero di suoi amici
accarezzavano l'idea di un "Impero greco ortodosso" in seno ad un Impero ottomano
rimaneggiato e riformato. Nel clima favorevole instaurato dalla sommossa dei Giovani Turchi
del 1908, tali progetti non sembravano né stravaganti né ridicoli, benché, in realtà, lo fossero.
Questo"Impero", che riuniva i cristiani ortodossi greci sotto l'egida dei Greci dell'Impero
ottomano, passava anche per essere stato un sogno accarezzato dall’élite fanariota prima della
guerra d'indipendenza greca degli anni 1820. Arnold Toynbee, che associava quest'idea ai
Fanarioti, conosceva apparentemente molto poco quest'élite prenazionale greca; sembra tuttavia
essere stato influenzato da questi stessi avvenimenti e dalle loro interpretazioni che
determinarono precisamente la posizione di Dragoumis e del suo gruppo di greci sradicati.
Mentre Dragoumis giudicava il modello dello Stato-nazione greco superato ed inutile, Toynbee
considerava lo Stato futuro come un sogno inaccessibile dei liberali occidentali, assolutamente
incapace di integrare le istituzioni liberali occidentali (Dragoumis, 1985; Toynbee 1922,1981).
Un uomo molto diverso da Dragoumis si situava all'opposto di quest'ultimo: Eleutherios
Venizelos, un grande uomo di Stato cretese che cominciava allora una brillante e tumultuosa
carriera politica in Grecia. Venizelos non aveva alcun dubbio né alcuna illusione su ciò che il
futuro riservava alla Grecia, purché i servitori dello Stato gli affidassero il potere indispensabile
alla guida del paese. Egli credeva fermamente che il regno un tempo instabile, che Dragoumis
scherniva e disprezzava, rappresentava un formidabile strumento nelle mani degli individui
capaci, posti sotto la sua autorità. In realtà, egli era convinto che lo Stato greco costituisse il
solo mezzo suscettibile di garantire il futuro dei Greci. La "grande idea", che in passato era
spesso sembrata favorire i disegni di quelli che progettavano una insurrezione panellenica dei
Greci dell'Impero ottomano e la loro unione in seno ad un Impero greco, non aveva altro scopo,
nello spirito di Venizelos, che di permettere l’annessione, attraverso il regno della Grecia, di
tanti territori limitrofi di quanti gli sarebbe stato possibile impadronirsi e ciò, egli sperava, con
la collaborazione degli altri Regni della regione, per meglio salvaguardare queste conquiste
territoriali (Veremis, 1980,1989).
Venizelos che era stato favorevole alla rivoluzione contro l'ordine stabilito prima di riversare le
sue ambizioni sul regno della Grecia, non credeva più nelle insurrezioni dei Greci dell'Impero
ottomano del tipo di quelle che il regno aveva fomentato, presso gli irredentisti dei dominions
europei del sultano, nel corso di tutto il diciannovesimo secolo. Egli era in grado di misurare la
debolezza essenziale: erano condannate al fallimento, poiché non si basavano su un esercito
nazionale regolare, ma piuttosto su uomini in armi di ogni risma arruolati sul posto, tra cui
briganti, e perché le grandi potenze europee non avrebbero permesso lo smembramento
dell'Impero ottomano.
72
Le potenze protettive della Grecia, cioè l'Inghilterra, la Francia e la Russia, si opponevano, in
particolare le prime due, che i greci turbassero la pace nella regione. Questo atteggiamento
aveva condotto i governi greci successivi a privilegiare il ricorso a fazioni irregolari per favorire
i disegni irredentisti del regno, provocando il sollevamento dei territori greci sotto la
dominazione straniera, cosa che aveva avuto per effetto di mettere in piedi un formidabile
contingente di uomini in armi che si presentavano come il vero esercito della nazione e
depredavano quasi sempre impunemente i contadini (Koliopoulos, 1987). Venizelos non
intendeva proseguire su questa via, poiché era deciso a costituire un esercito regolare potente e
credibile, ciò che riuscì a fare con l'aiuto di ufficiali francesi quando arrivò al potere.
L'uso di metodi irredentisti simili in Bulgaria e negli altri paesi della regione favorì l'ascesa di
uomini come Venizelos, che desideravano mettere un termine a vecchie abitudini che avevano
la vita dura. L'abbandono delle pratiche e degli obiettivi deludenti del passato dovette molto ad
alcune modifiche profonde del sistema di sicurezza europeo. Le due alleanze di grandi potenze
europee, la Triplice Alleanza stabilita tra la Germania, l'Austria-Ungheria e l'Italia, così come la
Triplice Intesa, che riuniva l’Inghilterra, la Francia e la Russia, si erano unite in due campi
militari opposti che, per timore di una guerra che avrebbe infiammato tutto il continente,
avevano costretto le potenze ad evitare ogni provocazione. La pace era così garantita dalla
minaccia imminente di una deflagrazione generale. La moderazione di cui davano prova le
grandi potenze indusse i piccoli Stati a mantenere i loro schieramenti regionali, con l'intenzione
di prendersi la rivincita ed iniziare le ostilità localmente.
La Lega balcanica
La Lega balcanica del 1912 vide la luce nel quadro di questa moderazione che le grandi potenze
europee si imposero. Il tradimento dello zar russo da parte dell'imperatore austro-ungarico nel
1908, quando l'Austria-Ungheria annesse la Bosnia-Herzegovina, senza informare prima la
Russia contrariamente al passato accordo, provocò l’umiliazione di quest’ultima privandola
dell’ occasione di impadronirsi dei distretti. Desideroso di trovare una sorta di compensazione
nella regione alla quale riteneva di avere diritto, il governo russo assicurò agli Stati slavi
dell'Europa del Sud-Est il suo sostegno nella comune azione contro l'Impero ottomano. La
guerra italo-turca del 1911-1912 agì come un catalizzatore: un membro della Triplice Alleanza
era in guerra con l'Impero ottomano e "le grandi potenze europee erano ancora una volta
chiamate a confrontarsi su una crisi riguardante la Questione orientale (v. Helmreich, 1938,
Tricha et Gardika-Katsiadaki, 1993).
Gli incoraggiamenti insistenti della Russia portarono all'alleanza della Serbia e della Bulgaria e
costrinsero i due Stati a mettere a punto un’azione comune contro la Porta. Gli obiettivi militari
non furono precisati; la parte dela torta che sarebbe spettata a ciascuno doveva dipendere dalla
fortuna delle armi, mentre la mediazione dello zar, prevista in caso di disaccordo sulla
spartizione, tradiva il protettore interessato di questa alleanza. Si trattava così di un'alleanza
slava motivata dal desiderio della Russia di prendere il sopravvento sulla sua rivale, l’AustriaUngheria, come pure dal desiderio della Serbia e della Bulgaria di soddisfare le loro
revendicazioni territoriali a spese dell'Impero ottomano e, all’occorrenza, delle pretese
territoriali greche che sarebbero andate nello stesso senso.
Il tempo della guerra di Crimea, dove l'azione comune di tutti i cristiani ortodossi della regione
sotto l'egida della Russia appariva come una missione sacra assegnata da Dio agli ortodossi dell’
Europa dell'Est, era passato. Gli Stati della regione giungevano a una certa maturità ed
assimilavano i mezzi messi in atto dai Paesi occidentali a cui si ispiravano. Uomini nuovi
respingevano la retorica e le suscettibilità di un tempo e raccoglievano le loro forze per agire
alla maniera di Camillo di Cavour, Otto von Bismarck e Napoleone III.
L'alleanza slava
73
L'alleanza slava del 1912 fu per la Grecia fonte di nervosismo e di preoccupazione, giustamente
del resto. Molto più dell'accordo di Bled del 1947, tra il maresciallo Tito e Georgy Dimitrof in
vista della creazione di una federazione yougoslavo-bulgara e dell'unione della Macedonia
bulgara del Pirin e della Repubblica popolare di Macedonia di allora, l'alleanza serbo-bulgara
del 1912 rappresentava per la Grecia una minaccia senza precedenti. E’ opportuno notare che
nel 1912, contrariamente al 1947 in cui la Grecia poté contare sulla protezione dell'Inghilterra e
degli Stati Uniti per contrastare il pericolo che rappresentavano la Iugoslavia e la Bulgaria
comuniste, il paese si trovava praticamente isolato in una nuova serie di azioni militari che
sembravano sul punto di essere intraprese nella regione per privare il sultano ottomano di un
certo numero di territori.
Venizelos era in grado di distinguere la grave minaccia che la Serbia e la Bulgaria facevano
pesare, alleate sugli interessi della Grecia; non esitò un secondo a fare entrare il suo Paese
nell'alleanza slava. Venizelos non fu sorpreso di constatare che la Bulgaria era sensibile alla
proposta greca: essa era abbastanza forte per accettare un socio la cui sola carta era la marina.
La Bulgaria possedeva infatti di gran lunga l'esercito più potente della regione ed il suo ruolo
sulla terraferma sarebbe certamente risultato determinante. Inoltre essa beneficiava del sostegno
incondizionato della Russia, di cui era considerata l'artefice nel conflitto che si annunciava nella
regione. In questo senso, il ravvicinamento della Grecia di fronte alla Turchia costituiva tanto
una misura difensiva riguardo alla Bulgaria che una manovra offensiva nei confronti della
Turchia.
Gli eventi della regione precipitavano troppo rapidamente perché la Grecia vi potesse fare fronte
da sola. L'intesa fragile che esisteva un tempo tra la Grecia e la Turchia per evitare la
spartizione dei possedimenti europei del sultano, di cui sapevano entrambe che sarebbe
avvenuta a proprie spese, era sminuita e minata dal sentimento di potenza infuso all'Impero
ottomano dai Giovani Turchi dopo il 1908 e la nuova missione che essi avevano loro assegnato.
Inoltre, questi ultimi non dissimulavano la loro intenzione di ristrutturare il vecchio apparato e
trasformarlo in uno Stato-nazione moderno simile a quelli che gli erano succeduti nella regione.
La concezione che avevano i Giovani Turchi del futuro non lasciava alcun posto alla Grecia.
La guerra
La guerra fu iniziata nella regione nell'ottobre 1912 ed imposta alla Turchia, come ci si poteva
aspettare, da parte degli Stati che l'avevano sostituita. La Serbia, il Montenegro, la Bulgaria e la
Grecia piombarono sull'Impero ottomano e si impadronirono di tanti territori quanti permise
loro l’avanzata delle loro proprie forze sulla terraferma. Il conflitto conobbe un certo numero di
risultati e di fallimenti inattesi, in particolare lo sfondamento delle truppe greche che, dal sud, si
addentrarono in profondità nelle zone franche slavofone di Macedonia rivendicate dalla
Bulgaria, l'avanzata rapidissima della Serbia in questa stessa Macedonia che era oggetto delle
rivendicazioni bulgare, ma in direzione della quale l’ avanzata della Bulgaria fu rallentata
dall’incontro con il grosso delle forze ottomane in Tracia, come pure l’intervento dell'Italia e
dell'Austria in nome dello Stato-nazione albanese da poco tempo creato.
Questa piega imprevista presa dalla guerra produsse una situazione radicalmente diversa nella
regione. La vittoria della Serbia e del Montenegro permise loro di estendersi in profondità nel
territorio macedone sul quale portavano le mire bulgare e respingere il nuovo Stato albanese più
al sud, in Epiro, che la Grecia desiderava annettere. Con l'estensione territoriale serba al
Kosovo, l'Epiro settentrionale sfuggì alla Grecia e diventò l'Albania meridionale. La Grecia si
rifece facendo la parte del leone in Macedonia. Dopo il fallimento della conferenza di Londra, la
Bulgaria si impegnò in una seconda campagna militare, questa volta contro la Grecia e la
Serbia. Oltre ai suoi vecchi alleati, ora affrontava anche la Romania e la Turchia. La Bulgaria
correva incontro al disastro che non mancò di verificarsi.
In materia territoriale, l'estensione di uno Stato significava il restringimento di un altro. La
Turchia fu la principale vittima di questo rimaneggiamento delle frontiere. Ci si poteva
74
certamente attendere che subisse perdite territoriali, ma non di tale ampiezza. La Bulgaria ne
uscì anche perdente, ed in modo del tutto inatteso. La disposizione dell'Albania assunse un
aspetto imprevisto, in particolare perché si spostò verso il sud sotto la spinta serba. Il Trattato di
Bucarest dell'agosto 1913, che mise fine al conflitto militare nella regione, contribuì molto poco
ad attenuare i risentimenti turchi e bulgari e lasciò una considerevole mole di rivendicazioni e
contro-rivendicazioni insoddisfatte.
La situazione del dopo-guerra
Le due campagne militari ed il trattato che mise termine a queste ultime rappresentarono il
trionfo dello Stato-nazione sul vecchio ordine che prevaleva in questa parte del continente.
Nello spazio di meno di un anno, la carta politica della regione era diventata irriconoscibile: dal
Danubio a Creta e dall'Adriatico al Mar Nero, profondi cambiamenti avevano avuto luogo o
erano sul punto di verificarsi. Gli uomini di Stato fecero il conto delle espansioni o delle perdite
territoriali, mentre i giornalisti e gli altri osservatori cercarono di fare il punto della nuova
situazione (v., ad esempio, la tesimonianza vivente di Crawford Price, 1915).
Essa presentava una realtà singolare e di cattivo auspicio: le Comunità formate nell’insieme
degli Stati della regione da popolazioni "diverse", che furono definite "minoranze". Numerosi
secoli di spostamenti e di insediamenti più o meno pacifici di popolazioni in questa parte
d'Europa avevano derminato la loro relativa mescolanza, che metteva alla prova le attitudini e
l'immaginazione dei pubblici poteri (Rapporto Carnegie, 1914r). Le autorità non erano a
conoscenza dell'esistenza di queste popolazioni "diverse" sul loro territorio o, almeno, i pubblici
poteri non sembravano giudicare che la questione dell’eterolinguismo meritava la loro
attenzione. La lotta per la preminenza educativa ed ecclesiastica che fu impegnata in Macedonia
nel periodo che precede la rivoluzione giovane-turca attesta dei primi atti di discriminazione
gravi perpetrati contro i locutori di una lingua straniera: i Greci, in particolare in Bulgaria ed in
misura inferiore in Romania, subirono, in ritorsione all'azione condotta da una fazione greca in
Macedonia, ciò che fu chiamata più tardi una pulizia etnica, nel corso della quale i Bulgari ed i
Rumeni definirono fratelli rispettivamente gli Slavi ed i Valacchi.
L'omogeneità dello Stato-nazione non era affatto diffusa nella regione, contrariamente a ciò che
potrebbero lasciare credere le critiche recentemente formulate in occidente sulla pulizia etnica
praticata negli anni 1990. Gli Stati nazioni di questa parte dell'Europa iniziarono soltanto ad
applicare a casa propria pratiche in uso da moltissimo tempo all'ovest del continente. Inoltre,
durante il periodo che ci interessa qui e prima che la società multiculturale diventasse una forma
di composizione sociale accettabile in Occidente, la società linguisticamente e religiosamente
omogenea di uno Stato era considerata come la norma, e non come un'eccezione. L'omogeneità
rappresentava una fonte di potere e di sicurezza ed ogni misura volta a realizzarla non sembrava
né straordinaria né inaccettabile.
Due ragioni almeno, che si ha tendenza a dimenticare, portarono il movimento che mira a
garantire questa cara omogeneità nazionale a prendere l'aspetto sinistro che gli conosciamo:
l'assenza in quel tempo di un'organizzazione di regolazione internazionale suscettibile di
preoccuparsi della protezione delle minoranze minacciate o d’intervenire in loro favore e la
localizzazione della maggior parte di queste minoranze locali in zone frontaliere, limitrofi degli
stati che consideravano i loro membri come i fratelli dei propri cittadini.
Il diritto internazionale era lungi dal comportare la regolamentazione e gli strumenti
indispensabili ad una protezione efficace delle minoranze. Sembra che occorresse alla comunità
internazionale sopportare due guerre mondiali spaventose perché pensasse, finalmente, a
stabilire norme ed organi destinati a proteggere le minoranze vulnerabili. Gli eventi recenti
sopraggiunti in questa stessa regione ed in altre parti del globo mostrano quanto cammino
rimane da percorrere in materia.
75
Le guerre balcaniche del 1912-1913 generarono molte minoranze frontaliere di questo tipo nella
regione. Esse furono spesso le vittime di autorità statali ostili, non tanto perché i loro membri
differivano dalla popolazione maggioritaria dello Stato, quanto perché rappresentavano
soprattutto una minaccia per la sicurezza di quest'ultimo o erano percepite come tali. Le
rivendicazioni sollevate dai paesi limitrofi, la cui popolazione maggioritaria era simile ad una
minoranza linguistica o religiosa stabilita dall'altro lato della frontiera, minavano la posizione di
quest'ultimo e, nello stesso tempo, ritardavano la sua incorporazione e la sua assimilazione
sociale in seno allo Stato-nazione.
Conclusioni
Le terribili sofferenze ed umiliazioni sopportate dalle minoranze degli Stati-nazione, seguite
all'Impero ottomano nella regione, non possono costituire un'argomentazione a favore del
regime precedente.
Gli Stati-nazione della regione, che uscirono rafforzati dalle guerre balcaniche, praticarono a più
riprese una cattiva gestione delle minoranze che avevano ereditato; ma liberarono nello stesso
tempo popolazioni molto più numerose dal giogo dispotico e tirannico di un potere autocratico
che si era rivelato incapace di riformarsi e fecero nascere in esse un sentimento raro, o
inaccessibile: l'orgoglio di cittadini liberi di praticare la propria lingua, usufruire della propria
cultura e mantenere la propria identità.
I politologi, ed a volte gli storici si impegnano spesso sul terreno scivoloso degli insegnamenti
tratti dal passato. Ma lo storico che studiasse in modo retrospettivo gli obiettivi, le politiche,
come pure le azioni degli stati e dei loro rappresentanti, che presero parte alle guerre balcaniche
quasi un secolo fa, si troverebbe molto imbarazzato a trarne un insegnamento. Una prima
osservazione si impone tuttavia: i calcoli e le aspettative dei diversi protagonisti furono sventati
dalla sorte mutevole delle armi e dal risultato dei due confronti successivi.
E’ anche il caso di constatare che se questi stessi protagonisti fossero inizialmente preoccupati a
garantire la loro sicurezza, quest’ ultima e la pace risultarono difficili da realizzare dopo il
conflitto, come lo erano state prima. Inoltre, malgrado le assicurazioni contrarie date spesso da
più parti, l’annessione dagli Stati interessati,di qualsiasi territorio che si trovava alla loro
portata, dimostra ciò che era il loro obiettivo primo, tanto è vero che i conflitti tra Stati sono
stati sempre motivati soprattutto dalla sete di nuove conquiste territoriali. Osserviamo a questo
proposito che le intese e gli accordi precedenti furono spazzati via dalla tempesta guerriera fin
dall'entrata in guerra; gli Stati alleati della regione appresero così ciò che l'Occidente sapeva per
esperienza già da molto tempo: gli accordi stabiliti potevano essere violati non appena
l’interesse nazionale lo richiedesse.
La Lega balcanica del 1912 fu la prima lega di questo tipo, nel senso che riuniva i tre principali
Paesi che contestavano al sultano ottomano i possedimenti che conservava ancora nella regione,
cioè la Grecia, la Serbia e la Bulgaria. Subito dopo il 1912, questi tre Stati non hanno mai fatto
parte insieme ed nello stesso momento di una stessa alleanza. Speriamo che la Serbia e la
Bulgaria raggiungeranno il più presto possibile la Grecia in qualità di membri di una Unione
europea preoccupata di raccogliere in modo uguale le sfide sulle quali si sono confrontati gli
Europei e condotte da uomini la cui concezione dell'Europa differisce da quella che alimentò i
conflitti del tipo delle guerre balcaniche.
76
Riferimenti bibliografici
Camegie Endowment for international Peace, Report of the Intemational Commission to Inquire
into the causes and the Conduct of the Balkan Wars, washington DC, 1914.
Dragoumis, ion, Phylla hemerologiou ('Diary leaves'), ed. Thanos Veremis et J. S. Koliopoulos,
Atene, 1985.
Helmreich, C., The diplomacy of the Balkan wars, 1912-1913, Cambridge MA, 1938.
Koliopoulos John S., Brigands with a cause: Brigandage and irredentism in modern Greece.
1821-1912, Oxford, 1987.
Price, Crawford, The Balkan cockpit, Londra, 1915.
Todorov Maria, Imagining the Balkans, New York, 1997.
Toynbee, Arnold, The western question in Greece and Turkey, Boston, 1922.
Toynbee, Arnold, The Greeks and their heritages, Oxford, 1981.
Trcha, Lydia e Gardika-Katsiadaki,Eleni (ed), E Hellada ton Valkanikon Polemon,1910-1914
(La Grecia nelle guerre balcaniche 1910-1914), Atene, 1993.
Veremis, Thanos (ed.), Meletemata gyro apo ton Venizelo kai tin epochi tou (Studi su Venizelos
e la sua epoca), Atene, 1980.
Veremis, Thanos (ed.), Eleutherios Venizelos: Koinonia - oikonomia - politike stin epoche tou
(Eleutherlos Venizelos: Società, economia e politica nel suo tempo), Atene, 1989.
77
78
10 Le ripercussioni delle guerre balcaniche del 1912-1913 sulla vita
quotidiana dei civili
Helen GARDlKAS-KATSIADAKIS
Ricerche sull'argomento
Non esiste a mia conoscenza alcuno studio dedicato alle ripercussioni economiche e sociali
delle guerre balcaniche in Grecia, ancora meno riguardo la loro incidenza sulla vita quotidiana,
ad eccezione di alcuni capitoli delle opere del professore greco di finanze pubbliche Andreas
Andreadis. Il volume che si avvicina di più è quello che si intitola Gli effetti economici e sociali
della guerra in Grecia, nella serie Storia economica e sociale della guerra mondiale pubblicata
nel 1928 dalla Fondazione Carnegie per la pace internazionale. Questo compito infatti si sarebbe
rivelato praticamente impossibile per il periodo limitato alle guerre balcaniche. Cme fa
osservare il delegato greco della Commissione dei profughi della Società delle Nazioni,
Alexander Pallis, nel suo studio dedicato agli effetti della guerra sulla popolazione greca inserita
in quest'opera collettiva:
“la Grecia ha conosciuto, dal 1912 al 1923, un periodo di guerra quasi ininterrotta." Nel
corso di questi dodici anni, infatti ha preso parte a cinque campagne militari, cioè la
prima guerra baIcanica contro la Turchia nel 1912-1913, la seconda guerra baIcanica
contro la Bulgaria nel 1913, la guerra europea alla quale ha partecipato a partire dal
1917 a fianco dell'intesa, la spedizione di Ucraina intrapresa su richiesta degli alleati
contro i Bolscevichi nel 1919 e, infine, la guerra greco-turca del 1919-1923 "(Pallis,
1928, p. 131)."
Queste guerre, che siano vittoriose come le prime tre o disastrose come l'ultima, determinarono
delle modifiche territoriali considerevoli e lo spostamento di milioni di persone, che ebbero
ripercussioni sulla vita quotidiana della gente comune e trasformarono le carte demografiche ed
etnologiche della regione. Tuttavia, per quanto riguarda in particolare i cambiamenti sociali,
risulta estremamente difficile distinguere tra gli effetti a breve termine delle guerre balcaniche
ed i cambiamenti a lungo termine dell'insieme di questo periodo.
Il presente esposto non riguarderà le questioni demografiche e tecnologiche. Basti precisare che
le guerre balcaniche causarono in Grecia uno sconvolgimento sociale o economico rilevante. Le
conseguenze furono spettacolari dal punto di vista dell'espansione tanto geografica quanto
demografica: la Grecia raddoppiò praticamente di superficie e di popolazione.
Superficie in km
Popolazione
1907
65029
2.631.952
1914
118784
4.881.052
%
82,66
85,45
Più importante ancora, il paese cambiò natura, poiché per la prima volta dalla sua adesione
all'indipendenza includeva gruppi etnici abbastanza importanti diversi dalla popolazione
cristiana ortodossa ellenofona predominante. In realtà, in alcune regioni, le Comunità cristiane
ellenofone ortodosse formarono una minoranza.
Per misurare le ripercussioni delle guerre sulla vita quotidiana in Grecia, mi baserò, per
mancanza di documentazione di prima mano, su fonti narrative (memorie, lettere, ecc.).
Due guerre
79
Gli effetti socioeconomici delle guerre sulla popolazione civile media non furono spettacolari
nelle regioni che componevano il regno prima del 1912, quelle che furono chiamate allora le
"vecchie province". La situazione del cittadino greco comune, del regno precedente al 1912, non
conobbe alcun miglioramento né deterioramento nel corso dell'immediato dopo-guerra. Il lungo
periodo di guerra che rappresentò la prima guerra mondiale, le conseguenze che seguirono e le
sue ripercussioni nazionali drammatiche tendono ad influenzare il nostro giudizio ed a lasciarci
credere che le guerre balcaniche, da cui il paese uscì tuttavia vincitore, ebbero un effetto
pregiudizievole sulla vita quotidiana. Le due guerre del 1912 ed il 1913 formarono due conflitti
distinti, relativamente brevi. Inoltre, benché la popolazione maschile restasse sotto le armi per
poco più di tredici mesi (da settembre 1912 a dicembre 1913), i periodi di reali combattimenti
sui diversi fronti ed in mare coprirono appena sette mesi in totale. L'insoddisfazione sociale
causata dai lunghi periodi di mobilitazione e da campagne militari prolungate, estenuanti ed
infelici, sopraggiunse successivamente.
Si tratta di una valutazione generale. Esaminiamo ora in modo dettagliato, nella misura in cui ce
lo consentono gli elementi di cui disponiamo , gli effetti delle guerre:
●
●
sul fronte, fra le truppe mobilitate e la popolazione dei territori occupati
sulla popolazione delle retrovie, nelle zone rurali e nelle città.
Nel 1912, la popolazione maschile della Grecia reagì al decreto di mobilitazione generale del 19
settembre con un sentimento di orgoglio nazionale e di apprensione. I brutti ricordi del conflitto
precedente del 1897 erano ancora vivi, benché quella sconfitta umiliante non fosse stata subita
dai conscritti del 1912, ma dai loro padri. Secondo le stime, 282000 uomini in totale furono
chiamati sotto le armi per tutto il periodo del 1912-1913. La mobilitazione colpì in larga misura
la manodopera del Paese. Per le necessità della seconda campagna, in particolare, le risorse
umane erano diminuite a tal punto che si fece perfino appello agli orfani ed agli emigrati e che
gli uomini in servizio nelle retrovie, posti, per esempio a guardia degli edifici pubblici o degli
istituti bancari, furono inviati al fronte.
Perfino gli emigrati che si erano stabiliti negli Stati Uniti risposero al primo appello alla
mobilitazione e rientrarono per servire il loro Paese. Secondo alcuni studi, 57.000 emigrati
ritornarono, così, nella loro terra natale (Andreades, 1928). Una parte di loro non rivide mai più
gli Stati Uniti. Altri vi ritornarono dopo la guerra.
Nonostante la censura messa in atto e l'assenza di malcontento, espresso pubblicamente durante
queste campagne, si può dire, senza troppo esagerare, che la durata dei conflitti fu troppo breve
per permettere la nascita di un movimento di opposizione alla guerra o di qualsiasi situazione di
massiccia diserzione. L'opinione pubblica sosteneva nell'insieme le scelte del Paese e le sole
critiche rivolte al governo provennero da cerchie eccessivamente nazionaliste. Nelle loro lettere,
i semplici soldati e gli ufficiali si lamentavano, cosa che non sorprenderà, dello stato
dell'esercito, dei rigori della campagna e del clima, come pure delle condizioni sanitarie, ma non
vi si percepisce alcun sentimento di ostilità alla guerra o di antinazionalismo (V. per ex.
Gardikas - Katsiadakis, 1998; Tricha, il 1993).
La seconda guerra balcanica, condotta contro la Bulgaria, fu più breve, ma molto più violenta
della prima. Le truppe nemiche ed alleate erano molto più disperse lungo un fronte non ben
definito. Inoltre, i combattimenti iniziarono in piena estate. Molti diari dedicano passaggi alla
natura dei combattimenti; ne descrivono la crudeltà e lo sfinimento dei soldati. I racconti
parlano soprattutto del calore soffocante, della sete di cui soffrono i combattenti e delle
devastazioni di un nemico fatale: il colera. Alcuni giorni prima della firma dell'armistizio a
Bucarest, la metà degli effettivi di ogni unità era stata contaminata. I racconti pervenuti sono
drammatici. La citazione seguente è estratta dal diario di un giovane greco, Vasilios Sourrapas,
che aveva lasciato il suo villaggio del Peloponneso all'età di otto anni in compagnia dei suoi due
fratelli maggiori e che in seguito si stabilì definitivamente ad Atene, dove fondò il primo
caseificio industriale, EVGA:
80
“Ci alzammo alle cinque del mattino." Molti dei nostri camerati erano stesi al suolo. Si
torcevano ed agitavano le gambe come rane. Furono portati ai margini del campo sotto
la sorveglianza di un medico e di una infermiera. Molti di loro morirono e le infermiere
ritornarono a più riprese a cercarne altri che avevano contratto questa malattia mortale e
terribile che è il colera Alle otto, un nostro cacciatorpediniere venne ad ormeggiare in
prossimità ed i medici di bordo si recarono al campo per visitare i pazienti e individuare
la natura del loro male: diagnosticarono il colera.
[... ] Attraversammo tutto il giorno la pianura di Nigrita. Camminammo sotto un calore
insopportabile ed in una nuvola di polvere. Soffrimmo di disidratazione per tutto il
giorno . Eravamo logorati dalla stanchezza e sfiniti dalla diarrea che causava la malattia.
Due di noi morirono sulla strada ed una buona parte degli uomini era allo stremo. Il
medico testimone di tale situazione venne ad informare il comandante che i soldati
erano in un tale stato di debolezza e di sfinimento che sarebbe stato loro impossibile
continuare, ma questi gli rispose: "Andrò a Nigrita, dovessi giungervi con soli tre
uomini!". Il rombo dell'artiglieria si avvicinava e raggiungeva i nostri orecchi, la terra
tremava e noi scoprivamo i villaggi incendiati ai quali il nemico, che batteva in ritirata,
aveva messo il fuoco dopo averli saccheggiati. Finalmente raggiungemmo Nigrita alle
otto della sera, ma vi trovammo soltanto rovine fumanti. L'odore del fumo e la vista di
questa città offrivano uno spettacolo orribile. Tutto era distrutto. Gli splendidi edifici e i
palazzi eleganti erano crollati. Attraversammo questo campo di rovine e stabilimmo il
nostro bivacco fuori dalla città devastata. Vi trovammo soltanto alcuni vecchi, donne ed
uomini, che rimanevano là all’aperto.
Il posto era estremamente fertile, piantato ad alberi da frutta, a viti e ad altre colture. Nella vigna
situata sulla sinistra, un battaglione del 21° fece prigioniero il 19° reggimento bulgaro e ne
massacrò la maggior parte. Solo 7.000 prigionieri furono consegnati alla Croce-Blu. Furono
trasferiti su navi "(Tricha, 1993, p. 187).
La crudeltà della guerra aveva così trasformato un civile pacifico e intraprendente in un
individuo che ne osservava le atrocità con distacco. Le due guerre si caratterizzano per le
atrocità alle quali diedero luogo. Il sentimento di disagio e di sospetto che aveva alimentato per
decenni il conflitto, che oppone le Comunità nelle regioni disputate, deve essere attribuito al
carattere esclusivo del processo di costruzione della nazione, apparso nei Balcani nel xix°
secolo. Vasilis Gounaris ritiene in modo convincente che queste rivalità fossero precedenti alla
comparsa di una differenziazione etnica nella regione e che prendano generalmente la loro
origine nelle dispute partigiane sorte in seno alla collettività. Cita a questo proposito un
dispaccio redatto nel 1904 dal Console generale Lambros Koromilas: "Ma come abitualmente
accade in Macedonia, i villaggi sono innanzitutto teatro di conflitti di interesse, che poi
degenerano, inevitabilmente, in rivalità nazionali" (Gounaris, 1993, pp 200-201).
Nelle regioni che si disputano molti gruppi etnici, l'intensificazione di questo processo aveva, un
tempo, provocato esplosioni di violenza. Questa situazione si riprodusse quando gli eserciti di
liberazione degli Stati balcanici vicini all'Impero ottomano espulsero le autorità turche. Il nuovo
potere locaIe e militare riuscì a mantenere l'ordine fino all’insediamento delle autorità civili
nelle zone liberate.
“I soldati avevano fatto aprire i commerci turchi ed ebbero luogo dei saccheggi, che non
furono tanto opera dell’esercito, quanto della popolazione locale, che prese così la sua
rivalsa sui Turchi", nota un soldato nel suo giornale a Elassona, all'inizio della guerra
(Tricha, 1993, p. 42).
Nonostante l’atmosfera di sospetto reciproco che regnava in occasione della prima campagna,
non esiste alcuna prova di violenze etniche generalizzate.
81
"Sono malato ed ho ottenuto questo pomeriggio il permesso di recarmi al villaggio. I
suoi abitanti parlano il bulgaro e sono finalmente riuscito dopo molti sforzi a comperare
due oche da uno del villaggio "(ibid, p. 49).
Durante la seconda guerra balcanica, la violenza etnica prese tuttavia proporzioni
incontrollabili. La distruzione delle città e dei ponti con le truppe che battevano in ritirata era
una pratica corrente, sulla quale il comando militare chiudeva gli occhi e che incoraggiava
spesso; in alcuni casi, l'esercito regolare prese parte ad atti di violenza pura perpetrati nei
confronti di abitanti che sospettava di essere dei franchi-tiratori o degli informatori. Il
comandante in capo delle forze greche, lo stesso re Constantino , non fu esente dal generale
spirito di crudeltà. Egli concepiva il conflitto contro la Bulgaria come una guerra di
annientamento e telegrafò al governo: "delenda est Bulgaria!". Era quello stesso personaggio,
che, all'inizio della prima guerra, aveva fatto frustare in pubblico un civile ellefono che non
aveva rispettato il divieto di porto d’ armi decretato dalle autorità nella città appena occupata di
Servia (ibid, p. 47).
Si tratta della pagina più buia della guerra, che procede di pari passo con la distruzione delle
infrastrutture praticata dagli eserciti in ritirata ed il flusso costante dei profughi venuti a mettersi
al riparo dietro la linea mobile delle frontiere provvisorie. Tutti conoscono queste immagini di
profughi in miseria, gettati sulle strade con pochi effetti personali, delle atrocità commesse e
della distruzione generale del teatro delle ostilità.
Nuovi territori
L'acquisizione di nuovi territori impose alla Grecia costrizioni supplementari, poiché non aveva
ancora interamente integrato al suo ordinamento sociale e giuridico le province ottenute nel
1864 e nel 1881, le isole Ioniche e la Tessaglia. Esse presentavano importanti antagonismi in
materia socioprofessionale e giuridica, di cui il cui principale riguardava la proprietà fondiaria,
che non erano stati risolti in occasione della loro presa di possesso da parte della Grecia. Infatti,
la questione agraria era peggiorata con l'acquisizione di territori in Macedonia ed in Epiro. I
problemi erano simili, ma non identici. In Macedonia, grandi estensioni di terre sotto-popolate
rimanevano incolte, mentre i loro mezzadri rimanevano nei piccoli villaggi delle colline
circostanti. Questa situazione pregiudizievole all'esistenza degli abitanti, alla proprietà ed alle
infrastrutture del paese era aggravata da un'importante ondata di emigrazione.
La campagna in favore di riforme profonde che era stata lanciata dopo il 1910 sulla parte
vecchia del territorio greco trovò nelle regioni recentemente acquisite un vasto campo
d'applicazione, poiché lo Stato si era impegnato ad integrare queste zone quanto più
rapidamente possibile. L'esperienza acquisita in Tessaglia si rivelò inestimabile. Grazie ad essa,
lo Stato adottò misure volte a migliorare la situazione e trasformare l'economia e
l'amministrazione delle nuove province.
Immediatamente dopo la conquista, proprio all’ inizio del mese di novembre 1912, non appena
le autorità amministrative si furono sistemate nelle grandi città, gruppi di esperti finanziari ed
amministrativi furono inviati di Atene per fare il bilancio della situazione sul posto, come pure
del regime fiscale e giuridico, e proporre misure di assimilazione delle nuove province
(Demakopoulos, 1993). Queste missioni generarono molti e notevoli studi pubblicati nel 1914.
Il governo adottò, inoltre, una legislazione che proibiva il passaggio di proprietà e progettò un
vasto programma di riforma agraria, che fu tuttavia rinviato a causa della prima guerra mondiale
(Petmezas, 1993, pp. 210-214). Le città subivano anche le conseguenze dei conflitti. Non
soltanto alcune erano completamente distrutte, ma le principali agglomerazioni dovettero
accogliere un flusso di profughi in situazione di miseria. Per rimediare a queste necessità, il
governo creò nel 1914 un ministero supplementare, il Ministero della Comunicazione, la cui
missione principale consistette nel commissionare nuovi progetti d'urbanistica.
82
Questa nuova "patria" presentava delle caratteristiche sconosciute dalla vecchia
amministrazione e dai suoi amministrati. Lo Stato multinazionale precedente, nel quale le
comunità erano definite e dirette secondo la loro confessione religiosa, fu sostituito da uno Stato
nazionale "moderno", centralizzato e desideroso di rendere omogenea la sua popolazione. Una
legge del 1914 (350/1914), relativa "all’insediamento dei concittadini rifugiati in Macedonia ed
altrove", inaugurò un nuovo sistema di gestione concertata della terra detenuta dai membri della
Comunità, che rappresentò il punto di partenza di una legislazione arricchita successivamente.
Ma questo piano d'omogeneizzazione non fu in alcun settore così pronunciato come in quello
urbanistico. Le autorità locali delle grandi città che accolsero ondate di profughi provenienti dai
territori annessi da altri Stati balcanici commissionarono ad architetti stranieri i piani di nuove
agglomerazioni. Molte città medie e di piccola dimensione, come serre, Kilkis, Amyntaio
(Sorovitz) e Doxato, distrutte nel corso della seconda guerra mondiale, furono fra le prime a
beneficiare di questo nuovo slancio di urbanistica (Karadimou-Gerolymbou, 1993).
La situazione delle isole occupate era diversa. L'incertezza non era così segnata e i sentimenti
che vi dominavano non erano gli stessi. La loro popolazione ellenofona si rallegrava della
sconfitta e della partenza dei Turchi e la gioia era generale. La loro gioia fu attenuata
unicamente dall' elevato aumento del prezzo delle derrate.
"Non chiederci quello che viviamo in questo momento", scrive un abitante di Chios,
Stefanos Kynigos, a suo fratello stabilito negli Stati Uniti. "Abbiamo assistito da un lato
all'arrivo dei Greci e dall'altro ad un aumento dei prezzi che supera ogni
immaginazione." La doppia pagnotta di pane si compera a 18 metalikia, tutto è costoso,
il bidone di benzina è a 28 grossia. Non abbiamo più un soldo per finire questo mese.
Nove giorni più tardi, la loro madre gli indica:
"Qui, mio caro Giorgio, i prezzi sono terribilmente aumentati. Il pane costa oggi 24
metalikia. Per gli altri prodotti, è meglio non chiedere. "
I prezzi si abbassarono leggermente dopo Natale, ma un ritorno alla normalità era impossibile
per la vita quotidiana ed il commercio finché durava la guerra.
Precisa nuovamente il 24 febbraio:
"Gli affari sono ripresi un po’, ma non riescono a ritrovare il loro ritmo normale a causa
dei prezzi elevati […]. Speriamo che quando la pace sarà firmata e la situazione
migliorerà, i prezzi si abbasseranno ".
La loro principale preoccupazione era di ritornare ad una vita normale, in modo da evitare la
coscrizione. Quando scoppiò la Seconda Guerra Balcanica, la signora Kynigos, sul cui
patriottismo non c’era alcun dubbio, scrisse a suo figlio:
"Tu stai per partire soldato e ciò mi fa disperare fino all’inverosimile, mio caro Giorgio
[...]. Ieri l’altro Stefanos è andato in Prefettura ed ha trovato il sig. George Bitsas, che
una volta lavorava al Consolato; gli ha chiesto se esistesse un mezzo per esentarti e gli
ha risposto che a causa della guerra era molto difficile. Bisogna avere molti appoggi. La
sola cosa che si possa fare, ha aggiunto, è, quando ti presenterai per prestare servizio, di
depositare una domanda, così sarà possibile fare qualcosa "(Tricha, 1993, pp. 251-265).
Per ritornare alla popolazione rurale delle "vecchie province", precisiamo che non esiste alcuna
cifra capace di illustrare le conseguenze delle guerre baIcaniche. Ma la contabilità presentata
nelle fonti descrittive offre un certo numero di indicazioni. La mobilitazione e il successivo
accorpamento, degli uomini disponibili, alle retrovie hanno privato la campagna di manodopera,
mentre la requisizione delle bestie e dei veicoli per i bisogni delle operazioni militari ha imposto
83
un carico supplementare alla popolazione rimasta sul posto. Il costo in vite umane delle due
guerre non è stato molto elevato, confrontato con le perdite subite dagli eserciti bulgaro e serbo:
Morti
Feriti
Soldati
7428
42191
Ufficiali
304
628
Totale
7732
42819
(Fonte: Adreades, 1928)
L'aumento dei prezzi che colpì le province occupate non sembra avere influito sulla vita
quotidiana dell'”ex" Grecia in modo così spettacolare come nella zona dei combattimenti.
Contrariamente a ciò che si verificò in Bulgaria ed in Romania, la dracma conservò il suo valore
alla pari, grazie alla legislazione di riforma fiscale del 1910, ai prestiti nazionali e stranieri
provvisori contratti con la mediazione della Banca nazionale della Grecia, come pure grazie alla
stabilità generale dell'economia. I depositi bancari e le riserve auree della banca nazionale
aumentarono durante la guerra, mentre il commercio estero e le entrate pubbliche rimasero
stabili (Andreades, 1928, p. 11).
Condizioni economiche e sociali
Andreadis attribuisce la stabilità dell'economia, tra altre ragioni, ad un certo numero di fattori
sociali: il numero esorbitante di Greci emigrati negli Stati Uniti che ritornarono nel loro paese in
occasione della guerra, come pure l'aiuto finanziario considerevole fornito dai Greci di tutto il
mondo, l’ afflusso di regali e la premura delle contadine di sostituirsi agli uomini partiti in
guerra, cosa che permise di mantenere la produzione agricola (ibid, p. 12).
Non disponiamo di alcuna cifra che permette di misurare le ripercussioni immediate della guerra
sulla produttività agricola, poiché l'ultimo studio realizzato prima della guerra risale al 1911,
mentre lo studio seguente è stato pubblicato nel 1929. Tuttavia, poiché la popolazione del paese
era praticamente raddoppiata, mentre la produttività era diminuita nella zona dei combattimenti,
i conflitti ebbero a breve termine un effetto globalmente negativo sulla bilancia commerciale
greca, come mostra la tabella seguente:
(Fonte:Andreades, 1928)
Anno
1911
1912
914
Importazioni
173510
157653
319000
Esportazioni
140902
149162
179000
Le conseguenze delle guerre furono
relativamente moderate sui centri
%
urbani delle "vecchie province". I
aumento
102,34
20
conflitti provocarono in genere un
1912-14
esodo rurale verso i centri urbani,
dovuto a un certo numero di ragioni (Kalitsounakis, 1928, p. 216). La popolazione delle città
dell'”ex Grecia" aumentò. Il primo censimento disponibile per il periodo del dopo-guerra,
realizzato nel 1918, include le migrazioni sopraggiunte durante tutta la prima guerra mondiale.
Le cifre rilevate per Atene ed il complesso del Pireo ne danno una vaga idea:
1907: 240.000
1918: 310.00
L'aumento della popolazione determinò naturalmente una penuria di alloggi. Questo problema
era diventato minaccioso nel 1916, tanto che risultò necessaria una legislazione che imponesse il
84
blocco degli affitti. Una legge di emergenza aveva, tuttavia, impedito fin dal 1912 l'espulsione
degli inquilini (Kalitsounakis, 1928, p. 216).
Una delle particolarità della guerra fu di causare uno slancio di patriottismo che conquistò tutto
il paese e trovò la sua espressione più manifesta negli ambienti urbani. La guerra offrì alla
popolazione femminile delle famiglie dell'alta società ateniese l'occasione di manifestare il
proprio patriottismo e condurre una vita sociale lavorando come infermiere negli ospedali di
campagna.
Così annota Aspasia Mavromichali nel suo giornale:
"Volevo rendermi utile in questo momento e non mi preoccupavo per nulla di me
stessa [...]. Subito dopo il nostro arrivo ad Atene, mia sorella ed io ci arruolammo nella
Croce-Blu, un'associazione creata dal direttore del Polykliniki, il sig. Alivizatos, e
presieduta dalla principessa Elena. Mamma era la vicepresidente. Fummo inviate in una
piccola unità operativa all’aperto [...] e iniziammo nello stesso tempo i corsi e la pratica.
Quanto questa prima giornata nel tentare di abituarmi a quest'ambiente mi ha esaurita!
La disgrazia, lo strazio e la miseria più nera componevano un quadro dipinto nei colori
più accesi. Emanava dai pazienti che arrivavano, tutta gente del popolo, sporchi come
sono e cenciosi, un tale odore da provocare il vomito ".
In occasione dell'ispezione di altri ospedali di campagna in compagnia della principessa, scrive
nel suo giornale:
"La situazione era spaventosa. Tutti questi ospedali di fortuna mancavano di letti ed
erano sprovvisti di infermiere, di tutto. Si sentivano solo gemiti, sospiri e pianti.
Nessuno accorreva in aiuto di questi infelici [...]. Chiesi il permesso di salire nella
camera della principessa a rinfrescarmi un po'. Mi lavai abbondantemente con acqua
fredda e, rinfrancata, scesi con premura; cominciammo allora a sistemare i feriti nelle
automobili. In quel periodo, molte signore di Larissa erano arrivate, la maggior parte
tutte incipriate e vestite a festa. Ci guardarono con stupore, come se fossimo cadute da
Saturno ".
Una di esse, l’infaticabile Anna Papadopoulou, diventò una eroina nazionale. Ma non tutte le
donne erano così resistenti come lei per sopportare tali condizioni difficili:
"Apprendemmo, durante una fermata alla stazione, che la principessa, che soffriva di
cuore, aveva avuto un attacco dovuto alla gravosità del lavoro e che il sig. Alivizatos
aveva fatto tutto il possibile per darle sollievo. Il treno era lanciato a piena velocità
quando nel bel mezzo del silenzio della notte udimmo il segnale di allarme. Il treno si
immobilizzò di colpo. Ci precipitammo tutti fuori [...]. Che cosa era successo? La sig.ra
Katsara aveva avuto una violenta crisi di nervi ed era stato necessario chiamare
urgentemente il medico "(Tricha, 1993, pp 31-6).
L'impatto della guerra
Quando la notizia delle prime vittorie riportate dall'esercito greco raggiunse Atene, la
popolazione fu presa da un sentimento di euforia nazionale che impregnò la vita quotidiana
della città. I giornali aumentarono le loro tirature e pubblicarono edizioni speciali quando eventi
straordinari, come la battaglia di Limnos, si verificarono. Si mancava di carta, di stampanti e di
corrispondenti di guerra. La sete dei lettori per le storie palpitanti fu soddisfatta dalla comparsa
di un grande numero di pubblicazioni popolari, che illustravano argomenti patriottici e
sfoggiavano titoli come "I Mangiatori di Turchi del 1912", "I Nostri Delfini del 1912" ed "I
Combattenti giganti di Jannina" (Demakopolous, 1993, p. 209n).
85
La gerarchia amministrativa assisteva alle celebrazioni religiose ufficiali della vittoria. La
popolazione manifestava la sua febbre frequentando le produzioni teatrali popolari, vaudevilles,
commedie e drammi che affluivano per celebrare le vittorie militari. La loro popolarità fu tale
che gli stessi teatri "seri" furono obbligati a seguire il movimento per sopravvivere (Delveroudi,
1993, pp. 377-8).
Tentare di valutare l’incidenza del conflitto sulla vita dei cittadini comuni non è cosa facile, sia
perché difettano le ricerche approfondite sulla questione, sia perché le ripercussioni delle guerre
balcaniche sono state spazzate via dagli eventi che sono seguiti: la mobilitazione, la crisi
politica interna, gli anni di guerra dal 1917 al 1922 ed il disastro sociale dello sdradicamento e
del nuovo insediamento di un milione e mezzo di rifugiati dell’ Asia minore. Prenderò in
prestito piuttosto le parole di un importante autore greco progressista, Giorgio Drosinis, che
evoca nelle sue memorie il destino di un istituto privato dell'insegnamento secondario tecnico;
egli aveva svolto un ruolo determinante nella sua installazione, poco tempo prima delle guerre
balcaniche, su un grande terreno di Ambelokipi, che formava allora un sobborgo verde situato ai
piedi della collina di Lykabettus, con un giardino curato che adorava:
"Nella primavera del 1913 il giardino era al suo massimo. Ogni visitatore ripartiva dalla
casetta con le braccia cariche di rose, di gelsomino e di caprifoglio e gli amici vi
raccoglievano fiori per intrecciare le ghirlande del 1° maggio.
Ma con le guerre balcaniche inizialmente, quindi la guerra in Europa ed infine la
sfortunata campagna dell’ Asia minore, la scuola, il giardino, la casetta, tutto passò da
requisizione in requisizione. Gli strumenti e le illustrazioni della scuola furono
ammassati nelle due grandi stanze della casa; io conservavo soltanto un angolo della
piccola stanza dove era disposto il mio letto, in modo da poter continuare a passare
occasionalmente la notte.
Non avevo più alcuna compagnia. La mia presenza a scuola era inutile ed era per me
soltanto fonte di pena, nulla a che vedere il modo in cui le altre persone trattavano le
piante che avevo riunito ed assemblato così amorevolmente. Giacevano spezzate,
strappate, sparse sul terreno circostante, come scheletri di animali morti. Recandomi a
scuola camminai su di esse e feci fatica a riconoscerle. Il giardino non esisteva più,
esistevano solo gli alberi, che la loro robustezza aveva preservato. Il resto della
vegetazione era stato distrutto [...]. Ciò che era sopravvissuto al saccheggio degli
uomini era stato mangiata o calpestato dai cavalli e dai carri che andavano e venivano
liberamente.
La povera scuola conobbe tante trasformazioni: servì da caserma a un migliaio di
soldati, da deposito per le divise dei conscritti, da carcere per gli ufficiali e, infine, da
ospizio per le vittime della guerra, che battezzai "rifugio della madre patria" [...]. Il
"rifugio della madre patria" modificò considerevolmente nello stesso tempo l'aspetto
della scuola e lo stato del giardino. Noi cominciammo a coltivarlo nuovamente con
l'aiuto di alcuni pensionanti volontari. Benché non mi fosse più possibile installarmi
confortevolmente nella piccola casa, ci passavo delle ore felici, al punto che vi passavo
a volte la notte "(Drosinis, 1982, pp. 209-211).
La vita quotidiana nell’entroterra fu, in realtà, appena turbata durante le guerre balcaniche. Nel
1914, dopo due guerre vittoriose, tre trattati di pace vantaggiosi e l'accoglienza calorosa
riservata agli uomini smobilitati, la società considerava il futuro con ottimismo, persuasa non
soltanto che la ripresa del paese fosse a portata di mano, ma ancora che la sua estensione
territoriale promettesse nuove possibilità. Fu un periodo d'euforia, durante il quale i
responsabili politici condividevano con la società la convinzione che la pace era indispensabile
perché la Grecia si rialzasse dallo sforzo della guerra (un prestito di 500 milioni fu firmato a
Parigi a tale scopo), che essa utilizzasse al meglio le sue risorse supplementari e che questa pace
86
fosse possibile. "il felice anno 1914" durò soltanto un breve momento di otto mesi, tra la
smobilitazione e lo scoppio della grande guerra.
Il 1914 celebrò anche il 50° anniversario della prima estensione importante del territorio greco:
l'acquisizione delle isole Ioniche. La conferenza tenuta per segnare l’evento si concentrò sulle
questioni relative allo sviluppo della regione e il sentimento di euforia che regnava dopo le
guerre balcaniche impregnò i suoi lavori. Ma le cose non avvennero come previsto. Il seguito
della storia dell’istituto tecnico di Drosinis è a questo titolo istruttivo. Riaprì un breve momento
nel 1930, ma non trovò la sua piena attività prima degli anni 1950, grazie al finanziamento del
piano Marshall ed al boom generale dell'economia greca del dopoguerra (Belia, 1999, p. 236).
87
Riferimenti
Andreades A., "Le finanze pubbliche" in Storia economica e sociale della guerra mondiale,
Parigi, 1928, p.11.
Belia, Eleni D., Society for the Diffusion of Useful Books: A hundred-year course, 1899-1999,
Atene, 1999 (in greco).
Delveroudi, Eliza-Anna, "Théatre" in History of 20th-century Greece: The beginnings 19001922 ed. Christos Chadziiosif, volume Iii, pp 377-8 (in greco).
Demakopoulos Georgios D., "The amministrativa organization of the occupied territories
(1912-1914): A generale overview "in Greece during the Balkan wars, 1910-1914, Atene,
1993."
Drosinis G. Loose pages of my life, Vol. II, Atene, 1982 (in greco).
Gardikas-Katsiadakis, Helen (ed.), Leonidas Paraskevopoulos, Balkan wars (1912-1913):
Letters to his wife Koula, Atene, 1998.
Gounaris, Vasilis C., "Ethnic groups and party factions in Macedonia during the Balkan wars"
en Greece during the Balkan wars, 1910-1914, Atene, 1993, pp. 200-1.
Kalitsounakis D., "Legislazione operaia e sociale greca durante e dopo la guerra" in Storia
economica e sociale della guerra mondiale, Parigi, 1928, p. 216.
Karadimou-Gerolymbou, Aleka, "Towns and town planning" dans History of 20th-century
Greece: The beginnings, 1900-1922, ed. Christos Chadziiosif, Athens, 1993, vol. Ii, pp. 242-6
(in greco).
Pallis, A. A. "Gli effetti della guerra sulla popolazione della Grecia" in Storia economica e
sociale della guerra mondiale, Parigi, 1928, p. 131.
Petmezas, Sokratis D., "Agrarian economy" dans History of 20th-century Greece: The
beginnings, 1900-1922, ed. Christos Chadziiosif, Atene, 1993, vol. Ii, p. 82 (in greco).
Tricha, Lydia (ed.), Diaries and letters from the front: Balkan wars, 1912-1913, Atene, 1993.
88
11
Le guerre balcaniche: valutazioni e previsioni dal servizio di
informazioni dell’armata russa. (Nuovo quadro della situazione
stabilito a partire dalle varianti delle opinioni antiche).
Arutyun Ulunyan
Durante il periodo che precedette la prima guerra mondiale l’Europa fu testimone di gravi
conflitti militari e politici conosciuti sotto il nome di guerre balcaniche. Esse sono considerate
come un catalizzatore, che scatenò lo scontro internazionale e diede dimostrazione del carattere
esplosivo della regione dei Balcani. N. M. Butler, direttore ad interim della Fondazione
Carnegie per la pace internazionale, scrisse nel febbraio 1914 nella prefazione del rapporto della
commissione internazionale d’inchiesta sulle cause e lo svolgimento delle guerre balcaniche: “
Le circostanze che furono alla base delle guerre balcaniche dal 1912 al 1913 presentavano un
carattere proprio da fissare su di esse l’attenzione del mondo civilizzato” (Rapporto Carnegie,
1914, p. iii). Alla vigilia degli avvenimenti, diversi Stati aldilà dei Balcani, e principalmente
quelli che si definivano le grandi potenze, osservavano con una vigilanza costante la situazione
della penisola. La Russia giocò nella fattispecie un ruolo importante, proprio per i suoi legami
storici con i Balcani e della sua partecipazione attiva negli affari regionali di questa parte del
continente.
La burocrazia imperiale russa si suddivideva in due rami, l’una civile e l’altra militare; essa
tentò di avere un peso sulle decisioni relative ai Balcani e prese attivamente parte sia
all’elaborazione delle valutazioni politiche della situazione, che alla stesura di previsioni
analitiche sulla possibile evoluzione dei Balcani. Agli inizi del XX° secolo, il servizio di
informazioni dell’armata russa aveva consolidato la sua posizione all’interno del dispositivo di
informazione fornendo all’apparato governamentale dei dati sensibili e importanti. La struttura
degli addetti militari faceva integralmente parte dell’insieme dei servizi di informazioni ed era
subordinata allo stato maggiore. Secondo il loro statuto e le loro funzioni, essi assolvevano delle
missioni all’estero ed erano assegnati presso i governi stranieri. Essi erano incaricati di mettere
insieme delle informazioni militari e politiche e di eseguire delle missioni di informazioni
clandestine all’estero ( vedi Sergeyev e Ulunay, 1999).
Per tutto il 1911, gli agenti del servizio di informazioni dell’armata russa presenti negli Stati
Balcanici lavorarono su diversi livelli, determinati in funzione delle particolarità e delle
caratteristiche dei paesi nei quali essi erano assegnati. In tal modo, principalmente in Romania,
le riforme e l’equipaggiamento tecnico dell’armata nazionale suscitarono molto particolarmente
l’interesse dell’addetto militare russo locale. L’addetto militare in Bulgaria fu incaricato di
seguire attentamente “ le relazioni politiche tra la Bulgaria e la Turchia, ivi compresi i suoi
rapporti con l’Austria-Ungheria” e di mettere insieme delle informazioni “sulle attività militari
condotte dalla Turchia sia sulla frontiera bulgara e nel Bosforo in rapporto con la guerra turcoitaliana”. L’addetto militare presso la Serbia ricevette l’ordine di ottenere delle informazioni e di
procedere per una ricerca analitica al fine di chiarire “ l’attitudine politica adottata verso la
Turchia e l’Austria-Ungheria in seguito all’azione di quest’ultima in Bosnia-Erzegovnia”. Il
ruolo affidato all’addetto militare presso il Montenegro inglobò (così come lo definì la
Direzione principale dello stato maggiore) il seguito della “situazione politica legata
all’insurrezione albanese e ai piani offensivi dell’Austria-Ungheria”, la supervisione della
riorganizzazione dell’armata montenegrina e il controllo dell’impiego dei sussidi versati dal
governo russo al Montenegro. L’addetto militare presso la Grecia ebbe come ordine di osservare
lo stato dell’armata greca e di seguire le attività degli istruttori stranieri destinati alle forze
armate greche. In Turchia, l’addetto militare si concentrò sull’attitudine di quest’ultima rispetto
all’insurrezione in Albania, sui preparativi militari impegnati dalle autorità turche nella parte
europea dell’Impero e sulle relazioni italo-turche (da ANRHM, F2000, In. I, Dossier 7335). Gli
agenti militari russi dell’insieme dei Balcani seguirono con molta attenzione la questione
89
maggiore della presunta firma di un trattato tra la Romania e la Turchia, poiché quest’alleanza
militare era ritenuta pregiudizievole a San Pietroburgo.
Il progetto di costruzione di una linea ferroviaria, conosciuto sotto il nome di progetto DanubioAdriatico, così come le imprese simili previste per le regioni dell’Asia minore dell’Impero
ottomano, rappresentarono uno dei problemi maggiori per i quali furono messi a confronto gli
addetti militari dei Balcani. Per il fatto dei disegni contrari delle autorità di Belgrado, partigiane
di un “ progetto Danubio” in direzione del sud, e di quelle di San Pietroburgo, desiderose di
vedere questa linea ferroviaria pianificata per il nord, il bilancio della situazione fatto
dall’armata russa entrava nel quadro delle intenzioni strategiche definite a partire dalle proposte
analitiche formulate dagli addetti militari russi nei Balcani. Si ritenne che il progetto della
ferrovia “congiungerebbe i paesi slavi della penisola balcanica e i paesi slavi alla Russia”, per
cui si esigeva
“una preparazione politica seria, in vista della definizione da parte di questi Stati
di una soluzione comune per i loro obiettivi strategici nei Balcani. Se mai la politica ci
ha assegnato l’obiettivo strategico “di impedire l’invasione della penisola balcanica dal
mondo germanico”, notoriamente la conquista da parte dei tedeschi di Tessalonica e di
Costantinopoli, l’esistenza di una ferrovia“panslava “ collegando il Mar Nero
all’Adriatico, la Bulgaria, la Serbia, la parte della Turchia che accoglie una popolazione
serba e il Montenegro, facilita una tale missione” (ANRHM, F2000, In. I, Dossier
7337).
Per ciò che atteneva al secondo progetto, ogni costruzione ferroviaria nelle regioni asiatiche
dell’Impero ottomano era giudicata, potenzialmente pericolosa per la Russia, dal punto di vista
strategico. I servizi di informazione russi accordavano anche tutta la loro attenzione alla minima
evoluzione politica e militare nei Balcani.
I sopraggiunti avvenimenti politici negli Stati della regione potevano far precipitare i calcoli
analitici. Il cambiamento di governo che si produsse in Romania agli inizi di Gennaio del 1911
aggiunse nuovi elementi alle considerazioni russe. Il colonnello M. Marchenko, che occupava il
posto di addetto militare russo a Vienna, ritenne che in seguito al fallimento del governo liberale
diretto da Bratiano, la situazione in Romania era cambiata: egli qualificò il Primo Ministro
Carp “ uomo di Stato pro- tedesco che nutre apertamente dei sentimenti ostili verso la Russia e
gli Slavi “ ( ANRHM, F2000, In. I, Dossier 3093).
La situazione in Montenegro e gli avvenimenti sopraggiunti alle sue frontiere, dove il
movimento di liberazione nazionale albanese si mostrava più attivo, suscitarono tanto interesse
quanto preoccupazioni, Il colonnello N. Potapov, addetto militare in Montenegro, indicò nel
rapporto speciale che indirizzò allo stato maggiore che il principe regnante montenegrino Nicola
“lui stesso vuole la guerra contro la Turchia per non “perdere la faccia” di fronte agli
Albanesi a fianco dei quali il principe e i suoi consiglieri piuttosto imprudenti si sono,
in maniera sconsiderata, impegnati in un combattimento contro i Turchi. Ci sono delle
ragioni per credere che sono i Montenegrini, e non i Turchi, che si sforzino per
scatenare la guerra “ (Mezhdunarodnye otnosheniya, MO, p.117)
I fattori summenzionati austriaco e turco della situazione dei Balcani risvegliarono
l’interesse degli addetti militari russi in servizio nella regione e li incitavano a ottenere delle
informazioni sicure sugli eventuali progetti dei due imperi.Una pubblicazione speciale regolare
e segreta, intitolata “Collezione dei documenti della Direzione principale dello Stato maggiore”,
pubblicata nell’estate del 1911, concluse che l’Austria-Ungheria segnava una pausa, non tanto
per risolvere le sue difficoltà finanziarie, quanto per rinforzare la sua armata in maniera che
potesse far fronte ad ogni aggressione futura (giugno1911, p.16). Le informazioni trasmesse al
90
servizio di informazioni dell’armata russa dai diversi canali condussero alcuni esperti analitici
del quartiere generale regionale a concludere che le misure prese dalle autorità austro-ungariche
non miravano “direttamente alla Russia” (ANRHM, F 1859, In. 6, Dossier 139). Il servizio di
informazioni dell’armata russa prendeva d’altronde molto seriamente i progetti della Turchia.
L’addetto militare russo a Sofia, il colonnello G. Romanovsky, ottenne nella metà dell’anno
1911 delle informazioni confidenziali dallo zar di Bulgaria Ferdinando, che aveva in verità fatto
conoscere la sua posizione evocando l’instabilità della situazione nei Balcani. Questo punto di
vista s’articolava in due argomenti correlati: da una parte, i preparativi della guerra della
Turchia nel mar Nero e, dall’altra parte, l’eventualità di una guerra nei Balcani che egli
prevedeva in un prossimo avvenire (ANRHM, F 2000, In. I, Dossier 3067).
La presunta minaccia turca era insomma maggiormente presa sul serio dal servizio di
informazioni dell’armata russa che non quella Austria-Ungheria. La costante rivalità che
opponeva i due imperi su un ampio ventaglio di soggetti, ivi compresi la questione degli stretti,
la politica balcanica, le regioni del Caucaso e anche dell’Asia centrale, influenzava la logica e il
contenuto dell’approccio analitico del problema del servizio di informazioni. E’ quello che
dimostrano i dispacci dell’addetto militare presso l’impero ottomano, il generale di divisione I.
Kholmsen. Il rapporto speciale altamente confidenziale che egli indirizzò al capo di stato
maggiore poggiava sui 1) “ piani turchi di conquista del Caucaso e del nord della Persia e 2) il
desiderio della Turchia di beneficiare del sostegno della Triplice Alleanza (ANRHM, F 2000,
In. I, Dossier 3819).
La guerra italo-turca fu scatenata il 16 settembre 1911 e servì di ripetizione ad un eventuale
conflitto nei Balcani, se per avventura una grande potenza europea avesse l’intenzione di
modificare l’insieme della carta geopolitica della regione. Alla fine del mese di settembre del
1911, alcuni addetti militari russi presentarono la loro analisi della possibile evoluzione dei
Balcani nell’avvenire. Essi constatarono molte conseguenze della disfatta della Turchia nella
guerra che essa avesse condotto contro l’Italia. Secondo loro, i seguenti eventi erano da
prevedere: 1) la costituzione di una coalizione anti-turca composta da piccoli stati balcanici; 2)
le velleità della Turchia di ottenere dei suscettibili risultati di compensazione nei Balcani
rispetto alla disfatta militare contro l’Italia; 3) le intenzioni dei Giovani Turchi di conservare il
potere attraverso una attacco contro la Grecia e del regolamento della questione cretese in
favore della Turchia (ANRHM, F 2000, In. I, Dossier 7382). In occasione della guerra italoturca, gli agenti del servizio dell’armata russa in servizio nei Balcani indicarono che
“ l’atmosfera di agitazione nata dalla disfatta militare dell’Impero ottomano è sempre
carica di una nuova rivoluzione, ed è ciò che potrebbe dare il segnale di un movimento
disorganizzato intrapreso contro la Turchia dai suoi vicini della penisola balcanica e
condurrà inevitabilmente allo smantellamento dei possedimenti territoriali turchi in
Europa “ (ANRHM, F 2000, In. I, Dossier 7382).
L’autunno del 1911 fu un periodo critico della storia dei Balcani. Le negoziazioni segrete
intraprese dalla Bulgaria e dalla Serbia, considerate come una tappa importante verso la
conclusione di un accordo militare segreto, sollevarono la questione estremamente sensibile sul
modo di come la Russia dovesse reagire ad una alleanza intrabalcanica di questo tipo. L’addetto
militare russo in Bulgaria, il colonnello G. Romanovsky, fornì un’analisi dettagliata della
possibile evoluzione della regione e sottopose diverse raccomandazioni ai suoi superiori. Egli
sottolineò la reticenza marcata dalla Bulgaria a cedere alla Romania Sinistra e Balchik, le quali
annoveravano una “popolazione in maggioranza bulgara”, come compensazione in caso di
estensione del territorio bulgaro in Macedonia. Tenuto conto di questi elementi, Romanovsky
era giunto alla conclusione che
“ in queste circostanze, il nostro sostegno alle aspirazioni rumene potrebbe
compromettere il nostro prestigio, e persino portare alle dimissioni del governo
(bulgaro) attuale. Quest’ultima situazione nuocerebbe gravemente e senza equivoco i
nostri interessi nel paese. Il governo attuale si compone in effetti dei più sicuri e più
91
fedeli della Russia. Se il gabinetto fosse dimissionario, sarebbe immancabilmente
rimpiazzato dagli eredi di Stambolov, ai quali si unirebbe un gruppo di avventurieri e di
truffatori. Se si pensa che la situazione politica bulgara entra in una fase nuova, non
sarebbe salutare per noi che gli eventi prendano un tale risvolto”(ANRHM, F 2000, In.
I, Dossier 3002).
Oltre alle già esistenti contraddizioni bulgaro-rumene, l’addetto militare prevedeva un
deterioramento delle relazioni tra la Bulgaria e la Grecia, che porterebbe i due Stati all’auspicio
di ottenere Tessalonica. Al fine di mantenere o le relazioni bulgaro-serbe, o l’influenza della
Russia in Bulgaria, e di promuovere un’alleanza tra la Grecia e la Serbia, fu ritenuto prudente
per la Russia l’astensione da qualsiasi conflitto, che potesse opporre Sofia e Bucarest o Sofia e
Atene.
La formazione di un’alleanza militare nei Balcani, dove i piccoli Stati avevano considerato
l’Impero ottomano come loro comune nemico, riguardava altre potenze che avevano i loro
propri interessi nella regione e ne erano confinanti. Era il caso dell’Impero austro-ungarico, che
aveva tradizionalmente un ruolo attivo nei Balcani tentando di dominarne i settori più sensibili.
Anche l’addetto militare russo presso la doppia monarchia, il colonnello M. Zanchevich,
predisse in un rapporto indirizzato ai suoi superiori che l’obiettivo primario di Vienna nei
Balcani comportava l’occupazione austriaca del Sandjak di Novi Pazar, in funzione di aprire la
via verso la Serbia e Tessalonica. Secondo i calcoli dell’addetto militare, se gli eventi avessero
preso una svolta, avrebbero trascinato un certo numero di conseguenze, come lo scatenamento
di una guerra contro la Turchia, la Serbia, il Montenegro così come contro la Russia, che
sosteneva Belgrado e Podgoritsa ( ANRHM, F 2000, In. 6, Dossier 139).
Dopo la firma d’una serie di accordi segreti tra la Bulgaria, la Grecia, la Serbia e il Montenegro,
durante l’inverno e la primavera del 1912, i piccoli Stati balcanici (per la prima volta nella
storia) formarono un’alleanza motivata da una forte comune ostilità nei confronti dell’impero
ottomano, ma i cui principi erano estramamente fragili e incerti. Alla fine dell’estate ed agli
inizi dell’autunno 1912, l’attività della direzione bulgara del servizio di informazioni
dell’armata russa si era intensificata. La politica regionale condotta da Sofia era considerata
come un annuncio degli eventi futuri e degli eventuali cambiamenti. Gli ufficiali del servizio di
informazioni dell’armata russa percepivano le realtà della politica bulgara attraverso la loro
comprensione della situazione del paese. Essi constatavano gli importanti sforzi che metteva in
campo un “governo ragionevole” affinché il paese si astenesse “ad indirizzare una dichiarazione
di guerra ufficiale vero la Turchia” (ANRHM, F 2000, In. I, Dossier 7392). Tuttavia, tutti questi
interventi apparivano molto inutili, poiché lo stesso servizio di informazioni russo ottenne delle
informazioni degne di credibilità sulla decisione bulgara di cogliere l’occasione che gli offriva
“la situazione critica della Turchia e di intraprendere un’azione militare contro l’Impero
ottomano insieme ai Serbi e ai Greci nella seconda quindicina del mese di settembre [ 1912 ]”
(ANRHM, F 2000, In. I, Dossier 2987). Il grave conflitto militare al quale bisognava aspettarsi
nei Balcani giocò un ruolo importante nelle previsioni analitiche fatta dagli ufficiali
d’informazioni dell’armata russa in servizio nella regione e influenzò il loro giudizio della realtà
della situazione.In tal modo, l’addetto militare russo in Grecia, il colonnello P. GudimLevkovich, commenta l’offerta ufficiosa fatta dall’ambasciatore tedesco in Turchia al suo
omologo russo, sull’argomento dell’eventuale occupazione di Belgrado dall’Austria-Ungheria e
della presa di Varna dalla Russia , in funzione di prevenire una futura guerra nei Balcani,
facendo partecipi i suoi superiori del suo timore che “ la nostra politica attuale ci trascini su
questa strada” (ANRHM, F 2000, In. I; Dossier 2994).
Malgrado tutte le informazioni ottenute da fonti pubbliche e dai canali confidenziali, il servizio
d’informazioni dell’armata russa restò nell’incapacità di rispondere a due maggiori questioni
fino alla metà di settembre del 1912: da una parte, da chi le operazioni militari sarebbero
intraprese,e quale sarebbe il piano di coordinamento tra gli alleati balcanici ? Dall’altra, in quale
data questo eventuale conflitto si sarebbe scatenato? La prima e la più importante avanzata
permettendo di rispondere a queste domande fu l’opera dell’addetto presso il Montenegro, il
92
colonnello N. Potapov. Il 15 settembre 1912, egli inviò al quartiere generale del servizio di
informazioni dell’armata un missiva segreta che conteneva delle informazioni ultra sensibili e
apportava una risposta a queste due domande. Secondo lui, la situazione avrebbe conosciuto la
seguente evoluzione:
“Innanzitutto, le operazioni militari contro la Turchia dovrebbero essere impegnate
simultaneamente dagli alleati in un lasso di tempo di cinque giorni secondo la ratifica
dell’accordo; secondariamente, le due parti [ la Serbia e il Montenegro] dovrebbero concentrare
al massimo il loro potenziale militare; in terzo luogo, i distaccamenti alleati si dovrebbero
fornire in mutuo soccorso un appoggio sulla frontiera dove si svolgerebbero le operazioni
militari, cioè lungo il Sandjak del Novi Pazar e attraverso questo , ivi compresi al nord
dell’Albania e nella regione di Scutari, sulla quale il Montenegro ha delle mire; in quarto luogo
nessuna delle due parti [la Serbia e il Montenegro] non è autorizzata a firmare un trattato di pace
senza il consenso dell’altro; in quinto luogo, infine, in caso di intrusione austriaca nel Sandjak,
le due parti sono tenute ad inviare le loro forze per respingerle (ANRHM, F 2000. In.I, Dossier
2989). Secondo gli ufficiali di informazione russi in posta nell’insieme degli Stati balcanici,
tranne la Turchia, lo scatenamento della guerra doveva avvenire in un prossimo avvenire e la
data precisa del 1° ottobre fu anche avanzata per l’inizio delle ostilità. Esistevano, tuttavia, delle
evidenti contraddizioni tra le informazioni fornite, da una parte, dagli ufficiali del servizio di
informazioni dell’armata russa stanziato in Bulgaria, in Montenegro, in Serbia e in Grecia e ,
dall’altra parte, dagli addetti militari in Turchia, che impedirono i superiori del detto servizio di
abbozzare un quadro generale di un possibile risvolto degli avvenimenti. La dichiarazione di
guerra indirizzata alla Turchia dal Montenegro il 9 ottobre 1912, e la partecipazione degli altri
piccoli stati dei Balcani a delle operazioni militari nei Balcani, solamente nove giorni più tardi,
presero San Pietroburgo alla sprovvista. I piani militari degli alleati balcanici e loro eventuali
acquisizioni territoriali divennero allora la principale preoccupazione del servizio di
informazioni dell’armata russa. I nomi di Costantinopoli e di Adrianopoli furono avanzati a
titolo delle possibili esigenze territoriali bulgare (ANRHM, F 2000, In. I, Dossier 7400). Questa
questione risvegliò l’interesse degli esperti civili e militari russi; essa riguardava i piani a lungo
termine stabiliti dalla Russia a proposito della regione dei distretti e della stessa Costantinopoli.
Il ministro dell’Armata, V. A. Sukholminov, ebbe tra le sue più profonde preoccupazioni la
reazione che avrebbe potuto avere la Bulgaria e alcuni dei suoi alleati se la Russia si fosse
mostrata ostile a tali rivendicazioni. Egli indicò che in caso di risposta sfavorevole della Russia
alle aspirazioni della Bulgaria,
“gli Stati slavi dei Balcani rappresenteranno un elemento particolare, mal disposto nei
nostri confronti, ciò che ci permetterebbe difficilmente di includerli tra i nostri alleati in
caso di confronto armato con la Germania e l’Austria-Ungaria” (ANHM, F 2000, In. I,
Dossier 3002).
Le operazioni militari della coalizione balcanica si protrassero fino a dicembre1912 e
dimostrarono ad un tempo la forza degli alleati e la loro dipendenza rispetto alle grandi potenze.
Secondo le valutazioni militari realizzate dallo stato maggiore russo, la disfatta turca in Europa
poteva modificare l’equilibrio nei poteri in Asia e nel Caucaso, ma non in favore della Russia.
Quest’ultima ritenne che il cessate il fuoco concluso il 20 novembre 1912 potesse aprire la
strada ad un trattato di pace generale. Nel frattempo, la situazione nella quale si trovavano i
paesi balcanici influenzò molto la loro posizione alla conclusione della firma del trattato di
pace.
Questo punto fu l’oggetto di tutta l’attenzione del servizio di informazioni dell’armata russa
nella regione.Trattandosi della Bulgaria, l’addetto militare di Sofia era giunto alla conclusione
che, malgrado l’attitudine favorevole dello zar Ferdinando rispetto al “ partito della guerra”, il
suo paese non era pronto a condurre lunghe operazioni militari e dipendeva ampiamente
dall’aiuto finanziario e alimentare straniero in caso di prosieguo del conflitto (ANRHM, F 2000,
In. I, Dossier 2997). Il suo collega in servizio in Serbia sottolineò d’altronde che il paese
93
includeva ugualmente ardenti una politica di chiusura verso la Turchia, favorevoli di marciare
contro Andrinopoli e Chataldja (ibid). Tutte queste osservazioni e valutazioni
Questo punto fu l’oggetto di tutta l’attenzione del servizio di informazioni dell’armata
russa della regione. Trattandosi della Bulgaria, l’addetto militare di Sofia era giunto alla
conclusione che nonostante l’atteggiamento favorevole dello zar Ferdinando verso il “partito
della guerra”, il suo paese non era pronto a condurre delle lunghe operazioni militari e
dipendeva molto dall’aiuto finanziario e alimentare straniero nel caso di proseguimento del
conflitto (ANRHM, F 2000, In. I, Dossier 2997). Il suo collega in posta in Serbia sottolineò
d’altronde che il paese comprendeva ugualmente partigiani ardenti di una politica di chiusura
verso la Turchia , ma favorevoli all’idea di marciare contro Adrianopoli e Chataldja (ibidem).
Tutte queste osservazioni e valutazioni dagli agenti del servizio di informazioni dell’armata
inglobavano ugualmente nuove questioni che non erano sfuggite alla loro attenzione. In tal
modo, alla fine del 1912, alcuni addetti militari avvertirono lo stato maggiore dell’imminenza di
un conflitto tra i paesi balcanici. Le relazioni tra la Bulgaria e la Romania si erano deteriorati,
per il fatto della rivalità che opponeva i due Stati balcanici nel loro desiderio di dominio della
penisola. L’ufficiale di informazioni in posta in Romania, il colonnello E. Iskritsky, analizzò la
situazione della regione e indicò, nei rapporti che egli indirizzò alla direzione principale, che
“uno dei grandi principi della politica estera rumena, dalla sua indipendenza nel 1878,
consiste nel preservare l’equilibrio esistente tra la Romania e la Bulgaria, cioè di
impedire ogni rafforzamento di quest’ultima senza un rafforzamento simultaneo della
Romania” (ANRHM, F 2000, In. I, Dossier 2988).
Iskritsky prevedeva anche che, se delle potenze come la Russia, l’Austria-Ungheria e la
Bulgaria restringessero nella loro morsa la Romania, quest’ultima potrebbe sentirsi in posizione
di debolezza e rischierebbe di essere una minaccia imminente per esse.
Mentre la conferenza degli ambasciatori di Londra, che durò da dicembre 1912 agli inizi del
mese di gennaio 1913, si immortalava sulla conclusione di un trattato di pace tra gli Stati
belligeranti,ogni deterioramento della situazione nella penisola comportava il rischio di vedere
fallire un tale accordo. Le informazioni trasmesse dal servizio di informazioni dell’armata russa
al comando militare del paese conducevano quest’ultimo a temere un possibile conflitto nei
Balcani. La Bulgaria e la Romania erano considerate come le prime istigatrici di ogni
scaramuccia regionale che si sarebbe potuta verificare. Nel frattempo, la lotta politica che
opponeva in Turchia i partigiani dell’organizzazione dei Giovani Turchi “Ittihad ve taraki” e
quelli del “Hürriyet ve ittilaf”, giunti al potere il 1 luglio 1912, si era intensificata. La decisione
del governo turco di acconsentire alla richiesta fatta dalle grandi potenze di cedere Andrinopoli
alla Bulgaria fu considerata dai Giovani Turchi come un tradimento, di cui si era reso colpevole
il regime in carica. Il 10 gennaio 1913, i dirigenti dell’ “Ittihad ve taraki” fecero un colpo di
stato, destituirono il governo precedente e, dopo aver denunciato gli accordi precedenti,
ripresero le ostilità. Gli addetti militari russi della regione proseguirono le loro inchieste al fine
di determinare il risvolto che gli avvenimenti avrebbero preso nei Balcani. Le informazioni
iniziali sullo scatenamento di un eventuale conflito tra gli Stati balcanici alleati, principalmente
tra la Bulgaria e la Serbia, giunsero dal colonnello F. Boulganine in servizio a Roma. Alla fine
di marzo del 1913, egli informò i suoi superiori, in una lettera ultra confidenziale inviata
d’urgenza a San Pietroburgo, dell’”esistenza di un accordo segreto tra la Serbia e il Montenegro,
rivolta verso la Bulgaria”( ANHRM, F 2000, In. I, Dossier 7400). Nell’intervallo, il litigio che
opponeva la Romania alla Bulgaria, che alcuni ufficiali di informazioni russe aveva analizzato
nei loro precedenti rapporti, fu considerato come un anello di una catena di disaccordi che
divideva i Balcani. E’ la ragione per la quale essi prevedevano l’arrivo di un nuovo conflitto che
farebbe seguito al precedente, nel quale la Bulgaria e la Grecia si disputerebbero il controllo di
Tessalonica (ANRHM, F 2000, In. I, Dossier 3002).
Man mano che si avviava il completamento della redazione delle disposizioni del trattato di
pace tra l’alleanza balcanica e l’Impero ottomano, le relazioni tra la Bulgaria, da una parte, e la
94
Serbia e la Grecia, dall’altra si deterioravano. L’accordo di pace sottoscritto a Londra il 17
marzo 1913 modificò profondamente la carta della penisola balcanica. L’Albania aveva chiesto
l’indipendenza e Creta era stata annessa alla Grecia. L’Impero ottomano perse l’insieme dei suoi
possedimenti territoriali nei Balcani a beneficio degli Stati membri dell’unione balcanica, tranne
una porzione della Tracia orientale e di Costantinopoli. La Bulgaria, la Grecia e la Serbia
ottennero diverse parti della Macedonia e della Tracia. La divisione di questi territori tra questi
tre alleati fu apprezzata in maniera diversa da Atene, Belgrado e Sofia, ma condivisero tutti la
stessa insoddisfazione in quanto all’ampliamento delle loro nuove acquisizioni territoriali.
Inoltre, la Romania, che non aveva preso parte alla guerra, giudicava indispensabile ottenere la
Dobroudja come compensazione della sua neutralità.
L’addetto militare russo in Bulgaria, il colonnello G. Romanovsky, mentre osservava le
possibili conseguenze dell’animosità che opponeva i vecchi alleati, si sforzò di formulare delle
raccomandazioni sul modo di regolamentare i disaccordi che li dividevano. Il piano che espose
nel dispaccio indirizzato allo stato maggiore preconizzava di fare una pressione sulla Serbia, al
fine di convincere Belgrado di rinunciare ai suoi progetti bellici. Secondo le spiegazioni
dell’addetto militare, lo smantellamento simultaneo delle armate serbe e bulgare avrebbe dovuto
concorrere al raggiungimento di questo obiettivo ( ANRHM, F 2000, In. I, Dossier 7407). Il
collega di Romanovsky in Serbia, il colonnello Artamonov, difendeva un punto di vista
radicalmente opposto su questa situazione. Nel cablogramma codificato che egli inviò a San
Pietroburgo, l’addetto militare russo evocò la posizione inflessibile della Bulgaria sulla
questione territoriale, che giudicava contraria agli interessi della Russia imperiale (ibid).
Nel frattempo, la Grecia e la Serbia avevano firmato il 1° giugno 1913 un patto segreto contro la
Bulgaria; quindici giorni più tardi, le truppe bulgare attaccarono le posizioni greche e serbe. Era
evidente per tutti gli osservatori stranieri e locali che la Bulgaria era nell’incapacità di condurre
la guerra su due, vedi tre fronti, contro i suoi antichi alleati balcanici, così come contro la
Romania e la Turchia. A Belgrado, il colonnello V. Artamonov condivise questa valutazione
con i suoi superiori di San Pietroburgo e credette nella possibilità di una rinascita dell’Unione
balcanica ( con la partecipazione attiva della Romania, sotto gli auspici dell’Intesa) alla
conclusione della disfatta della Bulgaria e del ripristino dell’equilibrio dei poteri nei Balcani
(ANRHM, F 2000, In. I, Dossier 3151). Queste valutazioni utopiche contraddicevano, pertanto,
molto le valutazioni realizzate dall’addetto militare in servizio in Grecia, il colonnello P.
Gudim-Levkovich, che ricorse a degli argomenti etnici e confessionali per tentare di convincere
i suoi superiori dell’esistenza di un rischio di disfatta della Bulgaria dovuta, supponeva, alla
vittoria di una “coalizione non slava”, nella quale la Serbia non aveva un ruolo maggiore e che
rappresentava secondo la Grecia “il fallimento della politica russa” ( ibid ).
L’accordo di pace di Bucarest sottoscritto il 28 luglio 1913 dalla Bulgaria, da una parte, e la
Grecia, la Romania, la Serbia e il Montenegro dall’altra, comportò delle profonde modifiche
territoriali nei Balcani, che perseguirono dopo la conclusione del trattato di pace tra la Bulgaria
e la Turchia. La fine della seconda guerra balcanica, o guerra interalleata, conferirà nuove
caratteristiche alle valutazioni della situazione dei Balcani dagli addetti militari russi. Le loro
conclusioni, fondate sull’evoluzione che fece seguito alla seconda guerra balcanica, rinchiuse un
largo ventaglio di ipotesi e di valutazioni. L’addetto russo a Bucarest, il colonnello Iskritsky,
predisse un possibile riavvicinamento rumeno-serbo, che egli giudicava benefico per la Russia
(ANRHM, F 2000, In. I, Dossier 7410).
Malgrado tutte le contraddizioni che presentavano le loro valutazioni della situazione attuale e
le loro inclinazioni personali a favore di un modo d’azione particolare, gli agenti del servizio di
informazioni dell’armata russa in posta nei Balcani condividevano un punto di vista unanime
sulle guerre balcaniche, nelle quali esse vedevano una prefigurazione di un conflitto molto più
grave a cui potrebbero prendere parte le grandi potenze e l’insieme dell’Europa. Per tutti gli
anni 1912-1913, le informazioni trasmesse dagli agenti del servizio di informazione russa nella
regione dei Balcani furono accuratamente raccolte negli uffici del Ministero dell’Armata e del
95
Ministero degli Affari Esteri. Alcuni documenti furono comunicati allo zar Nicola II°. Ma in
molti casi, gli argomenti politici invocati dissimulavano altri motivi.
96
Riferimenti
Carnagie Endowement for International Peace, Report of the International Commision Inquire
into Causes and Conduct of the Balkan Wars, Londra, 1914.
Mezhdunarodnye otnosheniya (“ Affari Esteri”), Serie N2, Volume XVIII, Parte 1, p. 117 ( N.
Potapov a Ya. Zhilinsky, 3 giugno 1911).
Archivi nazionali russi di storia militare, (ANRHM), Fond 2000, Inventario 1, Informazioni del
dipartimento “Balcani” sulle attività degli agenti militari e Quartieri generali del distretto
militare di Odessa nel 1911.
Archivi militari russi di storia militare (ANRHM), Fond 1859, Inventario 6.
Sergeyev, E. Y., e Ulunyan, A., Military attaché of the Russian Empire in Europe and in the
Balkans, 1900- 1914, Mosca 1999
97
98
12 Le guerre balcaniche nella storiografia e i manuali bulgari recenti.
Ivan Ilchev
Nella storiografia bulgara, esiste un luogo comune nei riguardi delle guerre balcaniche. In
generale, ciò si presenta come segue:
Le guerre balcaniche del 1912-1913 rappresentano uno dei punti culminanti
dell’evoluzione nazionale bulgara. La nazione e l’armata bulgare, unite nella nobile
ambizione di liberare i loro fratelli dal giogo turco, brandirono la bandiera della libertà
nell’ottobre 1912. Le indistruttibili atrocità commesse durante un’oppressione
quotidiana, lo sfruttamento economico, gli omicidi, lo stupro delle ragazze così come
delle donne, l’arbitrario e la corruzione dei Turchi, così come l’incapacità dello Stato
ottomano a riformarsi a dispetto degli sforzi dispiegati da quasi un secolo, fecero
sembrare evidente che il momento arrivasse per buttare fuori gli invasori turchi dalla
penisola.
L’armata bulgara subì il più forte dei combattimenti infliggendo una disfatta al grosso
delle forze turche in Tracia orientale e nella catena montuosa del Rodope. I suoi alleati
non incontrarono che una debole resistenza da parte dei Turchi che preferirono
arrendersi ai Serbi e ai Greci piuttosto che ai valorosi Bulgari. L’armata bulgara
conquistò da sola le fortezze di Lozengrad e di Adrianopoli, reputate imprendibili da
tutti gli eminenti esperti militari dell’epoca.
Durante le guerre balcaniche, l’armata bulgara era di gran lunga la più moderna: essa fu
la prima ad utilizzare gli aerei e i bombardamenti aerei nel corso delle ostilità e
inaugurò gli attacchi notturni nei quali gli assalti lanciati dalla fanteria alla luce dei
proiettori erano sostenuti dalla tattica del bombardamento a tappeto dell’artiglieria.
Mentre la Bulgaria combatteva i Turchi, la Serbia e la Grecia complottavano alle sue
spalle. I governi dei due paesi, divorati da un sinistro nazionalismo non avevano alcuna
intenzione di rispettare gli obblighi per cui avevano sottoscritto in virtù di trattati
bilaterali. Dall’ingresso delle loro truppe in Macedonia nell’autunno 1912, essi
iniziarono immediatamente a reprimere ogni manifestazione di sentimento nazionale
bulgaro, perfino nelle parti del territorio si presumesse ritornare alla Bulgaria. I preti e
gli insegnanti furono maltrattati, poiché essi impersonavano ai loro occhi il patriottismo
bulgaro. Le bandiere nazionali bulgare furono ammainate e strappate da soldati ubriachi
e i consigli delle città e dei villaggi bulgari furono immediatamente disciolti, mentre le
autorità militari dirigevano con un pugno di ferro tutti gli aspetti della vita quotidiana.
La Serbia e la Grecia, senza nessuna provocazione da parte della Bulgaria, spinte dalla
cupidigia, conclusero un trattato bilaterale segreto al fine di conservare a loro profitto
esclusivo le spoglie della guerra. Nello stesso tempo, una Romania invidiosa, che
ambiva dei territori che non contavano nemmeno il più piccolo abitante rumeno,
s’apprestava a lanciare a tradimento la sua offensiva.
I Serbi e i Greci colsero la loro opportunità e attaccarono la Bulgaria nell’estate 1913,
nel corso di una delle loro innumerevoli scaramucce senza importanza. L’armata
rumena invase quasi simultaneamente la Bulgaria, mentre i Turchi, approfittando
dell’occasione che si offriva a loro, rioccuparono la Tracia orientale, che era stata
attribuita alla Bulgaria nell’ambito del trattato di pace di Londra del 1913, e si
sbarazzarono in pratica di tutti i cristiani della regione, bulgari e greci.
99
Gli antichi alleati della Bulgaria cominciarono allora a diffondere attraverso il mondo
delle menzogne sul comportamento dell’armata bulgara, accusandola di aver commesso
delle atrocità all’incontro con la popolazione civile e i prigionieri di guerra.
Circondati da tutte le parti, i Bulgari combatterono perfino con coraggio. Essi giunsero
a superare l’offensiva lanciata dalla Serbia e penetrarono anche in territorio serbo. Nello
stesso tempo, le truppe bulgare giunsero a circondare l’armata greca condotta dal re
Costantino e solo la firma del trattato di pace di Bucarest salvò i Greci da una
confusione totale. Il trattato di pace di Bucarest sottrasse alla Bulgaria i frutti delle sue
vittorie e i bulgari de Macedonia furono la preda di una repressione ancora peggiore di
quella che aveva condotto i Turchi. La Tracia orientale fu violentemente debulgarizzata
e la Romania annesse la Dobroudja meridionale. Ciò fu un disastro nazionale, una
tragedia che sprofondò nelle tenebre le prospettive d’avvenire della Bulgaria.
Ecco, in mancanza del racconto completo, a dir poco a cosa rassomigliavano in buona sostanza
le tendenze più marcate della storiografia bulgara delle guerre balcaniche. Un quadro simile e
ancora più appassionante è stato tracciato nelle emissioni televisive che proponevano una
versione molto popolare della storia, raccontata o suggerita da personalità molto in vista del
piccolo schermo, di cui una parte almeno era storica di formazione o di professione. I manuali di
storia, notoriamente quelli delle classi superiori, presentano i fatti in un modo che, per non
essere troppo radicali, non sempre risultano identici.
Le guerre balcaniche sono state e rappresentano un centro di interesse della storiografia bulgara.
Le prime opere che si sforzarono d’analizzare gli avvenimenti fecero la loro apparizione dal
1913. Esse non erano tanto il frutto di un lavoro specializzato, quanto di mettere a frutto delle
circostanze per rilanciare degli attacchi contro un nemico politico. Uno degli artigiani
dell’Unione balcanica, il Primo ministro bulgaro Ivan Evstratiev Geshov, pubblicò nel 19141915 due opere, che contenevano le sue memorie, le sue analisi e un certo numero di documenti
sulla storia della guerra. Sopraggiunse la prima guerra mondiale, che portò in maniera
provvisoria una battuta di arresto ad ogni schizzo serio di studio dei due conflitti.
Gli anni tra le due guerre furono l’occasione di un ripristino di interesse per gli avvenimenti
delle guerre balcaniche. Un certo numero di circostanze di circostanze spiega quest’evoluzione.
In primo luogo, il re Ferdinando, che trascinato la Bulgaria nei due disastrosi conflitti, fu
costretto a rinunciare al trono. In quanto principale colpevole non era più al potere e che la sua
influenza non bastava ormai più a occultare il soggetto, risultò più facile estendersi sugli errori
della politica straniera. D’altra parte, queste due guerre divennero una delle rare sorgenti di
orgoglio nazionale. La loro popolarità d’allora in poi non si è smentita. Esse rappresentavano
uno dei rari esempi della storia recente della Bulgaria in cui i dirigenti e la popolazione del
paese unirono i loro sforzi per uno scopo comune. In effetti, ciò non fu il caso nel caso della
prima guerra e meno ancora intorno alla seconda guerra mondiale. In seno ad una società in
preda alla disillusione, che tentava in maniera penosa di riaffermare i valori che erano i propri
all’indomani della schiacciante e umiliante disfatta del 1918, il ricordo delle vittorie
dell’autunno 1912 procurava una certa stabilità. Una pletora di opere e di articoli furono
pubblicati, di cui gli autori erano sia degli storici civili di professione, degli storici militari e dei
teorici militari.
Un certo numero di persone che avevano preso parte alla guerra, dai membri di gabinetto, i
diplomatici, i generali, fino ai soldati semplici, agli infermieri e perfino ai becchini militari
pubblicarono le loro memorie sui fatidici dieci mesi dall’ottobre 1912 all’agosto 1913. Il
Giornale della storia militare, vera miniera d’oro sui conflitti, pubblicava regolarmente degli
articoli sui movimenti, i combattimenti e persino le scaramucce dell’armata bulgara, dai corpi
armati fino alle semplici sezioni.
La realizzazione maggiore della storiografia militare de questi anni fu la storia ufficiale delle
due guerre pubblicata dal Ministero della Guerra. I due volumi di storia e di memoria personali
100
di Andrei Toshev, antico ministro plenipotenziario a Belgrado, rappresentano la migliore opera
di storia diplomatica.
Molti soggetti principali di ricerca furono definiti nel corso degli anni tra le due guerre, che non
conobbero nessuna modifica sostanziale nei decenni successivi.
La prima guerra balcanica fu quasi unanimemente considerata come una conseguenza del
movimento di liberazione nazionale apparso in Macedonia e nella regione di Adrianopoli, in
Tracia, di natura bulgara e di cui lo scopo ultimo era l’unificazione con la Bulgaria o
l’ottenimento di uno statuto autonomo concepito come un trampolino di lancio verso
un’unificazione futura.
Essa fu il risultato del comportamento inopportuno dei medi dirigenti turchi, incapaci di
conciliare la loro concezione dell’impero con le realtà dell’Europa agli inizi del XX° secolo.
Essa fu una conseguenza della lotta nella quale si liberarono le grandi potenze per la
supremazia della regione.
Essa fu il frutto del convincimento, condiviso dalle élite al potere negli stati cristiani dei
Balcani, che nel caso in cui il conflitto si fosse protratto in un periodo successivo, la
situazione critica dei cristiani della penisola rischiava di peggiorare.
Era unanimemente ammesso che la costituzione dell’alleanza balcanica era stata un errore.
Per la prima volta la Bulgaria dovette rinunciare ad un principio fondamentale della politica:
il rifiuto di intraprendere ogni discussione sulla divisione della Macedonia.
Le modalità dell’alleanza militare costituirono un ennesimo errore. Si presumeva che la
Bulgaria dovesse concentrare la sua azione militare sulla Tracia orientale, allorquando essa
suggeriva come obiettivo strategico la Macedonia, alla Grecia e alla Serbia.
La Bulgaria si era fidata fino all’eccesso della buona volontà dell’imperatore russo e
dipendeva interamente dalla Russia nei Balcani per mantenere la pace in Romania.
I Bulgari tentarono di tranquillizzare i loro alleati fino a che la cosa divenne in sostanza
impossibile.
L’offensiva lanciata contro la Grecia e la Serbia nel luglio 1913 fu decisa dal re Ferdinando
e il suo seguace militare, il generale Mihail Savov, senza consultare le élite politiche. La
guerra essa stessa, prima dell’offensiva di Chataldja, fu una successione di vittorie che
stupirono il mondo.
Anche dopo Chataldja, l’azione della Bulgaria e la sua supremazia nei combattimenti furono
senza paragoni con quelle della Serbia e della Grecia.
Come si può costatare, nonostante la brevità di queste enumerazioni di conclusioni, l’attenzione
fu essenzialmente riposta su due aspetti maggiori della guerra ( militare e diplomatico), con
talvolta un’allusione ai conflitti etnici.
Per quanto strano ciò poté apparire, la situazione non cambiò dopo la presa del potere da parte
dei comunisti alla fine degli anni 1940. Una buona parte della storiografia antica fu preservata,
ma la spiegazione dei fatti storici appurati divenne radicalmente diversa. Alcune variazioni si
sono potute produrre nel corso di questi anni, principalmente in funzione dello stato delle
relazioni con la Jugoslavia, ma nella regola generale i nuovi storici comunisti continuarono a
seguire i sentieri già battuti. Pertanto oramai, il monarca e l’élite dirigente furono accusati di
aver fatto prova di irresponsabilità, mancanza di vigilanza e rovinati gli ideali della nazione.
La storia delle due guerre fu compresa in maniera più responsabile agli inizi degli anni ottanta.
La documentazione storica sui due conflitti fu prolifica, in particolare nelle date dei loro
anniversari (1972, 1982, 1987), benché il grado di interesse erudito per questa questione non
cambiò affatto. Solo un certo numero di raccolte di ricordi sui combattimenti che si svolsero nei
dintorni di Edirne e sulla situazione nel massiccio di Rodope o in altri posti meritano di essere
ricordati.
101
Una breve opera consacrata ai paesi balcanici durante le guerre del 1912-1918 da Siméon
Damianov quasi permise un avanzamento su questa questione (che non si concretizzò mai). Ciò
fu il primo tentativo bulgaro di studio della dimensione balcanica del conflitto, secondo un
punto di vista balcanico. E’ vero anche che questa prospettiva fu un po’ falsata dal patriottismo
in un senso troppo esaltato dall’autore, ma quest’opera non resta meno innovatrice. Fu
pubblicata nel 1982 in un numero limitati di esemplari, dal ministero della Difesa. Essa non fu
messa in vendita da nessuna parte, poiché la si giudicò abbastanza pericolosa. Questa diffusione
limitata, associata alla morte dell’autore prima della sua pubblicazione, spiegano come l’opera
passò quasi inosservata.
Dopo il 1990, durante l’agitazione che la caduta del muro di Berlino e la caduta del comunismo,
la storia diventa in Bulgaria un mezzo per sfuggire ai problemi quotidiani. Un certo numero di
storici professionisti e di estimatori considerarono la storia come una sorgente possibile di
conforto e le vittorie del passato come un balsamo per il sentimento di orgoglio nazionale
duramente provato dalla crisi che attraversava la società. Secondo l’adagio, la storia è spesso la
schiava obbediente, a scapito di mostrarsi zelante, della politica e la posizione della storiografia
bulgara contemporanea sulla questione riflette i problemi verso i quali essa stessa si trova essa
stessa si trova confrontata.
Secondo i dati incompleti di cui noi disponiamo per gli anni 1989-2004, undici opere,
quarantasei articoli, sedici memorie e sette raccolti di documenti sono stati pubblicati sulla
storia dei Balcani.
I temi delle opere e degli articoli summenzionati possono essere raggruppati nelle seguenti
categorie:
30
25
20
15
10
5
0
1
1. Opere generali
2. Arte della guerra
3. Macedonia
4. Giornalismo
2
3
4
5
5.
6.
7.
8.
6
7
8
Operazioni precise
Storia diplomatica
Storia sociale
Donne
Riassumendo, l’interesse per il tema non si è mai smentito. La migliore opera sulla storia delle
guerre balcaniche fu probabilmente la monografia solidamente documentata e ben concepita da
Georgi Markov, il quale sintetizzò le migliori opere della storiografia bulgara miscelandole alle
sue ricerche. Il libro di Georgi Markov rappresenta al momento il solo tentativo di redazione di
una storia concisa della grande strategia della guerra.
Gli storici bulgari che si sono inclinati sulla storia delle guerre balcaniche hanno avuto la
tendenza a concepirli in un modo molto tradizionale, limitandosi al confronto militare. Tutti gli
altri aspetti del conflitto erano giudicati, molto recentemente ancora, secondari e privi di
interesse. Si può affermare, ritengo, che il tema della storia militare pura della pura guerra
militare è in sostanza esaurito. Al contrario, un mucchio di questioni che sono tratte dagli aspetti
102
sociali dei conflitti sono appena accennate dalle generazioni più recenti di storici, e per più
recente non intendo naturalmente la nuova generazione.
Tra i migliori accenni di studio della guerra sotto un’angolatura differente, troviamo i seguenti
lavori: due monografie di Sv. Eldurov consacrate alla chiesa bulgara durante il corso delle
guerre balcaniche ed alla situazione critica della popolazione bulgarofona in Albania durante
questo periodo. Eldurov si rivela particolarmente dotato per gli elementi fattivi e le sue opere si
fondano su delle ricerche approfondite. Una monografia e molti articoli di R. Koneva sulla sorte
riservata alla cultura durante i conflitti meritano di essere menzionati. Questi lavori privilegiano
piuttosto la gestione pubblica della cultura. Ivan Ilchev ha consacrato un certo numero di articoli
e una monografia al posto della propaganda durante i conflitti. Molti articoli riguardano
l’organizzazione del servizio medico dell’armata, il cui fiore all’occhiello è un articolo sul ruolo
delle donne. Uno degli aspetti economici delle due guerre, il ruolo della marina bulgara e lo
sviluppo d’Alexandrupolis (Dedeagach) durante questo periodo, è stato d’altronde abbozzato.
La storia sociale dei due conflitti non è stata tuttavia in sostanza considerata e resta molto poco
tempo per dibattere dei temi sui quali mi sono sforzato per anni di convincere i miei studenti per
fare delle ricerche:
La storia delle idee che hanno condotto alle guerre balcaniche e i tentativi fatti dai governi e
i gruppi di pressione, di modellare le menti della popolazione secondo i loro punti di vista:
Il ruolo giocato dallo Stato moderno nella generazione di un nazionalismo moderno, fondato
sulla concezione di uno Stato-nazione che possiede i propri giorni feriali, il suo
martirologio, i suoi propri santi, le sue credenze ben stabilite ecc.
Le guerre balcaniche viste sotto l’angolatura della creazione del mito individuale e
collettivo.
La storia e le difficoltà del giornalismo bulgaro nel corso di questo periodo.
La rappresentazione visiva “dell’altro”, il vicino balcanico, esaminata privilegiando i
disegni satirici politici. Intendiamo da quì la visualizzazione della guerra: le cartoline che
rappresentano delle battaglie reali e immaginarie, degli eroi più veri di natura e di infami
nemici, così come l’arte militare, le illustrazioni delle battaglie, ecc…
Niente è stato intrapreso per trarre qualcosa dall’impressionante risorsa che rappresenta la
letteratura popolare, giudicata di poco interesse per alcuni storici, in altre parole le raccolte
di canzoni, gli annuari, le collezioni di poesie poco elaborate e pieni di sciovinismo, che
colpiscono, talvolta, di più l’immaginario del pubblico che colpiscono, talvolta, di più
l’immaginario del pubblico della letteratura detta di qualità.
Nonostante la paranoia di cui fanno prova gli storici a riguardo dei problemi strategici del
conflitto, di cui un certo numero di errori di decisione, molte questioni restano sconosciute.
L’analisi dell’ossessione dei responsabili politici bulgari per la Macedonia.
Il peso dei rifugiati macedoni nella definizione dell’orientamento generale della politica
bulgara.
Il posto preponderante della capitale, in cui vive un gran numero di rifugiati originari della
Macedonia ( i quali rappresentano quasi il 50% del totale della popolazione nei decenni che
precedono le guerre balcaniche), nella proporzione città- campagna.
L’analisi dell’assenza totale di un reale interesse per la Tracia e uno sbocco sul mare Egeo.
Nessuno studio serio è stato condotto sui motivi delle decisioni importanti prese
nell’incontro dei responsabili politici dei paesi vicini.
La storiografia bulgara non arriva sempre ad ammettere il semplice fatto che i Turchi
vivono ormai da un mezzo millennio nei Balcani e che essi sono trattati come invasori o
come una componente straniera della regione.
Noi non disponiamo sempre, benché degli sbocchi siano stati realizzati in questo senso, di
una vera analisi del fattore detto russofilo e russofobo della politica bulgara.
Nessuno studio realmente sostanziale è stato consacrato alle donne e al ruolo che esse hanno
avuto durante la guerra, non solamente al fronte (esistono uno o due articoli a riguardo), ma
103
ancora all’indietro. Il posto preponderante delle donne nel mantenimento dell’economia è
stabilito dai documenti, ma ciò non è stato ancora dimostrato.
Noi non disponiamo ancora della minima pubblicazione sui problemi dell’infanzia durante
la guerra, la difficoltà di crescere durante gli anni della guerra e la difficoltà di
socializzazione in tempo di guerra.
Si osserva un interesse incoraggiante per lo stato dell’economia durante gli anni di guerra da
uno o due giovani storici. Essi preferiscono sfortunatamente essenzialmente il modo in cui
lo Stato gestisce l’economia durante la guerra, omettendo di trattare gli aspetti psicologici
dell’evoluzione economica indotta dalla guerra e dai disordini che ne seguirono.
Non esiste nessuno studio sui progetti bulgari di sistemazione di Porto Lagos, sul Mare
Egeo, che miravano a farne un porto importante.
I sopraggiunti cambiamenti nei sistemi di comunicazione non sono stati studiati.
Nessuna ricerca è stata condotta sulle richieste che hanno alimentato lo sforzo di guerra e
l’effetto paralizzante che esse produssero su un’economia indebolita, né sull’aspetto
psicologico della diffidenza che ha fatto nascere presso i contadini i prelevamenti importanti
dello Stato sul frutto del loro lavoro.
Gli aspetti umanitari della guerra non sono mai stati studiati:
Nessuno studio è stato consacrato alla situazione precaria dei Turchi e dei musulmani di
Bulgaria nel corso degli anni della guerra, al timore che essi vivevano e all’atmosfera
psicologica che li circondava.
Non esiste nessuna documentazione sul modo in cui i Turchi della Bulgaria (che
rappresentavano nel 1912 il 18% della popolazione bulgara) hanno reagito all’annuncio
della guerra né sulle misure prese dallo Stato per sorvegliarli direttamente, ecc.
Nessuna ricerca è stata condotta sui prigionieri di guerra e le loro condizioni di detenzione,
la loro alimentazione, il trattamento che era loro riservato, ec…Tuttavia, un punto
incoraggiante: un giovane collega lavora già da qualche anno sulle lettere indirizzate dai
soldati alle loro famiglie, ma esse non sono state ancora pubblicate.
La condotta delle truppe bulgare verso i loro avversari e le popolazioni pacifiche dei
territori acquisiti, non è stato l’oggetto di alcuno studio. Non esiste la minima ricerca sul
servizio giuridico dell’armata, in altre parole sul numero di disertori bulgari, le eventuali
persecuzioni intraprese all’incontro di soldati bulgari per furti, stupri, atrocità, ecc..
Un’eccezione incoraggiante: un’importante raccolta di documenti e un certo numero di
articoli sono stati pubblicati sulla conversione dei musulmani bulgarofoni del massiccio del
Rodope nel 1912-1913.
I rifugiati in Bulgaria e di Bulgaria rappresentano un problema particolare, di cui gli aspetti
giuridici ne sono stati l’oggetto di studi seri. La questione dei rifugiati esaminata nel quadro
delle relazioni internazionali del paese durante le due guerre dimora in parte sconosciuta. Altri
aspetti importanti non sono stati ancora affrontati: è il caso per esempio dell’adattamento dei
rifugiati al loro nuovo ambiente. Contrariamente ad un’idea molto diffusa e pregna di
sufficienza, l’accoglienza che si riservò a loro fu raramente calorosa o, più precisamente di
breve durata.
Noi non abbiamo che una vaga idea delle questioni relative all’installazione dei rifugiati. Alcune
ricerche sono state condotte sulla loro ripartizione nella campagna, ma nessuna è stata
consacrata alla situazione critica di quelli che hanno scelto di stabilirsi finalmente nelle città e di
cerarvi lavoro. Noi non sappiamo neanche quanti di loro si stabilirono per sempre nei villaggi
né quanti andarono ad accrescere la popolazione urbana del paese. Si tratta solo d’alcuni punti
essenziali. Nessuno non ha tentato mai di studiare le ripercussioni che ha avuto il cambiamento
dei modelli educativi negli adolescenti.
La politica bulgara si cullava in una cecità ( di cui la storiografia bulgara è molto pregna) che
consisteva nel ritenere che tutti i bulgari, secondo il posto dove avevano vissuto, parlavano la
stessa lingua con infinitesime particolarità regionali. Ma alla fine delle guerre balcaniche , ma la
104
lingua bulgara letteraria ufficiale era stata codificata e i bambini dei rifugiati, che iniziavano la
loro scolarizzazione impiegando un lingua differente, conobbero delle serie difficoltà di
adattamento.
Nessuna è stata condotta sui Greci che scelsero di lasciare il loro paese dopo le guerre
balcaniche né, soprattutto sui Turchi e i musulmani in generale che iniziarono un nuovo esodo,
il secondo dopo quello del 1878, intorno alla nascita della Bulgaria moderna.
Riassumendo, la storiografia bulgara si dimostra generalmente incapace di abbandonare la
retorica classica e pomposa quando parla delle guerre balcaniche. Gli storici bulgari si sono
nutriti della tradizione storica positivista e non hanno mai preso coscienza delle implicazioni
della sociale. Persino gli storici seri trascurano l’interesse che rappresentano i diari e le memorie
dei soldati, con il loro sforzo assiduo di mettere su carta i loro pensieri, discussioni ed attività
quotidiane, giudicati senza importanza e lontano dei grandi assi della storia
Mentre si tratta di guerre balcaniche, il loro trattamento rimane bulgaro. Questa miopia si spiega
principalmente per l’assenza di documentazione proveniente dai paesi vicini. Gli storici bulgari,
per esempio, non sono mai stati in grado di sfogliare gli archivi della Turchia, della Grecia o
della Romania su questo temi, anche se la situazione migliora un po’ per ciò che attiene la
Serbia.
In una parola, noi disponiamo di una storia del conflitto stesso, ma ci manca la storia dell’uomo
in questo conflitto: quali furono le sue idee, i suoi sogni, le sue speranze e le sue disillusioni?
Gli storici dovrebbero astenersi dall’accettare stupidamente e di avallare un certo numero di
asserzioni stereotipate, come quella che consiste nel pretendere che l’armata bulgara non abbia
mai perso una guerra e che i responsabili bulgari non siano mai giunti a vincerne una. Come se
le guerre fossero condotte in laboratorio, in un ambiente sterile.
Ciò significa che gli storici non dovranno in avvenire temere di perdere il loro guadagno, quale
che sia la modicità della loro razione. Poiché ciò che importa veramente , è di convincere i
nostri studenti che la storia non si riduce a semplici scontri armati, a dei sottili balletti politici ,
né all’adozione di decisioni apparentemente illogiche da un ‘elite di potere.
105
13. Le guerre balcaniche del 1912-1913: il punto di vista turco
Halil BERKTAY
L’aspetto di continuità
Innanzitutto mi piacerebbe far osservare che “il punto di vista turco” sulle guerre balcaniche
dell’inizio del XX° secolo può essere esaminato, almeno, in due modi molto diversi. Può
significare, in primo luogo, un esame retrospettivo del passato, destinato a tentare di misurare
ciò che esse hanno rappresentato per l’Impero ottomano e/o per la società turca: le loro
ripercussioni politiche dirette e, di conseguenza, ugualmente le incidenze sociali, culturali e
ideologiche più complesse di quanto loro ebbero all’epoca, di cui è permesso di dire che esse
esercitarono un’influenza costante senza essere lineare, dalle pulsazioni irregolari, simile ad
un’alta e bassa mare, durante i circa novant’anni che seguirono. Si può ugualmente intendere da
lì, oggi come allora, ciò che d’altronde significò: una concezione specificatamente “turca” degli
avvenimenti, in opposizione ad altre prospettive molto soggettive, così come i punti di vista
“greci”, “bulgari” o “serbi” sulle terre finitime del 1912-1913.
Conviene, allora, secondo questa seconda accezione, parlare no di una prospettiva turca, ma da
un punto di vista nazionalista turco. Mi piacerebbe conservare e sviluppare questa distinzione
nelle pagine che seguiranno, iniziando dalla prima dimensione, cioè da una mia considerazione
delle guerre balcaniche, formulata nella mia qualità di specialista della storia moderna della
Turchia (che nella fattispecie è Turco, conferendogli, in tal modo, una conoscenza e una
comprensione interiori del suo paese, senza che possa essere definito nazionalista); affronterà in
seguito inevitabilmente la seconda dimensione poiché, come mi piacerebbe dimostrare, il
nazionalismo turco non solamente si elaborò e si mescolò nella maggior parte nel calderone
delle guerre balcaniche, ma si rivelò, d’altronde, senza dubbio la loro più durevole eredità.
Le guerre balcaniche del 1912-1913 hanno avuto un ruolo cruciale nella storia turca moderna di
quanto spesso si possa immaginare, tanto per loro stesse quanto nella loro qualità d’anello di
congiunzione essenziale tra “le ultime due guerre dell’Impero ottomano e le prime guerre della
Turchia moderna”. Intendiamo, da questa perifrasi abbastanza lunga e poco comoda:
a) La guerra del 1911 che fece seguito all’invasione di Tripoli da parte dell’Italia;
b) Le guerre balcaniche del 1912-1913;
c) La prima guerra mondiale del 1914-1918 essa stessa, che fu per gli Europei la prima
Grande Guerra e rappresenta nella coscienza collettiva turca la mobilitazione generale
(Seferberlik ), ben inteso l’offensiva di Gallipoli, geograficamente molto vicina, così
come le campagne più lontane (e ormai distanziate dal punto di vista ideologico) del
Caucaso, di Suez, della Galizia e Mesopotamia: infine,
d) 1919-1922, conosciuta all’esterno come una guerra greco-turca supplementare (
relativamente minore) (vedi ad esempio, Overy, 1999), ma che rappresenta per i Turchi
la loro guerra d’Indipendenza (İstiklâl Harbĭ ) , che permise loro infine di allontanare lo
spettro della colonializzazione e di riaffermare il loro diritto alla sovranità, ben presto
consacrato dalla proclamazione il 29 ottobre 1923 dalla Repubblica Turca.
Questa guerra di indipendenza, di conseguenza e sotto l’azione storiografica, ha finito con
l’eclissare tutti gli altri conflitti che l’avevano preceduta e per intrattenere una relazione unica
nel suo genere con l’era Atatürk.
Transizione.
106
Tuttavia, secondo una veduta d’insieme, ognuno di questi conflitti forma l’anello di una lunga
catena d’avvenimenti: presi collettivamente, fanno parte integrante dell’ultima fase della
questione detta d’Oriente, nel corso della quale l’ultima agonia dell’uomo malato dell’Europa
cambiò o si mutò in un parto difficile di un nuovo Stato-nazione.
In altri termini, l’Impero ottomano fu colpito all’inizio del XX° secolo da una crisi profonda e
prolungata, che si protrasse dal 1908 al 1922, durante la quale le guerre balcaniche occuparono
un posto centrale da più punti di vista, e che formò lo zoccolo sul quale fu eretta la memoria
nazionale turca. Le testimonianze letterarie di questo di fatto abbondano. Il poema epico della
primavera del 1941, “ I paesaggi umani del mio paese” (Memleketimden İnsan Manzaralari),
del celebre poeta comunista turco Nâzim Hikmet, si apre con una scena nella quale si
rappresenta un certo caporale Ahmet, che è stato “ chiamato [sotto le bandiere] per le guerre
balcaniche/ chiamato per la mobilitazione generale/ chiamato per la guerra contro la Grecia” e la
cui manfrina “coraggio vecchio mio, ci siamo quasi” è diventata celebre (Hikmet, 1987, p.14).
Una sessantina di pagine dopo, vi incrociamo uno studente di sinistra che, dopo aver sentito il
suo compagno di viaggio declamargli una lunga storia a proposito di Gallipoli nel treno che li
conduceva a Ankara, pensa che:
“Così come esiste una varietà di pesci,
Una varietà d’alberi,
O una varietà di rocce,
Esiste ugualmente una varietà di esseri umani che vive in questo paese,
E per la quale le battaglie rappresentano
Il solo ricordo
Degno di interesse e indimenticabile.” (ibid, p. 79)
Nel romanzo di Yakup Kadri Karaosmanoğlu, lo “Lo straniero” (Yaban), un ufficiale di riserva
in convalescenza in un villaggio ritirato, in cui soggiorna dopo essere stato ferito nel corso della
guerra di indipendenza, incarna sia l’alienazione intellettuale che la stanchezza della guerra. La
letteratura scientifica offre almeno un esempio nel quale i diversi conflitti militari dal 1912 al
1922 sono prospettati come una sola e stessa “guerra dei dieci anni”, per il fatto delle mezze
generazioni implicate di soldati che essa ingloba (Görgülü, 1993).
Ecco per la continuità; ma che ne è dell’altro aspetto? Come questo aspetto si è operato, cioè in
quale momento, se ve ne è stato uno, si è passati dalle “ultime guerre dell’Impero ottomano”
alle “prime guerre della Turchia moderna?” In che modo le prime si sono fuse nelle ultime o
come una coscienza imperiale si è mutata in una coscienza nazionale? Inoltre, se è permesso in
un senso di qualificare “ ingiuste” le guerre condotte per la conservazione dell’impero mentre,
in opposizione, le guerre di liberazione o quelle condotte per respingere un’aggressione
sarebbero giudicate “giuste”, quale fu l’ultimo conflitto ottomano “ingiusto” e la prima guerra
turca “giusta”?
E’ senza dubbio più facile porsi queste domande che rispondervi. Formularle può aiutare a
mettere il dito su certi problemi spinosi, rilevando quanto è in generale indispensabile sostituire
la multiprospettiva di un’analisi all’egocentrismo obsoleto di un racconto nazionale degno del
XIX° secolo.Tuttavia, tranne ricorrere all’apriorismo logico (o alla dottrina esistenzialista) per
tentare di imporre una definizione categorica delle zone grigie o delle zone d’ombra e dei
contorni fluidi della storia, può rivelarsi in sostanza impossibile definire dei contorni precisi di
quale che sia la natura.
La nostra azione si riduce molto spesso a seguire l’evoluzione del processo: la rivoluzione
giovane-turca del 1908 portò il Comitato Unione e Progresso ( CUP) al potere ( o almeno ad
una divisione del potere). In opposizione al “dispotismo” (in turco: istbdat ) dell’era hamidiana,
il CUP proclamò la libertà ( Hürriyet ) per tutti. Esso intraprese ugualmente una politica che
mirava a “unire i diversi elementi “ (ittihad-i anâsir ) dell’impero intorno ad un’identità
107
“ottomana” comune ( che esso sperava vedere realizzata). Invece, esso fu messo a confronto con
una successione di sconfitte interne ed esterne, di fronte alle quali scivolò progressivamente, e
forse anche inconsciamente, verso un comportamento di difesa e combattivo destinato a
mantenere l’impero per il quale qualche anno prima aveva proclamato la libertà.
Che cosa bisognava scegliere: L’impero o la rivoluzione? L’impero o la riforma? L’impero o la
democrazia? Si può dire che tra febbraio e ottobre 1917 almeno, Kerenski scelse l’impero,
mentre Lenin preferì la rivoluzione, Nel 1956, lo stesso dilemma si presentò a Krouchov
quando, di fronte alle pressioni dei partigiani della linea dura del Politburo, inviò i carri armati
sovietici per reprimere la rivoluzione ungherese, segnando la fine della sua politica di
destalinizzazione. Verso la metà degli anni ottanta, al contrario, Gorbachov sacrificò la sua
posizione e il suo potere optando per la glasnost e la perestroika a discapito dell’impero. Si può
così ritenere che i Giovani Turchi preannuncino la scelta che Kerenski e Krouchov preferiscano
a quella di Gorbachov, che costò loro, come ai primi due, la loro rivoluzione.
Alcuni storici nazionalisti dei Balcani, piuttosto ostili ai Giovani Turchi, ritengono che questi
ultimi siano, dall’inizio, dei convinti nazionalisti turchi, che ricorrevano semplicemente
all’inganno e alla dissimulazione verso le comunità non musulmane e non turche dell’Impero
ottomano, prima di rivelare il loro vero volto di lupi travestiti d’agnello, che corrispondevano
dall’origine alla loro vera natura. Questa interpretazione è determinista e fa la sua bella parte
nella teoria del complotto, senza lasciare nessun posto agli incidenti della storia, ai processi di
“apprendimento “ reciproco e interattivo o alle contingenze e alla mutevolezza delle piattaforme
e dei programmi “iniziali”. Da un punto di vista empirico, al di là della loro intenzione di
restaurare la Costituzione del 1876, si può dire che gli Unionisti non avevano affatto progetti nel
1908. Sarebbe difficile trovare un gruppo di rivoluzionari del XX° secolo così improvvisati
come questi ultimi. E’ al contrario quando essi furono messi a confronto con l’imperialismo
delle grandi potenze e con il nazionalismo degli altri paesi balcanici che ritrasformarono a loro
volta in nazionalisti turchi ( dagli accenti imperialisti).
Questa trasformazione si operò in gran parte in seguito alle successive disfatte e non sotto
l’effetto di una qualsiasi simil vittoria, giacché essi persero la guerra del 1911 e subirono una
scottante disfatta del 1912-1913 e la seconda guerra balcanica aveva appena permesso loro di
recuperare solo una porzione dei territori persi. Tra il 1914 e il 1918, la sconfitta fu in pratica
totale, ad eccezione di Gallipoli, e solamente la guerra d’indipendenza del 1919-1922 permise di
mettere fine a questa successione di catastrofi. La disfatta fu sia, totale nel senso che ( a
discapito del gran numero di crudeltà e di massacri che furono commessi da più parti nel corso
di questo periodo) furono i Turchi musulmani dell’Impero Ottomano che risultarono i grandi
perdenti di questo lungo XIX° secolo ( vedi per esempio, McCarthy, 1995, 2001) che
dettagliata, infatti, ogni disastro particolare ha aggiunto la propria “goccia d’amarezza” ad una
coppa già troppo piena. D’altronde, le guerre balcaniche si rivelarono particolarmente amare:
questa disfatta non fu solamente inflitta dalle grandi potenze, ma, ciò che fu peggio è che fu
inflitta da un certo numero di piccoli Stati balcanici, “nostri antichi vassalli” per di più.
Così questa situazione, in un certo qual modo, è paragonabile all’insuccesso della repressione
greca del 1821 da parte di Porta, anche se le conseguenze sono state questa volta ancora più
drammatiche. All’epoca della prima guerra balcanica, il disordine ottomano innescò uno
sradicamento di popolazioni nate sul posto quasi equivalente all’esodo provocato dalla guerra
russo-turca del 1877-1878; si verificò, in tal modo, ancora una volta un’enorme affluenza di
rifugiati, di cui la povertà e la miseria nera si trasformarono in un’epidemia di colera, che
attraversò la Tracia fino alle imbarcazioni della riva europea di Istanbul e che attraversavano il
Bosforo per raggiungere l’Anatolia. La disfatta subita nei Balcani segnò di conseguenza una
nuova tappa nella formazione della Turchia moderna poiché nazione d’immigrati espulsi dalla
Crimea, dal Caucaso, dalla Grecia continentale, da Creta, dai Balcani o (in minor misura) dalle
antiche province arabe dell’impero. Questo disastro generò ugualmente l’avventò degli
Unionisti, il colpo di stato del 1913 (Babiâli Baskini), ed anche la venuta al potere di un
108
triumvirato di giovani capi militari ( Enver, Talat, Cemal) che aveva una totale irresponsabilità
politica.
Nello stesso tempo, la disfatta portò alle riforme militari del 1913-1914, nel corso delle quali la
vecchia generazione di colonnelli e di generali ottomani fu rimpiazzata da una nuova
generazione d’ufficiali unionisti, più giovani e più determinati. Furono precisamente queste
riforme che permisero all’armata ottomana di combattere in un modo piuttosto inconsueto
quattro o cinque anni dopo durante la Grande Guerra, al punto di sorprendere l’Intesa per
l’ostinata resistenza che essa contrappose soprattutto a Gallipoli. Mentre la passeggiata militare
alla quale si aspettavano i Britannici nel marzo-aprile 1915 sembra essere strettamente legata
agli impressionanti risultati delle forze ottomane nel 1912-1913, quest’associazione prevalse in
senso inverso, in seno al comando turco. Dopo una settimana appena d’intensi combattimenti
che avevano fatto seguito agli sbarchi del 24-25 aprile sulla penisola, Mustafà Kemal si rivolse
ai suoi subordinati nei termini seguenti, dando loro l’ordine di lanciare il 1° maggio 1915 un
contrattacco sulle forze dell’Anzac:
“Non posso assolutamente accettare che ci sia tra noi e tra le nostre truppe che noi
comandiamo degli uomini che preferirebbero vivere una decina di volte il disonore
subito nei Balcani piuttosto che morire qui. Se voi pensate che tali uomini esistono,
abbattiamoli immediatamente. “ (Steel e Hart, 1995, pp. 137-8)
Gli esempi di tali associazioni possono essere moltiplicati all’infinito. Dopo Mudros, mentre
Istanbul era occupata dai Britannici, ciò che restava della gerarchia unionista scelse Mustafà
Kemal per condurre una nuova resistenza nazionalista in Asia minore, che divenne così la
“Valley Forge” e lo “Yenan” della rivoluzione chemalista. Tuttavia, si può dire che l’idea di
liberare un ultimo combattimento in Anatolia non nacque nel 1918-1919, ma almeno cinque
anni prima, poiché l’estrema vulnerabilità di Istanbul era stata dimostrata perfino prima del
tentativo di penetrazione fatto dall’Intesa a Gallipoli, quando la prima guerra balcanica spogliò
l’Impero dei suoi possedimenti in Romalia e l’armata bulgara arrivò sulla linea di Satalca.
In essa stessa, quest’idea di ultimo combattimento, di ultima resistenza o, in altri termini, questo
sentimento per i Turchi di essere giunti in fondo alla corsa, non aveva niente che rassomigliasse
ad una caratteristica turca. Queste furono le conseguenze delle guerre balcaniche che ne fecero
una nozione comunemente condivisa. Aubrey Herbert all’epoca si trovava ad Istanbul; ecco ciò
che gli ispirarono le calamità umane e naturali durante l’inverno 1912-1913
“ Nevica senza tregua su una pianura desolata
e nell’alba nascente satura di fiocchi, la terra immacolata s’unisce al cielo
Cupo come un lupo famelico e ferito, la sua nuca scarnita presa in una
catena,
Il Turco affronta la morte.” ( op. cit. da Moorehead, 1985, p.82)
Per lo più, non si trattava di disfatte comuni che sopraggiungevano nelle situazioni classiche di
conflitto tra degli Stati-nazioni dalle frontiere chiaramente delineate e dalle popolazioni
etnicamente e politicamente consolidate, in cui “noi” ci ritroviamo all’interno, mentre il
“nemico” risiede all’esterno e il vincitore e il perdente si delimitano l’uno dall’altro ( o non si
confondono e s’osservano reciprocamente). Ora, nel 1912, l’Impero ottomano incominciava
appena il suo processo di separazione, anche se dal punto di vista turco, il “nemico” era tanto
all’interno quanto all’esterno.
Aubrey Herbert, infatti, costatò
“Nel 1913, quando i Balcani riportarono una schiacciante vittoria dopo l’altra sulle
forze turche equipaggiate male e disorganizzate, tutti i bar greci di Pera risuonavano di
canti trionfanti (ibid )
Si indovina appena il sentimento di estrema umiliazione, l’umore cupo e teso, così come
l’accumulo di odio che fecero nascere queste reazioni nei Turchi che li osservavano.
109
Nazionalismo
In tal modo, dalla disfatta risorge, prima di tutto forse, da una parte, un immenso sussulto
nazionalista che niente lasciava presagire, che non rappresentò né più né meno le prime
mobilizzazioni di massa della storia della Turchia moderna, traboccante d’assembramenti, di
interventi, di volontari e di lirici richiami alle armi, nato, notiamolo, non da problemi civili
nazionali che implicavano una lotta delle classi o altre forme di dissensi interni, ma una guerra e
l’urgenza della difesa nazionale, con tutto ciò che questo comporta in termini di autorità e di
solidarietà; ma questa disfatta generò ugualmente, d’altra parte, una forma di ideologia
nazionalista turca, dura, determinata, vendicativa e vendicatrice, che prese forma con il tempo
sotto l’effetto dell’insieme di questi fattori. Ben inteso, non si trattava ancora in questa epoca
della variante chemalista del nazionalismo turco, al quale tutti si sono abituati dopo la fine degli
anni 1920, ma in grandi linee e mal partorita esso presentava la sua versione iniziale. Per
collocare tutto ciò molto più aggiornato a tutt’oggi nelle prospettive teoriche usate nello studio
del nazionalismo contemporaneo, si potrebbe dire che questo nazionalismo unionista (Ĭttihatçi,
Ĭttihadist) o gli inizi del nazionalismo turco si situavano da qualche parte tra la terza via, definita
da Hroch, dello Stato-nazione europeo e i nazionalismi che stavano per apparire più tardi nel
contest coloniale dell’Asia o del terzo mondo.
Miroslav Hroch , e dopo di lui una vecchia studentessa Jitka Maleckova, hanno messo entrambi
in evidenza tre modelli fondamentali di costituzione dello Stato-nazione in ambito europeo: (1)
la traiettoria (britannica e francese) di rivoluzione o di modernizzazione, seguita da una
demografia relativamente stabili, già alla fine del medio Evo o agli inizi dei tempi moderni; (2)
un modello (tedesco ed italiano) di unificazione, che prevalse in Europa centrale e meridionale;
(3) un modello di deflagrazione degli imperi, molto più consono all’Europa orientale o al SudEst. Mettiamo da parte gli Asburgo per il momento; è indubitabile che nella sua fase di ripiego e
di disintegrazione, l’Impero ottomano fosse diviso sia all’esterno che all’interno; in altre parole,
questa separazione non fu soltanto l’opera delle grandi potenze, ma anche quella dei
nazionalismi serbi, greci, bulgari, rumeni, albanesi, montenegrini comparirono poco dopo e, in
definitiva, il nazionalismo turco, i quali si scatenarono in un combattimento accanito per il
possesso del territorio. Questa fu la stessa lotta che attenuò la sua acme intorno alle guerre
balcaniche ma, che modificò profondamente i loro molteplici e reciproci antagonismi, di cui
restano traccia ancora oggi.
Ma questa situazione presentò ugualmente un certo numero di squilibri; è la ragione per la quale
mi sembra indispensabile tentare di completare o di apportare delle modifiche alla terza ipotesi
definita da Hroch e Maleckova. Tutti questi squilibri sono in definitiva legati all’aspetto che
costituì l’insieme degli altri nazionalismi balcanici contro il potere imperiale, mentre il
nazionalismo turco si poneva per, a fianco di quest’ultimo. Soprattutto perché gli Unionisti si
trovavano essi stessi ai comandi, per così dire, e che il nazionalismo turco acquistò
nell’occasione di un suo confronto aperto e diretto con le grandi potenze, una dimensione proto
terzo-mondista di anticolonialismo generalizzato, relativamente assente dalle altre ideologie
nazionaliste dei Balcani.
In secondo luogo, come i Giovani Turchi ebbero a battersi per conservare l’impero, in
opposizione ai discorsi di liberazione degli altri nazionalismi balcanici, il nazionalismo turco
prese un accento fortemente imperiale e nazionale. In origine, l’aspetto imperiale dava inizio al
discorso nazionale in embrione. Paragonando i diversi decreti di mobilità del 1912, Fikret
Adanir ha dimostrato come tutti gli Stati balcanici hanno potuto fare appello direttamente e
istantaneamente alla “fede e alla nazione”, mentre il sultano ottomano era unicamente in grado
di invocare, debolmente e senza convinzione, la lealtà alla dinastia, i benefici della rivoluzione
del 1908, le riforme dei Giovani Turchi e l’ordine pubblico.
A questa epoca e in queste circostanze, una tale posizione non era molto semplice da sostenere e
quando l’impero scomparse, il nazionalismo turco si sviluppò in maniera repentina. In terzo
110
luogo, mentre esso agiva in tal modo, questa stessa situazione messa in evidenza dalle
acclamazioni dei Greci nel quartiere di Pera nel 1913 generò la sindrome del “nemico
dell’interno” e presentò, così, il nazionalismo turco, ossessionato dal tradimento e di essere stato
pugnalato alle spalle, come lo hanno dimostrato i recenti avvenimenti.
In quarto luogo, e ancora una volta in opposizione rispetto al potere imperiale ottomano, il
nazionalismo turco apparve e si sviluppò più tardi della maggior parte dei nazionalismi
balcanici, che divennero in conseguenza di ciò i suoi rivali e, paradossalmente, le sue guide e i
suoi maestri nell’oscura arte della creazione e dell’omogeneizzazione dello Stato-nazione. Alla
fine del XVIII° secolo e agli inizi del XIX° secolo, l’élite ottomana sembrava aver deciso di “
fare come gli Europei”, per essere in grado di tener testa all’Europa. Oggi, dopo quasi un secolo
di lancio del Tanzimat, accade quello che gli Unionisti avevano ipotizzato a loro volta “ di fare
come i Greci e i Bulgari”, per poter far fronte a questi nuovi demoni supplementari degli inizi
del nazionalismo turco. W. H. Auden scrisse nel “Il 1° settembre 1939”:
“La gente ed io stesso sappiamo bene
ciò che imparano tutti gli alunni:
Quelli a cui si fa del male
Fanno del male di rimando.”
Non esiste forse nessun legame di causalità diretta, ma un processo di interazione e di scalata
ideologiche che va dalle guerre balcaniche del 1912-1913 fino alle atrocità armene del 19151916. In fin dei conti, come in ogni vendetta, si riproduceva ciò che era stato già fatto.
Il rapporto con questa percezione da nessuna parte era espresso molto bene come nella
letteratura. Ömer Seyffedin (1884- 1920) fu uno dei pionieri degli inizi del nazionalismo turco.
Figlio di un capitano dell’armata la cui famiglia era stata costretta a fuggire dal Caucaso di
fronte all’espansione della Russia zarista, prese parte a sua volta personalmente ai conflitti e alle
tensioni di quest’ultimo disastroso decennio ottomano, durante il quale il nazionalismo esplose
in un modo così violento e repentino che la vita e la carriera di Ömer Seyffedin ricopre sia la
prima che la seconda fase della teoria dell’evoluzione del nazionalismo turco per tappe,
avanzata da Miroslav Hroch. Diplomato all’accademia militare (Mekteb-i Harbiye) nel 1903,
fece parte dell’armata con il grado di luogotenente e occupò un posto d’istruttore nella scuola
ufficiali della gendarmeria d’Izmir (1906-1907) – questa stessa nuova gendarmeria che ha
ricordato Ivan Ilchev nella sua esposizione sul punto di vista bulgaro presentata in questo
simposio. Nel 1908, l’anno della rivoluzione dei Giovani Turchi, fu trasferito nella terza armata,
accampata nella città ottomana di Selanik ( o Salonicco, oggi Tessalonica); testimone delle
operazioni condotte nel corso delle guerre balcaniche, egli si arrese alle unità dell’armata greca
durante l’assedio di Jannina. Liberato e inviato ad Istanbul dopo un anno di prigionia, egli lasciò
l’esercito definitivamente e consacrò il resto della sua vita alla letteratura.
In qualità di giornalista e di saggista, Ömer Seyfeddin militò per un nazionalismo di natura e a
carattere esistenzialista, affermando che “essere Turco ci induce a pensare, a sentire e ad agire
come un Turco”: Era ben inteso il contrario nella realtà: a forza di scrivere e di proclamare
senza tregua quale dovrebbe essere il modo di pensare, di sentire e di agire dei Turchi, lui stesso
e gli altri membri della sua generazione erano interamente occupati a costruire o ad inventare
l’identità turca (moderna).
Per Ömer Seyfeddin e gli altri, tutto ciò andava di pari passo con la trasmissione, di
quest’embrione iniziale di nazione turca, di una “memoria nazionale”, cioè un certo numero di
criteri sul modo di coltivare il “ricordo” di questa nazione, il suo passato e al di sopra di tutto, i
suoi nemici. Nelle definizioni della nazione proposte verso la fine del XIX° secolo,
parallelamente alla lingua, al territorio e all’economia, “un passato comune” in parte ispirato ad
Ernest Renan figura tra gli elementi più importanti. Questo elemento decisivo, intrinsecamente
soggettivo è associato ad altri elementi più materialisti o almeno poco soggettive, cosicché,
mentre l’aspetto innovatore dal punto di vista storico della nazione può essere generalmente
111
ammesso, la natura fantastica, inventata o virtuale del “passato comune” in questione e molto
ampiamente sottostimata o dimenticata.
Come mi sono sforzato di dimostrare a mia volta in altri scritti, succede che un gran numero di
letterati e di dilettanti che compongono “la stretta minoranza intellettuale” della prima fase del
nazionalismo definito da Hroch mettono in atto un riciclaggio selettivo degli elementi di una
“memoria sociale” pre-moderna, frammentata o eterogenea, in una “memoria nazionale”, ormai
incomparabilmente più densa e più omogenea; questa ultima è modellata, poi diffusa e acquista
una statura egemonica grazie allo “spazio-memoria” del capitalismo della stampa. Inoltre,
quando questo riciclaggio selettivo, fantastico e che richiama i sentimenti per convincere è
praticato su una larga scala, veramente popolare la finzione e la poesia sono immancabilmente i
media ideali.
Nel caso di Ömer Seyfeddin ugualmente, questo tipo di costruzione di memoria nazionale fu
realizzato non attraverso l’intermediazione dei saggi teorici, che egli indirizzava agli intellettuali
suoi pari, ma prima di tutto dalla sua finzione popolare, attraverso un numero considerevole di
novelle eccezionali, che non sono state mai superate dalla letteratura turca successiva e che la
loro sete di rinomate non fu mai spenta. Da questo punto di vista, un certo numero di racconti
particolarmente importanti trattano episodi dell’odiosa persecuzione subita dai Turchi o i
musulmani in seguito alle disfatte ottomano-turche e dal ritratto dell’impero dal 1908 al 1918,
durante i quali “noi” siamo le vittime e “loro”, gli scellerati, sono immancabilmente i Greci, i
Bulgari e gli Armeni. Questi racconti, che parlano globalmente di odio, sono tanto più
significativi se non sono pure invenzioni dell’immaginazione dell’autore ma che hanno le radici
(in parte) nella realtà della situazione sul terreno; poiché in questo affare abbastanza classico di
statuto di vittimismo volontariamente scelto e contestato, la scelta di Ömer Seyfeddin consiste
nel mettere l’accento su tutte le atrocità perpetrate dagli “altri” al “nostro” incontro, senza mai
andare ad indicare quello che nella stessa epoca “noi” facciamo, facevamo potremmo aver fatto
agli “altri”.
In ognuna di queste storie, ciò che risalta di più è che Ömer Seyfeddin non si accontenta di
colmare di ingiurie “i nostri nemici”, ma egli esorta ugualmente i Turchi a agire e a non
comportarsi peggio dei loro vicini.
Dovrebbe sembrare che la prospettiva di Seyfeddin sia unica. Permettetemi di far osservare che
alcuni dei primi poemi di Nazim Hikmet, scritti durante o in seguito di questo stesso sussulto
nazionalista provocato dalle guerre balcaniche traboccano tutto così violentemente di formule
vendicative, come “la mia eroica razza”, “i nostri nonni dalla barba bianca” o “le moschee
ormai coronate di croci”, e che ne rendono la lettura molto difficile oggi (vedi, per esempio,
Hikmet, 1987, pp.14,19). In seguito Nazim Hikmet, ben inteso, divenne non solamente
comunista, ma ugualmente un grandissimo poeta, uno dei più grandi che il XX° secolo abbia
avuto, e considerato da molti come l’equivalente di Pablo Neruda. Più di un quarto di secolo più
tardi, egli scrisse nella prigione di Bursa mentre era incarcerato, un’opera notevole, I paesaggi
umani del mio Paese.
In questo gigantesco affresco epico appare un personaggio simpatico, Kartalli Kâzim, uomo
onesto ardente comunista, di cui si è appreso che egli servì come giardiniere prima e dopo la
guerra di indipendenza, durante la quale egli ha combattuto dignitosamente e coraggiosamente.
Pertanto,questo stesso Kâzim ci è presentato con affetto e compassione da Nazim Hikmet come
un uomo che possiede due grandi debolezze che non riesce a superarle: egli continua a credere
in Dio e ad odiare i Bulgari, fino al punto che ogni volta che ascoltava un racconto infuocato da
agitamenti dei rivoluzionari bulgari, egli litigava con tutti. Ma ritrovava subito un sano conforto:
“ Siamo stati ingannati sia per gli atti commessi da questa nazione all’incontro delle donne
incinte durante la guerra dei Balcani, diceva- Sia questi rivoluzionari devono appartenere ad
un’altra tribù bulgara (op.cit.).
E’ per Kazim
un solo modo per farsi l’idea
dell’internalizzazione proletaria e di vedersi spiegare dal suo partito che fino ad oggi gli basta
considerare come suoi fratelli: E’ proprio lì il segno estremamente rivelatore dell’incidenza
112
degli anni 1912-1913 all’epoca e del modo in cui la demonologia iniziale del nazionalismo
turco si era ampiamente diffusa.
Arrivò, in seguito, la linea di rottura e il deliberato oblio ( o forse il semi-oblio o lo pseudooblio). Dopo la disfatta finale del corpo spedizioniere greco che aveva occupato l’Anatolia
occidentale, si giunse alla proclamazione della Repubblica Turca, preceduta dall’abolizione del
sultanato e seguita da quella del califfato, che aprì la via alla laicità. Considerata come il punto
principale di un nuovo programma d’occidentalizzazione totale. E’ interessante costatare come
la formula “raggiungere la civiltà contemporanea” ( muasir medeniyyet seviyesine ulaşmak)
divenne uno slogan principale di questa campagna di modernizzazione chemalista.
L’orientamento riaffermato dai chemalisti a partire della fine degli anni 1920 non mirava
unicamente a colmare il ritardo del paese sul cerchio o la famiglia, un tempo odiato e invidiato
contemporaneamente, delle nazioni “avanzate” o “civilizzate”,ma quant’anche a farne parte.
Questo desiderio di esservi ammessi apparve nella sfera della diplomazia nazionale sotto la
forma di uno slogan parallelo, “ Pace nel paese, pace nel mondo intero”, così come nel sostegno
energico accordato alla Società delle nazioni e nel ruolo attivo che vi giocò la Turchia. Esso
andò ugualmente di pari con la condanna esplicita del panturchismo e del turanismo degli
unionisti, o d’altronde da ogni altra varietà d’irredentismo turco. Ankara s’adoperò a
sconfessare tutte le rivendicazioni storiche possibili aldilà delle frontiere del Patto nazionale del
1920, preoccupata per impegnarsi in una politica precoce di non-allineamento, tentarono con
cupidigia di stabilire un’Intesa balcanica fondata sul riconoscimento multilaterale della
legittimità e dell’inviolabilità territoriale dell’insieme degli Stati esistenti della regione. In
questo contesto, i Balcani divennero il regno dimenticato dalla memoria del nazionalismo
(chemalista) turco a partire del 1930.
Tuttavia, rimase una base d’appoggio, uno strato sedimentario tossico depositato nel corso di
questo decennio micidiale delle “ultime guerre” del 1911-1922, che si estese come una placca
tettonica dall’unionismo al chemalismo e trascinò al suo seguito, in un lento movimento
sotterraneo, la demonologia iniziale del nazionalismo turco, quella dei “nostri nemici decretati i
Greci, i Bulgari e gli Armeni” ( con l’aiuto e la complicità delle grandi potenze). In che modo
questa epoca storica si sia evoluta, questo sostrato di memoria nazionale non è più tanto
immortalato dalla letteratura, la quale sarebbe oggi incapace di riprodurre la vivacità brutale
dell’odio di Ömer Seyfeddin, se non dalla storiografia e dai manuali.
Dalla storiografia, non penso naturalmente in questo contesto alla sottigliezza moderata di un
certo numero di universitari turchi, come Fikret Adanir (Bouchom), Engin Akarli (Brown),
Şükrü Hanioğlu (Princeton ) o Stefan Yerasimos ( Paris), che si sono schierati essi stessi con la
corrente dominante dell’erudizione storica così come, la si intende universalmente, ma alla
storiografia nazionalista, di cui si può rapidamente constatare tre caratteristiche principali. In
primo luogo, essa non è per niente diffusa, per il fatto che, da una parte, il riassetto dei Balcani
in un dominio dimenticato della memoria e, dall’altra, la valorizzazione chemalista
contemporaneamente all’episodio di Gallipoli, sopraggiunto all’epoca della prima guerra
mondiale e della prima guerra di indipendenza del 1919-1922, a discapito di tutte le altre. In
secondo luogo, degli scritti disponibili non trattano specificatamente il periodo 1912-1913, ma
privilegiano generalmente un continuum diluito “lungo il XIX° secolo”, in cui le inattese
aggressioni e senza un preavviso di dichiarazione di guerra ( come a Navarin nel 1827), il
tradimento e l’abbandono (come nel 1877-1878 ) o la perdita di territori persino in caso di
vittoria ( come si verificò il caso con la perdita di Creta dal 1896 al 1900) tendono a mischiarsi
con gli anni 1911 e 1912-1913 in un’unica successione di disgrazie interminabili e di
persecuzioni ingiuste, mentre le diverse clausole dei trattati di Londra (1830 ) Santo Stefano (
1878), di nuovo Londra ( 1913), Moudros (1918), e Sèvres (1920) si fondono ugualmente in un
solo ed unico metatesto del destino per tappe, ma pianificato prima, dell’uomo malato
dell’Europa.
113
In terzo luogo, questa narrazione si rivela estremamente minuta, lineare e schematica; e trattata
secondo un piano semplificato all’estremo, che si articola in un’opposizione tra, da una parte, le
“loro” ambizioni, cupidigie, tradimenti e aggressioni, e, dall’altra parte, la “nostra” innocenza,
le nostre buone intenzioni, i tradimenti che abbiamo subito e la nostra qualità di vittime. La
storiografia nazionalista turca ipotizza dapprima l’epoca detta classica dei secoli XV° e XVI°,
presentati come un periodo esente da conflitti dove l’armonia regnava tra lo Stato, i feudatari e i
contadini; essa ci ha fornito in seguito una versione espurgata della fine dell’antico regime
ottomano, che incarna secondo essa il trattamento giusto ed equo dell’insieme delle comunità
etniche e religiose (millets) da parte di Porta. Tutte le diverse rivolte nazionali e sociale che
scossero i Balcani sono giudicate talmente infondate e si ridussero a semplici banditismi o
brigantaggi. I Turchi erano, sembra, perfettamente abilitati a procedere verso una rivoluzione
unionista poi chemalista contro il dispotismo ottomano, mentre tutti gli altri movimenti
rivoluzionari nazionalisti non insorgevano contro lo stesso potere imperiale, ma in un certo
senso contro i Turchi in quanto tali. Il corollario di questo ragionamento è che “noi” eravamo
totalmente in diritto di cercare di ristabilire l’ordine pubblico, mentre “essi” continuavano a
perpetrare delle atrocità a nostro sfavore.
Molte opere riportandosi specificamente sulle guerre balcaniche sono eccessivamente
superficiali. Poiché sono state redatte per un pubblico esclusivamente nazionale e senza
preoccuparsi per niente delle norme della ricerca internazionale, fino al punto che gli autori
danno spesso l’impressione di essere così cinicamente disincantati dal loro soggetto che ne
diventano incapaci di darsi la pena di proporre un argomento valido che vada al di là dei cliché
dell’alterità nazionalista. Contemporaneamente alle condanne per la forma sono in uso, esiste
ugualmente un altro sotto-insieme di fonti primarie e secondarie, che comprendono le memorie,
i resoconti d’epoca delle diverse operazioni o campagne militari o le storie militari ufficiali
comandate dal dipartimento di storia della guerra, posto sotto l’autorità dello stato-maggiore ad
Ankara. Questi ultimi, notoriamente, sono uniformemente spenti, redatti non da storici, ma da
soldati in pensione, e destinati a degli ufficiali dello stato-maggiore e non ad un pubblico,
generale e intellettuale, essi brulicano a questo punto di dettagli tecnici che non giungono a dare
una visione d’insieme del problema.
Molte di queste storiografie sulle guerre balcaniche perdono la traccia della storicità del
nazionalismo turco, il quale si trova naturalizzato e immortalato fino al punto di perderne a sua
volta il suo concreto carattere storico. La comprensione del vero ruolo giocato dalle guerre
balcaniche nella costruzione iniziale della memoria nazionale turca non è chiara (manca), così
come le relazioni complesse tra l’unionismo e il chemalismo che ne scaturirono e che sfociarono
in una cancellazione parziale.
114
Riferimenti
Görgülü, Ismet, On Yillik Harbin Kadrosu 1912-1922, Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1993.
Hikmet, Nâzim, Memleketimden Insan Manzaralari, Adam Yayinlari, Istanbul, 1987.
McCarty, Justin, Death and exile: The ethnic cleansing of Ottomans muslims, 1821-1922, The
Darwin Press, 1995.
McCarty, Justin, The ottomans peoples and the end of empire, Londra, Arnold, 2001.
Moorehead, Alan, Gallipoli London, Ballantine Books, 1958.
Overy, Richard (ed.), The times atlas of world history, Londra, Times Books, 1999.
Steel, N., and Hart, P., Defeat at Gallipoli, Londra, Macmillan,1995.
115
116
14
Le guerre balcaniche (1912-1913): il punto di vista austriaco
Karl KASER
La situazione della monarchia austro-ungarica alla vigilia delle guerre balcaniche non era delle
più semplici sul piano della strategia politica e militare. Da un lato, essa considerava i Balcani
come la sua zona esclusiva d'influenza e come il solo spazio geografico e strategico dove
poteva sperare di emulare le altre grandi potenze europee nelle loro imprese coloniali;
dall’altro, la Russia era stata all'origine dell'alleanza militare degli Stati balcanici, cosa che
impediva all'Austria ogni influenza su questa stessa alleanza che, invece, i suoi sogni di potenza
coloniale richiedevano, e che rendeva i suoi obiettivi impossibili. Nello stesso tempo, il margine
di manovra della monarchia era limitato da diversi motivi, relativamente alle sue risorse
economiche e militari, ma soprattutto all'ordinamento politico internazionale del "concerto delle
grandi potenze", la cui dissonanza andava sempre crescendo, in particolare, riguardo ai sistemi
d'alleanza concorrenziali in vigore, che relegavano questo "concerto" ad una musica di fondo e
privilegiavano il confronto.
La politica estera austro-ungarica, nei limiti del possibile, si era essa stessa prefissata degli
obiettivi realistici, ma di cui solo una realizzazione parziale fu possibile, poiché le guerre
balcaniche generarono una dinamica che la monarchia non aveva previsto e che rimise in
discussione la sua strategia coloniale nei Balcani, in particolare in relazione alla Serbia. Le
autorità politiche e militari detentrici del potere decisionale trassero dalle guerre balcaniche la
conclusione che la strategia di politica estera che mirava a consolidare un'influenza decisiva sui
Paesi balcanici non poteva più essere attuata con mezzi politici, economici e diplomatici, tenuto
conto delle alleanze esistenti. Furono, alla fine, coloro che, fin dalla vigilia delle guerre
balcaniche, avevano imposto una guerra preventiva contro la Serbia per riprendere l'iniziativa
politica nei Balcani, che ebbero la meglio.
Il processo che portò a questa situazione sarà oggetto di una doppia analisi. La prima sarà
dedicata alle prospettive ed agli obiettivi coloniali della monarchia austro-ungarica alla vigilia
della prima guerra balcanica. La seconda esaminerà, in una prospettiva austro-ungherese, la
situazione strategica precaria sorta dalle conseguenze delle due guerre balcaniche.
Gli obiettivi colonialisti della monarchia degli Asburgo alla vigilia delle guerre balcaniche
Studieremo, in questa parte, inizialmente la posizione della monarchia asburgica in seno alle
grandi potenze europee. In un secondo tempo, ci soffermeremo sulla concezione colonialista
della monarchia in relazione ai paesi balcanici in generale, infine sul contenuto concreto della
politica estera austro-ungarica al termine della prima guerra balcanica.
Dal 1815 al 1878 circa, il "concerto delle grandi potenze" composto dalla Gran Bretagna, dalla
Francia, dalla Russia, dalla monarchia asburgica, come pure dalla Prussia/Germania, che l'Italia
venne a completare nella seconda metà del XIX secolo, garantì la stabilità dell'Europa. Questa
fu, tuttavia, rimessa in discussione dalla formazione dei nuovi Stati balcanici a spese
dell’Impero ottomano e dai tentativi della Russia, dell'Austria e dell'Italia, in vista di esercitarvi
una certa influenza. Questo sistema, che era stato per l'Europa una garanzia di pace e che
volgeva gradualmente alla sua fine, era sempre più eclissato dalle due alleanze costituite dalle
grandi potenze europee, che conducevano ad aumentare il rischio di guerra, nella misura in cui
l'impegno dell'uno dei suoi partner in un conflitto minacciava di trascinare al suo seguito i suoi
alleati nella guerra. Inoltre, questa politica internazionale d'alleanza delle grandi potenze si
accompagnava ad una politica d'armamento e d'investimenti militari (Mann 1998: 185f, 192).
Questo cambiamento avvenne in due fasi. 1) Dalla fine degli anni 1880 al 1902, esistevano due
zone opposte, separate l’una dall'altra: la Triplice Alleanza (Austria-Ungheria, Germania ed
Italia), che faceva fronte alla Doppia Alleanza (Francia e Russia). 2) Questi due blocchi di Stati
117
si consolidarono nel corso di una seconda fase: la crescita continua della Germania ed il crollo
della Russia durante la guerra contro il Giappone comportarono un riorientamento della
Granbretagna, che aderì in parte all'Intesa franco-russa (Mann 2001: 243). questi due decenni
videro l'adozione di una "teoria del realismo" in materia di guerra e di pace. Essa si basava su un
triplo postulato:
(1)
parlano;
(2)
(3)
Gli Stati hanno degli "interessi" o quanto meno i loro "uomini di Stato" ne
I conflitti di interessi tra Stati fanno parte della politica quotidiana;
La guerra è un mezzo ordinario e piuttosto pericoloso per uno Stato per imporre o
garantire i propri interessi.
Così, potenzialmente, lo scoppio di una guerra, considerata uno strumento razionale per
realizzare degli obiettivi nazionali, diventò sempre più probabile (Mann 2001: 238). Sotto
quet’aspetto, i piccoli Stati dei Balcani erano da tutti i punti di vista uguali alle grandi potenze:
le guerre balcaniche del 1912-1913 rientrarono pienamente in questo tipo di logica.
E’ opportuno anche, in questo contesto, prendere in considerazione il dogma nazionale
predominante che si impose nel corso della fine dello XIX secolo: la "geopolitica". Essa si
basava principalmente sulla convinzione che lo Stato costituiva un organismo geografico. Si
considerava, così, che Stati potenti e "vitali" avevano il desiderio "naturale" di estendere i propri
territori con la colonizzazione e la conquista. I geopolitici distinguevano quattro interessi
nazionali "vitali" per uno Stato:
(1) l'interesse preponderante della difesa del territorio;
(2) estendere il proprio controllo su altri territori attraverso un formalismo geopolitico,
(costringendo altri Stati a concludere "patti d'amicizia" o rendendoli economicamente
dipendenti);
(3) costituire uno spazio coloniale d'influenza e di dominazione strategica;
(4) garantire i primi tre punti ostentando una potenza economica e militare nell'ambito del
sistema degli Stati (ibid.: 241).
La lotta per l'egemonia, la razionalità della guerra, la geopolitica, gli interessi "oggettivi" delle
grandi potenze e una sorta di costellazione di alleanze furono i fattori che trasformarono un
conflitto regionale in una guerra mondiale. Così, un secolo, durante il quale l'Europa aveva
goduto di periodi di pace relativamente lunghi, volgeva alla sua fine. Le guerre balcaniche
furono un preludio alla prima guerra mondiale, nella misura in cui le loro conseguenze non
tenevano sufficientemente conto, agli occhi dell'Austria-Ungheria, dei suoi interessi.
Le possibilità per quest'ultima di realizzare le sue ambizioni nei Balcani si ridussero all'inizio
dello XX secolo, quando il concerto delle grandi potenze si mostrò sempre più pronto ad
abbandonare la sua politica d'ostacolo all'espansione dei piccoli e medi Stati balcanici a scapito
dell'Impero ottomano, che rappresentava dopo secoli di ostilità uno dei principali alleati
suscettibili di contrastare la "minaccia slava". La politica estera austro-ungarica mirava,
pertanto, a mantenere fino a quando possibile l'esistenza dell'Impero ottomano, da un lato, per
ridurre l'influenza della Russia nella regione e, dall'altro, per prevenire l'espansione degli Stati
slavi dei Balcani (che rischiavano anche di diventare una fonte di problemi nei suoi affari
interni). La monarchia entrò così in conflitto non soltanto con gli stessi Stati balcanici, ma anche
con le altre grandi potenze che avevano già abbandonato l'Impero otomano o si apprestavano di
distruggerlo. Gli storici più recenti ritengono che la doppia monarchia divenne quindi un peso
per il sistema europeo delle potenze. Annettendo la Bosnia nel 1908, lasciava intendere la sua
intenzione di inasprire la sua politica balcanica (Kos 1996:.10; williamson 1991: 42f; Bridge
1989:324f).
Le relazioni che l'Austria-Ungheria manteneva con i suoi due partner della Triplice Alleanza
riguardo a quella che veniva definita "la questione d'oriente", cioè la questione
118
dell'atteggiamento assunto nei confronti dell’Impero ottomano, ovvero del proprio
smembramento, erano più o meno delicate a causa della loro divergenza d'interesse. La
Germania, che non aveva alcuno scopo particolare sui Balcani, ma si concentrava sull'Anatolia,
temeva di essere trascinata in un conflitto balcanico dalla politica estera della doppia monarchia.
Si rifiutava pertanto di lasciare all'Austria il primo ruolo in materia di politica orientale
(Mommsen 1991: 206). questa posizione era in contraddizione con la politica estera austriaca,
che considerava i Balcani come sua sfera d'influenza esclusiva (Kos 1996: 42). La politica
estera tedesca sosteneva tuttavia gli interessi enunciati dall'Austria alla vigilia della prima
guerra balcanica, poiché non era possibile imporli con mezzi militari.
L'atteggiamento dell'Italia era diverso: cercava di preservare lo status quo fino a quando
quest'ultimo non evolveva in una direzione contraria ai suoi interessi. Per la politica estera
italiana, gli obiettivi definiti dagli affari esteri austro-ungarici dovevano condurre, dopo la loro
realizzazione nei Balcani, alla superiorità economica della monarchia asborgica a spese
dell'economia italiana, in particolare al Monténégro e alle zone di popolamento albanese.
Tuttavia, come l'Italia era fortemente impegnata nel Mare Egeo ed aveva rafforzato la sua
presenza in Africa del Nord in seguito alla guerra che la vedeva opposta all'Impero ottomano
sulle isole del Dodecaneso nel 1911-1912, non era in grado di svolgere un ruolo particolarmente
attivo nella prima guerra balcanica(Kos 1996:45ft).
Per quanto riguarda la doppia alleanza concorrente formata dalla Francia e dalla Russia, gli
interessi di quest'ultima nei Balcani erano considerevoli. La politica estera russa cercava di
consolidare gli Stati balcanici slav,i allo scopo, da un lato, di indebolire la doppia monarchia a
lungo termine almeno e, dall'altro, rafforzare la sua posizione nella regione. Mentre l'influenza
dell'Austria-Ungheria non cessava di ridursi fin dall'annessione della Bosnia nel 1908-1909, la
Russia riuscì a portare gli Stati rivali dei Balcani, cioè il Montenegro, la Serbia, la Bulgaria e la
Grecia, a concludere un’ alleanza militare contro l'Impero ottomano (Rossos 1981: 8fi).
Le ambizioni coloniali dell'Austria-Ungheria erano divise tra due tipi di politica coloniale: cioè
un esercizio diretto del potere e l'imposizione del suo sistema culturale ed amministrativo, come
in Bosnia-Herzegovina; cioè la tentazione di uno sfruttamento delle risorse economiche del
paese interessato, come ciò avrebbe dovuto essere realizzato per la Serbia, il rifiuto di
quest'ultimo di cedere alle esigenze della doppia monarchia che hanno tuttavia comportato lo
scoppio di una "guerra doganale" tra i due paesi (1904-1910). La politica coloniale adottata
dalla monarchia asburgica nei Balcani si basava anche, essenzialmente, su una filosofia
mercantile definita fin dallo XVIll secolo; secondo quest’ultima, occorreva sottoporre
l'espansione dei paesi ad un principio di spartizione distributiva del potere, poiché le ricchezze
del pianeta erano limitate e la loro ripartizione equivaleva ad un gioco a somma zero: qualsiasi
aumento della ricchezza di un paese A era realizzato inevitabilmente a scapito di un paese B.
Quest'idea era sostenuto dal legame ovvio che si stabiliva tra la ricchezza di un paese e la
propria capacità di uscire vittoriosi dalle guerre (Mann 1991: 357).
Si consideravano, così, le brevi ma intense guerre coloniali come operazioni razionali; il
vincitore si impadroniva delle colonie ambite, mentre il perdente doveva accontentarsi di ciò
che gli veniva lasciato. Questi conflitti offrivano per i decisionisti il vantaggio di non svolgersi
sul territorio nazionale. Condurre una guerra vittoriosa non presentava pertanto alcun
inconveniente nell'ambito dello Stato che l’ aveva vinta (eccetto un eventuale aumento della
fiscalità o una mobilitazione generale) e probabilmente andava anche a vantaggio della
maggioranza dei cittadini. Così, le classi abbienti si mostravano sempre più disposte a
finanziare una politica estera aggressiva, che favoriva i loro interessi (ibid.: 358f).
Il ruolo dello Stato consisteva, quindi, nei confronti di questa strategia, nell’aprire e proteggere i
mercati a favore della sua borghesia intraprendente, con l'aiuto della sua potenza militare. La
politica balcanica della monarchia asburgica non aveva altro scopo, anche nel corso della prima
guerra balcanica, che di impedire la perdita del suo ruolo di grande potenza di fronte alla
119
Germania, che era riuscita a costruire un impero coloniale durante i decenni precedenti, ed
all'Italia, che si preparava a fare lo stesso.
Era chiaro che se l'Impero ottomano non fosse uscito vittorioso dalla prima guerra balcanica,
questa avrebbe determinato, molto probabilmente, soltanto conseguenze negative per la
monarchia asburgica, poiché la vittoria sarebbe andata in questo caso agli alleati slavi ed alla
Grecia. Un intervento militare a favore dell’Impero ottomano avrebbe comportato una risposta
della Russia e sarebbe stato d'altra parte respinto dagli alleati tedeschi ed italiani. Quindi
appariva chiaramente agli occhi dei responsabili della politica estera della doppia monarchia, se
non dell'insieme del comando dell'esercito, che un intervento militare non costituiva una
alternativa seria (Bridge 1989: 323ff). La monarchia poteva, tuttavia, sperare in alcuni vantaggi,
a titolo, per così dire, di compensazione per essersi astenuta dall’ intervenire. A tale riguardo,
due obiettivi essenziali emersero dalle discussioni molteplici condotte dagli esperti consultati
dal ministero degli esteri all'inizio dell'autunno 1912:
a) garantirsi l'esercizio di un'influenza decisiva sul porto di Salonicco e sulla linea
ferroviaria che vi conduce;
b) impedire lo stabilirsi di ogni potenza ostile sulla riva orientale dell'Adriatico (nella zona
di popolamento albanese), come l'Italia (e ciò era poco probabile) o la Serbia (e questo
lo era maggiormente).
Si trattava, insomma, a prima vista, di esigenze principalmente commerciali ed economiche, ma
la cui realizzazione passava obbligatoriamente attraverso un'azione politica (Kos 1996: 231).
Non c’è alcun dubbio che questi due obiettivi venissero considerati come tappe preliminari, in
attesa di raggiungere lo scopo supremo della strategia militare e coloniale: la dominazione dei
Balcani. Grande perdente della politica coloniale delle grandi potenze europee, e dunque molto
in ritardo rispetto ad esse sul piano economico, l'Austria-Ungheria disponeva di risorse
economiche troppo limitate per conservare il suo posto fra di loro a medio termine (Kennedy
1989: 330ft).
Quando nell'autunno 1912 l'escalation delle tensioni rese apparentemente inevitabile una guerra
dell'alleanza balcanica contro l'Impero ottomano, il ministero austriaco degli Esteri considerò tre
grandi evoluzioni possibili del conflitto dopo il suo inizio: il mantenimento dello status quo in
caso di vittoria dell'Impero ottomano; la definizione di obiettivi realistici in caso di vittoria
dell'alleanza balcanica; l'accettazione dell'esistenza di sfere d'influenza degli Stati membri
dell'alleanza balcanica, associata ad un mantenimento parziale del status quo (Kos 1996: 19).
Trattandosi della seconda opzione, non sembrava ragionevole sperare di impedire agli Stati
vittoriosi di spartirsi i possedimenti europei dell'Impero ottomano; nessuno, ad eccezione di
alcuni dignitari dell'esercito, prevedeva (ancora) in questo caso un intervento militare. Nella
fattispecie, gli obiettivi strategici principali furono definiti come segue:
(1) creare un'Albania autonoma o indipendente;
(2) garantire un accesso a Salonicco. Vi si prevedevano la sistemazione di un porto franco
e, possibilmente, la concessione di uno statuto d'autonomia alla regione formata dalla
città e dalla penisola di Calcidica, messa sotto un'amministrazione internazionale di
qualunque natura;
(3) evitare che condizioni d'acquisto inaccettabili siano imposte al monopolio austriaco del
tabacco nella zona di produzione situata intorno alla città tracia di Drama o al porto di
Kavalla (Kos 1996: 20f).
L'Austria-Ungheria si aspettava, così, di conservare il suo ruolo decisivo di grande potenza nei
Balcani.
120
L'Albania
La creazione di un’Albania autonoma o possibilmente indipendente, che avrebbe permesso di
ottenere l'influenza risoluta dell'Impero asburgico, era diretta contro la Serbia, che desiderava
disporre di un accesso all'Adriatico indipendente dal Montenegro, e contro l'Italia, che
desiderava mettere questo stesso Adriatico nella zona d'influenza italiana. L'Austria-Ungheria
giudicava indispensabile mantenere la riva orientale dell'Adriatico sotto il suo controllo per non
disturbare la circolazione delle sue navi mercantili.
Benché la questione albanese fosse stata giudicata fuori luogo da Bismarck in occasione del
Congresso di Berlino nel 1878, le regioni di popolamento albanese costituirono gradualmente
nel corso dei decenni seguenti un fattore di politica internazionale, in particolare per l'AustriaUngheria, l'Italia e la Russia, le cui sfere di interesse si sovrapponevano sull'Albania. Più
semplicemente, gli interessi di queste potenze europee si potrebbero riassumere come segue: la
Russia si sforzava di sostenere l'espansione territoriale degli Stati slavi vicini a spese delle
regioni albanesi (e questo rafforzava nello stesso tempo indirettamente la sua potenza). L'Italia
ambiva a controllare le regioni popolate da Albanesi per controbilanciare l'amministrazione
della Bosnia-Herzegovina affidata nel 1878 all'Austria-Ungheria. Quest'ultima faceva il
possibile per ottenere l'indipendenza delle regioni albanesi più estese per fermare l'espansione di
due Stati balcanici slavi, la Bulgaria e la Serbia, in direzione del litorale adriatico.
Per i loro diversi interessi e per l'alleanza che erano suscettibili di concludere, due potenze
influenti, l'Italia e l'Austria-Ungheria, si mostravano, quindi, favorevoli all'indipendenza delle
regioni albanesi, quale che fosse la forma. Una rivalità crescente si instaurò tra questi due Paesi
a questo proposito, senza tuttavia sfociare apertamente in un conflitto . Questo ritegno può
spiegarsi con il fatto che nessuno dei due Stati cattolici ambiva, all'epoca, a controllare
direttamente regioni albanesi nelle quali essi avrebbero dovuto far fronte alle difficoltà legate
all'esistenza di una popolazione a maggioranza musulmana. Questa situazione avrebbe
certamente posto problemi all'Austria-Ungheria in particolare, poiché era messa a confronto dal
1878 con i conflitti che opponevano le popolazioni musulmane e cristiane in BosniaErzegovina. La prospettiva del declino della potenza ottomana in Europa aveva portato fin dal
1876 i due paesi a preconizzare un'azione comune riguardo alle regioni albanesi; in caso di
crollo dell'Impero ottomano, avevano deciso di sostenere la concessione di uno statuto
d'autonomia o d'indipendenza a favore di queste.
L'alleanza diplomatica e militare stabilita tra la Germania, l'Austria-Ungheria e l'Italia a partire
dal 1882 non lasciava grandi margini di manovra ai due Stati sulla questione albanese. Ma nel
1887, in occasione dei negoziati sull’estensione della suddetta alleanza, l'Italia era riuscita ad
imporre all'Austria-Ungheria la sua esigenza di compensazione in caso di modifica del status
quo nei Balcani a favore di quest'ultima. Esisteva dunque implicitamente per l'Italia un diritto a
compensazione a proposito delle regioni albanesi.
Nel 1897, i rappresentanti dei due Stati decisero a Monza di mantenere fino a quando possibile
la stabilità della situazione nei Balcani. Se una modifica territoriale si fosse prodotta tuttavia,
dovevano decidere insieme un'azione comune. Quest'accordo implicava che i due Stati
sostenessero la dominazione ottomana sulle regioni albanesi. Ma in caso di evoluzione della
situazione, i due Stati si sarebbero sforzati di raggiungere un accordo sul futuro statuto delle
suddette regioni, cosa che non escludeva la possibilità della creazione di una Albania
indipendente (Gostentschnigg 1996: 62f).
L'Italia e l'Austria-Ungheria si dedicarono, tuttavia, nello stesso tempo ad un'azione
concorrenziale di seduzione degli Albanesi sul piano culturale. Ma essa si limitò e doveva
limitarsi alla popolazione cattolica della parte settentrionale della zona di popolamento albanese.
Questa popolazione cattolica doveva esercitare il ruolo di trampolino per le altre regioni
albanesi. I metodi usati dai due Stati erano abbastanza simili: costruire e/o finanziare scuole,
influire sulla nomina dei membri del clero, costruire chiese ed offrire alla popolazione altri
121
regali più importanti o più modesti che si supponeva la appagassero. L'Austria-Ungheria era in
grado di mettere in vista il suo ruolo ufficiale di potenza protettrice delle popolazioni cattoliche
(ciò che venne definito “protettorato culturale"). Questa pratica generò l'afflusso annuale di un
aiuto finanziario considerevole nelle regioni albanesi. Nell'insieme, questa politica di
sovvenzione rappresentò, tuttavia, una concezione o uno strumento estremamente limitato della
politica estera, incapace di fare evolvere la situazione in una qualsiasi direzione
(Gostentschnigg 1996: 102-113).
Era chiaro che i cambiamenti decisivi dovevano provenire dall'esterno. Molte ribellioni della
popolazione albanese non erano riuscite a compromettere realmente la sovranità ottomana su
queste regioni. Si trattava di solito di sommosse locali motivate da esigenze molto specifiche,
come la resistenza all'aumento della fiscalità o al dispotismo di qualche funzionario ottomano.
Nel 1909-1910, ad esempio, il Kosovo fu, a varie riprese, scosso da sommosse causate
dall'aumento delle imposte o dal reclutamento di nuovi soldati. Nel corso dell'anno successivo,
le regioni albanesi del nord si sollevarono in maniera massiccia e trasmisero ai rappresentanti
delle grandi potenze europee accreditati nella capitale del Montenegro un memorandum che
esigeva la concessione di uno statuto d'autonomia in seno all'Impero ottomano, ma non
l'indipendenza; la componente musulmana della popolazione agì da parte sua con prudenza. Una
situazione simile si riprodusse nel 1912, che sfociò ancora una volta nella rivendicazione di
un'autonomia.
Così, globalmente, la monarchia asburgica era capace di svolgere il ruolo dominante che
considerava come un interesse vitale, creando una regione amministrativa albanese autonoma in
seno all'Impero ottomano o uno Stato albanese indipendente. La rivalità con l'Italia sulla
questione non poneva alcun problema, poiché il matrimonio dell'erede al trono e futuro re
Vittorio Emanuele I con la più giovane figlia del re Nicola I del Montenegro offriva un'altra
opzione d'ancoraggio territoriale nell’ Adriatico orientale.
Salonicco
Fin dal 1870, l'Austria-Ungheria considerava Salonicco come la porta più importante del
commercio mondiale austro--ungherese ("il commercio di Oriente”), questa posizione deve
intendersi nel contesto della costruzione del canale di Suez. Due scuole si opponevano sulla
questione del trasporto ottimale delle merci, cioè del modo più ragionevole di trasporto.:
(a) Aumentare il trasporto marittimo delle merci via Trieste, secondo un tragitto più
conveniente ma più lungo. L'inconveniente strategico di quest'opzione riguardava lo
stretto di Otranto, che poteva essere bloccato dall'Italia se essa riusciva a a stabilirsi
nelle regioni albanesi meridionali.
(b) Aumentare il trasporto ferroviario via porto di Salonicco, più caro ma più rapido. Fino
alla prima guerra balcanica, quest'opzione presentava il vantaggio, in caso di
realizzazione della linea ferroviaria detta "linea del Sandjak", di attraversare
esclusivamente territori sotto controllo austro--ungherese ed ottomano.
La tratta Tessalonica-Mitrovica (Kosovska Mitrovica), costruita dalla Società delle "ferrovie
d'Oriente" (sempre finanziata all'epoca da capitali tedeschi), fu aperta nel 1874; ancora non era
tuttavia collegata alla rete ferroviaria austriaca in Bosnia-Erzegovina. Il progetto della "linea del
Sandjak" doveva permettere il collegamento alla rete ferroviaria bosniaca, sistemata tuttavia
completamente secondo un sistema di via stretta. La realizzazione della linea della valle della
Morava sarebbe stata più economica, in particolare perché la monarchia aveva nel 1878
acquisito diritti considerevoli sulla rete ferroviaria serba. La linea ferroviaria del Sandjak non
rappresentò più un vantaggio al termine della prima guerra balcanica, poiché questa stessa
regione era diventata serba (Kos 1996: 190-193; Riedl1908: 10-13).
122
La politica estera austro--ungarica desiderava fare di Salonicco un porto franco, che avrebbe
accordato alcuni privilegi al commercio austro--Ungherese e la cui amministrazione sarebbe
stata affidata ad un imprenditore austriaco o ungherese (Kos 1996: 31).
Kavalla
Il tabacco coltivato nella regione tracia di Drama, situata a nord della città, era esportato dal
porto di Kavalla. In materia di trasporto, in particolare, la regione non era sufficientemente
sviluppata; l’unico elemento d’interesse per il porto di esportazione di Kavalla era rappresentato
dalle condizioni climatiche della città e dei suoi dintorni, particolarmente favorevoli allo
stoccaggio del tabacco. Contrariamente al porto concorrente di Salonicco, Kavalla era
climaticamente protetta a nord e non era, quindi, esposta ai suoi venti freddi. Il"vardarac"
poteva infatti fortemente alterare la qualità del tabacco nel porto di Salonicco. Quasi 150 piccole
e grandi società, principalmente austriache, si erano stabilite fin dall'epoca ottomana e si
fornivano in tabacco presso la direzione dei tabacchi ottomani. La località di Kavalla non era
tuttavia essenziale all'industria austriaca del tabacco, poiché il 63% delle sue necessità potevano
essere soddisfatte dalla propria produzione (Kos 1996: 218:ff).
Possiamo così concludere che l'Austria-Ungheria attendeva le conseguenze della prima guerra
balcanica con una prospettiva di successo estremamente limitata, poiché la speranza del
mantenimento dell'Impero ottomano in Europa era svanita e l'aumento della potenza degli Stati
ostili all'alleanza balcanica diventava inquietante. Con chi l'Austria-Ungheria doveva o poteva
formare una coalizione per raggiungere gli obiettivi d'altra parte poco ambiziosi che si era
prefissata?
La prima guerra balcanica ed i nuovi dati
Le conseguenze negative della guerra dei Balcani sulla posizione della doppia monarchia
condussero il ministero austro--ungarico degli Esteri a lanciare una controffensiva strategica: si
trattava di rompere l'alleanza militare ricongiungendo uno dei suoi membri (Kos 1996: 121).
Era importante innanzitutto avvicinare la Serbia e il Montenegro, quindi la Bulgaria. Questo
tentativo sembrò facilitato dal fatto che all'inizio dell'anno 1913 l'alleanza balcanica era
evidentemente sul punto di frantumarsi a causa dell'incapacità dei suoi membri, la Bulgaria, la
Serbia e la Grecia, ad intendersi sulla spartizione della Macedonia.
Fin dalla fine del mese d'ottobre 1912, quando la sconfitta dell'Impero ottomano fu evidente,
Vienna intravide fondamentalmente tre mezzi per raggiungere i suoi obiettivi economici e
politici:
(1) un'unione doganale fondata su accordi economici di una portata considerevole con la
Serbia e/o il Montenegro
(2) un'unione doganale con diversi Stati dei Balcani o con gli Stati dell'Unione balcanica
(3) un accordo di cooperazione con la Bulgaria
La doppia monarchia tentò di attuare queste opzioni senza coordinare la sua azione con le altre
grandi potenze, poiché considerava la regione come la sua sfera d'influenza esclusiva (Giesche
1932: 16ft).
Trattandosi di un'unione doganale con la Serbia e/o il Montenegro, gli accordi commerciali
conclusi abitualmente a quel tempo comprendevano una clausola della nazione più favorita che
non bastava a garantire ad un partner commerciale una posizione privilegiata sul mercato della
parte contraente. Un'unione doganale, cioè l'abolizione delle frontiere doganali tra due paesi
poteva rivelarsi uno strumento più efficace: avrebbe garantito le vendite di merci austro-ungheresi alla/e parte/i contraente/i e l'importazione a buon mercato di prodotti agricoli prodotti
da quest'ultimi. Fin dall’inizio, naturalmente, la monarchia asburgica pensava anche a mettere in
tal modo la Serbia sotto la sua dipendenza. Era almeno il progetto del Ministero degli Esteri;
123
ma il ministero delle Imposte e delle Finanze respinse definitivamente questo progetto d'unione
doganale, poiché risultava difficile da realizzare per ragioni tecniche e perché era impossibile,
secondo lui, mettere in ginocchio un paese come la Serbia con questo mezzo, come aveva
sufficientemente dimostrato la "guerra doganale" intrapresa da questi due paesi tra il 1904 ed il
1910, in seguito alla questione dell'esportazione del maiale serbo verso la doppia monarchia
(Kos 1996: 53).
La Serbia e la questione del suo accesso all'Adriatico
La guerra doganale con l'Austria-Ungheria evocata precedentemente aveva condotto alla
riorganizzazione e alla diversificazione delle esportazioni serbe (dal bestiame e dagli animali da
cortile fino ai cereali e ai prodotti di trasformazione). L’economia di esportazione serba
dipendeva dalla sua possibilità di accedere al porto di Salonicco, cosa che restava un’opzione
aleatoria, poiché l’Impero ottomano ne aveva a più riprese proibito l’accesso. Quindi il progetto
di disporre del proprio porto nelle regioni albanesi del nord e del centro vide il giorno (Vojvodic
1987: 247). Esso prevedeva l'apertura di un corridoio da quaranta a cinquanta chilometri di
larghezza da Mrdare a Shengjin (al Nord-ovest di Lezha) o Durrës, via Pristina e Djakova.
L'esigenza di un porto serbo sull'Adriatico risaliva al XIX secolo e doveva garantire
l'indipendenza del commercio serbo riguardo all'estero. Questa misura doveva accompagnarsi
ad una linea ferroviaria Danubio-Adriatica che attraversava il sud della Serbia (Kos 1996:.62).
La realizzazione di questo progetto avrebbe richiesto investimenti considerevoli, poiché i due
porti previsti offrivano soltanto una debole bretella d'acqua a causa del loro forte insabbiamento
(Kos 1996: 64).
Sembrava abbastanza evidente che il riavvicinamento economico della Serbia e dell'AustriaUngheria dipendeva dalla condizione preliminare dell'accettazione della costruzione di un porto
sull'Adriatico (Kos 1996: 59). ma era altrettanto chiaro d'altra parte che la doppia monarchia
non poteva acconsentirvi. Questa soluzione infatti avrebbe in primo luogo compromesso la
formazione di un’Albania autonoma o indipendente e, in secondo luogo, avrebbe presentato il
rischio di un'alleanza possibile italo-serba, cosa che avrebbe avuto per conseguenza di
permettere all'Italia di stabilirsi nei territori albanesi (meridionali) e controllare così lo stretto di
Otranto: l'accesso dell'Austria-Ungheria al commercio mondiale sarebbe stato colpito finché
Trieste fosse rimasta il suo primo porto d'esportazione.
Così, risultava difficile conciliare gli interessi dei due paesi. La politica austro--ungarica mirava,
da un lato, a forzare la Serbia a formare un'unione doganale impedendole definitivamente di
possedere un porto sull'Adriatico e, dall'altro, a prendere il controllo di Salonicco per privare la
Serbia del suo porto d'esportazione (Kos 1996: 69f). Ma il governo serbo si oppose con
fermezza a questa politica. Il ministero austro--ungarico degli Esteri propose finalmente alla
Serbia un compromesso nel quale l'unione doganale era sostituita da solidi rapporti commerciali
e l'utilizzo da parte della Serbia di un porto sul Mare Egeo (Kavalla, eventualmente Salonicco).
Questa soluzione sembrava presentare per la monarchia il vantaggio di offrire alla Serbia una
possibilità d'accesso ad un porto sul Mare Egeo grazie al solo sostegno diplomatico dell'AustriaUngheria. La Serbia inoltre si sarebbe disinteressata dell'Adriatico e sarebbe entrata in conflitto
con la Grecia e la Bulgaria, cosa che poteva comportare la scissione dell'alleanza balcanica (Kas
1996:.81). Ma questo compromesso avrebbe imposto la realizzazione di due condizioni: la
cessione di Salonicco alla Bulgaria ed un trattato d'amicizia tra quest'ultima e la monarchia
austro--ungarica, che avrebbe allora controllato due porti. Il rifiuto definitivo di quest'offerta da
parte del governo di Nikola Pasic dispensò l'Austria dall’ avanzare su questa via (Kos 1996: 82).
D'altra parte, l'esigenza serba di un porto sull'Adriatico non era neanche sostenuta dalla Russia,
poiché quest'ultima riteneva che la cosa non meritasse il rischio di una guerra con la monarchia
asburgica. Così, divenne impossibile alla Serbia concretizzare quest'idea, ciò che confermò
anche la conferenza degli ambasciatori di Londra in occasione della quale fu decisa la creazione
di un’Albania indipendente e territorialmente coerente (Kos 1996: 90f; Bridge1989: 326).
D’altra parte, quest'evoluzione metteva un termine ai tentativi austro--ungarici di colonizzazione
124
pacifica della Serbia. Il progetto, d'altra parte vago, d'unione doganale con diversi Stati balcanici
fu in realtà abbandonato; in ogni caso, la sua realizzazione avrebbe imposto di superare la
resistenza dei suoi due alleati: l'Italia temeva infatti di perdere la sua influenza economica nella
regione, poiché la doppia monarchia sarebbe in tal modo stata in grado di garantirsi il
monopolio personale; la Germania temeva da parte sua di essere trascinata in questo modo nei
conflitti balcanici che ne fossero scaturiti (Kos 1996: 84).
Il solo successo riportato dalla monarchia asburgica fu quello della creazione di uno Stato
albanese indipendente. I territori albanesi erano stati occupati nel corso della prima guerra dei
Balcani dall'alleanza balcanica. Nel sud, l'esercito greco teneva il nord dell'Epiro, la Serbia
occupava il Kosovo, il nord della Macedonia e l'Albania centrale, mentre il Montenegro
controllava la città di Shkodra ed i suoi dintorni. Dopo avere consultato il conte Berchtold,
ministro austro-ungherese degli Esteri, Ismail Kemal Bey, uno dei dirigenti albanesi in esilio, si
recò a Durrës quindi a Vlora, le sole città importanti a non essere occupate da truppe straniere.
Un governo provvisorio rapidamente formato proclamò l'indipendenza dell'Albania il 28
novembre 1912.
Tutto il resto era ormai di competenza dei negoziati internazionali condotti dagli ambasciatori
delle grandi potenze europee accreditati a Londra. Mentre la spartizione della Macedonia causò
lo screzio dei vecchi alleati e lo scoppio della seconda guerra balcanica, i negoziati iniziarono
sulla questione delle frontiere albanesi. Fra tutte le parti del negoziato, l'Austria-Ungheria
sostenne con più determinazione una soluzione quanto più generosa possibile per l'Albania. Lo
Stato più risolutamente opposto a questo progetto era la Russia. La questione di Shkodra fu
delicata, poiché la città era occupata dalle truppe montenegrine. L'Austria-Ungheria mise tutto il
suo peso sulla bilancia e riuscì ad averla vinta. Ma fu incapace di imporre il suo punto di vista
sulla frontiera orientale dell'Albania. Pertanto, la totalità del Kosovo e la Macedonia occidentale
ritornarono alla Serbia (Gostentschnigg 1996: 74-77). La controversia sulla frontiera
meridionale con la Grecia sfociò in un accordo soltanto nella primavera seguente. Benché la
creazione dell'Albania fosse indubbiamente un successo per la diplomazia austro-ungarica,
rimase tuttavia relativo, poiché il giovane Stato affondò immediatamente in una crisi duratura.
La questione dell'alleanza con la Bulgaria
A causa del fallimento di qualsiasi forma d'alleanza con la Serbia, non restava alla politica
estera austro-ungarica che l'ultima delle tre opzioni strategiche che aveva previsto, cioè
un'alleanza con la Bulgaria; si trattava di un argomento delicato, in particolare perché la
Romania era alleata della Triplice Alleanza e manteneva apertamente una controversia
territoriale con la Bulgaria rivendicando la Dobroudja meridionale e la città di Silistra. D'altra
parte, la Bulgaria era pronta ad accettare l'esistenza di uno Stato albanese e la doppia monarchia,
da parte sua, era più favorevole a una Grande Bulgaria che ad una Grande Serbia. La Bulgaria
avrebbe anche acconsentito all'attribuzione dello statuto di porto franco a Salonicco, come pure
alla costruzione di una linea ferroviaria che avrebbe collegato Kavalla (Kos 1996:.122; 130);
essa diede tuttavia il suo accordo a proposito di Salonicco soltanto dopo che la città fu assediata
dall'esercito greco.
La convergenza rumeno-bulgara costituiva il presupposto indispensabile per qualsiasi alleanza
tra la monarchia asburgica e la Bulgaria. Quest'ultima accettò di avviare negoziati con l'AustriaUngheria, nonostante gli aspetti economici negativi che si aspettava, in particolare perché questa
era la sola grande potenza da prometterle una compensazione per la cessione di Silîstra alla
Romania: l'attribuzione di Salonicco. La Russia infatti si era pronunciata prima per la
conservazione del porto da parte della Grecia. Inoltre, la monarchia sosteneva anche le esigenze
bulgare su Ohrid e Bitola, a scapito della Serbia (Kos 1996: 159).
Nel caso in cui Salonicco fosse messa sotto amministrazione bulgara, la Bulgaria avrebbe
accordato all'Austria-Ungheria le concessioni economiche seguenti:
125
-
la costituzione di una zona portuale franca per il commercio di transito
l'autorizzazione per l'Austria-Ungheria di costruire nel porto depositi giganteschi e
capannoni destinati a fungere da depositi provvisori
la partecipazione dell'Austria-Ungheria all'amministrazione del porto sotto una forma
adeguata (Kos 1996: 160).
La Bulgaria e la Grecia si erano disputate il controllo di Salonicco fin dalla sua occupazione da
parte delle truppe greche, all'inizio del mese di novembre. In fondo molto poco interessava alla
doppia monarchia che la città appartenesse all'uno o all'altro di questi due Stati, purchè si
concretizzasse il suo progetto di accesso al porto. Entrambi erano nel complesso pronti ad
accordare uno statuto particolare all'Austria-Ungheria. Ma quest'ultima si pronunciò a favore
della Bulgaria, per concludere con essa l'alleanza alla quale aspirava e che esigeva, da un lato, la
cessione di Sîlistra alla Romania e, dall'altro, la concessione di una compensazione alla Bulgaria
(Kos 1996: 135ft).
La politica estera austro-ungarica riuscì a creare sulla questione una certa dinamica verso la fine
del mese di gennaio 1913, nel momento in cui l'alleanza balcanica minacciava di dissolversi. Il
governo austro-ungarico decise di acquistare dalla Deutsche Bank la Società delle ferrovie
d'Oriente, che gestiva anche la linea ferroviaria Salonicco-Mitrovica di cui deteneva la
maggioranza del capitale. La monarchia sperava in questo modo di sottolineare il suo impegno
nella questione di Salonicco (Kos 1996: 151f).
La diplomazia austro-ungarica non riuscì tuttavia ad imporre successivamente il suo punto di
vista su Salonicco. Il 31 marzo 1913 si aprì a Sanpietroburgo, in presenza dei rappresentanti
delle grandi potenze e sotto la presidenza del ministero russo degli Esteri, la conferenza degli
ambasciatori che mirava al regolamento della controversia territoriale che opponeva la Romania
alla Bulgaria. Fin dai primi negoziati, i rappresentanti della Triplice Alleanza si mostrarono
incapaci di raggiungere un accordo sull'attribuzione di Salonicco alla Bulgaria in
compensazione della perdita di Silistra, poiché l'Italia e la Germania espressero la loro
opposizione a quest'idea. Inoltre, la Russia e la Francia, a fianco della Germania, rifiutarono
categoricamente la proposta austro-ungherese, la doppia monarchia fu quindi costretta ad
abbandonare i suoi progetti economici e politici a proposito di Salonicco (Tukin 1936: 164ff).
La conferenza di Sanpietroburgo fu una cocente sconfitta per l'Austria. La Bulgaria non
otteneva Salonicco a titolo di compensazione, mentre la città era ora attribuita così alla Grecia,
cosa che avrebbe permesso alla Serbia, che aveva nel frattempo concluso un accordo con la
Grecia, di beneficiare di un accesso a questo stesso porto. Fu chiaro fin da allora che il governo
greco non avrebbe accordato all'Austria-Ungheria condizioni d'accesso al porto di Salonicco più
favorevoli di quelle della Serbia (Ebel 1939: 199ff).
I tentativi austro-ungheresi di fare della doppia monarchia una grande potenza europea,
decisiva nei Balcani con mezzi diplomatici, erano così falliti in seguito alla prima guerra
balcanica. Nonostante il successo che rappresentava per essa la creazione di un’Albania
indipendente, non era riuscita a controllare la Serbia, nè con la sua dominazione economica nè
attraverso un'alleanza con la Bulgaria. Per la prima volta, il ministro austro-ungarico degli Esteri
previde seriamente di regolare la questione serba con il ricorso a una soluzione violenta
(militare) (Tukin 1936: 164ff).
La situazione strategica fondamentale della monarchia asburgica peggiorò sotto due aspetti al
termine della seconda guerra balcanica: in primo luogo, la Serbia ne uscì rafforzata; in secondo
luogo, la Bulgaria perse il suo accesso al Mare Egeo o piuttosto le regioni tracie produttrici di
tabacco ed il porto di Kavalla. L'Austria-Ungheria aveva interesse che la Bulgaria conservasse
la regione di Kavalla che occupava dalla prima guerra balcanica, non tanto per la sua
importanza economica (l'industria di sigarette) abbastanza marginale, quanto per ragioni
politiche (fare entrare contro qualsiasi attesa la Bulgaria nel suo campo) (Kos 1996: 221f).
Durante la Conferenza di pace di Bucarest nell'agosto 1913, la Russia e l'Austria-Ungheria
iniziarono ad entrare in conflitto sulla questione, poiché la Grecia, sostenuta dalla Russia, non
126
intendeva abbandonare le province tracie che aveva conquistato nel corso della seconda guerra
balcanica. Agli occhi dell'opinione pubblica, la Conferenza di Bucarest apparve come una
disgrazia per l'Austria-Ungheria (Kos 1996: 224f; Gostentschnigg 1996: 74).
Conclusioni
L'Austria-Ungheria deve essere considerata come la grande perdente, nell'ambito delle grandi
potenze, della crisi dei Balcani del 1912-1913, benché la Russia non sia stata capace di imporsi
in modo preponderante. Ma mentre i Balcani rappresentavano per la Russia soltanto un teatro di
operazioni fra le altre, in cui soddisfare le proprie ambizioni espansionistiche, essi offrivano
all'Austria la sola possibilità d'espansione e le conseguenze negative delle guerre balcaniche
furono tanto più importanti. Da un lato essa aveva contribuito con successo a rompere l'alleanza
balcanica ed era riuscita a consolidare la sua posizione sull'Adriatico; dall’altro, non era riuscita
né a ricongiungere la Bulgaria al suo fianco, né ad eliminare o neutralizzare la Serbia, al
contrario: la Serbia usciva rafforzata dalla crisi ed il piccolo Stato era diventato una potenza
media rispettabile. Così, sia sul piano politico che su quello economico, la monarchia era lungi
dall’avere raggiunto gli obiettivi che si era prefissata.
Questo fallimento finì col mettere davanti l'opzione militare per la realizzazione dei progetti
colonialisti. Fin dalla vigilia della crisi balcanica, gli ufficiali superiori e l'erede al trono,
l’arciduca Francesco Ferdinando, si erano pronunciati a favore di una guerra preventiva contro
la Serbia (Hantsch 1963: 360ff). Al termine della prima guerra balcanica, la subordinazione
economica della Serbia sembrò improbabile per l'Austria-Ungheria e la politica estera di
quest'ultima si orientò sempre più verso un confronto diretto con la Serbia, mentre il ministro
degli Esteri, Berchtold, indietreggiava ancora, all'epoca, davanti alle conseguenze di una tale
decisione, che avrebbe probabilmente significato l'entrata in guerra della Russia. Inoltre, i
partner della Triplice Alleanza erano contrari ad un impegno militare (Kos 1996: 202).
Una volta conclusa la seconda guerra balcanica, Berchtold si chiese se non sarebbe stato
preferibile impegnarsi militarmente a fianco della Bulgaria contro la Serbia. Egli non escluse
più ormai l'idea di una guerra preventiva (Kos 1996: 229) e giunse alla conclusione che era
meglio esigere il ritiro della Serbia da alcune regioni, allo scopo di provocare un'escalation che
avrebbe permesso il ricorso ad una soluzione militare. Questo cambiamento d'atteggiamento è
anche da mettere in relazione con, da un lato, il ravvicinamento che prendeva forma sempre più
tra la Romania, partner della Triplice Alleanza, e le potenze ostili dell'Intesa e, d'altra parte, con
l'alleanza ora evidente tra la Grecia e la Serbia (Kos 1996: 231).
Il conflitto che oppone l'Austria-Ungheria alla Serbia aveva raggiunto dopo la seconda guerra
balcanica un tale parossismo che rendeva a lungo termine ogni soluzione pacifica impossibile
per l’uno o l'altro Stato, poiché ciascuno tentava di privare l'altro dei mezzi indispensabili alla
sua esistenza. Una coesistenza pacifica era possibile per l'Austria soltanto sulla base di una
relazione coloniale, mentre supponeva per la Serbia l'abbandono da parte dell'Austria del suo
atteggiamento di grande potenza. Davanti a quest'escalation conflittuale, i responsabili politici
favorevoli ad una conciliazione vedevano le loro possibilità di farsi intendere ridursi di giorno
in giorno. Mentre la Serbia e il Montenegro perseguivano una politica di "piccoli colpi di
pungolo" nei confronti dell'Austria-Ungheria, le élite politiche e militari della monarchia
asburgica pensavano sempre più a cogliere la minima occasione per scatenare un conflitto
militare (Kos 1996: 235). l'assassinio dell'erede al trono, Francesco-Ferdinando, a Sarajevo, il
28 giugno 1914, fornì il pretesto di una soluzione militare.
127
Riferimenti
Bridge, Francis «Ôsterreich (-Ungarn) unter den Groûmâehten», Die Habsburgermonarchie
1848-1918, éd. Adam Wandruszka et Peter Urbanitsch, vol. VI: Die Habsburgermonarchie im
System der intemationalen Beziehungen, vol. 1, Vienne, 1989, 196-373.
Ebel, Ernst: Rumânien und die Mittelmûchte von der russisch-tûrkischen Krise 1877/78 bis zum
Bukarester Frieden vom 10. 1913, Berlino 1939.
Giesche, Richard: Der serbische Zugang zum Meer und die europâische Krise 1912 (Beitrâge
zur Geschichte der nachbismarkischen Zeit und des Weltkriegs, Quaderno 18), Stuttgart 1932.
Gostentschnigg, Kurt: Zwischen Wissenschaft und Politik: Die ôsterreichisch-ungansehe
Albanologie 1867-1918, Diss. Graz 1996.
Hantsch, Hugo: Leopold Graf Berchtold. Grandseigneur und Staatsmann, 2 voll., Graz-ViennaColonia 1963.
Kennedy, P.: Aufstieg und Macht der grojJen Mâchte. Okonomischer Wandel militârischer
Konfliki von 1500 bis 2000, Francfort 1989.
Kos, Franz-Josef: Die poltttschen und wirtschaftlichen Interessen Osterreich-Ungarns und
Deutschlands in Sûdosteuropa 1912/13. Die Adriahafen-, die Saloniki-und Kavallcfrage.
Bôhlau: Vienna-Colonia-Weimar 1996.
Mann, Michael: Geschichte der Macht: Vom Rômischen Reich bis zum Vorabend der
Industrialisterung. Francfort 1991.
Mann, Michael: Geschichte der Macht: Die Entstehung von Klassen und Nationalstaaten, 2
voll., Francfort, 1998-2001.
Mommsen, W.J. «Osterreich-Ungam aus der Sicht des deutschen Kaiserreichs» In: Innere
Staatsbildung und gesellschaftliche Modernisierung in Osterreich und Deutschland 1867/711914. Historikergesprâcb Osterreich -Bundesrepublik Deutschland 1989, éd. H. Rumpler,
Vienna-Munich 1991,205-220.
Riedl, R.: Sandschakbahn und Transversallinie. Ein Beitrag zur Geschichte der
verkehrspolitischen Interessensgegensâtze auf der Balkanhalbinsel. Vortrag gehalten am
13.Marz 1908 im Niederôsterreichischen Gewerbevereine Wien [1908]
Rossos, A.: Russia and the Balkans: Inter-Balkan rivalries and Russian foreign policy 19081914, Toronto-Buffalo-Londra 1981.
Tukin, Cemal: Die politischen Beziehungen zwischen Osterreich-Ungarn und Bulgarien von
1908 bis zum Bukarester Frieden, Hambourg 1936.
Vojvodié, Mihailo: «Serbia and the First Balkan War: Polittcal and Diplomatie Aspect» in:
East Central European Society and the Balkan Wars, sotto la direzione di Béla K. & Dimitrije
Djordjevic,Highland Lakes, N.J. 1987,240-259.
Williamson, S.R.: Austria-Hungary and the Origins of theFirst World War (The Making of the
20th Century), Londra 1991.
128
129
PARTE III
Il 1919 nella storia europea
130
131
15. Introduzione all’anno 1919
La prima guerra mondiale non si conclude in maniera netta. Nonostante l’armistizio sia firmato
l’11 Novembre 1918, le ostilità proseguono in alcune parti d’Europa, come in Russia, dove
divampa la guerra civile. Per di più, nuovi conflitti non tardano a sorgere tra la Polonia e
l’Ucraina per la Galicia orientale, tra la Polonia e la Germania per quanto riguarda Posnan e la
Silesia, tra la Polonia e la Lituania per quanto riguarda Vilnius, conflitti ai quali si aggiungono
la guerra russo-polacca del 1920 e la guerra greco –turca del 1921/22. Governi che crollano,
imperi che si disintegrano, lasciando alle spalle un vuoto politico. Il caos e la confusione che ne
risultano spingono movimenti indipendentisti e rivoluzionari socialisti a tentare di impadronirsi
del potere. Ciò avvenne in Russia già dal 1917, ma altre nazioni, tra cui la Bulgaria, l’Austria, la
Germania, l’Ungheria vivono eventi simili.
E forse inevitabile che ogni tentativo di raccogliere documenti sugli avvenimenti del 1919, che
dimostrano una molteplicità di prospettive storiche – come quelle che presentiamo nei prossimi
capitoli – dia largo spazio alle conseguenze fatali degli accordi di pace, in particolare quelle dei
trattati di Versailles, Neuilly, Trianon e Sèvres, e alle aspirazioni revanscistiche e irredentistiche
che questi trattati hanno provocato nelle nazioni sconfitte. Non sorprende che da un’analisi
storica transnazionale di questo tipo venga fuori un sentimento crescente di disillusione e di
speranze deluse. Lo stesso vale per l’incapacità e la reticenza degli uomini di stato europei ad
abbandonare l’idea, discreditata, di equilibrio delle potenze per il concetto wilsoniano di
sicurezza collettiva per l’isolazionismo crescente degli Stati Uniti dopo la morte di Wilson, per
il crollo della Repubblica di Weimar, per le divisioni interne che non tardano a sorgere nella
maggior parte dei nuovi stati creati e che portano la gran parte di loro a tornare presto a regimi
autoritari, per l’ascesa del fascismo e del nazionalsocialismo, l’impotenza dello “Spirito di
Locarno” di risolvere “il problema tedesco” e in ultimo l’incapacità della Società delle Nazioni
di impedire una nuova guerra mondiale.
Tuttavia questi capitoli mostrano che la “Grande Guerra” e gli sviluppi del processo di pace
hanno contribuito a fissare e a influenzare, l’ordine del giorno delle relazioni internazionali per
il resto del secolo. La Società delle Nazioni ha fallito negli anni ‘30, ma l’idea di sicurezza
collettiva non è stata discreditata e gli sforzi per creare istituzioni internazionali e
intergovernative efficaci, al posto del vecchio sistema di alleanze e di equilibrio delle potenze,
sono proseguite. Un altro risultato durevole del Patto della Società delle Nazioni è la creazione a
La Haye nel 1921 di una corte permanente di Giustizia internazionale. La conferenza di pace di
Parigi, o più esattamente la sua Commissione delle riparazioni, inventa il concetto di crimine di
guerra, anche se i tentativi di allora per giudicare i sospetti criminali di guerra falliscono. Altri
elementi di controllo e d cooperazione internazionale, che oggi consideriamo come acquisiti,
trovano la loro origine in negoziati tenutisi a Parigi nel 1919/20; è il caso, tra l’altro
dell’Organizzazione internazionale del Lavoro, della limitazione e il controllo dell’armamento o
ancora dei tentativi per controllare il traffico di droga e il commercio di schiavi.
132
16. L’indomani della “Grande Guerra”: la Francia ed i Francesi nel
1919
Jean-Jacques Becher
L’11 novembre 1918, all’annuncio dell’armistizio, le città e in particolare Parigi hanno potuto
conoscere scene di entusiasmo quasi folle, ma da quel momento si mescolano strettamente in
quel entusiasmo, l’euforia della vittoria certa, ma ancora di più la soddisfazione di avere finito
ed il ricordo di spaventosi sacrifici. Ciò è particolarmente vero per i soldati del fronte dove
l’entusiasmo è misurato, anche perché le ultime settimane della guerra sono state durissime, le
perdite molto pesanti, 157.000 morti da agosto a novembre 1918.
Il lutto
Le campane della vittoria si mescolano spessissimo i rintocchi della morte dovuta “all’influenza
spagnola”, infatti non si può mancare di notare tra la folla i militari che portano un nastro nero
segno della perdita di un parente. Ciò è il primo aspetto della Francia nel 1919, il sentimento di
un enorme salasso umano. A dire il vero non si sa ancora quale è stato il costo in vite umane
della guerra, il segreto era stato cosi ben custodito che nessuno lo conosceva veramente, ma non
conoscere la cifra esatta dei morti non poteva impedire a tante famiglie di essere immerse nel
lutto, a tante giovani donne di sapere che il marito non sarebbe più tornato, a tanti genitori che il
loro unico figlio era morto oppure in certi casi due, tre, quattro figli erano caduti, tanti figli che
non avrebbero mai conosciuto il loro padre.
Ci volle del tempo per conoscere la realtà: solo nel 1920 il rapporto dovuto al lavoro del
deputato di Nancy, Louis Marin, permise di sapere che il numero dei morti e degli scomparsi –
erano infatti, a parte alcuni casi rarissimi, morti non identificati – era al primo giugno 1919, di
1.383.000. Molto più tardi, ai giorni nostri, si è fatto il calcolo che ciò rappresentava in media
quasi 900 morti al giorno dall’inizio della guerra. Alla cifra dei morti si aggiungeva il numero
considerevole di feriti, circa cinque milioni, cifra senza grande significato poiché la gravità delle
ferite è stata molto varia e alcuni sono stati feriti più volte. Ma ciò che aveva un significato era il
milione di invalidi a più del 10%, di cui 300.000 mutilati e tra di loro i numerosissimi feriti in
faccia ( “i musi rotti”), diventati un elemento permanente della società francese, senza contare
gli avvelenati con il gas, cosa che non si vedeva, ma che soffrirono fino alla morte.
La Francia del 1919 è anzitutto una nazione di vedove, orfanelli, mutilati …, un paese in
lutto
In questo quadro della società francese nel 1919, sarebbe un grave errore tralasciare l’enorme
movimento che solleva la nazione affinché la guerra e le sue vittime, non siano dimenticate ma
restino mel cuore dell’anima francese. Ci sono le innumerevoli lapide che dappertutto ricordano
il sacrificio di giovani uomini di tale gruppo professionale, di tale amministrazione, di tale
impresa…., ci sono soprattutto i monumenti ai caduti. A partire dal 1919, in quasi tutte le città e
villaggi di Francia, sono eretti a migliaia, per l’eternità. L’11 novembre dell’anno seguente
diventa giorno festivo imposto dagli ex combattenti per commemorare non tanto la vittoria
quanto l’immensità dei sacrifici e, lo stesso giorno dell’11 novembre 1920, la tomba del soldato
ignoto era inaugurata sotto l’Arco di Trionfo dell’Etoile.
La Bancarotta
133
Questa nazione dissanguata, alla quale la debolezza di vecchia data della sua demografia fa
risentire ancora più crudelmente che per altre nazioni la perdita di tanti suoi giovani, è anche
una nazione impoverita e una nazione in parte rovinata.
E’ difficilissimo calcolare quale fù il costo della guerra: ci furono le spese di equipaggiamento,
armamento, mantenimento di un enorme esercito, il pagamento dei sussidi alla popolazione
civile, anche il prezzo di ingenti distruzioni – un’intera striscia di territorio di 500 km di
lunghezza e una larghezza compresa tra 10 e 25 km era completamente devastata, città, villaggi,
rete stradale e ferroviaria, ponti, scuole, chiese, edifici pubblici e industriali, campi diventati
incoltivabili, senza contare la mancanza di guadagni dovuta all’arresto di ogni attività
economica normale, gli investimenti esteri perduti.
Il totale delle spese ammontava ad un livello inimmaginabile rispetto alle risorse normali
dell’anteguerra, ma il loro calcolo era reso ancora più difficile dalla svalutazione della moneta.
Inoltre, essendo stato impossibile di fare coprire queste spese dalle tasse, anche perché una
buona parte dei contribuenti era mobilitata – più di 8 milioni di uomini- la guerra fu fatta a
credito: prestiti interni di tutte le specie, prestiti esteri dal Regno Unito e ancora di più dagli
Stati Uniti.
Paradossalmente, allorché la preoccupazione di come fare fronte a questa situazione avrebbe
dovuto essere la cosa più importante, uno slogan coinvolge tutta la popolazione (compresi i
dirigenti e particolarmente il ministro delle Finanze): “La Germania pagherà”. Il trattato di pace
doveva comportate l’obbligo, per i vinti, di pagare le “riparazioni” – per dare un carattere
morale agli antichi “indennizzi di guerra”- destinate a coprire le spese della guerra. Nessuno o
quasi (per lo meno in Francia) s’interrogava sulla possibilità per la Germania ugualmente
rovinata dalla guerra (anche se non ci furono distruzioni sul suo suolo) di potere pagare.
La Rivoluzione
Prima della guerra, o poco prima che scoppiasse, alcuni socialisti come il tedesco Babel o il
francese Jaurès avevano pronosticato che se ci fosse stata una grande guerra, sarebbe finita con
una grande rivoluzione. Non si sbagliarono, fuorché sulla sua localizzazione. La rivoluzione era
scoppiata in Russia dove i Bolscevichi si erano impadroniti del potere, ma per loro era solo una
prima tappa di una rivoluzione che non poteva essere che mondiale e per cominciare europea…
Finchè durò la guerra, la rivoluzione russa fu avvertita in Francia, come l’abbandono, addirittura
il tradimento dell’alleato russo, ma come sarebbero andate le cose alla fine della guerra? La
situazione era completamente diversa da quella della Russia. Una rivoluzione non poteva che
essere contadina. Anche se i contadini avevano conosciuto le perdite più pesanti - 600.000
agricoltori erano stati uccisi, quasi la metà della totalità dei morti, se il mondo rurale ha
particolarmente sentito la promessa fatta da Clemenceau ai combattenti, “ hanno dei diritti su di
noi”, la loro situazione materiale era piuttosto migliorata durante la guerra. Sono riusciti a
liquidare i loro debiti, comprare dei terreni. Miglioramenti in parte fittizi. L’aumento dei prezzi
di vendita dei prodotti agricoli è dovuto alla debolezza della moneta, mentre bisognerà
sostituire, ad alto prezzo il materiale agricolo, cosa che non era stata fatta durante la guerra.
Almeno per il momento, le rivendicazioni dei contadini non rischiavano di prendere una piega
rivoluzionaria, anche se alcuni giovani contadini gridano il loro odio per la guerra e sono tentati
dal bolscevismo.
Le reazioni degli operai potevano essere diverse tanto più che la rivoluzione russa appariva da
lontano come una rivoluzione operaia. Le loro perdite erano state proporzionalmente più lievi di
quelle dei contadini, ma i loro redditi si erano abbassati. Il loro contributo allo sforzo di guerra,
secondo le loro stime, giustificava un miglioramento delle loro condizioni di vita e di lavoro.
Ma in una certa misura, si produce il contrario. Le donne che lavoravano nelle fabbriche di
guerra sono state rapidamente rimandate a casa, molti ex combattenti provano difficoltà a
134
ritrovare il loro lavoro; le difficoltà della riconversione di un’economia di guerra in
un’economia di pace non facilitava le cose.
In queste condizioni la CGT conosce un rapido progresso dei suoi effettivi, sebbene
paradossalmente i suoi dirigenti come Léon Jouhaux, anarchico e dal linguaggio rivoluzionario
prima del 1914, sono diventati adesso riformisti: sottopongono al governo un ampio programma
di riforme, di cui una sola – importante- è concessa con una legge del 23 aprile 1919: la
riduzione della giornata di lavoro a 8 ore, ossia 48 ore settimanali senza riduzione di salario.
Questa riforma non basta per calmare la crescente agitazione operaia, tanto più che ci vuole
molto tempo per attuarla: la giornata del primo maggio 1919 è molto movimentata, misure
d’ordine molto importanti sono state prese, gli scontri tra manifestanti e forza dell’ordine sono
violenti, ci sono dei morti; in primavera, gli scioperi si moltiplicano nelle ferrovie, presso i
metallurgisti, i minatori.
Aggiungiamo un odio crescente per la guerra, quando è finita! (lo slogan: “Mai più questo!”
conosce un grande successo), una parte dell’ opera volge lo sguardo verso il bolscevismo che è
riuscito a tirare la Russia fuori dalla guerra. Come si sarebbe adattato il partito socialista a
questa situazione? Prima della guerra esso ostentava volentieri un discorso rivoluzionario, anche
se la sua pratica era moderata. Durante la guerra aveva partecipato all’Unione sacra, ma sul
finire del conflitto i suoi avversari erano diventati maggioritari. E’ profondamente turbato
dall’opposizione tra i partigiani e gli avversari del bolscevismo. La grande discussione è aderire
o meno alla 131° Internazionale, l’Internazionale Comunista. Ma la questione del Bolscevismo
non riguarda soltanto l’area socialista e il movimento operaio. Preoccupa gran parte della
popolazione – le classi medie in particolare- che ha il sentimento che una rivoluzione si sta
preparando come in altri paesi d’Europa.
Svolta a destra
Per l’opinione francese, la grande discussione del momento è stata prima quella del tratto di
pace che doveva impedire per sempre che un tale cataclisma potesse ricominciare. Ma è divisa
in parti molto disuguali. D’un lato una minorità abbastanza debole si rende conto rapidamente
che questi negoziati che hanno luogo senza la presenza dei vinti – e questo permetteva ai
tedeschi di considerarsi l’oggetto di un diktat – non seguono lo spirito wilsoniano, “la pace
senza vittoria”, ma lo stesso presidente americano è molto cambiato da quando ha pronunciato
questa espressione all’inizio del coinvolgimento degli Stati Uniti, dall’altra una grande
maggiorità si rende conto ugualmente e molto rapidamente che questa pace non sarà la pace
auspicata, che le condizioni imposte alla Germania saranno meno pesanti di quanto voleva
(anche se d’altro canto in Germania sono considerate come insopportabili).
In queste condizioni deve essere eletta una nuova Camera dei deputati. I deputati in esercito,
eletti nel maggio 1914 per 4 anni avevano visto la loro funzione prorogata, viste le circostanze,
fino alla fine delle ostilità. Le ostilità furono giuridicamente terminate solo dopo la ratifica dal
Parlamento del trattato di pace e le elezioni fissate soltanto al 16/11/1919. Il rancore contro un
trattato di pace insufficiente di cui gli alleati della Francia sono resi responsabili, il timore della
rivoluzione – il manifesto più famoso della campagna rappresentava l’uomo dal coltello tra i
denti sgocciolando di sangue, simbolo del bolscevico russo – le difficoltà economiche, si
tradussero con una netta svolta a destra e la vittoria del blocco nazionale che intendeva piazzarsi
nel prolungamento dell’Unione sacra. Il blocco nazionale, non era soltanto la destra, come è
stato detto troppo spesso, ma anche il centro, anche il centro-sinistra, ma la sua vittoria fu tanto
più notevole che la destra era stata praticamente esclusa dalla vita politica francese da più di 20
anni...
Alla fine del 1919, la Francia e i Francesi sembrano profondamente traumatizzati dalla guerra
che hanno appena vinto e che bisognerà adesso pagare. Hanno voluto che questa guerra sia stata
la “der der der” ma non l’hanno creduto per molto tempo. Sono sicuri però di non voler
135
ricominciare, da qui il pacifismo che non cesserà di svilupparsi negli anni seguenti. Sono sicuri
che non vogliono la rivoluzione, anche se l’anno seguente glielo farà ancora temere, ma sono
pronti a resisterci. Vorrebbero che la vita ricominciasse come prima, e che la guerra sia stata
solo una terribile parentesi. Ma una guerra del genere non è mai una parentesi, è il punto di
partenza di temibili mutamenti e i francesi non volevano vederli. Non si rendevano conto che il
ritorno al tempo passato era assolutamente utopico.
136
17. La Repubblica di Weimar: il peso della Grande Guerra
Gerd Krumeich
Introduzione
Il fallimento della prima Repubblica tedesca nel 1933, preludio alla catastrofe europea della
seconda guerra mondiale, ha suscitato un gran numero di domande e risposte contraddittorie
sulle sue cause. Ci fù un tempo, dopo il 1945, in cui l’ascesa di Hitler fu spiegata dagli storici
con le cause legate alle questioni di politica internazionale e al sistema monetario. Si evocò
prima di tutto il trattato di Versailles del 1919, chiamato dai tedeschi in modo molto
peggiorativo, “Diktat”, oppure -nei cerchi dell’estrema destra- “Schmachfrieden”.
Le generazioni seguenti di storici, soprattutto dalla fine degli anni ‘60, hanno radicalmente
messo in dubbio questa spiegazione, insistendo, loro, sul peso che costituiva per la Repubblica,
la “continuità delle elite (secondo la formula dello storico Friz Fischer) tra l’Impero di
Guglielmo II e la Repubblica. “Continuità delle elite” significava soprattutto che gli strati
dirigenti del vecchio Reich tanto i militari che il corpo dei grandi amministratori e dei
funzionari non erano stati rinnovati dai repubblicani eppure, erano al potere dalla caduta della
monarchia nel novembre 1918 e dalla proclamazione della Repubblica fatta dal leader
socialdemocratico Philipp Scheidemann, il 9/11/1918.
Dagli anni ‘70, la storiografia “di sinistra” o di orientamento democratico, ha largamente
analizzato questo processo di tergiversazione dei nuovi responsabili davanti a l’elite del vecchio
regime. Tergiversazioni che si spiegano soprattutto con l’ossessione antirivoluzionaria dei
leader della socialdemocrazia, piuttosto centrista, proiettati al potere, un po’ loro malgrado, nel
1918. Ad insistere su questo aspetto è soprattutto l’illustre storico Hans Mommsen. Non per
caso il suo grande libro sulla Repubblica di Weimar, apparso nel 1982, porta il titolo, certo
provocatore, “Die Verspielte Freiheit” (La liberté perdue). La questione fondamentale che la
generazione degli storici degli anni ‘60 ha posto a quella dei loro padri e nonni era di sapere
perché la democrazia non aveva saputo liberarsi dal peso del passato, perché non aveva voluto
impadronirsi del “potenziale democratico” delle masse, perché aveva combattuto e non integrato
il vasto movimento di democrazia diretta, rappresentato soprattutto dai “consigli di operai e di
soldati” (Arbeiter – und Soldatenräte) che sorsero spontaneamente un pò dappertutto in
Germania, nelle giornate cupe della fine della guerra. Non si sarebbe potuto ottenere che la
maggior parte di questi consigli servissero una repubblica democratica invece di farsi inghiottire
dal movimento rivoluzionario, di tendenza dapprima spartachista poi comunista, represso
all’occasione delle varie insurrezioni dell’inizio del 1919?
Queste domande erano rilevanti e necessarie all’epoca e scaturivano dall’ostinazione della
generazione precedente a prendere in considerazione solo il peso della politica estera per
spiegare il crollo della Repubblica di Weimar. Questa interrogazione ha senza dubbio aperto la
strada ad una migliore comprensione delle forze politiche esistenti, soprattutto per quanto
riguarda il carattere e l’importanza dei consigli dei soldati e degli operai. Bisogna riconoscere
che questa generazione ha ignorato l’impatto della Grande Guerra e delle sue conseguenze
politiche sulla Repubblica di Weimar. Possiamo oggi “riaprire il dossier” e considerare, senza
alcuno spirito di parte, l’impatto della Grande Guerra su coloro che l’avevano vissuta, e che
hanno dovuto trarne le conseguenze politiche.
La politica di Weimar
Per prima cosa occorre constatare che la repubblica di Weimar è nata dalla guerra. I suoi primi
passi, anche prima della sua creazione ufficiale, furono estremamente carche di conseguenze
politiche e morali. In quel momento si dovette fare fronte alla disfatta. Il presidente americano
Wilson aveva dichiarato, fine ottobre 1918, che la pace si sarebbe conclusa solo con un governo
parlamentare, e non con la vecchia casta militarista prussiana. Questa dimensione parlamentare
137
della monarchia fu introdotta fin dal primo novembre, mantre il cancelliere Max von Baden
formava un gabinetto “parlamentare”, nato dalla maggioranza del Reichstag. Già il 29 settembre
1918, un mese prima, il generale Ludendorff, quartiermastro generale, aveva chiesto al Kaiser
“di fare formare un governo dalle forze che ci hanno messo nella situazione in cui ci troviamo”.
Era già il rimprovero, formulato apertamente, che l’esercito vittorioso era stato “pugnalato alla
schiena”, da dietro, dai civili stanchi di guerra. In effetti, la leggenda della “pugnalata alla
schiena” doveva rivelarsi il peso schiacciante iniziale della Repubblica. Tanto più che in quel
momento, nessuno tra i civili conosceva lo stato deplorevole in cui l’esercito tedesco era stato
ridotto, sia a livello morale che materiale, dopo il fallimento dell’ultima grande offensiva di
marzo 1918, dal nome echeggiante di “Michael”. Da quel momento, l’esercito aveva subito una
grave crisi morale. Alcuni soldati cominciarono a non andare più in guerra, rifiutandosi di
raggiungere il reggimento, rifiutandosi di attaccare, ecc….
Non lo si seppe che tardivamente, e la denunzia, da parte dei capi militari, degli “intrighi
comunisti” sembrava credibile per molti. Non avevamo assistito ad uno sciopero degli operai
nelle fabbriche di armamenti di Berlino (e altrove) nel gennaio 1918, sostenuto da personalità
piuttosto centriste della Socialdemocrazia come il deputato Friedrich Ebert? E’ probabile che
Ebert, Scheidemann e gli altri si misero a capo del movimento per farlo cadere e fare fallire gli
“spartachisti”, desiderosi di trasformare la protesta in rivoluzione. I socialdemocratici centristi
hanno voluto persuadere forse gli ex combattenti di tornare in fabbrica per non turbare il
“lavoro” dei loro compagni rimasti nelle trincee senza fucili e munizioni. Ma l’ombra di questo
affare inseguì Ebert tutta la vita. Capo del governo, poi eletto Presidente della Repubblica nel
1919, non riuscì mai a convincere la Destra e il Centro, di non essersi prestato nella “pugnalata
alla schiena”.
Durante tutta l’esistenza della Repubblica di Weimar, il rimprovero fatto alla sinistra di essere la
vera colpevole di una sconfitta immeritata, assillò le menti. Niente è più evidente per i
propagandisti estremisti, che la rivoluzione del 1918 e l’istituzione di una repubblica governata
dai “disfattisti” aveva fatto perdere la guerra alla Germania. Adolf Hitler non fù, all’inizio, che
un protagonista tra gli altri. Egli e il movimento nazista avevano tuttavia una particolarità.
Rifiutavano ogni discussione o distinzione. Erano convinti che la pugnala alla schiena, la firma
e il trattato di Versailles erano stati concepiti e messi in opera “dall’ebreo”, bolscevista o
capitalista era lo stesso.
Sotto questi auspici la Repubblica fece i primi passi vacillanti, ma viste le circostanze, coronati
da un sorprendente successo. La prima cosa da ottenere fu il ritorno all’ordine dei soldati. E’
vero che dal 9 novembre 1918, data dell’armistizio di Rethondes, circa 7 milioni di soldati
tedeschi rifluivano verso il loro paese, ritorno che si effettuò il più delle volte in un ordine
perfetto. Ma cosa dovevano fare questi uomini armati e inaspriti dalla sconfitta “immeritata”,
confrontati con i movimenti rivoluzionari? La grande paura era nell’eventualità di un putsch, di
un esplosione di rabbia da parte di chi tornava, di una rivolta dalle conseguenze imprevedibili.
Il governo Ebert, investito ancora prima dell’armistizio, affrontò per primo la sommossa dei
marinai di Kiel rivoltatisi fin dal 30 ottobre 1918. Da questi ammutinamenti nacque
rapidamente il movimento dei “consigli di soldati e operai”, istituitisi a Berlino, Hambourg,
Kiel e poi nelle grandi città della Renania e di altrove. Essi concepivano la loro missione come
il controllo del governo e del processo di democratizzazione della società tedesca. Per il
governo, si trattava soprattutto di controllare questi “consigli”, dalle strutture politiche
inizialmente mal discernibili, e in seno ai quali si supponeva una forte movenza rivoluzionaria.
Di fronte alla massa dei soldati, all’atmosfera politica tesa e alla probabilità di una Rivoluzione,
i governi successivi ebbero una sola priorità: stabilire e mantenere l’ordine per darsi i termini
necessari all’istituzione di una repubblica ben costituita e all’elezione di un’Assemblea
nazionale, il cui compito sarebbe la redazione di una costituzione democratica. Ebert affermò,
fin dal 5 novembre 1918 che tale era lo scopo principale. Quattro giorni più tardi, Philipp
Scheidemann, deputato socialdemocratico, prese l’iniziativa di proclamare la repubblica dal
138
balcone del castello della città di Berlino, il 9 novembre 1918. Parlando della vittoria del
popolo, del “crollo delle vecchie strutture” e del militarismo esorta la folla a non sminuire
questa vittoria con degli incidenti: “Occorrono adesso ordine, sicurezza e tranquillità”.
La rivolta spartachista
Si aprì immediatamente una grande ferita della Repubblica, forse inevitabile ma estremamente
costrittiva. Di fronte alle varie (piccole) sommosse, in particolare la sommossa spartachista di
gennaio 1919, il nuovo governo usò massicciamente e brutalmente la forza armata. Si mise al
servizio della Repubblica i cosiddetti “capi franchi”, delle unità di ex soldati, rimasti o tornati
sotto gli ordini dei loro ex capi militari, comandanti di reggimenti, ecc….. Furono dunque
soldati agguerriti, disponendo di un armamento pesante, e sotto gli ordini di capi militari
rappresentanti soprattutto la vecchia elite militare della Prussia (ad esempio il generale von
Lüttwitz) ai quali la giovane repubblica affidava – o fu costretta ad affidare?- la difesa
dell’ordine e della legge. Ne avranno abusato?
E’ probabilmente vero che questi corpi franchi, infierendo contro gli spartachisti o gli operai in
sciopero, procedettero spesso con una grande brutalità. All’odio di classe di questi soldati
uscenti da una sconfitta militare, bisogna aggiungere il loro odio e il loro rancore trovandosi
improvvisamente di fronte a persone tra le quali supponevano si trovassero coloro che li
avevano pugnalati alla schiena. L’annientamento della rivolta spartachista a Berlino nel gennaio
1919, rispecchia questo odio. I due leader del movimento spartachista, Rosa Luxemburg e Karl
Liebknecht, furono selvaggiamente torturati, “giustiziati” e buttati nell’acqua. Gli assassini ne
uscirono indenni. Fu una delle grandissime divisioni –insormontabili a lungo andare, che fu
creata in seno alla nuova Repubblica: si contarono 300.000 manifestanti ai funerali di Karl
Liebknecht e Rosa Luxemburg, gridando il loro odio alla “nazione militare”.
Le relazioni tra la socialdemocrazia governante e il movimento comunista si trovarono
durevolmente segnati. Fino al 1933 e all’ascesa di Hitler non fù mai possibile superare questo
abisso tra i partiti di sinistra incapaci dunque di fare fronte comune contro la destra unita
nell’assalto contro il sistema repubblicano. La mancanza di interesse del popolo operaio di
fronte alla repubblica democratica fu una pesante ipoteca durante tutta la Repubblica di Weimar.
Per quanto riguarda i corpi franchi furono formalmente sciolti il 6 marzo 1919, ma le loro unità
restarono a disposizione di chi voleva servirsene. La Reichswehr sciolta e ricostituita secondo le
clausole del trattato di Versailles con 100.000 uomini soltanto, vi reclutò numerosi membri.
Riuscì, malgrado tutti i controlli esercitati dagli alleati, a tenere in serbo una “Reichswehr nera”,
di cui fecero parte gruppi di reduci. L’organizzazione la più potente fu il “ Stahlhelm” (caschi
d’acciaio) che contava circa 400.000 aderenti. Tra questi gruppi figurava anche un servizio
“d’ordine”di un piccolo partito operaio, fondato nel 1919 al quale aderiva un certo Adolf Hitler,
ex grande ferito e decorato dalla croce di ferro di prima classe. La sua guardia personale si
chiamava “Sturm abteilung”. S.A., ricevette armi e formazione come elementi della
Reichswehr. Questa S.A. aveva 300 “soldati politici” nel 1920, tutti devoti al loro Führer. Nel
1933, contava più di 500.000 uomini.
Hagen Schulze che ha scritto la storia dei capi franchi sotto la repubblica di Weimar ha concluso
che il merito dei capi franchi fu di salvaguardare l’unità tedesca sotto la forma di una repubblica
parlamentare e borghese. Ma alla fine della Repubblica, questa forze stesse furono i boia della
democrazia.
Malgrado tutti questi vortici, l’Assemblea nazionale fu regolarmente eletta il 19 gennaio 1919,
votando, le donne, per la prima volta. Una maggioranza chiara di centro sinistra potè costituire
un governo dal quale la destra fu esclusa. Ebert, il leader incontestato della socialdemocrazia, fu
eletto Presidente della Repubblica, e la Costituzione, discussa e votata dall’Assemblea a
Weimar, sembrò suscettibile di garantire l’esistenza e la perennità di una democrazia forte e
139
resistente. Una specie di equilibrio tra il Presidente da una parte ed il corpo legislativo dall’altra
fu stabilita. Il Presidente della Repubblica aveva prerogative chiare, soprattutto quella di
ricorrere all’articolo 48, che permetteva di sospendere temporaneamente i diritti fondamentali
ed il diritto del Parlamento a legiferare. Questo articolo, introdotto per garantire la democrazia
nascente contro ogni eventuale colpo di forza dalla destra fu utilizzato, nel 1933, per smantellare
le ultime vestigia della Repubblica ad opera di coloro che volevano abolirla “nella legalità”. Ma
evidentemente questo pericolo non fu risentito nelle circostanze del 1919, in cui la Repubblica
si trovò alle prese con un’estrema sinistra frustrata della sua rivoluzione e un’estrema destra,
che nutriva risentimenti sociali, nostalgie ma anche e soprattutto un odio feroce contro quelli
che per loro sembravano essere l’origine della sconfitta e del “ribasso” internazionale della
Germania.
Le conseguenze del trattato di Versailles
Il trattato di Versailles, rappresentò un immenso fardello per la Repubblica uscita dalla guerra. I
vincitori erano stremati, e dovettero rispettare il desiderio dei loro popoli di ricompense e
riparazioni per i danni subiti durante la guerra. Non torneremo qui sulle modalità di questo
trattato rispecchiante la volontà wilsoniana di ristrutturare le relazioni internazionali, con la
creazione, ad esempio, del Völkerbund e organizzando anche un ufficio della Lega delle
Nazioni e un Ufficio internazionale del Lavoro. Ma ciò che importava in una prospettiva
immediata era senza dubbio l’infamante articolo 231 del trattato cosi formulato:
“I governi alleati e associati dichiarano e la Germania riconosce, che la Germania e i
suoi alleati sono responsabili, per averli causati, di tutte le perdite e
di tutti i danni
subiti dai governi alleati e associati e dai i loro nazionali in
conseguenza
della
guerra, che è stata loro imposta dall’aggressione della Germania e dei suoi alleati”.
Dagli anni ‘30 si è discusso sul contenuto di questo testo, se veramente metteva moralmente
sotto accusa la Germania oppure se non era piuttosto un articolo il cui scopo era di garantire il
pagamento dei danni. Ma bisogna insistere sul fatto che nel clima del 1919, questo testo
rispecchiava di certo il sentimento dei popoli alleati e dei loro governanti di poter finalmente
fare i conti con un paese che secondo loro aveva messo deliberatamente il fuoco all’Europa e fu
perciò tenuto come responsabile di milioni di morti e di immense devastazioni soprattutto in
Francia e in Belgio.
In Germania ci fu una totale costernazione, e all’inizio un rifiuto completo di firmare un tale
“trattato della vergogna”. Il deputato Scheidemann, colui che aveva proclamato la Repubblica
pochi mesi prima, si espresse in questi termini “chi firmerebbe questo trattato che biasimasse la
mano”. Ma dato che gli alleati restavano fermi sulle condizioni imposte, minacciando di
occupare militarmente la Germania e di porre fine all’unità del Reich, il trattato fu firmato con
rassegnazione il 28 giugno 1919, in presenza di una rappresentanza di “musi rotti” francesi, la
cui presenza simboleggia ancora i torti fatti dalla Germania ai suoi vicini, alleati contro la sua
“barbaria”.
La protesta contro “Versailles”e il “trattato della vergogna”, non si calmava durante i 15 anni
del regime repubblicano in Germania. Ci furono, certo, dei governi che provarono a
ottemperare, creare una nuova fiducia internazionale, contribuire alla “Società delle Nazioni”,
creata con l’articolo primo del trattato di Versailles. Fu il caso soprattutto di Walther Rathenau,
grande industriale e filosofo che aveva riorganizzato l’economia all’inizio della guerra e che si
rassegnò come capo del governo nel 1922, ad una politica di esecuzione del Trattato. Fu anche il
caso di Gustav Stresemann che cominciò, 2 anni più tardi, d’accordo con il capo del governo
francese Aristide Briand, a concepire una politica di pace ed una politica europea. Ma tutti
questi tentativi di ravvicinamento internazionale si trovarono falsati per il fatto di Versailles.
140
Tutti i governi tedeschi hanno protestato, fino al 1933, contro l’articolo 231 di cui si pretese
l’invalidazione. Uno dei motivi della grandissima fama di Hitler alla fine degli anni 20, anche
tra gli stati per nulla attratti dal nazismo, fu la sua risoluzione a lottare contro il trattato della
vergogna.
La protesta contro il trattato di Versailles era dunque universalmente condivisa in Germania. Ma
tuttavia non creò un’unità di pensiero e di azione. Al contrario, questa lotta contro Versailles fu
viziata dall’inizio con l’aggiunta “del colpo di pugnale alla schiena”. A partire da novembre
1919, Hindenburg, capo del grande quartier generale, eroe incontestato ed estremamente
popolare, dichiarò, davanti ad una commissione di inchiesta sulle cause della sconfitta che
incontestabilmente la sconfitta era stata provocata dal fermento comunista, affermazione che fu
ripresa dalla destra nazionalista. La radicalizzazione politica, contro “Versailles” e la
designazione dei “colpevoli” della sconfitta portò ad una bipolarizzazione estrema e ad una
onda di destra.
Il nazionalismo si radicalizzò e prese una direzione “völkisch”, estremamente razzista,
sottolineando la superiorità sia per il sangue che per la storia, del popolo tedesco. Hitler stesso si
riferì continuamente al sangue tedesco. La Germania schernita e assoggettata, si diceva, doveva
rinascere in tutto il suo splendore. A causa di Versailles, gli estremisti “völkisch”trovarono un
ascolto molto più largo di prima. Il “deutschvölkischer Schutz-und Trutzbund” (Associazione
per la protezione del popolo tedesco), estremamente razzista e che accusava gli ebrei della
sconfitta e della rivoluzione contava più di 100.000 aderenti alla fine del 1919 ed esercitò
un’influenza crescente sulle associazioni di reduci, soprattutto il Stahlhelm. Ma ciò che è ancora
più significativo di questa evoluzione fu che il grande partito di centro destra, il
Deutschnationale Volkspartei, si avvicinò a questo estremismo. Il programma del partito, nel
1920 espresse chiaramente la sua opposizione contro l’elemento ebreo la cui predominanza in
seno al governo e al parlamento è sempre più nefasta.
L’ascesa dell’estrema destra nella politica tedesca del dopo guerra
Di conseguenza le elezioni del 1920 furono segnate da una forte bipolarizzazione destra/sinistra.
Il risultato delle elezioni faceva chiaramente vedere l’ascendente che l’estrema destra aveva
preso sin dal 1919. Dopo queste elezioni, i partiti detti “ costituzionali” non ebbero mai più, da
soli, la maggioranza parlamentare.
La situazione estremamente tesa in politica interna fu ancora inasprita a causa della decisione
presa dagli alleati a Londra, il 5 maggio 1921, di fissare la somma dovuta dai tedeschi a titolo di
risarcimento dei danni materiali della guerra alla cifra, che sembrava allora esorbitante, di 132
miliardi di Goldmark. Era pagabile in più versamenti previsti fino agli anni ‘90, ma in Germania
sollevò le proteste. Manifestazioni organizzate ovunque riunirono centinaia di migliaia di
persone gridando il loro rifiuto di questa sottomissione del popolo tedesco. Il governo che
sapeva di dover acconsentire, per evitare un occupazione militare della Germania e la scissione
del Reich, fu deriso. Niente era più grave per la destra (centro e estremista) che la
“Erfüllungspolitik”, la politica di esecuzione del trattato. Quando i capi di governo successivi,
Wirth e Rathenau, dichiararono che avrebbero seguito una politica di esecuzione del trattato per
dimostrare agli alleati che la Germania era nell’impossibilità materiale di pagare l’insieme del
debito, la destra si ribellò.
Rathenau era ebreo, e non importava più che avesse aiutato brillantemente ad organizzare
l’economia di guerra nel 1914. Bande di estrema destra diffusero lo slogan che si gridò per le
strade: “Walter Rathenau non invecchierà: assassina quel dannato porco ebreo”. Fu fatto il 24
giugno 1922 da due membri dell’organizzazione “Consul”, società segreta nata dal corpo franco
più rinomato ( e più brutale), la “brigata Ehrhardt”. Questa brigata fu costituita nel 1919 e
raggruppava circa 2.000 ufficiali del vecchio esercito. Ufficialmente fu sciolta nel 1920 ma
141
trasformata in organizzazione segreta i cui intrighi furono largamente tollerati dalla burocrazia
bavarese, la stessa sempre più in rottura con la Repubblica ed il Reich.
Questi incidenti ebbero un effetto di radicalizzazione in Baviera. La reazione alla legge per la
protezione dello Stato, votata dai partiti di sinistra e del centro dopo l’assassinio di Rathenau
incoraggiò i partiti repubblicani e suscitò, per un momento, un fronte repubblicano. In Baviera,
Hitler, le cui azioni brutali furono largamente tollerate dalle autorità intensificò i suoi sforzi di
organizzazione. Il gruppo paramilitare che proteggeva le riunioni del partito e attaccava
“comunisti ed ebrei” in sanguinosi scontri in strada, ebbe un forte aumento: da 300 S.A. fine
1921 se en contò 3.000 alla fine del 1922. Il capo della S.A. era un ex ufficiale della
Reichswehr, di Monaco che, dalla fine della guerra, tentava di coordinare le attività della
Reichswehr con la cosiddetta “reichswchr nera”, i corpi franchi e gruppi paramilitari
onnipresenti, reduci dalla Grande Guerra. Ha descritto il suo obiettivo nei suoi Ricordi,
pubblicati nel 1928, cioè “dare al soldato del fronte la parte di governo alla quale ha diritto”.
Fino 1923, Hitler, il prototipo stesso del soldato del fronte, si credette sufficientemente forte per
tentare un colpo di Stato. Questo fallì per via della “diserzione” delle autorità bavaresi che non
di meno lo avevano incoraggiato.
Questo dopo guerra terminò con la “battaglia della Ruhr” nel 1923, in seguito all’occupazione
dalle Ruhr da truppe francesi e belghe il 10 gennaio. Poincaré aveva preso questa decisione
perché i tedeschi cercarono (e trovarono) più pretesi per sottrarsi all’adempimento del Trattato
di Versailles ed al pagamento degli indennizzi in liquido o in beni (tra l’altro carbone). Questa
“occupazione pacifica” rassomigliò molto ad una vera occupazione di guerra. In un certo senso i
francesi e i belgi fecero pagare ai tedeschi ciò che avevano sofferto sotto l’occupazione dal 1914
al 1918. Ancora una volta, l’ombra della grande guerra fu molto pesante per la Repubblica di
Weimar.
Tuttavia riuscì a liberarsi per un pò. Il periodo compreso tra il 1924 ed il 1928 fu un brillante
intermezzo di stabilità politica e di sviluppo culturale. Però quando venne la grande crisi
dell’economia mondiale del 1928/29, iniziata con il crollo della Borsa di New York, lo spettro
della grande guerra riapparve. E’ interessante notare cha soltanto a partire da quel momento
iniziò la produzione di letterature e di film di guerra in Germania, culminante con la famosa
“controversia” attorno al grande libro di Erich Maria Remarque: “A l’ouest rien de nouveau”. Il
partito di Hitler si trasformò in partito di massa (all’occasione di questa crisi economica).
Continuò ad apparire come il soldato della grande guerra riaffermando in ogni discorso che la
sua presa di potere significherebbe la fine della schiavitù di Versailles e di ogni tradimento. Fu
molto applaudito, addirittura da coloro che non lo seguivano, quando denunciò la firma tedesca
del trattato di Versailles nel 1933.
18. Immagini di sconfitta: l’Ungheria dopo la guerra persa, la
rivoluzioni ed il trattato di pace di Trianon
Peter Bihari
(Poesia revionista, anni 1920) (testo in inglese)
Questo contributo riguarda meno gli avvenimenti nel particolare – le rivoluzioni del 1918/1919
e le disposizioni disastrose del trattato di Trianon – che il loro impatto e la loro sopravvivenza
nella memoria collettiva. La memoria non è soltanto un approccio storico di moda, ma
costituisce, a mio parere, un’opportunità per professori e studenti in storia che desiderano
veramente mettere in relazione il presente con il passato.
C’è un parallelismo ma le situazioni ungheresi e tedesche intorno al 1919 – a parte la
dimensione, la potenza e l’importanza internazionale delle nazioni in questione. Tutte e due
hanno subito una sconfitta che stentano ad ammettere come tale, vedendovi piuttosto una
142
“pugnalata alla schiena”; tutte e due hanno sviluppato un nazionalismo radicale – sulla base di
torti reali o presunti- e tutte e due erano società profondamente divise, unite solo dal loro
desiderio di riscrivere completamente trattati di pace “ingiusti”.
A proposito di ciò che è successo realmente in Ungheria nel periodo di grande confusione degli
anni 1918/1920, citerei l’eccellente riassunto che ne fa Robert O.Paxton nel suo recente lavoro
sull’anatomia del fascismo.
“Si può trarre più conclusioni di questa storia. In primo luogo, a prescindere
dall’importanza dei radicalismi di sinistra e di destra in Ungheria, il destino della
Nazione è stato globalmente sigillato dalle potenze vittoriose dell’Intesa (e
della
piccola Intesa). In secondo luogo nessuna nazione vinta ha conosciuto una simile sorte,
in termini di smembramento e di perdite di territorio all’eccezione forse della Turchia
nel quadro del trattato di Sèvres che è stato rettificato, al termine della guerra di
liberazione, 3 anni più tardi a Lausanne. In
terzo luogo, nessuna altra nazione o
popolazione sopportò tanti cambiamenti come l’Ungheria in materia di sistema politico
– eccetto l’Ucraina. Tutto ciò si è svolto in 10 mesi. Aggiungete la perdita della Grande
Ungheria – sin dal
1919- e non ci si meraviglierà più delle profonde divisioni, per
non parlare
di discriminazioni che sono apparse in seno alla nazione. D’altronde le
risentiamo ancora oggi nel XXI secolo” (IDEZET/Paxton, 2005, pp.
24/25).
Chi avrebbe mai immaginato?
Questa parte del mio contributo si concentra sulle conseguenze e l’impatto del trattato di
Trianon sulla coscienza nazionale ungherese – in altri termini, le immagini di sconfitta, ovvero
Trianon “come luogo di memoria”. Per iniziare conviene interrogarsi sulle ragioni per cui il
trattato abbia causato tal choc, e tale protesta presso l’opinione pubblica della nazione. Ne vedo
tre: la prima risiede nel fatto che l’uomo della strada, gli intellettuali ed i politici non ebbero
nessuna coscienza di ciò che succedeva allora.
“Tutto è capitato cosi in fretta! 5 anni prima, 2 anni prima, avremmo preso in giro, o
anche malmenato chiunque avesse predetto che l’Ungheria del 1920 non sarebbe più
stata formata che di 14 o 20 contee invece di 63, con Kosice,
Bratislava, Timisoara,
Arad, Cluj, Subotica diventate terra straniera! (……). Chi
avrebbe
potuto
pensare che sarebbe bastato cosi poco per rovinare un paese
millenario,
una
nazione che aveva resistito ai Turchi, ai Tartari e agli invasori occidentali – oggi alla
deriva, sull’orlo dell’abisso!” si lamenta già Béla
Bangha, padre gesuita di
destra, in uno scritto datato 1920.
Inoltre, dopo il 1920, l’Ungheria è diventata una delle nazioni europee più piccole e deboli,
quand’anche fino al 1928, poteva considerarsi come una grande potenza, elemento chiave della
doppia monarchia, l’impero millenario di Santo Stefano (cosa da notare, nessuno
apparentemente ha rilevato che la rottura della doppia monarchia ha fatto allora del paese – per
lo meno sul piano formale- uno stato indipendente, dopo praticamente 400 anni di dominio
straniero).
Infine, bisogna tenere presente che i territori smembrati erano con precisione i più saldamente
associati al passato storico della nazione. L’Alta Ungheria e la Transilvania hanno cosi
conservato la nazionalità Ungherese durante l’occupazione turca, per diventare la culla di tutta
una discendenza di ungheresi, di eccezione, da Matthias Corvin a Béla Bartok. Era quasi
inconcepibile che i luoghi di nascita di questi eroi potessero essere visitati solo con un
passaporto valido – come anche i luoghi di parenti vivi o morti.
Movimenti di protesta contro il trattato di Trianon, ma anche commemorazioni di quest’ultimo,
iniziano il giorno stesso della firma. Il 4 giugno 1920, alcune scuole e negozi restano chiusi.
143
Parecchie centinaia di migliaia di persone scendono in strada a Budapest. Bandire nazionali
sono messe a mezz’asta, e resteranno cosi per decenni. Sono pubblicati giornali con margini
neri, in segno di lutto e le campane suonano senza sosta. La cosa si ripete nel novembre 1920,
quando l’assemblea nazionale esamina e adotta il progetto di legge – che, evidentemente, tutti
quanti respingono. “Questo trattato di pace, che mira a strangolare una vecchia nazione
civilizzata, è nullo davanti a Dio e agli essere umani”- dichiara il deputato Jeno Czetter
all’occasione del dibattito parlamentare attorno al trattato. Poi, facendo appello ai vecchi
compatrioti, aggiunge:
“Non dovete dimenticare che la vostra patria, l’antico impero di Santo Stefano, è stata
sempre un paese di libertà, ordine, cultura, stato di diritto, dove ogni razza ha sempre
potuto svilupparsi liberamente, e ogni persona prosperare secondo i propri meriti”.
Non è difficile scoprire qui un genere del mito dell’età d’oro – mito del quale si ritrova la traccia
nello slogan più popolare del revisionismo ungherese: “L’Ungheria mutilata non è una nazione
– l’Ungheria nella sua compiutezza è una nazione divina”. Ne approfitto per citare un altro
grande slogan, che è in realtà, una sorte di preghiera nazionale: “Credo in un Dio unico, credo in
una sola patria, credo in una sola ed unica verità eterna e divina, credo nella risurrezione
dell’Ungheria, amen” (la preghiera e lo slogan sono stati scelti tutte e due grazie ad una
“competizione revisionista” organizzata su scala nazionale). Lo slogan più breve- “No, no, mai”
– con la sua triplica negazione, era un’allusione al nome Tri-a-non (1.a, b. kép:”Nem, nem,
soha!”+ “No, no, never!”).
I simboli del revisionismo e dell’irredentismo
Veniamo adesso alle immagini visibili dell’irredentismo e del revisionismo del periodo tra la
prima e la seconda guerra mondiale in Ungheria. Condivido l’opinione secondo la quale la
nozione di revisionismo in se stessa rimanda ad un approccio più moderato, e che prende un
carattere giuridico e pragmatico, mentre “l’irredentismo”, sia per natura più intenzionale,
arbitrario, aggressivo e – in genere- irrealista. In Ungheria, tuttavia prevalse quest’ultimo
atteggiamento, almeno nella propaganda nel discorso pubblico.
Ci sono più immagini della bandiera nazionale a mezz’asta; almeno una ricavata da una
cartolina sulla quale appare la preghiera sopra citata (1928). Il monumento era ricoperto di
simboli e di iscrizioni cerimoniali. In cima all’asta, la mano lunga un metro – alzata come per
un giuramento- era stata modellata su quella di Horthy. Le figure, evidentemente, rappresentano
tutti gli strati della popolazione; le immagini piccole ad ogni angolo si riferiscono a 4 nuovi
monumenti eretti alla stesso posto: “Ovest”, “Nord”, “Est”, e “Sud”. Questi simboleggiano i
territori perduti.
La statua della “tristezza ungherese” rappresentava – e non c’è da meravigliarsi- una donna
nuda. Nel 1932, Ferene Herczeg, presidente della lega revisionista ungherese e per altro celebre
scrittore, fa un discorso all’occasione della cerimonia di inaugurazione.
“Noi, ungheresi, siamo il popolo più triste della terra, perché ogni cosa, a noi sacra, è
stata derisa, demolita e crocifissa. Quanto all’eredità dei nostri avi, i
mercenari
l’hanno giocata ai dadi. La nostra nazione è stata più volte sotterrata in passato, ma
sempre è risuscitata il terzo giorno”.
Questa citazione, a mio parere, è piena di senso. E’ l’espressione di un nazionalismo fondato su
ingiustizie e sconfitte nazionali storicizzanti, che fa ricorso, in modo molto significativo, al
lessico cristiano. La sofferenza ungherese è messa sullo stesso piano della passione di Gesù
Cristo, mentre le potenze di occupazione susseguitesi nel paese sono molto spesso descritte
come demoni a grinfie e coda. L’immagine seguente”l’Ungheria crocifissa” - per altro copertina
di “Giustizia per l’Ungheria”, celebre libro scritto in più lingue- è un’altra buona illustrazione di
144
questo parallelo. Oppure guardate ancora questo stemma di Trianon a forma di croce. E’
necessario aggiungere che il revisionismo avesse i suoi propri “dieci comandamenti”?
L’immagine dell’Ungheria sola in mezzo ai suoi nemici, regolarmente vinta ma sempre risorta,
diventa presto un luogo comune (che rispecchia le visioni romantiche del XIX secolo). In un
articolo su “le nostre catastrofi nazionali”, Albert Berzeviczy, presidente dell’Accademia
ungherese di scienze, evoca i Tartari, i Turchi e l’assolutismo dopo la rivoluzione del 1848, e
conclude che “Trianon rappresenta la sintesi di quasi tutte le caratteristiche delle nostre tragedie
nazionali passate, e ne fa, fino ad ora, la crisi più grave che abbia mai messo alla prova, la
nostra vitalità”. Inoltre, attribuisce l’incapacità del paese di difendersi dalle attività di
tradimento che vi si svolgono – ponendo cosi le basi del nostro proprio mito (latente) della
“pugnalata alla schiena”, ciò fin dal 1920. L’analogia tra il disastro della battaglia di Mohacs
(1526) e Trianon torna allora frequentemente, diventando anche il tema di esami finali di storia
al liceo; cosi, nel 1929, l’enunciato della prova prende una forma delle più semplici:
“parallelismi tra Mohacs e Trianon”.
Non di rado, all’epoca, diversi memoriali erano innalzati alla gloria dell’irredentismo,
addirittura nei quartieri più umili e nei luoghi più comuni. Vedete le vetrine di Budapest, negli
anni 1920 e 1930. Queste cose non erano “attese dall’alto” ma facevano semplicemente parte
dello “spirito pubblico”. Soffermiamoci su alcuni oggetti innocenti del quotidiano, come un
distributore di bibite, un posa cenere, un astuccio, una “cimice nazionale”, un orologio
irredentista o ancora una pubblicità per lucido. I vestiti non fanno eccezione, anche se è
interessante notare che i vestiti tipicamente ungheresi sono diventati di moda soltanto nel 1930.
I vestiti alla moda sono in relazione con “l’Ungheria in lutto”. Prediligo l’acconciatura che
conteneva la sacra corona di Santo Stefano, vincitrice di un concorso.
Nessuna occasione è stata tralasciata per rinforzare il messaggio: una corsa a piedi irredentista
con l’iscrizione “no, no, mai!”, un gioco di carte “del destino ungherese” o un gioco di società
irredentista “Raggiungere la grande Ungheria” – l’ ultima risalendo alla fine degli anni 1930,
momento in cui questo programma prenderebbe forma e diventerebbe realtà.
Un solo campo importante è stato tralasciato, l’educazione, che non è facile a illustrare. Durante
tutta l’era Horthy, le giornate scolastiche cominciavano e si concludevano con la “preghiera
nazionale”. Materie come la letteratura, la geografia, o ancora la storia sono piene di contenuti e
di simboli irredentisti. Ho già menzionato i temi d’esame al liceo che riguardano, direttamente o
no, Trianon o il Revisionismo. Un piano di corso dettagliato sul “modo di insegnare il trattato di
Trianon” agli alunni di prima è un testo appassionato, molto di parte, anche estremista, allo
stesso modo offensivo e ingiurioso per i vicini della nazione, gli ex compatrioti.
Conclusioni
Abbiamo visto come i memoriali della gloria di Trianon si sono diffusi, essenzialmente a partire
dalla seconda metà degli anni ‘20. Senza sorpresa, molti di loro si ispirano allora a dei manifesti
della prima guerra mondiale: la propaganda ufficiale in effetti ha spiccato il volo durante gli
anni della guerra ( e le rivoluzioni hanno seguito). Molti, per non dire la maggior parte di questi
memoriali fanno appello ai simboli del nazionalismo romantico, d’una parte, e del cristianesimo
dall’altra: i più efficaci tra di loro combinano d’altronde, i due che non di meno, in fondo, non
hanno niente a che vedere l’uno con l’altro. Abbiamo visto in che modo varie forme di
commemorazione del Trianon e della “Ungheria nella sua computezza” si sono ritrovate nella
vita di tutti i giorni: appoggiandosi su piaghe lasciate aperte, sono innegabilmente efficaci.
Tuttavia, alcuni contemporanei rimpiangono già che il rituale perpetuato attorno a Trianon si sia
cosi svuotato del suo senso fino a diventare controproduttivo e a rilevare ormai un
autoaccecamento puro e semplice.
Eppure – ed è un punto cruciale- tutto ciò presenta una funzione essenziale per la comunità.
Secondo lo storico francese Raoul Girardet, i miti storico politici moderni possono essere
145
spartiti in 4 grandi gruppi: le teorie del complotto, i miti dell’età dell’oro, le apologie eroiche ed
i miti a proposito dell’unità di una comunità. Ora, pare che il mito di Trianon partecipi
contemporaneamente ai quattro: la grande Ungheria, difesa dalla nazione ungherese, eroica e
giusta, resistente da sola contro tutti i suoi assalitori – rappresentava un’età d’oro, ma complotti
intrecciati da nemici sia interni che esterni, hanno avuto la meglio su di essa. Tuttavia, le
basterebbe unirsi nuovamente per innalzarsi e resuscitare all’occasione di una completa
revisione. In quanto all’unità, secondo un giovane storico ungherese, “il revisionismo era
praticamente la sola forza capace di accogliere un consenso dell’Ungheria del periodo compreso
tra le due guerre mondiali”. Spiega cosi che questa dottrina “svolgeva il ruolo di autoterapia
psicologica post traumatica”.
Aggiungerò che prima, all’epoca del socialismo di stato – gli storici avevano tendenza a fare
prova di parzialità accordando un’importanza smisurata alla funzione legittimante della
sindrome di Trianon, in modo particolare dando da pensare che contribuisse più di ogni altra
cosa alla stabilità del sistema conservatore di destra di Horthy e Bethlen. Si trattava in quel caso
di un opinione distorta, per il fatto che trattava Trianon ed il revisionismo come un problema
creato dal nulla, allo scopo di manipolazione da parte di gente delle classi dirigenti. Ma vi
mostrerò altre due immagini che provano che le apparenze non erano necessariamente
ingannevoli: la prima con Horthy, capo, in mezzo, e la seconda – un manifesto di campagna
datato 1931, sul quale appare il primo ministro, il conte Istvan Bethlen “per la resurrezione
dell’Ungheria”.
Per finire, vorrei brevemente segnalare alcune grandi caratteristiche della coscienza nazionale
ungherese tra le due guerre mondiali. Come in Germania, questa si è definitamene allontanata
dalle vestigia del liberalismo per prendere un aspetto nazionalista fanatico ed esclusivo. Da
allora ha preso come bersaglio gli ungheresi imperfetti e magri che trattava come nemici interni,
facendo prova di razzismo e antisemitismo crescenti. In un certo modo, questa coscienza
nazionale si è anche rivolta contro l’Europa dell’ovest – che non era altro che fonte di
sofferenze e vedeva solo le origini orientali “barbari” degli ungheresi. A questo riguardo, una
citazione del 1920 del radicale di destra Gyula Gömbös (primo ministro tra il 1932 ed il 1936) è
particolarmente rivelatrice: “Abbiamo sempre protetto l’Europa contro i nostri fratelli turanici e
questa stessa Europa firma oggi la nostra condanna a morte.”
Un immagine è l’esatto riflesso di queste parole: vi si può leggere”Da 1.000 anni per l’ovest”.
Notate la croce apostolica ed il guerriero “barbaro”. Più tardi, negli anni trenta, il movimento
nazista ungherese – gli uomini della croce frecciata – riciclerà questi simboli “turanici”per
indicare la rottura con l’ovest, ma anche con le tradizioni cristiane.
Cronologia degli avvenimenti
1867
1913
1914
1916
1917
1918
ESTATE
17 ottobre
24 ottobre
30/31 ottobre
Compromesso austro ungherese – creazione della doppia
monarchia
Il conte Istvan Tisza torna come primo ministro (fino al 1917)
L’Austria – Ungheria entra nella prima guerra mondiale
dichiarando guerra alla Serbia (fino al 1918)
La Romania entra in guerra attaccando la Transilvania. Il conte
MichaelKarolyi fonda il suo partito indipendente antiguerra e
antitedeschi – Carlo IV segue Francis Joseph
Carlo IV priva del potere Tisza. Si seguono governi minoritari
instabili. Dibattito sulla questione ebrea nei giornali
(l’antisemitismo guadagna terreno)
l’ultima offensiva della monarchia sul Piave gira al disastro
Tisza annuncia in parlamento che l’Ungheria ha perso la guerra
Creazione del consiglio nazionale ungherese formato da partiti
di opposizione di sinistra
Vittoria della rivoluzione democratica (“rivoluzione degli astri
146
3 novembre
13 novembre
16 novembre
dicembre
1919
gennaio
20/21 marzo
Aprile / giugno
Luglio / agosto
autunno
1920
1° marzo
1921
4 giungo
Marzo / ottobre
aprile
1922
settembre
Michael Karolyi diventa primo ministro (praticamente niente
sangue versato, ma il conte Tisza è ucciso da soldati
sconosciuti).
Armistizio di Padova firmato con rappresentati della vecchia
monarchia
Rappresentanti ungheresi firmano un armistizio distinto a
Belgrado
Proclamazione della repubblica ungerese a Budapest
Aumento delle tensioni e del malcontento. I comunisti e i
nazionalisti radicali si organizzano; gli eserciti della
Cecoslovacchia e della Romania varcano le frontiere
dell’armistizio.
Karolyi diventa (temporaneamente) capo di stato.
un comunicato dell’Intesa rivolto all’Ungheria esige un nuovo
indietreggiamento praticamente fino alla frontiera che sarà tardi
quella di Trianon. Dimissione del governo, creazione della
Repubblica Sovietica
l’esercito della Repubblica sovietica sostiene vittoriosamente
gli attacchi rumeni e cecoslovacchi ma si china davanti
all’ultimatum di Clémenceau
la repubblica sovietica è in crisi; il governo di Béla Kun si
dimette il primo agosto. L’esercito rumeno entra in Budapest
terrore bianco contro i comunisti, socialisti, ebrei, ecc… I
rumeni lasciano Budapest; le truppe dell’ammiraglio Horthy
entrano nella capitale; questi assume la funzioni di comandante
capo
la nuova assemblea nazionale elegge Horthy reggente di
Ungheria (fino al 1944)
firma del trattato di Trianon
l’ex re Carlo IV tenta di tornare sul trono di Ungheria (grazie a
due colpi di stato del re). Le potenze della piccola Intesa
si
mobilitano; i due tentativi falliscono
il conte Istvan Bethlen forma un governo ( riamane primo
ministro fino al 1931)
l’Ungheria si unisce alla lega delle nazioni.
147
19. Dall’equilibrio delle forze alla sicurezza collettiva? La Società delle
Nazioni e la diplomazia internazionale
Alan Sharp
Un nuovo ordine?
In dicembre del 1918, Woodrow Wilson, allora presidente degli Stati Uniti, riceve
un’accoglienza particolarmente entusiasta in Europa; prima a Parigi, poi a Roma e infine a
Londra dove, all’occasione di un discorso a Palazzo di Città, interpreta questo atteggiamento nei
suoi confronti come un omaggio alla sua politica. “Vedo nell’accoglienza che mi è riservata il
segno che esse (le nazioni alleate) hanno combattuto per sbarazzarsi del vecchio ordine al fine
di stabilirne uno nuovo, e che il pilastro del vecchio ordine era quella cosa instabile che
eravamo soliti chiamare equilibrio di forze, la quale era determinata dalla sciabola brandita su
ambedue i lati, equilibrio mantenuto grazie ad una vigilanza gelosa ed un conflitto di interessi
che, benché generalmente latente, era sempre ben ancorato” (Shaw, 1919, p.65).
Wilson, in effetti, con un cospicuo gruppo di personalità europee e mondiali, procede tentoni
verso un sistema di sicurezza collettiva, di cui ha già tracciato le grandi linee nel più importante
dei suoi 14 punti dell’8 gennaio 1918: “Un’associazione generale di governi deve essere
formata in virtù di patti specifici per offrire garanzie reciproche di indipendenza politica e di
integrità territoriali ai piccoli stati come ai grandi” (Temperley, vol. 1, 1969, p.435).
All’indomani del discorso a palazzo di Città, Georges Clémenceau, presidente del consiglio
francese, ottiene l’approvazione della Camera dei Deputati, dichiarando a Parigi: “Esiste un
vecchio sistema di alleanze chiamato equilibrio delle forze – questo sistema di alleanze, al quale
non rinuncio, guiderà la mia azione al momento della conferenza di pace” (MacMillan, 2001,
p.31). Questa evidente rottura tra la fiducia di Wilson in una nuova strada e la fede confermata
di Clémenceau nella vecchia, danno da pensare che non è necessario di mettere un punto
interrogativo al titolo di questo saggio.
Se Wilson pensa allora che “il grande gioco, ormai discreditato per sempre, dell’equilibrio delle
forze” non ha più corso (Temperley,op. cit. p. 439), i suoi colleghi europei non ne sono cosi
sicuri; cosi, malgrado l’importante sostegno popolare e intellettuale di cui beneficia, durante la
prima guerra mondiale e dopo, l’idea di un nuovo sistema di relazioni internazionale per
sostituire i meccanismi che hanno fallito nel 1914, questo entusiasmo non è necessariamente
condiviso dalle elite politiche, ancorché un potente istinto di sopravvivenza proibisca loro
sempre più di ammetterlo. Pochi dicono apertamente come Clémenceau la loro costante fedeltà
al vecchio regime e non tutti sono irrevocabilmente attaccati ad una via che si è mostrata ai loro
occhi inefficace, ma la sicurezza collettiva rappresenta un salto nell’ignoto le cui conseguenze
possono essere fatali.
Il grande pubblico, che aspira ad un’organizzazione capace di impedire che si ripeta la prima
guerra mondiale aspetta dai suoi dirigenti che sostengano la lega. Questi ultimi, per vari motivi,
da quell’orecchio non sentono molto, ma non vogliono neanche dissociarsi dal progetto. Una
delle linee di frattura dell’insieme del sistema, nel corso degli anni ‘20 e fino agli anni ‘30,
risiede in questa dicotomia tra ciò che dicono i dirigenti politici al loro elettorato e ciò che
pensano realmente. La crisi profonda del 1935 metterà il governo britannico, in particolare, di
fronte alle conseguenze di tale atteggiamento.
L’equilibrio delle forze
148
L’equilibrio delle forze è stato definito da Emmerich de Vattel come “uno stato degli affari tale
che nessuna potenza occupi una posizione sufficientemente dominante per dettare la sua legge
agli altri” (Bull, 1995, p.97). In quanto sistema è più strettamente associato al XIX secolo post
napoleonico, di cui il britannico Lord Palmerston è considerato uno dei più ferventi sostenitori.
L’opinione di quest’ultimo secondo la quale “da un punto di vista politico è fare prova di
ristrettezza mentale di volere tale o tale nazione come eterno alleato o nemico perpetuo
dell’Inghilterra. Non abbiamo ne l’uno né l’altro – i nostri interessi sono eterni, e il nostro
dovere è di seguirli”, contiene da sola elementi importanti della filosofia che sottende il sistema.
I giovani devono seguire i propri interessi tenersi pronti a difenderli. Devono anche poter
mostrarsi flessibili, sia per cooperare con un altro membro che per opporsi in funzione della
situazione.
E’ importante mantenere un equilibrio di forze che vi sia favorevole come anche ai vostri alleati
(del momento). Tuttavia, come lo ha fatto notare il diplomatico francese Charles Maurice de
Talleyrand, il Sistema è artificiale e suppone una dimensione morale e allo stesso tempo una
certa potenza militare o economica. “Se (…) la potenza di resistenza minima, scrive, (….) fosse
uguale alla potenza di aggressione massima (…..), ci sarebbe un reale equilibrio. Ma (….) la
situazione attuale permette soltanto un equilibrio artificiale e precario che non può durare a
lungo se non fin quando alcuni Stati saranno animati da uno spirito di moderazione e di
giustizia”. La politica in questione è particolarmente associata al Regno Unito; d’altronde, come
Eyre Crowe lo esprimeva in un modo più conciso nel suo celebre memorando del primo
gennaio 1907, “il fatto di stabilire un parallelismo tra la politica secolare dell’Inghilterra e
l’equilibrio delle forze rileva dell’ovvia verità storica (citato in Otte, 2003, p.77). Nel 1923, il
professore
Pollard, dal canto suo, fornisce una definizione più cinica e partigiana di questa
relazione: “l’equilibrio delle forze in Europa era in realtà una dottrina secondo la quale la Gran
Bretagna doveva disporre della forza mentre gli altri paesi assicuravano l’equilibrio” (Pollard,
1923, p.60).
Si può pensare che l’era delle alleanze bismarchiane abbia privato il sistema della flessibilità di
cui aveva bisogno per funzionare. Anche se le relazioni non sono mai state esclusive, l’AustriaUngheria e la Germania si sono alleate dopo il 1879, come la Francia e la Russia a partire dal
1894, poi l’Italia ha contratto un’alleanza (sempre più distante) con l’Austria – Ungheria e la
Germania allorché l’Inghilterra cadeva nell’orbita francorussa, ma in modo informale. La
fluidità necessaria di Palmerston non fa più parte del sistema. Si potrebbe anche affermare che
la Gran Bretagna di allora non abbia indicato in modo chiaro che avrebbe combattuto per
impedire alla Germania di dominare il continente, benché sembra poco probabile che una
dichiarazione del genere cosi chiara (che per motivi di politica interna, il segretario britannico
agli affari esteri, Sir Edward Grey, non è mai stato in grado di fare) avrebbe mai fermato i
tedeschi, in particolare nel corso della crisi di luglio 1914.
Un nuovo approccio di pace?
Wilson non è solo a pensare che lo scoppio della guerra del 1914 sia imputabile a incrinature
nelle strutture esistenti in materia di politica e di relazioni internazionali, e cambiamenti radicali
siano rivendicati in modo sempre più insistente a mano a mano che appare in modo più chiaro
l’enormità di una guerra che non è ancora finita quando arriva Natale nel 1914, 1915, 1916,
addirittura 1917.Grey è convinto che la guerra avrebbe potuto essere evitata se fosse riuscito a
convincere i suoi colleghi di Berlino e di Vienna, a partecipare ad una conferenza europea delle
grandi potenze e a rispettarne le decisioni. Sin dal 1913, la conferenza di Londra sui Balcani,
sembra indicare che il Concerto dell’Europa, nato nel XIX secolo, sia ancora in grado di
impedire un conflitto globale, come i suoi adulatori rivendicano che lo faccia dal 1815. Ma il
sistema è sempre riposato sulla sola volontà delle potenze di partecipare e non prevede nessun
meccanismo per forzare i suoi membri ad una consultazione mutua. Grey si converte dunque
molto presto all’idea di una nuova architettura internazionale di sicurezza disponendo di poteri
che gli permetterebbero di esigere la tenuta di tale consultazione e di imporre un termine prima
149
che la guerra possa essere dichiarata, ma è proprio quando Wilson unisce la sua voce a quella di
piccoli gruppi influenti in favore di un cambiamento che l’idea di una Società delle Nazioni
guadagna il suo più efficace difensore, in mancanza del suo ideatore più influente.
L’idea di un’alleanza generale per mantenere la pace non è nuova. Maximilien Sully,
consigliere del re Enrico IV di Francia, aveva già suggerito un “Grande disegno”. La “Santa
alleanza” apparsa dopo la rivoluzione e le guerre napoleoniche, come la “federazione di stati
liberi” cara ad Emmanuel Kant, costituiscono tante altre nuove proposte anteriori che miravano
a raggiungere lo stesso obiettivo. Il XIX secolo ha visto la firma di vari accordi internazionali
per facilitare il commercio e le comunicazioni, come anche un ricorso sempre più frequente al
regolamento di conflitti per mezzo del diritto o di procedure di arbitraggio. Nel 1899, la prima
conferenza dell’Aia ha creato una corte permanente di arbitraggio che vede uno dei suoi
membri, Léon Bourgeois, pubblicare nel 1908 un’opera intitolata “La società delle nazioni”, che
ha dato il suo nome all’organizzazione ed è quasi tutto. Praticamente tutte le grandi potenze
hanno allora degli accordi, formali o no, secondo i quali si impegnano a sottoporre i loro litigi a
tale o a tale forma di regolamento di conflitti, dal momento che l’onore o la sicurezza del paese
non siano in gioco. Se una guerra mondiale non avesse coinvolto tutte le grandi potenze nel
1914, gli storici del XX secolo avrebbero forse scritto di un internazionalismo crescente e di un
mantenimento efficace della pace che, nati nel XIX secolo avrebbero raggiunto la piena maturità
alla loro epoca.
Wilson venne infatti a Parigi con un’idea forza che sottende l’insieme della sua visione del
ristabilimento della pace. Crede nella bontà fondamentale dell’essere umano. Dando potere alla
gente, si assicura un avvenire prospero e pacifico. L’applicazione dei principi di
autodeterminazione nazionale e di democrazia, che per Wilson sono inestricabilmente legati,
significherà che la gente potrà scegliere lo stato in cui vive e controllare il governo di questo
stato. Visto che sono buoni, sceglieranno un governo saggio. Ciò favorirà l’armonia nazionale.
L’estensione dell’influenza di queste persone razionali ed informate nel campo delle relazioni
internazionali potrà essere realizzata con la creazione di una Società delle nazioni, un
organizzazione concepita non per proibire la guerra con il diritto ma per impedire un’
infiammarsi rapido come quello che è successo nell’estate 1914. Preparando il mondo alla
democrazia, se ne farà un posto più sicuro, perché i governi sentiranno gli avvertimenti di un
opinione pubblica informata e non lasceranno le controversie degenerare in guerra. Wilson
spiega: “ La mia concezione della Società delle nazioni è semplice: questa deve operare come la
forza morale organizzata degli uomini del mondo intero, ed ogni volta che una nazione prevede
o progetta di aggredire un’altra o di causarle torto qualche sia il posto, questo lampo di
coscienza dovrà essere puntato su di lui e tutti gli altri uomini dovranno chiedergli: cosa avete in
cuore contro la buona marcia di questo mondo?”(Armstrong, 1982, p.98). Georges Clémenceau
è meno convinto – “Vox populi, vox diaboli”, brontola, facendo a Wilson il complimento
dubitoso sul “nobile candore del suo spirito”. (Duroselle, 1988, p.738).
Tenendo conto che Wilson era visto come il grande campione della Società, è sorprendente che
non sia stato coinvolto più di tanto nell’elaborazione di piani e progetti di legge prima del suo
arrivo a Parigi. Infatti, è in Gran Bretagna, con il rapporto Phillimore a maggio, e in Francia,
con a giugno le conclusioni di una commissione presieduta da Bourgeois, che le prime proposte
pratiche appaiono nel 1918. La Società secondo Phillimore sarebbe un parente stretto del
Concerto dell’Europa. Questa organizzazione insisterebbe sulla sovranità degli Stati. Tuttavia,
Lord Justice Phillimore, invocando il concetto anglosassone del “hue and cry”, propone che
ogni membro che parte in guerra senza avere esaurito le procedure della Società “si trovi ipso
facto in guerra contro tutti gli altri stati alleati….”. Questa sanzione automatica e senza
equivoco è al centro dell’idea di sicurezza collettiva, e la sorte che le sarà riservata determinerà
se la Società diventerà o no una forza veramente nuova e rivoluzionaria nella diplomazia
internazionale. Il rapporto francese condivide molto le idee avanzate da Phillimore, ma
Bourgeois propone inoltre che la Società abbai un po’ più di muscoli, in altre parole una forza
militare internazionale. Per altro insiste perché l’adesione non sia proposta soltanto agli alleati
150
del tempo della guerra, il che porta inglesi e americani a sospettare che la Francia voglia rendere
perpetua l’alleanza di guerra unicamente per imporre la pace alla Germania (Egerton, 1979, pp.
65/69).
Solo dopo questi rapporti, di cui dice che non lo impressionano, Wilson comincia a stendere le
sue prime proposte, con l’aiuto del suo amico e confidente, il colonnello Edward House. In un
primo momento, prende anche in considerazione la sanzione di entrata in guerra ipso facto,
come stabilito ugualmente nel progetto di Jan Smuts, ministro sud africano della guerra e
membro del gabinetto di guerra di Lloyd Gorge, e in quello di Robert Cecil, uno dei principali
membri del partito conservatore e d’altronde ex ministro incaricato del blocco imposto alla
Germania. Nel suo primo (testo) elaborato, Wilson scrive così: “Ogni potenza contrattante che
rompe questo patto o non ne tiene conto…entra di questo fatto, ipso facto…. in guerra contro
tutti i membri della Società”. Queste parole contengono alla volta l’idea centrale della sua
organizzazione internazionale alternativa, la sicurezza collettiva, e la garanzia automatica da
parte di tutti i membri di un’alleanza universale in favore dell’indipendenza politica e
dell’integrità territoriale degli altri stati partecipanti di fronte ad un aggressione unilaterale. La
formula di Wilson, tuttavia evidenzia la principale incrinatura del sistema – la contraddizione tra
la sovranità degli stati e la necessità di una garanzia assoluta, incondizionale ed automatica. In
questo quadro, la decisione fondamentale che un governo sovrano può essere indotto a prendere
– quella di partire in guerra – sarebbe in realtà presa da un altro governo che non avrebbe
rispettato i suoi impegni internazionali. Ora, come lo fanno notare al presidente il suo segretario
di stato, Robert Lansing, e uno dei suoi consiglieri giuridici più vicini, David Hunter Miller,
tale disposizione è incompatibile con il diritto costituzionale degli Stati Uniti che affida al
Congresso la responsabilità di dichiarare guerra in nome della nazione. Per altro è accolta male
ugualmente dagli altri grandi Stati; sarà dunque la formula modificata di Wilson a formare
finalmente la base dell’articolo 16 del Patto che dispone che “ogni potenza contrattante che
rompe questo patto o non ne tiene conto … è in realtà considerata ipso facto come avendo
commesso un atto di guerra contro tutti i membri della Società”. Ciò restituisce ad ognuno dei
governi coinvolti la scelta della risposta che desidera obiettare per conto suo a tale mancanza.
Nella competizione che oppone una Società sovranazionale alla sovranità nazionale non c’è
nessun dubbio che prevalgono gli Stati, ma a danno dell’immediatezza della sicurezza collettiva
da cui dipende la credibilità di ogni garanzia (Sharp, 1991, pp. 42/76).
Perciò, quando i membri della Società promettono, all’articolo 10, “di rispettare e preservare
dalle aggressioni esterne l’integrità territoriale e l’indipendenza esistente di tutti i membri della
Società..”, Robert Cecil dice ad alta voce ciò che molti pensano: “Si, ma ce ne sono tra di noi
che ne hanno veramente l’intenzione?”. Lo stesso Cecil ha annotato che “per l’essenziale, non si
cerca in nessun modo di appoggiarsi su un potere sovranazionale qualunque, ma piuttosto
sull’opinione pubblica – e se ci sbagliamo su questo punto, ci sbagliamo su tutta la linea”. Il
delegato francese alla commissione della Società, Ferdinand Larnaude, avrebbe del resto
esclamato: “Sono ad una conferenza di pace oppure sono finito in un manicomio?” (Sharp,
1991, pp. 57,62).
In realtà, i principali membri della Società vedono in questa meno una sostituzione che uno
sviluppo ed un miglioramento del sistema esistente di relazioni internazionali, e le ambiguità
che ne derivano vengono a galla sin dal 1919. La Società è tenuta ad offrire ai suoi membri una
garanzia assoluta alla loro integrità territoriale, essendo nello stesso tempo vettore di un
cambiamento pacifico. La Gran Bretagna in particolare insiste sul fatto che un sistema che non
saprebbe mostrarsi flessibile nè accogliere il cambiamento sarebbe a lungo andare vittima della
propria rigidezza, ciò ne farebbe una minaccia per la pace mondiale che si proponeva di
assicurare.
Wilson si consola dicendo che benché sia inevitabile che la conferenza di pace commetta errori,
i meccanismi della Società con il tempo li rettificherebbero. Tuttavia se molte delle nuove
frontiere dell’Europa saranno definite, ai sensi dell’articolo 19, come “condizioni internazionali
la cui perennità potrebbe costituire un pericolo per la pace mondiale”, si può allora pensare che
la soluzione consista in un cambiamento. Ma, in questo caso, cosa ne sarebbe della garanzia
151
territoriale dell’articolo 10? Chi la politica di assicurazione della Società protegge, e a chi si
applica solo a certe condizioni – le quali non sono chiaramente espresse nelle piccole linee?
Se ad esempio la Francia crede nella sicurezza collettiva come è definita nel progetto del patto
di febbraio 1919, a cosa servono le garanzie offerte in marzo da Lloyd Gorge e Wilson contro
un nuovo attacco tedesco? Se una grande potenza come la Francia avvertiva il bisogno di
beneficiare di una protezione supplementare, perché gli stati meno importanti dovrebbero
affidare ad altri, senza riserva, la responsabilità della loro sicurezza nazionale? Si può sempre
riconoscere l’aggressore in un litigio internazionale? Questo porterà sempre, come nei vecchi
western, un cappello nero che lo identifica chiaramente come il cattivo?
La lega delle Nazioni
La Società non sarà mai l’organo universale che richiedeva la sua missione. Nel 1920, conta 32
membri fondatori – essenzialmente i vincitori della guerra ed alcuni stati neutri. I principali
nemici sono esclusi, e l’incertezza che prevale per quanto riguarda la situazione russa mantiene
un’altra grande potenza dell’antiguerra in disparte dalla nuova organizzazione. Quest’ultima
attiverà fino a 63 Stati, ma nel corso della sua esistenza, vedrà 17 nazioni ritirarsi di loro
spontanea volontà oppure esserci invitate, tra le quali il Giappone, la Germania, l’Italia o anche
l’URSS. In nessun momento l’organizzazione raccoglie insieme tutte le grandi potenze, e la
perdita degli Stati Uniti sin dall’inizio le assesta un colpo di cui non si riprenderà mai del tutto.
Non solo si trova privata della forza e della perizia americana, ma gli stati di cui si aspetta che
facessero rispettare le decisioni della Società, con al primo posto la Gran Bretagna, devono
ormai tener conto, prima di agire, di un eventuale confronto con gli Stati Uniti nel caso, ad
esempio, di un blocco navale contro un membro aggressivo con il quale gli americani avrebbero
ancora la speranza di trattare.
La libertà dei mari in tempi di guerra è stata sempre un punto sensibile nelle relazioni
angloamericane, svolgendo un ruolo particolarmente importante nello scoppio della guerra che
ha opposto i due paesi dal 1812 al 1815, e complicando ancora le cose durante la guerra civile
americana e la prima guerra mondiale. Stanly Baldwin, un conservatore che diventerà primo
ministro di Gran Bretagna, precisa cosi che nell’eventualità di un blocco discuterebbero con
Washington prima di mettere la Royal Navy al servizio della Società. Come per l’esito della
guerra in genere, il fatto che gli americani si ritirino dall’esecuzione di politiche che hanno
largamente contribuito ad elaborare lascia l’essenziale delle responsabilità alla Gran Bretagna e
alla Francia, e Ginevra, dove la Società si è insidiata, diviene un’arena in più dove si oppongono
violentemente le loro visioni antagoniste (Henig, 2000, pp. 138/157).
Il Canada si preoccupa vivamente delle conseguenze dell’assenza americana sulla sua relazione
con il suo potente vicino e di conseguenza tenta a 4 riprese di sopprimere o attenuare la portata
dell’articolo 10. Un delegato canadese dichiara cosi, forse a torto e in modo poco diplomatico,
che la sua nazione vive “in una casa resistente al fuoco, lontana da ogni materiale
infiammabile”, e che dunque non giudica essenziale di prendere parte ad un’equipe
internazionale di pompieri. Se, tecnicamente le iniziative canadesi falliscono, un memorando del
Foreign Office britannico riconosce pur sempre, nel 1926, che gli obblighi dei membri in virtù
del Patto saranno limitati in funzione delle “condizioni specifiche e della situazione geografica”
proprie; spetta dunque ad ogni stato di decidere del contributo che desidera portare ad ogni
operazione di sicurezza collettiva, e le sentenze previste all’articolo 16 non sono obbligatorie
(DBFP, 1996, Serie 1°, vol. 1, pp. 847/8).
Come lo spiega allora Gilbert Murray, presidente dell’Unione della Società delle Nazioni in
Gran Bretagna, la sicurezza collettiva non è molto sicura. “L’obbligo dell’articolo 10 è alla volta
troppo vasto per essere accettato da una nazione prudente, e troppo vago perchè questo possa
fare affidamento su di esso. Nella sua forma attuale, il Patto non permette a nessuna nazione di
sperare che in caso di attacco, il resto della Società spedirebbe eserciti per difenderla (Daily
News, febbraio 1923) (citato da Henig, 2000, p.148). I tentativi di rinforzare la sicurezza
152
collettiva a titolo, prima del trattato, di alleanza mutua, poi del protocollo di Ginevra,
incontrarono una feroce resistenza britannica per mezzo del Foreign Office e dei servizi di stato
che pensano che potrebbero portare a degli impegni militari indefiniti ed inaccettabili. I
difensori ottimisti di queste proposte che mirano ad aumentare l’efficacia della sicurezza
collettiva affermano che favoriscono di natura a lanciare e un progressivo disarmo mutuo. I
dubbi, pieni di pessimismo e paradossali, nel novembre 1935, del comitato britannico di difesa
imperiale: “è quasi impossibile prevedere con quali nazioni potremmo entrare in conflitto in
seguito ad una mancanza al patto…è difficile lo stesso di determinare il modo… in cui
dovremmo utilizzare le nostre forze armate, dato che non si può beneficiare di nessuna
indicazione per quanto riguarda la condizioni nelle quali si dovrebbe operare. Di conseguenza…
il principio di sicurezza collettiva costringe a prepararci ancora meglio di prima alla guerra”
(Dunbabin, 1993, pp.440/1).
Benché la Società sia essa stessa un prodotto degli accordi di pace, e pure se i 26 articoli del
Patto costituiscono la prima parte di tutti i trattati negoziati a Parigi, diventa rapidamente chiaro
che i britannici ed i francesi non hanno l’intenzione di lasciare gli aspetti più importanti
dell’applicazione di questi trattati, sfuggire loro di mano. All’indomani del putsh Kapp di marzo
1920 in Germania, ed in rappresaglia a ciò che considera come un incursione illegale delle
truppe del suo vicino nella zona demilitarizzata della Ruhr, la Francia decide unilateralmente, il
5 e 6 aprile, di occupare 5 città tedesche: Francoforte, Darmstadt, Hanau, Hambourg e Dieburg.
Lord Robert Cecil suggerisce che la presenza di queste truppe tedesche nella zona vietata
rappresenta una minaccia di guerra e rileva dunque, in virtù del trattato, delle competenze della
Società. Ma il Foreign Office, anche se giudica l’argomento convincente, non è disposto a
seguire questa politica – queste questioni devono essere risolte dai governi alleati, e non dalla
Società (191340/4232/18 in FO371/3783, Archivio nazionale britannico, Kew). Questa ha le sue
pratiche, che consistono ad esempio nel mettere da parte il principio di autodeterminazione
quando pare necessario di attribuire alla Francia il carbone della Saar o alla Polonia l’uso del
porto di Danzig, senza accordare alla popolazione delle regioni coinvolte la minima sovranità
nazionale. E peraltro ben comodo di affidare la protezione delle minorità dell’Europa centrale e
dell’Est alle cure della Società.
La Gran Bretagna e la Francia chiedono anche alla Società di trovare una via d’uscita al
problema in cui si trovano di fronte ai risultati del plebiscito dell’Alta Silesia del 1921 riguardo
ai confini reali della regione, cosa che costituisce un coinvolgimento inabituale ed eccezionale
dell’organizzazione nell’applicazione del trattato. D’altronde ciò non riesce necessariamente ai
britannici giacchè il confine che sarà finalmente tracciato è molto più favorevole alla Polonia di
quanto Londra avrebbe auspicato. La descrizione poco lusinghiera che fa del comitato, secondo
il segretario del Gabinetto britannico dell’epoca, Sir Maurice Hankey, un gruppo costituito da
“un belga profrancese, due Mètèques e un cinese” dà un’idea del poco rispetto che le era
concesso e riflette chiaramente la delusione britannica (Hankey D’Abernon, 2 ottobre 1921.
D’Abernon papers, ADD MSS 48954, British Library). Si comprende meglio l’atteggiamento
anglofrancese quando le due nazioni respingono, nel 1921, l’idea di una sostituzione della
Commissione di controllo permanente delle missioni militare alleate della Società stessa come
organo principale di controllo del disarmo tedesco, e anche quando si dichiarano scettici per
quanto riguarda la capacità dell’organizzazione di svolgere in fortuna attività di sorveglianza,
nonostante alcune disposizioni dell’articolo 213 del trattato.
La Società registra certo dei successi, di cui, quelli più rappresentati, sono relativi al problema
delle isole Aaland nel 1920 e al conflitto greco-bulgaro del 1925, ma riguardano zone
accessibili dell’Europa, oppongono stati minori e non coinvolgono gli interessi diretti di una
grande potenza. Il ruolo positivo dell’organizzazione nella lotta contro la schiavitù, la
prostituzione internazionale e il traffico di droga, come nella protezione dei rifugiati e delle
minorità, è già riconosciuto all’epoca e sarà confermato più tardi dagli storici. Ma è difficile
determinare se la nuova diplomazia di allora ottiene risultati diversi da quelli che avrebbe
raggiunto la vecchia, in circostanze identiche.
153
La Società è molto meno efficace quando i criteri menzionati non si applicano, come ad
esempio nel confronto tra Bolivia e Paraguay all’inizio degli anni 1930, od ancora negli
incidenti degli anni 1920 come la presa di Vilna da parte dei polacchi. L’occupazione franco
belga della Ruhr nel 1923 offre un altro esempio del modo in cui l’organizzazione è messa in
disparte quando si tratta di fare rispettare il trattato. Lo stesso anno, l’incidente di Corfou mostra
che le esigenze del sistema internazionale, il prestigio e la politica delle grandi potenze sono
tanti elementi che danneggiano a modo loro l’implicazione della Società (Dunbabin, 1993,
Henig, 200). Quando il problema si verifica in lontane contrade e coinvolge una grande potenza,
come succede in Manciuria nel 1931, gli sforzi della Società restano nell’insieme senza effetto,
tanto più che è difficile di designare chiaramente il Giappone come l’aggressore (Armstrong,
op. cit. pp. 28/32). Tuttavia, è in Abissinia nel 1935 che le esigenze delle vecchie e nuove
diplomazie si scontrano più violentemente.
Nel dicembre 1934, le forze italiane e abissine si affrontarono a Wal-Wal, in Abissinia
(Etiopia). Il 3 gennaio 1935, gli abissini chiedono alla Società di beneficiare delle garanzie
offerte dall’articolo 11; ma 9 mesi più tardi, il leader fascista italiano, Benito Mussolini, si serve
di quel incidente per legittimare l’invasione che lancia il 3 ottobre 1935. Le altre grandi potenze
avrebbero potuto tollerare un tale atteggiamento (ma i popoli invasori evidentemente no) nel
XIX secolo, ma non è più il caso nel 1935. Non c’è allora nessun dubbio che l’Italia abbia agito
in modo aggressivo e contrario ai suoi obblighi nei confronti di un altro membro
dell’organizzazione (di cui d’altronde, ironia della storia, essa ha sostenuto la candidatura). Allo
stesso modo, è chiaro che l’Abissinia, già ben conosciuta a Ginevra per le sue posizioni,
dubbiose in materia di schiavitù, può difficilmente considerarsi un membro reale da meritarsi la
solidarietà internazionale, ma le circostanze non mostrano di meno che la credibilità della
Società e della “sua nuova diplomazia”, sia ormai inestricabilmente legata alla risposta che
daranno i suoi principali membri a questo problema preciso.
La loro posizione si trova tuttavia ostacolata dalle esigenze della “vecchia diplomazia”. Sempre
più preoccupate di vedere la Germania di Hitler rinunciare al disarmo ed imporre la coscrizione,
la Gran Bretagna e la Francia vogliono evitare di perdere il sostegno italiano in Europa. L’Italia
possiede in effetti un impressionante flotta moderna e Mussolini vanta la potenza e l’importanza
dei suoi mezzi aerei. La nazione rafforza la sua vocazione ad assumere un ruolo di primo piano
sul teatro europeo quando le sue truppe marciano verso il confine del Brenner ed impediscono
ad Hitler di andare più avanti in Austria, in seguito all’assassinio del cancelliere Dolfuss a luglio
1934. L’Italia acquisisce cosi l’immagine di una componente importante per ogni equilibrio
delle forze in Europa. Il vertice di Stresa, che riunisce l’Inghilterra, la Francia e l’Italia in aprile
1935, dà ai britannici e ai francesi l’impressione di avere rinforzato un blocco contro la
Germania, mentre per Mussolini, l’indifferenza anglo francese di fronte al destino dell’Abissinia
costituisce il quid pro quo del sostegno italiano (per una visione globale del contesto
diplomatico europeo, vedere Marks, 2002, Steiner, 2005).
D’un lato, c’è dunque la sicurezza collettiva, la Società e la moralità internazionale e, dall’altro,
considerazioni sull’equilibrio delle forze ed un approccio amorale della diplomazia
internazionale che si preoccupa dei fini, non dei mezzi. La Gran Bretagna, forse in una misura
maggiore della Francia, è attanagliata tra queste due visioni antagoniste. La crisi in Abissinia ha
come effetto di aumentare la pressione sull’elite decisionista britannica, divisa tra il sostengono
riaffermato del pubblico alla Società e il proprio scetticismo, che si accompagna ad una
preferenza per l’alternativa la più dura a digerire. In una nota dal tono tipicamente acerbo, in
data 8 giugno 1935, Robert Vansittart, il sottosegretario permanente del Foreign Office,
riassume perfettamente la posizione poco invidiabile di questa elite: “la situazione è chiara
come l’acqua della fontana. Bisogna subornare – non abbiamo paura delle parole- l’Italia in un
modo o l’altro, altrimenti l’Abissinia sarà distrutta”. La cosa in se potrebbe avere un’importanza
molto relativa se non significasse che la Società, in questo caso, andrebbe distrutta anch’essa (e
che l’Italia compierebbe simultaneamente un nuovo voltafaccia per gettarsi nelle braccia della
Germania, movimento che dipende sia dall’alta politica che dall’alto imbroglio – che possiamo
154
difficilmente permetterci di questi tempi). Prevede dunque “un orribile autunno” (Adamthwaite,
1977, p.138).
Durante l’autunno in questione, il governo britannico affronta un’elezione. Su 31.379.050
elettori , 21.997.254 votano in occasione di questo scrutinio generale di novembre.
Precedentemente, sempre nello stesso anno, l’Unione della Società delle Nazioni, che vede
diminuire il numero dei membri (da 407.000 nel 1931, a 377.824 nel 1935) organizza uno dei
primissimi sondaggi dell’opinione pubblica, attraverso il quale cerca di determinare come la
Società è percepita dai britannici. Quasi 11 milioni di persone, più della metà di quelle che
voteranno poco dopo in quell’anno, rispondono ad una serie di quesiti incentrati sulle difficoltà
di impiego nell’industria bellica e che finiscono col chiedere al pubblico britannico se sia
disposto a lottare per salvaguardare la pace. Alla prima domanda, che chiede se la Gran
Bretagna debba rimanere membro della Società, 10.642.560 britannici rispondono di si, 337.964
di no, il che equivale senza sorpresa al 97% di parere favorevole. Le 3 domande seguenti
riguardano la fondatezza del disarmo globale e del divieto di vendere armi su scala
internazionale. La quinta, in due parti, riguarda prima il modo in cui un aggressore debba essere
costretto a desistere con mezzi economici e non militari, al che 9.627.606 (ossia il 94.10%)
persone interrogate rispondono di si, contro 60.167 che rispondono in modo negativo. La
seconda parte tratta del sostegno che il pubblico porterebbe a sanzioni militari contro un
aggressore, se fosse necessario. 6.507.777 persone si dichiarano pronte ad appoggiare tali
procedimenti, contro 2.262.261 che non li vorrebbero, vuol dire, ciò nonostante, che il 74.2 % di
coloro che hanno risposto sarebbe favorevole alla guerra come ultimo ricorso. Nessuno dei
partiti politici presenti all’elezione può ignorare questa convalida pubblica della Società
quand’anche i suoi dirigenti esprimerebbero dubbi a proposito della nozione di sicurezza
collettiva.
La Gran Bretagna appoggia dunque l’idea di sanzioni contro l’Italia, ma si dissocia da due delle
quali si può pensare sarebbero le più efficaci (oppure, ed è più imbarazzante, che avrebbero
spinto Mussolini a comportarsi da “cane impazzito”, secondo l’espressione dei dirigenti
britannici, lanciando ad esempio un attacco sorpresa sulla Royal Navy in Mediterraneo) -cioè un
embargo sulle consegne di petrolio ed un divieto di imboccare il canale di Suez.
Sarebbe bastato perché il governo conservasse la sua credibilità agli occhi dell’elettorato e
perché il governo nazionale di coalizione, dominato dai conservatori, sia tranquillamente
rieletto, ma i risultati internazionali si rilevano meno favorevoli. Le sanzioni contro l’Italia non
le impediscono di conquistare l’Abissinia, cosa che la Società riconosce a malincuore nell’estate
del 1936. Questa viene allora vista come fallimentare; diventa progressivamente obsoleta nella
diplomazia internazionale, i piccoli stati provvedono ormai alla propria sicurezza, oppure, come
in Irlanda, scelgono la neutralità e le nazioni più grandi tornano alle loro politiche tradizionali di
alleanze e riarmo. Quando l’Anschluss austriaco controlla l’indipendenza di un membro nel
1938, la Società non ne è nemmeno informata. L’ Italia diventa l’alleata della Germania nazista,
a distanza di mille leghe dal campo di Stresa da cui fu allontanata a causa di una politica che ha
prodotto effetti diametralmente opposti a quelli dati per scontati. La Gran Bretagna non ha
instaurato la sicurezza collettiva ne restaurato l’equilibrio delle forze.
Conclusioni
In realtà, la sicurezza collettiva sarebbe potuta arrivare a buon fine se le grandi potenze – in
particolare la Gran Bretagna e la Francia- fossero state disposte a portare il loro completo
sostegno alla Società, altrimenti era inevitabile che i piccoli stati si sentissero traditi nella loro
fede nel sistema. Per altro, sussisteva la questione di saper chi supporterebbe il peso dell’azione
della Società. Come Sir Samuel Hoare, segretario degli affari esteri britannici, dice
all’assemblea delle Società l’11 settembre 1935: “…. La mia nazione è risolutamente favorevole
… all’applicazione collettiva del Patto nel suo insieme, e particolarmente ad una resistenza
ferma e collettiva di fronte ad ogni atto di aggressione unilaterale” – ma è significativo che
questa osservazione sia stata preceduta da una messa a punto secondo la quale “ una cosa è
155
certa. Se ciò rappresenta un peso questo deve essere portato collettivamente. Se la pace deve
essere minacciata, deve esserlo per tutti. La sicurezza di tutti non può essere assicurata dagli
sforzi di alcuni, fossero i più potenti” (Hoare, 1954, p. 170). Un cinico direbbe che i più piccoli
stati traggono beneficio sia dal successo della Società che dal fatto che costi loro poco.
All’occasione di un conflitto tra la Colombia ed il Perù, nel 1932/33, il delegato irlandese presso
la Società, Sean Lester, propone di imporre al Perù un embargo sulle armi. A Dublino, Sean
Murphy (segretario assistente al ministero degli Affari Esteri) ricorda a Lester che l’Irlanda non
è né un fabbricante né un esportatore di armi. “Il ministero desidera evitare una situazione in cui
lo stato irlandese libero prenderebbe una parte troppo grande nell’accettare un obbligo la cui
responsabilità non li spetta ma rileva di altri stati” (Kennedy, 1996, p. 179).
La lezione abissiniana è dolorosa. Il 30 giugno 1936, l’imperatore Haile Selassie si rivolge
all’assemblea delle Società in questi termini: “ Chiedo alle grandi potenze, che hanno promesso
la sicurezza collettiva ai piccoli stati – questi piccoli stati sui quali incombe la minaccia di
subire un giorno la sorte dell’Etiopia: quali misure avete l’intenzione di prendere?
Rappresentanti del mondo, sono venuto a Ginevra per adempiere davanti a voi al dovere più
doloroso di un capo di stato. Quale risposta devo portare al mio popolo?” (Kennedy, 1996, p.
220). Per gli addetti della realpolitik, la risposta va da se, come lo dichiara Henry Pownall,
allora membro della segreteria del Comitato britannico di difesa imperiale: “Basta sicurezza
collettiva, “forze morali” e tutto questo genere di cose… Non è buono pensare che gli articoli 10
e 16 del Patto possono perdurare. La gente che conta sopra per la propria sicurezza se ne
morderà le dita, come l’Abissinia ne ha fatta l’amara esperienza. Le nazioni le più modeste ne
sono perfettamente coscienti e lo dicono con collera tramite “loro giornali”…. Di conseguenza
… sappiamo adesso a che punto siamo. L’esperienza è stata tentata, ed è fallita. Per fortuna è
stata tentata su piccola scala, anche se l’Abissinia non è probabilmente di questo parere” (citato
secondo Dumbabin, 1993, p. 441).
La grande esperienza di Robert Cecil si conclude dunque come un fallimento. Riposava infatti
su troppi paradossi: il tentativo di stabilire una sicurezza collettiva in un mondo composto da
stati sovrani, la speranza di una democrazia internazionale in un mondo dominato da grandi
potenze; la volontà di fermare un potenziale aggressivo e di mantenere la pace brandendo la
minaccia della guerra in ultimo ricorso; una garanzia di integrità territoriale combinata con un
organo di riaggiustamento territoriale; in breve, una base rivoluzionaria per assicurare la
stabilità internazionale futura. Tuttavia, questa esperienza costituisce un precedente sul quale
sarà edificata, nel 1945, l’Organizzazione delle Nazioni Unite, che conoscerà le proprie
difficoltà nell’applicare il concetto di sicurezza collettiva.
Infatti, nel caso dell’ONU, forse bisognerebbe scrivere “collettiva” con la K, visto che solo la
Corea (Korea in inglese) ed il Koweit sono stati il teatro di operazioni riuscite. La Società
rappresentava, alla fine della prima guerra mondiale, uno degli aspetti più nobili del
ristabilimento della pace. A questo titolo, l’esperienza di Jean Monnet come assistente del primo
segretario generale, Sir Eric Drummond, conta senza dubbio per molto nel suo pensiero futuro,
particolarmente quando suggerì che la cooperazione europea dopo la seconda guerra mondiale si
ispira alle caratteristiche internazionali della Società, ma includendovi competenze
sovranazionali. Monnet credeva fermamente nel potere delle istituzioni, citando spesso Henri
Frédéric Amiel, memorialista di Ginevra del XIX secolo: “Ogni uomo viene al mondo senza
memoria. Solo le istituzioni guadagnano in maturità: sono le custode della saggezza collettiva
che gli uomini, sottomessi alle stesse leggi, assimilano progressivamente – non è la loro natura
che cambia, ma il loro comportamento” (Duschene, 1994, p. 401).
Possiamo considerare che la Società non è stata un completo fallimento, visto che ha fatto
progredire l’idea di un diritto internazionale, e che ha contribuito alla creazione delle istituzioni
mondiali che conosciamo oggi; ciò non toglie che tra le due guerre mondiali, non è mai riuscita
a sostituirsi alla nozione di equilibrio delle forze nella mente della maggior parte dei principali
uomini di stato. D’altronde ci rincresce constatare che i loro tentativi, sinceri o cinici, di porsi a
156
difensori della sicurezza collettiva non sono serviti né all’unità, né alla sicurezza, rovinando allo
stesso tempo la politica che, anche se oggi ha perso ogni credito, aveva allora la loro preferenza.
157
20. Gli Iugoslavi alla conferenza di pace di Parigi e l’eredità della
prima guerra mondiale
TVRTK JAKOVINA
La prima guerra mondiale e la sua eredità presso gli slavi del sud
Uno dei miei giovani colleghi, assistente in storia americana, evocò il tema di un test che aveva
dato ai suoi alunni: fare l’elenco dei 5 più grandi presidenti americani. Con mia grande sorpresa,
Woodrow Wilson, 23° presidente degli Stati Uniti non fu menzionato in nessuna copia. Con sua
grande meraviglia, Wilson sarebbe probabilmente figurato (secondo me) nell’elenco della
maggior parte degli studenti europei. Che fosse stato ingenuo o idealista, oppure un messia ed
un uomo di stato in anticipo sul suo tempo, Wilson posò almeno 3 pietre angolari della politica
del mondo moderno: gli Stati nazionali, la democrazia e la sicurezza collettiva (vedi ad es.
Sheffield, 2002, p.278; Best ed altri, 2003, pp. 39/41). La fine della prima guerra mondiale
segna incontestabilmente l’inizio di un’era nuova. Anche se furono lungi dall’essere perfette, e
benché alcune elite nazionali abbiano considerato in seguito che la loro “età d’oro” si collocasse
nel XIX secolo invece del seguente ( è il caso, ad esempio, dei Croati), le conseguenze della
prima guerra mondiale, positive e durature, rappresentarono una vittoria.
La prima guerra mondiale modificò radicalmente la situazione degli slavi del sud e la geografia
politica dell’Europa del sud-est. Tre dei 14 punti esposti da Woodrow Wilson nel gennaio 1918
riguardano direttamente questa regione. Benché tutti gli iugoslavi siano stati finalmente riuniti
nello stesso stato, il regno dei Serbi, croati e sloveni, e abbiano da quel momento condiviso le
conseguenze, l’eredità della prima guerra mondiale non fu allora, e non è la stessa a tutt’oggi,
per l’insieme degli ex Iugoslavi. Dall’indomani della guerra, rappresentava molto più per i serbi
che per il resto della popolazione. Tutto l’insieme di villaggi che ricevettero il nome dal
reggente Alessandro Karadjordjevic fu fondato nella parte orientale della Croazia (Slovenia), in
Vojvodine (oggi nel nord della Serbia) e in Macedonia (che era allora chiamata Serbia del sud),
dove alcuni appezzamenti furono concessi ai veterani serbi. Altre misure, invece, furono lontano
dall’essere popolari. Il territorio del regno dei serbi, croati e sloveni che una volta faceva parte
dell’Austria Ungheria era più esteso, più popolato e più ricco di quello della Serbia ( Macedonia
e Montenegro compreso). Cosi la popolazione del primo fu scontenta della decisione di
cambiare le vecchie corone austro ungheresi al tasso di 4 corone per 1 dinar (vedi Tudjman,
1993, pp. 298/302; Pirjavec, 1995, p. 20).
Al termine della prima guerra mondiale, gli slavi del sud in passato separati, furono finalmente
riuniti in un solo stato e sotto l’autorità della stessa dinastia, quella dei Karadjordjevic. Ciò
spiega il fatto che l’eredità della guerra sia stata commemorata. Benché “l’dea iugoslava” fosse
in origine croata, i serbi e i numerosi altri slavi vi aderirono. La fondazione del nuovo stato può
essere accreditata sia agli ambienti militari e politici della Serbia, che ai responsabilità politici
sloveni, croati, e serbi dell’impero austro ungherese.
Dopo la seconda guerra mondiale, la posizione ufficiale della Iugoslavia socialista di Tito fu
identica a quella adottata dalla sinistra, cioè con gli intellettuali comunisti, nel periodo compreso
tra le due guerre mondiali. La creazione dello stato Iugoslavo e l’unificazione degli slavi del sud
costituivano una realizzazione positiva. Tutto il resto era beninteso, negativo: il sistema
capitalista, la monarchia, la dittatura, l’assenza di regolamento della questione nazionale. A
causa di questa situazione e di una storiografia sempre molto ansiosa per la “distanza storica”, le
opere consacrate alla prima guerra mondiale furono abbastanza numerose, soprattutto in certi
poli iugoslavi. I macedoni furono generalmente delusi dalle conseguenze della prima guerra
mondiale. I bulgari avevano tentato durante il conflitto di sradicare ogni traccia di influenza
serba; all’indomani della guerra, i serbi fecero lo stesso, in senso contrario.
158
Retrospettivamente, e benché non fossero stati riconosciuti all’inizio, i macedoni furono felici
della creazione della Iugoslavia. Durante la seconda guerra mondiale e nella Iugoslavia di Tito,
alcune prerogative di stato furono loro concesse. Cosi la loro lettura del trattato di Versailles fu
conforma alla dottrina ufficiale dell’epoca socialista. Gli albanesi del Kosovo non si adattarono
mai veramente alla sovranità serba né all’instabilità accompagnata dalla repressione che
precedette e segui le operazioni militari. Malgrado lo scoppio della guerra in seguito
all’assassinio dell’Arciduca Francesco Ferdinando a Sarajevo, il teatro delle ostilità fu
relativamente lontano dal territorio della Bosnia Erzegovina. La sua popolazione musulmana e
croata colse molto male l’assassinio dell’arciduca commesso da Gavrilo Princip, membro
dell’organizzazione “Giovane Bosnia”, con l’appoggio di una società segreta composta da
ufficiali dell’esercito serbo, la “Mano Nera”. Dopo la prima guerra mondiale, il ponte che
scavalca la Miljacka a Sarajevo fu chiamato però con il nome di Gavrilo Princip. Quest’ultimo
era principalmente decritto nei manuali scolastici iugoslavi come un patriota nato nelle classi
oppresse, un giovane che compì un atto patriottico certo disperato, ma comprensibile. Questo
stesso ponte ha ritrovato oggi il nome di “ Latinska cuprica” che portava prima della grande
guerra. Il monumento eretto alla memoria della coppia assassinata della famiglia imperiale fu
demolito poco tempo dopo la guerra e non fu mai ricostruito. L’impronta dei passi di Princip fu
rappresentata sul suolo nel luogo stesso dove si trovava al momento dell’assassinio e divenne
una delle curiosità turistiche della città.
I croati combatterono su più fronti. All’inizio delle ostilità, si trovavano esclusivamente nelle
file dell’esercito austro-ungherese, sui campi di battaglia della Serbia, della Galicia, e più tardi
dell’Italia. Per altro furono a migliaia a prendere parte, in qualità di arruolati volontari, ai
combattimenti del fronte detto di Salonica, nell’autunno 1918. Questi, come il futuro cardinale
croato Aloysiye Stepinac oppure il futuro bano di Croazia ed ultimo primo ministro reale Ivan
Subasic, furono sistematicamente considerati maggiormente come partigiani della monarchia e
della Iugoslavia, almeno per il momento. Ma senza l’autore croato Miroslav Krleza ed i suoi
romanzi, poi i film e i telefilm adattati dalle sue opere, il ricordo della prima guerra mondiale in
Croazia sarebbe difficilmente sopravvissuto al quotidiano. In effetti, rari sono i monumenti ai
caduti innalzati in onore dei soldati morti sul campo di battaglia. La storiografia croata non ha
mai prestato molta attenzione a questo periodo: si fermava all’assassinio di Sarajevo oppure
incominciava alla creazione del nuovo regno. Le opere consacrate ai vari episodi della vita
politica durante la guerra, all’azione del comitato iugoslavo o dei partiti politici del Sabor
(parlamento) croato alla stessa epoca, rappresentavano generalmente gli sforzi ostentati per la
creazione dello stato iugoslavo. Con la fine della guerra fredda e lo scoppio della Federazione
iugoslava, il discorso pubblico croato associò sistematicamente alla Iugoslavia i termini di
Grande Serbia o di comunista. La terza espressione la più corrente scherniva “la Iugoslavia,
prodotto di Versailles” (e della sua conferenza). Materializzava il sentimento di una gigantesca
cospirazione diretta contro i croati ed il loro diritto all’indipendenza. Siccome l’obiettivo era,
nel corso degli anni ‘90, di uscire dalla Iugoslavia, ogni elemento in relazione con questo stato e
soprattutto la sua creazione stessa aveva una connotazione negativa.
Gli sloveni si sentirono molto meno frustrati con l’annessione del loro paese alla Iugoslavia.
Ben più realisti dei croati, capirono che le loro possibilità di vedere regolata la situazione del
1918 in un senso più favorevole alla loro “causa nazionale” erano inesistenti. Gli italiani, usciti
vincitori dalla guerra e che erano finalmente riusciti ad oltrepassare la Soca (Isonzo), annettero
enormi parti di territorio nazionale sloveno (e croato) che erano stati loro attribuiti dal trattato
segreto di Londra. Unità dell’esercito sebo contribuirono ad impedire all’esercito italiano di
impadronirsi nuovamente di Ljubljana (Krizman, 1989, p. 338). Gli sloveni, la cui popolazione
istruita era la più avanzata dell’insieme degli slavi del sud, riuscirono a rinforzare la loro
posizione prima all’epoca del regno, poi nella Iugoslavia di Tito. Le regioni lasciate all’Italia nel
1919 furono parzialmente recuperate nel 1945. L’ovest della Slovenia è piena di monumenti e di
cimiteri sistemati a ricordo della prima guerra mondiale; presenta anche il magnifico museo di
Kobarid, al quale il consiglio di Europa ha concesso pochi anni fa il premio del miglior museo
dell’anno. Come per i croati, la fine della prima guerra mondiale segna per gli sloveni la fine di
un’unione di stato secolare con la dinastia degli Asburgi.
159
Il Montenegro assume una posizione particolare. Questo paese schierato dalla parte degli alleati,
ma sotto occupazione, fu esplicitamente menzionato nei 14 punti del presidente Wilson; il suo
monarca, di memorabile longevità, nonno del reggente serbo e futuro re di Iugoslavia, fu
destituito dal suo trono mentre il paese era privo della sua sovranità. I montenegrini, di
confessione ortodossa, furono favorevoli ad uno stato unito. Tutti non approvarono però i
metodi adoperati per giungere all’unificazione della Serbia e del Montenegro. I “Verdi” fedeli
alla dinastia montenegrina dei Petrovic, si opponevano ai “Bianchi”; questi, soprannominati cosi
a causa del colore dei volantini che diffondevano le loro idee, convocarono le elezioni della
Grande Assemblea nazionale del Montenegro, la quale depose Nicolas primo e proclamò
l’unione con la Serbia. Ogni ulteriore tentativo di modificare la situazione come la rivolta di
Natale 1919, si rilevò vano( Tudjman, 1993, pp. 250/273). La storia gloriosa di questo
principato a lungo indipendente, povero, ma che era riuscito ad intrecciare una rete notevole di
relazioni diplomatiche, fu una fonte permanente di ispirazione per numerosi montenegrini,
anche per coloro che avevano l’identità nazionale in parte serba. Quelli che si sentivano
maggiormente o esclusivamente montenegrini esaltavano la loro dinastia, la loro opposizione
agli ottomani e la loro indipendenza. Oggi, quando il Montenegro si incammina verso un
referendum che potrebbe ristabilire la sovranità piena ed integra di Podgorica, l’unificazione
senza condizione con la Serbia del 1918 viene sempre più spesso considerata come un errore.
Per i serbi, la prima guerra mondiale rappresentò un avvenimento storico tanto importante
quanto glorioso. Rare furono le nazioni confrontate a tante prove in un lasso di tempo cosi
breve: due guerre balcaniche, poi una guerra mondiale in meno di tre anni. I serbi riuscirono a
vincere più battaglie contro le forze austro ungheresi nel 1914, prima di essere vinti;
procedettero allora al ripiego del governo e dell’esercito più a sud, mantenendosi come forza
politica rispettosa e promessa ad un brillante avvenire. All’indomani della guerra, dovettero
scegliere tra l’annessione di regioni che consideravano come indubbiamente serbe (la Grande
Serbia) e la soluzione iugoslava, la quale significava la costituzione di uno stato più ampio. Il
regno recentemente creato di serbi, croati e sloveni, era dominato dai serbi ed incarnava, in un
senso l’esito trionfale di un secolo di evoluzione e di accrescimento territoriale della Serbia.
Inebriate dalla vittoria, le elite serbe si comportarono sfortunatamente di più da occupanti e
padroni che da fratelli. I croati soprattutto erano scontenti di aver perso le istituzioni e
l’autonomia di cui avevano goduto durante i secoli della dominazione asburghese. Nella
seconda metà degli anni ’80, un numero crescente di storici serbi cominciarono a contestare
pubblicamente la soluzione ritenuta nel 1918. Secondo loro, la scelta di uno stato più ridotto
sarebbe stata chiaramente più proficua agli interressi nazionali serbi. Questa identità avrebbe
inglobato i due terzi della Croazia, e la totalità della Bosnia-Erzegovina, il Montenegro e la
Macedonia.
Quando scoppiò la guerra nel 1914, il futuro presidente e dirigente iugoslavo Josip Broz Tito
era caporale dell’esercito austro ungherese. I primi combattimenti dati sul fronte della Serbia, ai
quali prese parte e dove combattè coraggiosamente in compagnia di migliaia di cittadini
provenienti da questa parte dell’impero austro ungherese, di cui i serbi, furono alla fine
cancellati dalla sua biografia ufficiale. Molto tempo dopo, mentre viaggiava in questa parte
della Serbia, egli evocò i luoghi dove la sua unità aveva combattuto. Alaxander Rankovic,
l’uomo forte della Serbia durante i primi tempi della Iugoslavia di Tito, gli raccomandò di
mantenere il riserbo su questo argomento (Ridley, 2000, p. 71). Durante la guerra che oppose
Otan e Serbia nel 1999, il monumento eretto in onore della Francia, in ricordo del sostegno che
essa le aveva portato durante la prima guerra mondiale, fu nascosto a causa della sua
partecipazione agli attacchi lanciati dall’Otan. Durante il processo dell’ex presidente serbo,
Slobodan Milosevic, uno degli “amici della corte” ricordò le imprese di Tito sul fronte serbo nel
1914. Fu interrotto dal giudice, che chiese che non si tenesse nessun conto delle sue
osservazioni, perché estranee alla causa. Questo incidente è tuttavia estremamente rilevatore. La
storia del sud-est europeo rimane molto presente e molto sfruttata (in modo indiretto) nel
dibattito politico.
160
La prima guerra mondiale
Gli slavi del sud comprendono i popoli separati dal resto del gruppo slavo, dagli ungheresi e dai
Rumeni. Soli i Bulgari, Serbi e montenegrini, avevano ottenuto l’indipendenza prima dello
scoppio della prima guerra mondiale. Gli abitanti della Macedonia rimasero sotto il dominio
ottomano fino al 1912, al momento della divisione storica della Macedonia tra Grecia, Bulgaria
e Serbia. La Bosnia-Erzegovina appartenne all’impero ottomano fino al 1878, ma divenne
ufficialmente austro-ungherese solo nel 1908. Da questa data, tutti i croati e gli sloveni, come i
serbi che vivevano in Vojvodine, Croazia e Bosnia Erzegovina furono sudditi austro ungheresi.
L’Austria /Ungheria si confrontò con il grave problema del malcontento degli slavi, che non si
limitavano a quelli del sud-est europeo. Benché la questione delle nazionalità divenne ogni
giorno più ampia, l’Impero resisteva alla contestazione nazionalista. Tutti gli sloveni, divisi su
più province storiche, come i Croati di Dalmazia e di Istria, facevano parte della metà austriaca
della monarchia. Il resto di questa popolazione era integrata al regno di Ungheria e riuscì a
preservare la sua autonomia e il suo Parlamento (Saber).
I contingenti militari del territorio della Croazia – Slovenia erano annessi alla “ Honved”
ungherese, ma la lingua di comando di ciò che si chiamava la “Domobranstvo” era il croato (dal
1868); gli ufficiali erano croati, le divise portavano i distinti croati e la bandiera stessa era
bordata dai colori nazionali croati (Cutura e Galic, 2004, p. 39/40). Malgrado queste
caratteristiche probabilmente lusinghiere per l’elite nazionale croata, tale organizzazione poneva
un problema di funzionamento pratico (come comandare un esercito i cui soldati parlavano 3
lingue diverse), senza dubbio più preoccupante di nessun altro. Qualunque sia stato il loro grado
di insoddisfazione di fronte alla situazione generale, queste popolazioni slave erano divise,
deboli , in piccolo numero e impoverite. I Serbi possedevano il proprio stato, cosa che
preoccupava Vienna. Belgrado ambiva in effetti a diventare il Piemonte degli slavi del sud.
“La monarchia deve prendere una decisione energetica per dimostrare la sua capacità di
sopravvivenza e porre fine alla situazione intollerabile che prevale nel sud-est”, faceva
osservare il primo ministro ungherese all’occasione dell’assassinio dell’arciduca Francesco
Ferdinando a Sarajevo il 28 giugno 1814 (Best e altri, 2003, p. 266). Poco importa se il primo
ministro serbo Nicolas Pasic sia stato informato o meno dell’attentato (MacMillan, 2003, p.
113). La guerra scoppiò dopo l’ultimato lanciato ai Serbi. Era vano sperare di schiacciare la
Serbia, umiliare la Russia e fare volare in frantumi l’Intesa. La maggior parte dei soldati che
parteciparono all’offensiva lanciata contro al Serbia erano croati e serbi della doppia monarchia.
L’esercito serbo vinse le prime battaglie, ma presto perse Belgrado. Quando la Bulgaria entrò in
guerra al fianco delle potenze centrali, il territorio serbo e montenegrino fu diviso e occupato
dalla stessa Bulgaria e dall’Austria /Ungheria fino agli ultimi giorni del conflitto.
L’Italia rimase neutra solo all’inizio delle ostilità per poi aggiungersi all’Intesa nel maggio
1915. Dopo mesi di negoziato tra le due parti, l’accordo segreto di Londra assicurò agli italiani
l’attribuzione di gigantesche parti di territorio albanese, croato e sloveno, come anche il sud
Tirolo. L’Italia lanciò senza successo 4 offensive sull’Isonzo (Soca) nel 1915, a scopo di
indebolire le posizioni austriache e di tentare una penetrazione fino a Trieste, poi fino a Vienna
e Budapest (Sheffield, 2002, pp. 326-31; Boban, 1991, p. 17). Questo piano prevedeva un
collegamento con le truppe russe sul suolo ungherese, ma le forze italiane erano troppo deboli
per riuscirci. Le interminabili campagne del 1915 proseguirono fino al 1916.
Nel 1917 non ci fu nessuno spostamento importante del fronte. Il comandante capo delle forze
austro ungheresi sul posto era il generale croato Borojevic. Quando la rivoluzione scoppiò in
Russia, gli affari esteri sovietici denunciarono la diplomazia segreta e pubblicarono l’insieme
degli accordi segreti conosciuti dei diplomati zaristi. L’atteggiamento della questura del popolo
agli Affari esteri e del marinaio Markin fu favorevole agli interessi austro/ungheresi. Il servizio
di propaganda di guerra di Vienna fece stampare, sotto forma di volantini, le carte dei territori
attribuiti all’Italia grazie all’accordo di Londra del 1915. I soldati sloveni e croati, in
maggioranza lungo il fronte della Soca, ne furono indignati. La prima vittoria schiacciante
161
riportata dagli italiani con l’aiuto dei britannici e dei francesi fu quella di Vittorio Veneto, svolta
dal 24 ottobre al 4 novembre 1918. Trieste fu finalmente persa. Grazie ai successi militari
ottenuti sul fronte di Salonico a sud-est, la prospettiva di formare uno stato unito apparve agli
slavi del sud per la prima volta nel corso della loro storia. Moltissime opinioni diverse si
contrapponevano a proposito della sua organizzazione, ma ci sarebbe un unico esercito ed una
sola dinastia.
Truppe coloniali francesi entrarono nel 1919 a Zagabria. Un battaglione fu acquartierato nel
centro stesso della città. Si componeva di Vietnamiti, che gli abitanti di Zagabria chiamavano
“cinesi”. Diedero rappresentazioni di opera popolare e spettacoli di danza ai quali partecipò la
popolazione locale (Suvar, 2001, p. 31). Ma questi vietnamiti furono acquartierati
temporaneamente. La prima guerra mondiale segnò un vero tornante storico. Cosi, dopo mille
anni di unione politica con Magyars e mezzo millennio di vita comune con gli Asburgi, i croati
appartenevano ad un nuovo stato di cui non erano più questa volta la componente meno
sviluppata, ma al contrario la più avanzata e la più ricca. La capitale era cambiata lo stesso come
la dinastia e la religione dominante. Il sistema stabilito era meno occidentale ma coloro che ne
avevano l’incarico erano considerati come fratelli e parlavano una lingua simile. Un gran
numero di croati edi sloveni rimasero fuori dalle frontiere del nuovo stato; tutti i serbi, invece,
vivevano ormai sotto la propria autorità. Le elite nazionali serbe, croate e slovene, non
condividevano la stessa concezione dell’organizzazione del nuovo regno. Queste divergenze
furono lampanti durante la guerra.
Al momento dell’apertura delle ostilità, Pietro 1°, considerato spesso come uno dei sovrani più
liberali della storia della Serbia, regnava sulla nazione. Il governo era diretto da Nicolas Pasic,
uno dei più brillanti uomini politici della Serbia moderna. Dal mese di settembre 1914, i
responsabili politici della nazione espressero la loro intenzione di costituire un potente stato, che
radunerebbe integralmente serbi, croati, sloveni. Questo obiettivo che andava al di là di una
semplice liberazione, fu riaffermato all’inizio di dicembre 1914 a Nis, nel sud del regno (Dimic,
2001, p.11).
Nel campo avverso, parte dell’elite politica croata lasciò la nazione e formò il comitato
iugoslavo. La sede di questo organo era stabilita a Londra. Era presieduta dal croato Ante
Trumbic, proveniente da Split, in Dalmazia. Il progetto dei suoi membri mirava alla creazione di
uno stato comune con la Serbia ed il Montenegro. Uno di loro, Frano Supilo, senza dubbio uno
dei migliori politici che la Croazia abbia mai avuto, era favorevole ad uno stato federale e non
centralizzato, posizione che non condividevano assolutamente i suoi omologhi serbi. Deluso
dall’atteggiamento di Pasic e dall’Intesa dopo la divulgazione del trattato di Londra, diede le
dimissioni. I rappresentanti del comitato iugoslavo firmarono finalmente, nel 1917, con i Serbi,
la Dichiarazione di Corfou, il cui spirito era consono alla concezione federalista.
Il futuro stato doveva prendere la forma di una monarchia costituzionale, parlamentare e
democratica. La Costituzione doveva garantire l’esistenza di 3 bandiere, 3 religioni e 2 alfabeti.
Il cambiamento di atteggiamento delle autorità serbe fu di breve durata, per via della rivoluzione
russa e del complicarsi delle relazioni politiche (Goldstein, 1999, pp. 110/11; Boban, 1992, p.
8).
I croati, sloveni e serbi che erano rimasti fedeli agli Asburgi e continuavano a prendere parte
alla vita politica nella metà austriaca della doppia monarchia, adottarono nel 1917 la risoluzione
detta di maggio.
Questa chiedeva la costituzione di un’identità distinta di slavi del sud in seno all’Impero.
Costituivano un cerchio iugoslavo, presieduto dallo sloveno Anton Karosec e facevano appello
alle tradizioni parlamentari e storiche croate (Dimic, 2001, pp. 21/24; Krizman, 1989, p. 342).
In seguito a questa decisione, con l’avvicinarsi della fine dell’Austria/Ungheria, i delegati
sloveni, croati e serbi formarono il consiglio nazionale (Narodno vijece) a Zagabria. Il 29
ottobre 1918 il vijece proclamò l’indipendenza e la creazione dello stato degli sloveni, croati e
162
serbi, con Zagabria come capitale. Non fu però riconosciuto dalla comunità internazionale,
sprovvisto di forza armate, messo in situazioni di conflittualità con la progressione militare
dell’Italia nelle regioni promesse a quest’ultima con il trattato di Londra ed in tante altre zone, il
nuovo stato si trovò in grande difficoltà. Una delegazione condotta dal Dr. Ante Pavelic (un
dentista) partì per Belgrado spianto dai croati di Dalmazia, direttamente minacciati dagli italiani,
e sorda agli appelli di Stjepan Radic e del Dr. Hrvoj che supplicavano i delegati di non andare in
Serbia ( “come oche nella nebbia”). Il discorso di unificazione fu letto al reggente Alexander
Karadjorjdevic il primo dicembre 1918.
Parigi 1919
La conferenza tenuta a Versailles iniziò in gennaio 1919. Le nazioni vinte ancora esistenti non
vi furono invitate. Benché la conferenza di Parigi contò fino a 58 commissioni differenti, le
decisioni del consiglio dei 5 e più ancora del consiglio supremo, composto dai primi ministri dai
presidenti del Regno Unito, della Francia, degli Stati Uniti e dell’Italia, facevano legge
(Kissinger, 1994, p. 232). Tuttavia, questi rappresentanti non condividevano gli stessi valori ne
la stessa concezione sul modo più opportuno di organizzare la pace.
Le trattative di pace di Parigi si svolsero mentre i combattimenti proseguivano. La “Grande
guerra” in effetti non fini alla fine dell’anno 1918. Al contrario, le truppe britanniche, francesi,
americane e giapponesi combattevano contro i rossi in Russia sovietica. I russi stessi erano in
piena guerra civile. Pochi anni più tardi, una volta respinte le forze controrivoluzionarie, uno dei
loro capi, il generale Wrangel, andò a stabilirsi con migliaia di russi nel nuovo regno dei serbi,
croati e sloveni; morì a Belgrado dove fu sepolto. Una guerra russo polacca infuriava nello
stesso momento. Gli ungheresi lottavano ancora su due fronti, nella moderna Slovacchia e in
Romania. Gli irlandesi si sforzavano di ottenere l’indipendenza. Un vento di insurrezione e di
rivoluzione comunista soffiava dappertutto. La popolazione dell’insieme del continente era
totalmente stremata da un conflitto che aveva causato un numero colossale di vittime e
giganteschi danni materiali. In quest’atmosfera si svolsero dei negoziati che, in una certa
misura, volevano dare una risposta alla situazione. La rettifica delle frontiere rappresentò una
delle questioni più cocenti. Alcuni tracciati come quello della frontiera orientale della Polonia,
furono ridisegnati sul campo di battaglia.
Le trattative ormai servirono in parte a legittimare modifiche realizzate con la forza. Offrirono
l’occasione di tenere referendum e plebisciti. Referendum furono cosi organizzati nel
Burgendland (Austria) e in al Schleswig – Holstein ed in Silesia, ma non ci fu nessun plebiscito
nel sud del Tirolo, in Alsazia Lorena, a Dantzig o nel corridoio polacco. Ciò si spiega beninteso
con il fatto che i 4 grandi erano all’altezza di prevedere che i plebisciti organizzati in queste
regioni avrebbero prodotto risultati contrari a ciò che speravano.
Le priorità dei 5 grandi erano diverse. Il Giappone desiderava il riconoscimento internazionale
dell’annessione delle colonie tedesche del Pacifico. La Gran Bretagna si preoccupava del suo
impero. La Francia voleva prendere la rivincita. Gli Stati Uniti erano favorevoli
all’autodeterminazione nazionale ed alla creazione di una Società delle Nazioni. L’Italia
augurava l’applicazione dell’accordo di Londra del 1915. La Grecia tentava, sia
diplomaticamente che militarmente, di restaurare una versione dell’impero bizantino a scapito di
ciò che era ancora l’Impero ottomano. I negoziati di pace di Parigi riconoscevano la
dichiarazione Balfour del 1917 e l’accordo Sykes – Picot.
Tutti questi elementi svolsero un ruolo cruciale nella definizione del territorio della Iugoslavia,
o più esattamente del regno dei serbi, croati e sloveni, la cui nazione aveva acquistato il nome
dal primo dicembre 1918. Il regno degli slavi del sud esisteva già prima dell’inizio della
conferenza di Versailles. L’unico punto che restava da regolare era quello delle frontiere. La
delegazione iugoslava presente al momento della conferenza si componeva di diverse persone.
La maggior parte di loro erano serbi, ma il ministro degli affari esteri era croato di Dolmazia, il
presidente del comitato iugoslavo Ante Trumbic. Benché quest’ultimo avesse firmato l’atto di
163
unificazione in cirillico e che fosse sicuramente proiugoslavo e opposto ad ogni idea di
mantenimento dell’impero Austro/ungherese, il suo discorso nei riguardi dei serbi non era, è il
meno che si possa dire, politicamente corretto.
“Non paragonerete, spero”, lanciò ad un autore francese “i croati, gli sloveni, i dalmati
diventati puri occidentali grazie a secoli di comunione artistica, morale ed intellettuale
con l’Austria, l’Italia e l’Ungheria, con questi serbi mezzo civilizzati, ibridi balcanici
degli slavi e dei turchi”.
“Per i serbi tutto è semplice; per i croati tutto è complicato” dichiarò al contrario un delegato di
origini serba al suo omologato britannico (Macmillan, op. cit., p. 113). Mentre certi membri
della delegazione erano molto più ansiosi di garantire le frontiere meridionali dello stato e di
orientare quest’ultimo in direzione della penisola balcanica, altri si preoccupavano della sorte
degli slavi rimasti sul territorio dell’Italia, dell’Austria o dell’Ungheria (Boban, op.cit.,pp.
17/19).
Alla fine della conferenza di pace di Parigi, la Bulgaria cedette alla Serbia più parti del suo
territorio nazionale situati presso Strumica, Caribrod e Basilegrad, anche la regione all’est di
Titmok. Il trattato di pace di Neuilly fu firmato con la Bulgaria il 27 novembre 1919. Il regno
dei serbi, croati e sloveni vi appose la propria firma il 5 dicembre. La Romania si vede promessa
la totalità del Banat. Velidaka Kikinda, Veliki Beckerek (Zrenjanin), Vrsac e Bela Crkva furono
finalmente ceduti alla Serbia. L’accordo definitivo fu firmato nel 1924. L’Ungheria perse
Medimurje, Prekomurje, Prekodravlje (Gola, Zdala i Repes) e Baranja, regioni popolate
esclusivamente da sloveni e croati, in virtù del trattato di Trianon del 4 giugno 1920. Benché le
rivendicazioni iugoslave riguardassero anche Klagenfurt, Villach e Volkermarkt, soltanto
Maribor e Radgona furono finalmente attribuite alla Iugoslavia. La divisione la più dolorosa fu
quella effettuata tra il regno dei serbi, croati e sloveni e l’Italia. Il trattato di Rapallo fu firmato
sul finire dell’anno 1920. Tutta la zona situata all’ovest di Snjeznik ed Idria in Slovenia, la
totalità dell’Istria, le isole di Cres, Losinj, Lastovo e Palagruza, cosi come la città di Zadar,
antica capitale della Dalmazia, divennero italiane. La città di Rijeka (Fiume) non era stata
promessa agli italiani con il trattato di Londra; Gabriele D’Annunzio, pittoresco avventuriero e
grande poeta italiano, occupò la città con l’aiuto di un esercito privato irregolare nel 1919.
Rijeka ottenne lo statuto di città libera separata, ma fu annessa all’Italia in un secondo
monumento (Boban, op.cit., pp. 17/19).
Conclusioni
La prima guerra mondiale fu l’evento chiave del XX secolo, all’origine di tutto ciò che segui,
come sostiene Gary Sheffield (Sheffield, 2001, pp. 264/674)? Alcuni esperti di primo piano
vanno fino ad affermare che essa fu un conflitto tragico ed inutile, altri la giudicano tragica ma
non inutile perché servì a lottare contro l’autocrazia militarista ed aggressiva. Tutte le nazioni
non divennero democrazie, la sicurezza collettiva di cui doveva farsi garante la Società delle
Nazioni appena creata si rilevò illusoria ed i nuovi “stati nazionali” erano lungi dal
corrispondere alla loro dominazione (la Cecoslovacchia raggruppava 10 milioni di cechi e di
slovacchi, 3 milioni di tedeschi, 700.000 ungheresi, 500.000 ucraini e 60.000 polacchi). I
negoziati di pace di Parigi oppure il trattato di Versailles non furono la causa diretta della
seconda guerra mondiale, ma le loro imperfezioni erano tali da contribuire sicuramente allo
scoppio di questo nuovo conflitto. Gli accordi di pace conclusi a Parigi nel 1919 non posero fine
a tutte le guerre. Ma la democrazie liberale non avrebbe trionfato senza la vittoria ottenuta
all’occasione della prima guerra mondiale.
Il regno dei serbi, croati e sloveni, rappresentava la migliore soluzione possibile per ognuno.
Qualunque altra decisione sarebbe stata meno favorevole agli sloveni e soprattutto ai croati.
L’unione con i serbi preservò enormi parti del territorio nazionale, che altrimenti sarebbero
diventate italiane (Antic, 2004, pp.15/21). Le speranze dei croati, di occupare, in seno al nuovo
164
stato, una posizione praticamente dominante almeno sul campo economico grazie al loro
progresso si rivelarono vane. I serbi, malgrado la ristretta maggioranza di cui beneficiavano,
pretendevano dominare tutto, cosa che avrebbe allora implicato un ricorso alla forza. La fine
della prima guerra mondiale ed il movimento rivoluzionario che vinse la lotta in Russia e scosse
brevemente tante città europee, marcarono l’inizio della guerra fredda? Se, per guerra fredda si
intende anzitutto una lotta di idee, fu effettivamente il caso. I nuovi dirigenti del regno dei serbi,
croati e sloveni, stabilirono una rete di “campi di internamento” in diverse regioni del nuovo
stato. Le persone internate non erano tutte potenziali bolscevichi o ex prigionieri di guerra
catturati dai russi; in mezzo a loro si trovavano anche lealisti fedeli agli Asburgi, membri delle
minoranze nazionaliste, ecc (Miloradovic, 2004, pp. 267/274). 80.000 detenuti in totale
soggiornarono in quei campi, di cui 57.000 fatti prigionieri in Russia. Sul piano politico, questa
iniziativa si rivelò estremamente impopolare. Questo errore, al quale si aggiunsero tanti altri,
rappresentò l’inizio di un processo di cui la Iugoslavia non si riprese mai (MacMillan, op.vìcit.,
p.117).
(Referenze e bibliografie p.189/190)
165
21. La “Grande Guerra” ed il trattato di Neuilly – sur – SeineRetaggio reale ed immaginario nel dibattito pubblico in Bulgaria
IVAN ILCHEV
Nel XX secolo nel giro di 35 anni, precisamente dal 1912 al 1947, circa la metà di una vita
umana, i Bulgari hanno fatto 4 guerre di cui ne hanno perso 3. Mi sembra un record ineguagliato
e saremmo tentati di dire che nessun altro stato europeo ce lo invidii. Di fatti, con un po’ di
fortuna, ammesso che convenga la parola, un coscritto dell’età di 18 anni nel 1912 avrà potuto
partecipare ad ognuno di questi conflitti.
Era inevitabile che queste guerre, e soprattutto le sconfitte ed i trattati di pace che seguirono,
lascino nella coscienza nazionale profonde cicatrici, che furono visibilissime e lo sono ancora,
almeno in una certa misura.
L’unico conflitto di cui la nazione sia uscita vittoriosa, fu quello della prima guerra balcanica
del 1912/1913, che si concluse con il trattato di pace di Londra nel maggio 1913. Ragion per cui
si erge nella memoria nazionale come il trionfo dell’azione collettiva dei bulgari. Ma non
ebbero né il tempo né l’occasione di raccogliere i frutti dei loro sforzi. La disastrosa seconda
guerra balcanica gli subentrò in effetti durante al torrida estate 1913. La sconfitta subita sui
campi di battaglia fu suggellata dal trattato di pace di Bucarest.
La prima guerra mondiale scoppiò due anni più tardi. La Bulgaria guadagnò in quell’occasione
il triste merito di essere l’unico stato al mondo ad avere ceduto alle “sirene” delle potenze
centrali dopo l’autunno 1914 ( preceduta in questo solo dall’Impero ottomano), mentre più di 20
nazioni sceglievano il campo dell’Intesa.
I sogni di rivincita e di gloria non tardarono a trasformarsi in triste sedute tenute al fronte ad
epidocchiarsi, o peggio, ad ammucchiare cadaveri mutilati buttati senza altre cerimonie sul
terreno roccioso della Macedonia. L’armistizio firmato a Salonico a settembre 1918, poi il
trattato di pace di Neuilly del 27 novembre 1919 significarono il crollo completo della Bulgaria.
Un piccolo stato
L’equilibrio delle potenze che prevaleva prima della guerra nella penisola balcanica si era
spezzato. All’inizio del secolo, la Bulgaria rappresentava il principale stato cristiano a sud del
Danubio. Era largamente considerata come il paese dei balcani la cui progressione era la più
rapida, con un economia in piena espansione, infrastrutture che migliorano a grande passo ed un
ordine giuridico progressista, sfoggiando una legislazione sociale moderna. Il suo esercito era
rimasto come il più disciplinato, il meglio attrezzato e probabilmente il più motivato della
penisola. In un rapporto rivolto nel 1911 ai suoi superiori, l’addetto militare francese di Sofia
affermava che un battaglione di fanteria bulgara valeva 3 battaglioni rumeni. Nell’autunno del
1912, in un articolo acceso consacrato alla storia recente del sud-est europeo, l’ex presidente
americano Teodoro Rooselvet, definì la Bulgaria il “Giappone dei balcani”, non tanto per le sue
prodezze militari che per il suo sviluppo economico sociale.
Dopo il 1919, la Bulgaria divenne il più piccolo stato dei balcani (all’eccezione dell’Albania); la
superficie del suo territorio rappresentò meno della metà della Iugoslavia o della Romania, essa
sprofondò durante circa 15 anni in un ristagno economico, mentre la sua vita politica era scossa
da numerose crisi e soccombeva alla violenza. I vincitori sorvegliavano con auspicio la minima
sua iniziativa in campo diplomatico o militare. Non vedevano nella Bulgaria che un eventuale
fonte di conflitto. Durante circa 20 anni, fu tenuta in disparte dalla scena internazionale. I suoi
vicini la umiliarono pubblicamente in più occasioni. Sofia non aveva scelta. Doveva presentare
delle scuse ed inchinarsi stringendo i denti.
166
Contrariamente e quanto era successo all’occasione dei conflitti precedenti, la partecipazione
della nazione alla seconda guerra mondiale non fu volontaria. Il re di Bulgaria Boris III tentò
fino all’ultimo momento di restare fuori dalla lotta che cominciava ad opporre le grandi potenze.
Ma questa posizione si rivelò impossibile a tenere. La Germania aveva bisogno della Bulgaria
per mantenere l’insieme della penisola sotto il suo dominio. Contava di utilizzare il suo
territorio come pedana per l’offensiva che prevedeva di lanciare contro la Iugoslavia e la Grecia.
Dal canto loro, le nazioni dette democratiche, la Gran Bretagna, la Francia e gli Stati Uniti, non
alzarono un dito per venire in aiuto ai bulgari nella difficile situazione in cui si trovavano. Sofia
era considerata come preda legittima per la Germania, parte indiscussa della sua sfera di
influenza politica ed economica.
Il paese beneficiava di alcune consolazioni. Grazie ad accorte manovre, Boris riuscì almeno ad
evitare l’impegno diretto del suo regno nella guerra. Questa tattica si rivelò tuttavia
insufficiente. Al termine del conflitto la Bulgaria si ritrovò ancora una volta nel campo dei vinti
e firmò il 10 febbraio 1947 il trattato di pace di Parigi al fianco dell’Italia, della Romania e degli
altri alleati della Germania. Quando si pensa a questo percorso, colpisce il fatto che
apparentemente il paese non abbia conosciuto una sorte cosi disastrosa come ci si sarebbe
aspettato. Al momento del suo impegno nella prima guerra balcanica, nell’autunno 1912, il suo
territorio si estendeva su 96.000 Kmq. Nel 1947, dopo tre disfatte consecutive, presentava una
superficie di 111.000 Kmq, cioè 15.000 in più rispetto a quanti ne contava 35 anni prima.
Le sue perdite in vite umane registrate ad ognuno dei conflitti armati della prima metà del
secolo furono in genere ben inferiori a quelle dei suoi vicini. Un altro elemento merita di essere
sottolineato. Durante queste 4 guerre, l’esercito bulgaro combattè fuori dalle frontiere della
Bulgaria propriamente detta. All’infuori dei bombardamenti del 1943/1944 essa fu risparmiata
dalle distruzioni e devastazioni che, in varie epoche, lasciarono praticamente in rovina la Serbia,
la Grecia, la Romania e la Turchia. Perché, in questo caso, i bulgari deplorano un esito che più
di un paese avrebbero persino definito un successo?
Questo genere di argomentazioni positiva aveva all’epoca poca fortuna, e poco più oggi, di
trovare un eco favorevole in Bulgaria. La maggior parte di bulgari rigettavano sulle sconfitte
militari ed i trattati di pace la principale responsabilità del ritardo e della debolezza del loro
paese. Il trattato di Neuilly – sur – Seine, che si inscrive nel quadro dei trattati di pace di Parigi
del 1919/1920, fu considerato come l’autore di tutti i suoi mali. Nella mente della popolazione
fu innalzato al rango di simbolo della condizione della Bulgaria, un “cliche”che permetteva di
spiegare tutti i problemi con i quali era confrontata in modo ricorrente a causa della natura
vendicativa dei suoi vicini e della bassezza delle grandi potenze che davano loro manforte.
Perché il buon andamento dell’economia non si trovava “all’appuntamento”? A causa del
trattato. Perché i politici erano corrotti ed indegni di fiducia? A causa del trattato. Perché il tasso
di divorzi saliva vertiginosamente? A causa del trattato. Perché il senso morale era scomparso?
A causa del trattato.
Come ognuno sa, i “cliche” in genere hanno un ruolo capitale sia in politica interna che nelle
relazioni internazionali. Secondo il padre della teoria moderna dei “cliches”, Walter Lippman, il
loro interesse principale sta nella loro funzione di classificazione del reale. Ma questo interesse
diventa spesso il loro principale inconveniente. Ciò si produce quando il “cliche” non è più
conforme alla norma oppure quando classifica le cose o i fenomeni in funzione di caratteristiche
secondarie, non essenziali. Lippman stesso precisa “che non è indispensabile che il cliche sia
menzognero”. Questa spiegazione suona come una scusa. Di fatti, un buon numero di eruditi
giudicano i cliche falsi di natura e considerano che rappresentano una “informazione
ingannevole, sciocchezze tradizionali, largamente propagate”. Perché no, dopotutto”! Un altro
ricercatore, Vaineke, ha in seguito affermato che era importante crederci. Questa convinzione
difficile da fare crollare, che conferisce al clichè la sua stabilità ne costituisce uno dei segni
distintivi. E’ ciò che provoca ben spesso “l’irrigidimento” delle conoscenze e le trasforma in
dogma, il che permette loro di sussistere a lungo dopo che l’epistemologia abbia dimostrato la
loro assenza di fondamento.
167
Il clichè più tenace della storia bulgara, risalendo all’ultimo quarto del XIX secolo è
rappresentato da ciò che chiameremo la sindrome di Santo Stefano. Secondo costui, la Russia
vittoriosa impose in marzo 1878 all’Impero Ottomano vinto di riconoscere il ben fondato delle
rivendicazioni bulgare. Il trattato preliminario di Santo Stefano fece nascere un vasto principato
bulgaro, dotato di un ampio litorale lungo il mare Egeo, che inglobava la maggior parte delle
popolazioni bulgare entro le sue frontiere.
Il trattato di Santo Stefano partorì una Bulgaria nata morta, che conobbe però una brillante
carriera nell’immaginario popolare e nella retorica politica. Fu esaminata ed analizzata in una
pletora di opere e migliaia di articoli pubblicati nella stampa, le riviste o serie pubblicazioni
erudite. Nessuno osò esprimere neanche l’ombra di un dubbio a proposito del ben fondato di
queste frontiere immaginarie, tracciate fino alla periferia della capitale dell’Impero Ottomano.
La triste e dura realtà fu tuttavia ben diversa: i bulgari dovettero viveri confinati all’interno di
frontiere definite a Berlino dalle grandi potenze durante l’estate del 1878, in quello che erano
soliti chiamare all’epoca la “loro gabbia”. Santo Stefano divenne un potente slogan politico, una
referenza che orientò la politica estera bulgara. Fino al 1912, il clichè di Santo Stefano fu fonte
di discordia tra la scena politica bulgara e l’insieme dei paesi vicini: nessuno di loro in effetti
condivideva il sogno di una grande Bulgaria installata al centro della penisola, che avrebbe
praticamente esercitato un controllo strategico sulle principali vie di comunicazione.
Il clichè della Bulgaria di Santo Stefano volò in frantumi con i conflitti militari. I Bulgari stessi
lo abbandonarono infatti in occasione dell’accordo bulgaro/serbo del 1912, quando
acconsentirono all’esigenza, formulata dalla Serbia, di condividere il pomo della discordia: la
Macedonia.
Fu sostituito nel 1919 dal clichè del trattato di pace di Neuilly. Secondo il parere dei bulgari,
questo trattato era eccessivamente severo e andava contro i nobili principi morali formulati dagli
alleati. La sua stessa stesura impegnò un anno, benché la maggior parte dei belligeranti sin dal
1914 elaborarono le loro rivendicazioni con l’intento di una futura conferenza di pace. Gli
esperti dell’Intesa si limitarono in genere a principi identici. Non contestarono le motivazioni
etniche, strategiche od economiche dell’irredentismo bulgaro. Fu ben diverso per i responsabili
politici.
Gli esperti potevano permettersi il lusso di proporre soluzioni strategiche suscettibili di
sviluppo, che miravano a stabilire, a lungo termine, la pace in seno ai Balcani. Gli ambienti
politici, al contrario, soffrivano di miopia congenitale. Erano incapaci di riflettere ad una
prospettiva più lontana di quella delle prossime elezioni. Il loro seggio parlamentare dipendeva
in effetti dal capriccio dei loro elettori che, in Europa occidentale e nei Balcani, si rilevavano
decisamente antibulgari.
Fine 1918 e inizio 1919, il ministero britannico degli affari esteri era disposto a lasciare alla
Bulgaria l’insieme, o una parte almeno, della zona detta incontestata della Macedonia che era
stata divisa in virtù del trattato bulgaro serbo del 1912, la Tracia orientale fino alla linea MjdiaAenos e la Dobroudja meridionale. “Fare rinunciare la Bulgaria alle sue aspirazioni legittime
destinerebbe al fallimento i sogni di unità dei Balcani” profetizzava un diplomatico britannico di
alto rango.
La commissione detta d’Inchiesta degli Stati Uniti, composta di esperti incaricati di gettare le
basi della pace futura, riconosceva alla Bulgaria dei diritti sulla Tracia orientale, la Dobroudja
meridionale e anche una parte importante del litorale del mare Egeo. Secondo questa stessa
commissione, la Macedonia costituiva senza dubbio una regione bulgara, ma gli avvenimenti
sopravvenuti questi ultimi anni e la “Real politik” rendevano inopportuno indispettire la Serbia.
168
La Francia era del parere di punire severamente i bulgari, “i piccoli bosci”. Nello stesso tempo,
la Serbia esigeva un territorio da 30 a 40 Km di lunghezza lungo il confine tra i due paesi, cosa
che avrebbe spostato quest’ultimo a 20 Km da Sofia. In quanto ai greci insistevano perché
l’interezza della Tracia ed il massiccio del Rhodope fossero loro concessi.
In fin dei conti prevalse il parere bulgaro ma non completamente. In virtù del testo definitivo del
Trattato, la Bulgaria abbandonava nuovamente la Dobroudja meridionale alla Romania. La
popolazione locale vi si spartiva secondo un rapporto di 23 Bulgari per un rumeno.
La Bulgaria perse inoltre più enclavi lungo il confine occidentale con la Serbia. I Serbi gli
avevano reclamati a gran voce per motivi strategici e non etnici, cosa pertanto difficile senza
arrossire dalla vergogna. La regione di Tzaribrod contava in effetti appena 79 Serbi su 21.000
abitanti, mentre 12 serbi vivevano in mezzo a 21.000 bulgari nel settore di Bossilegrad. La
frontiera tagliò in due villaggi,cimiteri ed anche case private.
Ma la principale perdita territoriale della Bulgaria fu quella del suo accesso al mare
Egeo. Nel corso della sua recente storia, il paese era riuscito per tre volte ad ottenere uno sbocco
precario sul litorale Egeo e, per tre volte, l’aveva perso. Questa situazione condannava il paese
ad una quasi chiusura continentale e orientava i suoi interessi economici verso l’Europa
centrale, cioè verso la Germania.
Il paese fu sommerso da rifugiati. Nessuno ne conosce il numero esatto che varia e si
estende secondo le stime tra 150.000 e 400.000. Furono per anni motivi di difficoltà per tutti i
governi bulgari, impotenti a risolvere questo problema. Bisognava nutrirli, dare loro lavoro ed
aiutarli a trovare un posto dove abitare. Il paese negoziò prestiti con stabilimenti finanziari
internazionali, ma non ebbero che una scarsa incidenza sulla situazione critica dei profughi.
Donatori privati tentarono ugualmente di venire in loro aiuto, con successo disuguale.
La Bulgaria si vide proibire di possedere un esercito di coscrizione. Fu in cambio
autorizzata, molto generosamente, a reclutare un esercito professionale di 30.000 uomini, cosa
che le conferiva il privilegio di mantenere il più modesto ma più costoso esercito dei balcani. Le
era proibito di detenere aerei militari, carri armati e pure, per un tocco di umorismo malvagio,
sottomarini.
Come tutti gli altri paesi vinti, la Bulgaria fu sovraccarica di riparazioni.
L’impatto del trattato di Neuilly
Le conseguenze psicologiche del trattato di Neuilly furono durevoli. Accentuò di più lo
scetticismo pragmatico che si inserisce sistematicamente nella psicologia nazionale bulgara. I
valori e gli ideali non hanno più corso! Contano soltanto la forza ed il potere! La legge suprema
è quella delle armi. Come gli altri paesi d’Europa, la Bulgaria vide apparire una generazione
senza ideali e sedotta da una concezione cinica dell’esistenza. I figli non capivano i loro padri e,
per di più, schernivano apertamente il loro attaccamento sbagliato a nobili idee come il
patriottismo, la patria, la giustizia e la morale.
Il trattato di Neuilly rovinò la reputazione dell’elite dirigente tradizionale. Una parte di essa
aveva preso parte attivamente alla scelta disastrosa all’autunno 1915. Quelli che vi erano
contrari non cercarono risolutamente di opporsi alle decisioni di re Ferdinando e del suo
malleabile servitore, il primo ministro Vasil Radoslovov. L’intera elite tentò di fare ricadere la
responsabilità della disfatta sull’esercito, cha aveva abbandonato il fronte in settembre 1918 e
provocato cosi la catastrofe. I soldati al loro volta, alimentarono il mito molto comodo di un
esercito bulgaro che non aveva mai perso una battaglia, quando gli ambienti politici del paese
non avevano mai vinto una guerra.
169
Il Trattato di Neuilly rinforzò la convinzione già ben radicata che la Bulgaria aveva da sempre
fatto funzione di vittima, di capro espiatorio delle grandi potenze sempre pronte ad offrirla con
devozione sull’altare dei loro interessi, per ritagliarne con lama insanguinata i migliori pezzi del
suo patrimonio nazionale. Questo sentimento era d’altronde condiviso dalla maggior parte della
popolazione dei Balcani.
Il trattato di Neuilly gettò un’ombra sull’immagine alquanto idealizzata dei paesi detti
democratici che fino a quel momento prevaleva in Bulgaria: la Francia e la Gran Bretagna
divennero gli ultimi degli scellerati, mentre gli Stati Uniti passarono per un paese debole,
bonaccione ed esitante nelle sue decisioni. Questo atteggiamento accentuò lo scivolamento della
Bulgaria verso la Germania degli anni ’30.
Il trattato di Neuilly contribuì all’apparire di una mentalità di perdente presso numerosi bulgari.
Il sogno più mite della politica estera del paese, il suo ultimo scopo durante il periodo che va
dalla prima alla seconda guerra mondiale, consisteva nell’evitare di commettere nuovi errori. La
paura del bastone agitato dalle grandi potenze fu all’origine di certe iniziative apparentemente
illogiche prese dai governi nel corso degli anni trenta quando proposero l’instaurazione di
relazioni più strette con la stessa Iugoslavia che, nella mitologia popolare, aveva rubato al
Macedonia ai bulgari.
Il trattato di Neuilly fu a lungo pregiudizievole alle relazioni tra i paesi balcanici. Avvelenò
queste ultime fino ad un punto di non ritorno, come lo mostrano in modo palese numerosi vani
tentativi di accordo durante gli anni trenta. Predeterminò in effetti le correnti di inimicizia e di
eventuale amicizia in seno alla penisola. All’inizio degli anni ’30, la Iugoslavia tentò alcune
trattative che fallirono, per fare entrare la Bulgaria nell’Intesa detta balcanica. “Potete
impiccarci, ma non chiedeteci di passarci noi stessi la corda al collo” rispose a questa proposta il
ministro plenipotenziario bulgaro a Belgrado pensando all’obiettivo confessato dell’Intesa: il
mantenimento dei confini esistenti.
Il trattato di Neuilly mise la Bulgaria nella sconfortevole posizione di una grande potenza decisa
a prendere la sua rivincita nella penisola. Almeno è cosi che la vedevano i responsabili politici
dei paesi balcanici vicini. Questo apprezzamento era puramente teorico. Il paese era in pratica
ben troppo debole, perché il suo esercito, rigorosamente limitato dal trattato di pace, era mal
rifornito. In una parola, non rappresentava una minaccia militare per nessuno dei suoi vicini. In
verità, la Bulgaria poteva diventare una fonte di pericolo se si alleasse ad un’altra potenza
assetata di vendetta.
Nel 1938, i paesi balcanici, allarmati dal peggioramento della situazione in Europa che
annunciava la guerra, tentarono di raddrizzare la barra. Un accordo firmato a Salonico concesse
alla Bulgaria il diritto dio disporre di un esercito di conscrizione. Fu autorizzata a fortificare i
suoi confini ed a procedere al riarmo, equipaggiandosi di un materiale moderno. Le fu anche
permesso di dotarsi di sommergibili se ne avesse i mezzi. Questo accordo sopraggiunse tuttavia
troppo tardi per permettere un riavvicinamento tra posizioni ormai irriconciliabili.
Il trattato di Neiully ravvivò presso i bulgari il triste e doloroso sentimento di non vedersi
riconosciuto il rango di veri europei, di essere considerati dagli occidentali come un popolo
galleggiante tra due acque, che faceva parte dell’Europa senza appartenervi: una sorta di
“Humpty Dumpty” perché su di un muro tra orientalismo ed europeanità.
Il trattato di Neuilly mise i bulgari che abitavano la parte serba o greca della Macedonia in una
situazione molto più difficile di quella che conoscevano prima delle guerre balcaniche. Nessuno
di loro era autorizzato a considerarsi come bulgaro. Possedere o leggere un libro in bulgaro
costituiva un crimine passibile dalla pena di morte. Il ricorso al terrore provocò praticamente la
scomparsa di tutto ciò che l’elite intellettuale bulgara aveva meticolosamente prodotto durante
le varie epoche.
170
Il trattato di Neuilly modificò l’atteggiamento di numerosi bulgari nei riguardi di ciò che
chiamavano il movimento macedone. Durante 40 anni i bulgari avevano speso e spanso, non
avevano risparmiato i loro sforzi ed avevano fatto scoppiare guerre per un sogno battezzato
Macedonia. Ora tutto ciò era stato intrapreso in vano: provavano vergogna a riconoscerlo, ma
cominciavano a stancarsene; non credevano più a questo sogno nazionale ed i nuovi dirigenti
del movimento macedone non possedevano più il carisma dei loro predecessori. Le lotte interne
e gli omicidi ciechi che dilaniavano le organizzazioni macedone negli anni ’20 non
migliorarono la situazione.
Il trattato di Neuilly fece delle Bulgaria un terreno propizio alla diffusione delle ideologie di
sinistra. Divenne uno dei rari paesi europei in cui le idee comuniste guadagnano terreno e dove i
comunisti rappresentavano una forza politica della quale bisognava tener conto.
Il trattato di Neuilly fu cosi cattivo come lo pensavano i suoi contemporanei e come lo credono
una maggioranza di storici? E’ senza dubbio severo, ma non era più spietato dei progetti che i
bulgari prevedevano di mettere in opera se fossero riusciti a fare inclinare la bilancia in loro
favore. Nel 1916, quando la situazione sembra favorire le potenze centrali, il ministro bulgaro
degli affari esteri, propose di dividere l’insieme della Serbia tra l’Austria e la Bulgaria, in modo
da evitare in futuro ogni causa di problemi. Dopo il 1919, nessuno osò ricordarsi di questo
punto né evocarlo.
Nel periodo tra la prima e la seconda guerra mondiale il Trattato di Neuilly si rilevò essere una
delle armi più potenti del dibattito pubblico. Tutta la classe politica dall’estrema sinistra fino
all’estrema destra, sfruttava le disgrazie a lui associate per trarne vantaggio a breve termine.
Ogni anno, il 27 novembre era l’occasione di manifestazioni di strada, di processioni di
profughi, di manifestazioni politiche e risse nei bar.
Questo clichè si rilevò molto utile. I manuali di storia trattarono la questione, anche dopo la
seconda guerra mondiale, in uno spirito assai simile a quello che prevaleva prima della guerra.
Ma gli anni passarono e questo clichè cominciò a perdere il suo fascino. Immediatamente dopo
il 1989, un gran numero di gruppi politici tentarono di riavvivarlo. All’inizio incontrarono un
certo successo, generato da sentimenti di nostalgia; ma sembra ormai che il trattato di Neuilly –
sur – Seine abbia definitivamente lasciato la sfera del dibattito pubblico e dell’utilizzo politico
per integrare l’universo degli storici.Questi ultimi continuano a discuterne insieme, ma le loro
discussioni non interessano più realmente i bulgari. Non che gli storici si mostrino
eccessivamente prolissi sull’argomento: malgrado le sue ripercussioni negative durevoli, il
trattato di Neuilly non ha fatto l’oggetto che di un pugno di opere erudite.
22. L’immagine della donna dal 1914 al 1920. Miti e realtà
(traduzione Prof.ssa Teresa Scanzano)
Ruth Tudor
Noi analizzeremo qui la rappresentazione delle donne sui manifesti di propaganda governativa
della Prima Guerra Mondiale e del dopoguerra in Europa e negli Stati Uniti d’America, con
particolare interesse alle seguenti domande:
come le donne sono state dipinte nella propaganda governativa durante la guerra e
all’indomani della guerra? Quali realtà si nascondevano dietro queste immagini?
In quali momenti sogni e realtà non sono stati che una cosa sola? Come spiegare le
divergenze? Quali sono le differenze nazionali identificabili?
Cosa c’insegnano le rappresentazioni idealizzate quanto alle idee e credenze
concernenti la natura della donna in quest’epoca?
171
Noi affronteremo ugualmente le seguenti domande, particolarmente interessanti nel contesto che
ci riguarda, “Le donne e la guerra”:
In che cosa la Prima Guerra Mondiale è stata un catalizzatore dei cambiamenti nella vita
delle donne e per quanto tempo?
In che misura la guerra ha modificato la vita di tutte le donne?
Qual è stato il contributo delle donne in tempo di guerra? Quali ruoli diversi e vari
hanno giocato?
Sfide metodologiche
Questo tema pone una doppia sfida metodologica: mettere in luce l’esperienza specifica delle
donne nel passato senza, per questo, imporre una interpretazione progressista, di emancipazione
della storia delle donne, ciò che Ute Daniel (1997, p.273) aveva chiamato il modello di pensiero
che consiste nel prendere i propri desideri per delle realtà.
Dopo la Prima Guerra Mondiale gli Stati Uniti e alcuni Paesi d’Europa, di cui la Gran Bretagna,
la Germania e la Russia, hanno accordato il diritto di voto alle donne. Noi dobbiamo, tuttavia,
evitare di accreditare l’ipotesi secondo la quale esse avrebbero agito, durante il conflitto, per fini
politici e che il loro diritto di voto è la conseguenza del loro sostegno e della loro partecipazione
alla guerra.
La tendenza a prendere i propri desideri per delle realtà, quando si parla di storia delle donne,è
particolarmente evidente nei manuali di storia che presentano generalmente la guerra come un
catalizzatore di cambiamento, ma non evocano la situazione delle donne dopo il conflitto. Se, in
Europa, i manuali di storia dell’insegnamento secondario affrontano frequentemente il tema
delle donne e della guerra, semplificano, talvolta all’eccesso, la diversità delle loro esperienze.
L’incidenza delle idee di genere sul vissuto delle donne durante la guerra e sulle loro
rappresentazioni nella propaganda non è spesso presa in considerazione. Daniel (ibid.)
sottolinea la necessità di attenersi alle fonti nel quadro dei lavori di ricerca consacrati alla storia
delle donne.
Peraltro è necessario avere coscienza della necessità della condizione femminile (in Europa
come negli Stati Uniti) e delle classi sociali.
Di solito la guerra è un catalizzatore di cambiamento per le donne, perché dà loro l’occasione di
assumere dei ruoli e di vivere delle esperienze che sono loro negate in tempo di pace. Esse
ottengono spesso un aumento di libertà sessuale e sociale e maggiore spazio; adempiono nuovi
compiti, per esempio nell’industria pesante; esse mostrano competenze, di solito, nella gestione
e nell’organizzazione. Prima della Prima Guerra Mondiale si riteneva, tradizionalmente in
Europa e negli Stati Uniti, che le donne non potessero rivestire questi ruoli, giudicati contrari
alla loro natura. Questa percezione dell’essenza stessa delle donne serviva a giustificare la loro
esclusione dal potere politico.
Come hanno dimostrato Grayzel (2002) e Shover (1975), la Prima Guerra Mondiale ha imposto
la partecipazione delle donne allo stesso titolo degli uomini. C’era bisogno, infatti, della
mobilitazione di tutta la popolazione. L’importanza delle donne nell’impegno bellico negli Stati
Uniti, per esempio, è illustrata dalle migliaia di immagini che rappresentano le donne e di cui la
pubblicazione aveva come scopo di “vendere la guerra“ e di ottenere il sostegno e la
partecipazione del popolo(Dumenil).
Nel corso della Prima Guerra Mondiale le donne hanno giocato un ruolo decisivo come
sostegno e attore nell’impegno bellico. La natura delle immagini di propaganda prodotte dai
diversi governi implicati nel conflitto riflette le convinzioni e le culture nazionali, comprese le
convenzioni commerciali, così come le credenze in materia di genere. Infatti, i governi hanno
deliberatamente giocato con le immagini culturalmente familiari per rafforzare l’efficacia della
loro propaganda. Per questo è necessario analizzare le rappresentazioni delle donne durante la
172
guerra in un contesto più largo al fine di comprendere e valutare le loro corrispondenze con la
realtà del vissuto delle donne.
Shover (ibid.) identifica un dilemma nel quale sono stati confrontati i governi durante la Prima
Guerra Mondiale. Questi avevano bisogno delle donne per rispondere alle esigenze della guerra,
ma contemporaneamente speravano di preservare l’immagine tradizionale delle donne quali
esseri passivi. Non era, dunque, questione di modificare in modo definitivo le relazioni di
genere, ma c’era bisogno di trovare un equilibrio delicato tra la trattativa della partecipazione
attiva delle donne e la tutela dell’ordine sociale stabilito.
Ruoli e immagini
Specialmente all’inizio della guerra, le donne hanno avuto essenzialmente la funzione di
sostenere lo spostamento degli uomini, in genere come combattenti.
Questo ruolo è stato particolarmente determinante in un Paese come la Gran Bretagna che
ignorava la coscrizione o il servizio di leva e nel quale l’armata si componeva, alla partenza,
solo di volontari. Nel corso dei primi anni di guerra il ruolo delle donne consisteva
nell’esercitare una pressione affettiva sugli uomini per invitarli ad impegnarsi. Le prime
immagini mostrano donne vulnerabili e vittime, spesso con i bambini. Sul manifesto britannico
“Women of Britain say Go!”, la sfera privata della patria è simboleggiata dalle donne e il
bambino, teneri, stretti gli uni agli altri e passivi, a mille leghe dalla sfera pubblica rappresentata
da soldati virili che si allontanavano in ordine di marcia. Gli uomini erano tutti uguali, attivi, le
linee dritte delle canne dei loro fucili, delle loro uniformi e della loro formazione di marcia in
contrasto con quella delle donne. Le immagini di questo tipo erano destinate tanto alle donne
quanto agli uomini. Le donne avevano come compito quello di incoraggiare gli uomini a partire
per la guerra e gli uomini quello di andarci. Il manifesto francese “Merci“ (vedi immagine 1)
evoca una situazione simile. La differenza tra le donne dipinte sui manifesti francesi e inglesi è
minima. Tuttavia, altre immagini presentano le donne francesi meno direttive e meno forti delle
donne inglesi, probabilmente sotto l’influenza del protestantesimo e della tradizione
dell’individualismo liberale della Gran Bretagna, allorché in Francia le relazioni di genere
restavano profondamente influenzate dal cattolicesimo iscritto nel Codice napoleonico.
Immagine 1
Tali riproduzioni, il cui obiettivo era d’incitare le donne ad incoraggiare la mobilitazione, non
rimettevano in causa la visione tradizionale della donna. Le donne erano spesso dipinte come
vittime e spettatrici passive. Queste rappresentazioni rischiavano, dunque, di contraddire altre
immagini tendenti ad ottenere la partecipazione delle donne alla guerra come operaie,
particolarmente per lavori pesanti, poco puliti e pericolosi. Il manifesto russo è un altro esempio
di questo tipo di rappresentazione, la vittima femminile che appare come un dettaglio
apparentemente secondario nell’angolo inferiore destro (Jahn, 1995 ). Un soldato tedesco tiene
una donna russa per i capelli sotto lo sguardo divertito di un altro soldato. La scena evoca
chiaramente la violenza imminente sulla donna e la sua umiliazione.
Immagine 2
Un manifesto britannico “Men of Britain! Will you stand this?” cerca di convincere gli uomini
ad impegnarsi ricordando loro i 78 donne e bambini uccisi al momento dell’attacco navale di
Scarborough nel 1915. L’illustrazione 3 “Enlist” descrive l’annegamento di una donna indifesa
e del suo bambino durante il naufragio della Lusitania. Il manifesto tedesco della illustrazione 4
“Agriculteurs, faites votre devoir: les villes ont faim!” mira a mobilitare i contadini, mostrando
delle donne e dei bambini che soffrono la fame. Alla maniera di altri manifesti tedeschi, questa
immagine è più realistica della maggior parte di quelle di altri Paesi. Nell’illustrazione 5
“Ramassez les cheveux des femmes” una donna spettrale e molto femminile offre la sua lunga
capigliatura - simbolo della sua femminilità - su uno sfondo di croce rossa. Questo manifesto è
173
stato affisso in Germania nel 1918, data in cui il blocco inglese ha costretto la Germania a
ricorrere a materie prime alternative, per esempio i capelli in sostituzione del cuoio e della
canapa (Shover, ibid.).
Immagine 3
Immagine 4
Immagine 5
Tutte queste immagini, concepite per rafforzare la fibra protettrice degli uomini verso le donne,
non rimettevano in causa la visione tradizionale che si poteva avere degli uomini e delle donne.
Tuttavia, l’illustrazione 6 “Les Austrichiens sont allés à Radzivily”, è di uno stile sensibilmente
differente. Si tratta di un manifesto russo che mostra dei soldati austriaci facilmente vinti da una
donna russa. Essa sollecita la mobilitazione degli uomini, ma adotta un registro diverso dalla
maggior parte delle immagini di allora. Infatti, essa gioca sull’amor proprio degli uomini per
incitarli ad arruolarsi nell’armata: anche una donna può opporsi al nemico, le basta per questo
una forca! Anche lì, questa immagine non rimetteva in causa la visione russa tradizionale della
donna. In un contesto più largo, si prende atto che questo manifesto è in uno stile “loubok“,
genere tradizionale che mette in scena delle contadine laboriose dedite alla terra e materne
(Petrone, 1998). Lo stile “loubok”, molto corrente in Russia nel 1914 e all’inizio del 1915, ha
conosciuto in seguito il declino e i manifesti di propaganda russa si sono uniformati alle
immagini occidentali.
Immagine 6
La rappresentazione di donne vittime sessuali era ugualmente destinata ad incitare gli uomini
alla Guerra. La donna generalmente vi appariva come la vittima impotente di un predatore
sessuale e non come una persona cosciente della propria sessualità. Queste immagini sono
totalmente conformi all’ideale femminile dell’era industriale nell’Europa occidentale. Le rare
rappresentazioni che mostrano delle donne volontariamente provocanti hanno sollevato
all’epoca critiche accese (vedi illustrazione 7 “I Want You for the Navy”). Questo manifesto
americano del 1917 faceva parte di una serie creata da Christy, un artista al quale si
rimproverava l’assenza di dignità nelle sue opere. E’ un esempio inusuale di propaganda della
Prima Guerra Mondiale che gioca sulla provocazione sessuale. Tuttavia, non rimette in causa
l’idea della donna dipendente dall’uomo e nega la realtà della presenza delle donne nella marina
in questo periodo( Grayzel, ibid.). L’illustrazione americana 8 “Destroy this Mad Brute”, datata
1917, era di stile molto più accettabile e corrente, difendendo la necessità per l’uomo
d’impegnarsi per difendere l’onore della sua donna. Essa mette in scena una donna rapita da una
bestia feroce per fini sessuali. La bestia rappresenta il nemico, mentre la donna rappresenta
l’onore, la purezza e la civiltà americana. L’illustrazione 9 “It’s Up To You” è di genere simile,
è stata pubblicata negli Stati Uniti nel 1917 e lascia chiaramente intravedere che la donna sta per
essere vittima di violenza.
Immagini 7 – 8 - 9
La rappresentazione delle donne in quanto madri era molto frequente. Essa era perfettamente
accettabile nella misura in cui riassumeva l’immagine tradizionale dell’essenza delle donne e
del loro posto nella società e rifletteva il loro ruolo essenziale in quanto madri durante il
conflitto. Questi manifesti, che presentavano delle donne dignitose, dolci, umane, erano privi di
ogni connotazione sessuale. La donna dell’illustrazione 10 “The Greatest Mother in the World”
è una rappresentazione inusuale delle donne sui manifesti in tempo di guerra a motivo della sua
taglia smisurata (Dumenil, 2002). Essa tiene tra le sue braccia un minuscolo soldato ferito.
Sembra, dunque, che in quanto madre, una donna può essere grande e forte. Queste madri non
rimettevano in discussione i valori tradizionali: la loro importanza è decisiva perché è loro
compito quello di nutrire e curare i soldati e i bambini e dare vita alla generazione futura.
Immagine 10
174
In realtà, le credenze dell’epoca sui rapporti tra le madri e la guerra e i vari comportamenti delle
donne di fronte alla guerra erano diversi e complessi. Il Dr. Aletta Jacobs, nei Paesi Bassi, ha
dichiarato che le madri non potevano sostenere la guerra perché il loro dolore era troppo forte.
Essa richiamava ad un futuro controllo della politica straniera per mezzo di un gruppo
internazionale di uomini e donne, tipo di pacifismo che diventerà una caratteristica del
femminismo negli anni 1920 e 1930 (MacDonald e al., 1987). In Svezia, Ellen Kay condivideva
questo punto di vista, giudicando anomalo che le donne sostenessero la guerra ( MacDonald,
ibid.). All’inizio della guerra, nel Regno Unito, le madri hanno organizzato la campagna “White
feather” (Piuma bianca), un’azione aggressiva e pubblica verso gli uomini che mirano a
suscitare la loro vergogna per il mancato impegno. Al contrario, in Malati, in Africa, le donne
hanno rifiutato d’incitare gli uomini ad impegnarsi ed alcune di loro sono state persino prese in
ostaggio per obbligare gli uomini a raggiungere le fila dei volontari (Grayzel, ibid.). Nel mondo,
solo una piccolissima minoranza di donne ha veramente partecipato ai combattimenti.. In Russia
un battaglione femminile soprannominato il “Battaglione della morte” si è formato per ferire gli
uomini nel loro amor-proprio al momento dei combattimenti. Le sue lodi sono state cantate
dalla femminista e suffragista Emmeline Pamkhurst ( MacDonald, ibid.).
I manifesti, che mettevano in scena delle donne infermiere erano fra le rare immagini che
autorizzavano la rappresentazione di uomini in situazione di dipendenza nei confronti delle
donne (Shover, ibid.) conservando tuttavia la loro virilità. L’illustrazione 11 (Croce Rossa
belga) è tipica. Le donne sono dolci, calorose e, nel caso di questo manifesto belga,
verosimilmente angeliche. Nel ruolo di infermiera, la visione familiare della donna non era
rimessa in discussione. Questi manifesti riflettevano di solito la loro femminilità, salvo quando
appartenevano al campo nemico: Nell’illustrazione 12 “Red Cross or Iron Cross” una crudele
infermiera tedesca rovescia intenzionalmente un bicchiere d’acqua sotto gli occhi di un soldato
ferito e assetato. Essa è dipinta come una donna “anormale”, cosa che è ammissibile poiché
simboleggia il nemico.
Immagini 11 – 12
Con l’evoluzione della guerra, Il ventaglio dei ruoli femminili si apre, come testimoniano le
illustrazioni. La partecipazione della donna era richiesta nell’industria pesante e dovevano farsi
carico delle funzioni di gestione, rimettendo così in questione i ruoli che erano tradizionalmente
loro affidati. Sui manifesti governativi, la limpidezza, la sicurezza, la facilità e la durezza del
lavoro delle donne durante la guerra erano fortemente minimizzate in rapporto alla realtà. Le
donne rappresentate al lavoro nel settore industriale erano generalmente giovani, probabilmente
per salvaguardare il concetto tradizionale del ruolo della donna in seno alla famiglia. Peraltro,
niente lasciava intendere che questi cambiamenti nel lavoro delle donne prendesse un carattere
permanente e, in Germania per esempio, alcune donne non avrebbero colto queste nuove
opportunità in ragione della loro natura temporanea (Daniel, ibid.). Sul manifesto britannico
“These Women are doing Their Bit”, il soldato sullo sfondo ricorda al pubblico perché le donne
devono fabbricare delle munizioni, ma lascia intravedere ugualmente il suo ritorno assicurato. Il
manifesto britannico “God Speed the Plough and the Woman who Drives it” insiste sulla facilità
e il romanticismo dei lavori agricoli. Il manifesto russo “Tout pour la guerre”, illustrazione 13,
libera anche l’immagine di un lavoro facile che attira le donne all’industria. Al contrario, le
donne dell’illustrazione 14, “Les Allemandes travaillent pour la victoire !” sembrano scontente.
Questa immagine del 1918 è più trucemente realistica delle paragonabili immagini di altri paesi.
Nel 1918 le Tedesche hanno partecipato a scioperi di grande entità nell’industria e a rivolte
frumentarie, fatte scattare dalle donne per numero utile fra di loro. Questo manifesto può essere
considerato, pertanto, come il riflesso della corruzione in Germania nel 1918. La
radicalizzazione dei cittadini della classe operaia nel 1918 è stata una delle cause della
rivoluzione del 1918 (Daniel, ibid.).
Immagini 13 – 14
175
Le realtà del lavoro delle donne durante la guerra erano più diversificate e complesse di quanto
non lo lasciassero intravedere i manifesti. In molti paesi, le donne erano avide di cogliere le
opportunità che offrivano questi lavori di genere nuovo, ma erano più motivate dai salari e dallo
statuto che dallo slancio patriottico. Una minoranza di loro ha penetrato i settori abitualmente
riservati agli uomini, ma quasi tutte hanno lasciato le loro occupazioni nel 1918. In generale,
non sembra che il numero di donne che occupava un impiego salariato sia aumentato dopo il
1918, paragonato al periodo dell’ante-guerra. Se il tipo di lavoro si è evoluto, non si trattava
tuttavia che di accelerazione di una tendenza già in corso. Negli Stati Uniti, per esempio, la
guerra ha accelerato un movimento nato nel 1870, spingendo più donne a occupare un impiego
salariato e ad investire nuovi settori di attività. Gli effettivi femminili sono evidentemente
aumentati nei lavori d’ufficio e industrie metallurgiche, chimiche ed elettriche mentre il numero
di impiegate a casa diminuiva (Weiner Grenwald, 1980). Negli Stati Uniti, la Prima Guerra
Mondiale ha offerto ad alcune donne, in genere povere e nere, nuove opportunità di impiego
meglio remunerati, per esempio nelle ferrovie e nella metallurgia. Sarebbe pericoloso pensare
che il lavoro delle donne durante la guerra avesse come unico scopo l’emancipazione, sapendo
che il diritto di voto è stato accordato loro in molti paesi dopo la guerra. Spesso, le donne hanno
colto queste occasioni per motivi finanziari.
L’illustrazione 15 è la fotografia di una donna che carica delle ogive di TNT all’arsenale di
Woolwich, in Gran Bretagna, nel 1918 (Condell e Liddiard, 1987). Prima del 1914, questo
arsenale impiegava 10 donne, mentre erano più di 24.000 nel 1918. Tuttavia, questi
cambiamenti non hanno resistito dopo la guerra. Nel 1918, alcune donne hanno fatto sciopero
per tentare di salvaguardare il loro impiego, ma la grande maggioranza ha accettato di
rinunciarvi senza troppe difficoltà. Alcune donne desideravano lasciare il loro impiego a causa
del doppio lavoro che gravava su di loro dentro e fuori casa, situazione alla quale si erano
adattate durante la guerra.
Immagine 15
Sui manifesti della Prima Guerra Mondiale le donne apparivano di solito come dei simboli. La
maggior parte dei paesi facevano ricorso all’immagine della donna per rappresentare la nazione,
in particolare la sua purezza e il suo onore. Queste immagini servivano a ricordare alle nazioni
la loro giusta causa per la guerra e spingevano gli uomini ad arruolarsi per proteggere la loro
patria. E’ importante notare che le donne in quanto simboli sono spesso dipinte allo stesso
tempo forti e sensuali. Questa rappresentazione era autorizzata perché, in quanto simboli, esse
non erano reali. L’illustrazione 16 “The Sword is Drawn, the Navy Upholds it” viene dagli Stati
Uniti e data 1917. Su questo manifesto, Columbia (simbolo della Libertà) porta la spada della
giustizia e chiama gli uomini a sostenerla. L’onore della donna simboleggia quello della
nazione. Sullo sfondo passa una nave da guerra e il manifesto porta in basso l’indirizzo
dell’ufficio leva della marina americana. L’illustrazione 17 “Souscrivez à l’emprunt” viene
dall’Italia e data 1917. L’Italia è rappresentata da una donna vigorosa, niente affatto spaventata
dall’avanzata del Goth che lascia cadere la sua clava del terrore davanti alla forza che essa
sprigiona. Anche l’illustrazione 18 “Souscrivez au 5me emprunt de guerre autrichien” del 1916,
presenta la nazione sotto l’aspetto di una donna ieratica, che ha tra le mani una spada decorata
degli allori della vittoria. Una delle figure allegoriche femminili più forti è la Marianne francese.
Nell’illustrazione 19 è rappresentata sotto forma di una potente guerriera, con in testa un casco
gallico e armata di una spada, che esorta il popolo francese a compiere il proprio dovere.
L’illustrazione 20 “La Russie pour la Vérité” (1914), dà un’immagine molto simile della donna.
Su un altro manifesto russo, tre donne simboleggiano l’unità tra la Russia rappresentata da Vera
(la fede), la Francia rappresentata da Lioubov (l’Amore) e la Gran Bretagna rappresentata da
Nadejda (la Speranza). Un manifesto italiano, illustrazione 21, “… et ce qui était à nous est de
nouveau à nous” fa riferimento ai territori annessi all’Impero austro-ungarico e dipinge l’Italia
sotto l’aspetto di una donna vigorosa e sensuale.
Immagini 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21
176
Il manifesto dell’illustrazione 22 (Stati Uniti, 1917), dai tratti estremamente naturali,
rappresenta un’eccezione alla regola che prevaleva sui manifesti della Prima Guerra Mondiale.
Esso presenta una contadina seducente, molto giovane e sicura che suona il tamburo. Il testo del
manifesto dichiara “The Spirit of Woman-Power. Women Serve Your Country Where You
Can”. Questa illustrazione, scelta da un’organizzazione di donne americane per promuovere
l’impegno in guerra, si ispira ad un quadro che rappresenta una contadina al tempo della
Rivoluzione francese.
Non essendo le donne né americane né contemporanee, la visione tradizionale della donna in
America non è in realtà chiamata in causa.
Immagine 22
Nel 1919, le donne scomparivano praticamente della propaganda governativa del dopoguerra. In
questo periodo, i paesi concentrano i loro sforzi sulla ricostruzione e il lutto. I monumenti
commemorativi e i manifesti del 1919 ignorano il contributo delle donne in quanto lavoratrici
durante la Prima Guerra Mondiale. Praticamente tutti i monumenti eretti dopo la guerra
rappresentano dei soldati. Le sole donne che vi figurano prendono le sembianze di una madre
oppressa dal dispiacere che simboleggia il dolore della nazione. Il monumento commemorativo
di Veliko Turnovo, in Bulgaria, ne è un perfetto esempio. La madre occupava un posto
importante all’indomani della guerra, poiché essa incarnava il dolore della nazione, ma anche a
motivo delle inquietudini legate alla natalità e all’elevato tasso di mortalità. Le donne subivano
forti pressioni per assicurare la futura generazione. Una notevole eccezione è il monumento di
Peronne, in Francia, dove la donna ostenta i tratti della collera.
L’illustrazione 23 (Francia, 1919), è un appello all’investimento nella ricostruzione nazionale.
Essa mostra tre operaie che piantano la bandiera francese sui territori precedentemente occupati
dalla Germania. Nell’illustrazione 24 (Francia, 1919) “Journée des régions libérées. Après la
victoire, au travail!”, un soldato francese congedato, che porta un gallo sulle sue spalle, se ne va
a lavorare per la ricostruzione. Nella Russia comunista, i manifesti rappresentano di solito delle
donne poiché il loro contributo è stato decisivo nella industrializzazione del paese.
L’illustrazione 25, “Ce qu’a apporté la Révolution d’octobre à l’ouvrière et à la paysanne”
mostra una giovane donna russa felice e impaziente di contribuire all’economia nazionale.
Immagini 23 – 24 – 25
In conclusione, i manifesti erano delle immagini idealizzate che in genere non riflettevano
realmente il contributo delle donne nell’impegno bellico. La grande maggioranza delle
illustrazioni mostravano delle donne dipendenti, emarginate nei ruoli domestici, rese mute da
uno spirito di sacrificio, dolci e generose. Le sole eccezioni sono le rappresentazioni allegoriche
o quelle delle donne nemiche, o ancora le donne che corrispondono alla concezione tradizionale
in un contesto culturale particolare. Esse non sono dipinte come un gruppo diversificato. La
maggior parte di quelle riprodotte nelle immagini sembrano benestanti e non essere motivate da
bisogni economici. La natura della propaganda ha così permesso ai governi di mobilitare le
donne per la guerra senza pertanto richiamare in causa le relazioni di genere tradizionali.
177
Referenze e bibliografia
178
23. 1919: La dimensione globale
Odd Arne WESTAD
Il presente contributo risponde ad una necessità: quella di considerare la storia europea come
una storia internazionale e globale. Per capire bene l’importanza del 1919, bisogna evocare la
questione coloniale ma anche, in questo contesto coloniale, certi aspetti sociali dell’epoca. In
qualche modo, noi passeremo in rassegna la storia di quest’anno, cardine in Europa, nella
duplice prospettiva di quelli che l’hanno vissuta e di quelli che l’hanno osservata dall’esterno.
Ad eccezione dell’Europa e degli Stati del Nord Atlantico, il 1919 segna, per il resto del mondo,
due grandi evoluzioni: da una parte, la decolonizzazione in Asia, in Africa e nei Carabi, di cui il
processo si può dire che ha dato il via a quest’anno; da un’altra parte, la radicalizzazione nel
Terzo Mondo dell’anticolonialismo a beneficio del marxismo e del comunismo. Se la
decolonizzazione fu una delle conseguenze della guerra, l’anticolonialismo fu il risultato di una
pace mancata, che non ha saputo rispondere alle aspettative dei popoli colonizzati.
La decolonizzazione
Nel 1919, il continente europeo, alla fine della Grande Guerra, è sull’orlo del baratro. La sua
fragilità, seguita molto attentamente fuori dall’Europa, non è solamente economica e materiale,
è anche politica e morale. Per milioni di Africani e Asiatici che hanno sofferto della guerra
europeo-europea per esservi stati coinvolti in Europa o altrove, la guerra ha rivelato un
continente destinato a lacerarsi. Molti sono gli esponenti locali del Terzo Mondo a perdere la
fede, largamente estesa prima del 1914, nei valori europei come giustificazione del
colonialismo. Prima della guerra l’Indonesiano nazionalista Sutan Sjahrir scriveva:
“Dal mio punto di vista, l’Occidente è una forza viva, potente, dinamica e attiva. Una
sorta di Faust che io ammiro, e io sono convinto che solo questo dinamismo
dell’Occidente permetterà all’Oriente di liberarsi dalla schiavitù e dalla sottomissione.
L’Occidente insegna oggi all’Oriente a considerare la vita come una lotta e uno sforzo,
un movimento attivo al quale la nozione di tranquillità deve essere subordinata…La
lotta e lo sforzo implicano un lotta contro-natura, è lì l’essenza stessa della lotta: la
volontà dell’uomo di sottomettere la natura e di governarla con la sua volontà”.
Nel 1919, non resta più niente dell’ammirazione di Sutan e della maggior parte dei capi istruiti
del Terzo Mondo.
Dall’inizio di quest’anno, per la prima volta, un numero crescente di movimenti nazionalisti
rivendicano innanzitutto l’indipendenza totale. Lo sviluppo del movimento anticoloniale nel
terzo mondo, che permetterà alle correnti nazionaliste radicali di prosperare, è iniziato durante
la Prima Guerra Mondiale. La guerra ha significato la fine dei valori europei, ma ha aperto
anche delle prospettive alle organizzazioni locali che la repressione dell’anteguerra aveva potuto
contenere. A partire dal 1914, essendo l’attenzione delle autorità imperiali rivolta altrove, i
nazionalisti locali si impegnano a consolidare i loro partiti e movimenti e a moltiplicare il
numero dei loro affiliati. Fin dal 1919, diverse organizzazioni nazionaliste in India, in Cina e in
Indonesia, per non citare che alcuni paesi, sono pronte a lanciare delle offensive politiche su più
vasta scala.
L’oggetto di queste offensive è largamente determinato dagli avvenimenti che si succedono nel
1919, al momento dei negoziati del trattato di pace da parte delle grandi potenze riunite a Parigi.
In India, Febbraio 1919 è segnato dalle prime campagne di Gandhi per l’indipendenza. La
risposta dei Britannici - il massacro di Amritsar del 13 aprile - e l’opposizione pacifica alla
violenza predicata da Gandhi elevano il mahatma al rango di leader nazionale. Quando Gandhi e
un certo numero di partigiani pacifisti constatano, al momento della conferenza di pace, la
179
mancanza di volontà da parte dei vincitori di regolare la questione coloniale, comprendono che
non potranno contare che su se stessi e le loro proprie azioni per ottenere l’indipendenza.
In Cina, il 1919 è un sisma. Il paese è allora una “semi-colonia” perché le potenze imperialiste
si sono attribuite le parti di territorio chiamate “concessioni” piuttosto che creare uno Stato
interamente coloniale.
Una buona parte di Cinesi spera dunque che le dichiarazioni del presidente americano Woodrow
Wilson sull’intera sovranità nazionale riguarderanno anche la Cina. Il popolo cinese è furibondo
quando scopre che la questione delle concessioni non è stata revocata durante la conferenza di
pace di Parigi, salvo quella della Germania. E quando si è deciso di trasferire i diritti tedeschi al
Giappone invece di tributarli alla Cina, la popolazione vi scorge un insulto e un disprezzo che si
esprimono con massicce manifestazioni, che tutti i cinesi conoscono oggi sotto il nome di
Movimento del 4 maggio, in omaggio a questa giornata del 1919 in cui gli studenti di Pechino
sono scesi in piazza.
Il Movimento del 4 maggio è all’origine del nazionalismo cinese moderno e dei due partiti che
domineranno la storia cinese del XX secolo – il Guomindang e il Partito Comunista cinese.
Gli slogans lanciati dagli studenti per la federazione del popolo in tutto il paese,
l’emancipazione delle donne e la nascita di una nuova cultura locale, segneranno l’evoluzione
della Cina fino al 1949 e oltre: Più di 400 giornali e riviste datati 4 maggio fanno del 1919 un
anno culturale e politico cardine nella storia cinese moderna.
Il giovane Mao Zedong scrive nel 1919:
“Dal grande appello alla rivoluzione mondiale, il movimento per la liberazione
dell’umanità è avanzato con accanimento e oggi noi dobbiamo cambiare atteggiamento
di fronte a delle poste in gioco che noi non contestavamo in passato, a dei metodi che
non utilizzavamo e tante parole che temevamo di usare. Contestate l’incontestabile.
Osate fare l’impensabile. Non abbiate paura di dire l’indicibile. Nessuna forza potrà
fermare quest’onda” (Schran, vol.1, 1995, pag. 318).
Non è soltanto in Cina che i cinesi contestano gli accordi firmati a Versailles. A Parigi, Wang
Jingwei, che ha lavorato nella capitale francese durante la guerra (e che, dopo il 1937, sarà il
principale collaboratore della Cina sotto l’occupazione giapponese), è in testa alle
manifestazioni, certamente più modeste che a Pechino. Le manifestazioni sono raggiunte da
connazionali delle colonie francesi nel Sud-Est asiatico, tra cui Nguyen Ai Quoc, un giovane
vietnamita che raggiungerà più tardi i comunisti sotto il nome di Ho Chi Minh..
Gli anni che seguono la Prima Guerra Mondiale sono determinanti per la carriera del giovane
Ho, tre anni più anziano di Mao. Avendo sollecitato invano l’aiuto americano per stabilire le
libertà democratiche e l’autonomia politica del Vietnam alla Conferenza di pace di Versailles, il
foto-ritoccatore di trent’anni stabilito a Parigi è amaramente deluso dalla diplomazia wilsoniana
e vede nel marxismo la soluzione ai mali del suo paese.
“L’idra del capitalismo occidentale stima che l’Europa è un campo d’azione troppo
ridotto e che il proletariato europeo è insufficiente a soddisfare il suo insaziabile
appetito, essa stende ora e per molto tempo i suoi orribili tentacoli ai quattro angoli del
globo”
spiega Ho al Congresso del Partito Socialista francese che si tiene a Tours nel 1920 (QuinnJudge, op. cit. p. 32). Rimproverando ai socialisti francesi la loro mancanza di impegno in
favore della liberazione delle colonie, Ho vota per l’adesione del partito all’Internazionale
Comunista e diventa più tardi un agente itinerante del Komintern in molti paesi d’Europa e in
Asia prima di dirigere, negli anni 1940, il Vietminh, movimento di resistenza comunista.
180
Il Comunismo
Creata nel 1919 per promuovere prima di tutto la rivoluzione in Europa, la III Internazionale,
detta Internazionale Comunista (IC) o Komintern, giocherà un ruolo maggiore anche nei paesi
del terzo mondo. Malgrado la promessa fatta nel 1919 di incarnare le aspettative della
rivoluzione mondiale -una sorta di Versailles al contrario dove tutti i paesi e i popoli avrebbero
un posto riservato ed equo - negli anni 1920, il Komintern funziona soprattutto come uno
strumento di controllo sovietico sul comunismo internazionale e finisce per venir meno alla
promessa.
Il Komintern è nato dalla triplice scissione della II Internazionale socialista sulla questione della
Prima Guerra Mondiale. Una maggioranza di partiti socialisti, di cui l’ala “destra”
dell’Internazionale, aveva deciso di sostenere il peso della guerra dei loro rispettivi governi
contro dei nemici che, ai loro occhi, erano molto più ostili agli scopi socialisti. La fazione
“centrista” dell’IC denunciò questo nazionalismo dell’ala destra e chiese che la II Internazionale
restasse fedele alla pace mondiale. Quanto ai militanti di “sinistra” guidati da Vladimir Lenin,
rinnegavano nello stesso tempo il nazionalismo e il pacifismo e volevano fare della guerra tra
nazioni una guerra tra classi transnazionali. Nel 1915, Lenin propose la creazione di una nuova
Internazionale al fine di promuovere “la guerra civile, non la pace civile”, facendo propaganda
tra i soldati e i lavoratori. Due anni più tardi, Lenin era a capo del movimento bolscevico, e nel
1919 indice il primo Congresso del Komintern a Mosca, allo scopo di sabotare le posizioni
espresse dai centristi per risollevare la II Internazionale. Soltanto 19 delegazioni e un gruppetto
di comunisti non Russi presenti a Mosca rispondono al suo appello, ma due anni più tardi, nel
1920 a Mosca il secondo Congresso riunisce le delegazioni di 37 paesi. Lenin fissa i trentadue
punti che sono le condizioni di adesione all’Internazionale Comunista. Per essere membro del
Komintern, un partito deve essere strutturato con l’applicazione di una disciplina di ferro,
conforme al modello sovietico, ed escludere i socialisti moderati e pacifisti.
L’organizzazione amministrativa del Komintern ricalca quella del Partito Comunista sovietico:
il Comitato esecutivo dirige i lavori nell’intervallo che separa le sessioni dei Congressi, e un
presidio ridotto funge da organo direttivo. Poco a poco, questi due organi supremi concentrano
tutti i poteri nelle loro mani e i partiti membri dell’IC devono adeguarsi alle loro decisioni. In
più, i Soviets stabiliscono la loro dominazione sul Komintern: l’Internazionale è stata fondata da
una iniziativa sovietica, il suo quartier generale è a Mosca, il partito sovietico è ampiamente
rappresentato negli organismi amministrativi e la maggioranza dei comunisti stranieri sono
indefettibilmente fedeli al primo Stato socialista del mondo.
Nel Terzo Mondo, anche i non comunisti sono numerosi nel pensare che l’ora del comunismo è
forse arrivato.
Il giovane Indiano Jawaharlal Nehru scrive nel 1919:
“Oggi, lo spettro del comunismo si è materializzato e tiene il mondo occidentale sotto il
suo dominio: La Russia e l’Ungheria hanno chiuso con l’antica dominazione dei
capitalisti e dei latifondisti. Orribili estorsioni vengono imputate ai bolscevichi in
Russia. Ma se così è, come immaginare che milioni di uomini e donne abbiano scelto il
terrore e l’abiezione e abbiano lavorato di buon grado per dargli vita. Noi siamo un
popolo comunitario e, giunto il momento, sarà forse inventata una forma di comunismo
più adatta alla natura umana rispetto ad un governo maggioritario. Prepariamoci in vista
di questo momento e che i nostri dirigenti pensino” (Gopal, 1972, pp. 140-4 ).
Il Komintern è lo strumento di cui hanno bisogno i comunisti per organizzare delle rivolte
contro l’imperialismo. Agli occhi di molti oppositori della dominazione straniera nel Terzo
Mondo, la rivoluzione russa è un avvenimento considerevole: non solo i bolscevichi vogliono
181
creare un loro nuovo Stato, che sopprimerà l’oppressione coloniale e la dominazione etnica, ma
promettono anche di sostenere tutti i movimenti che perseguono lo stesso obiettivo nel mondo.
E, la cosa più importante, i comunisti hanno ormai un modello, sanno come darsi da fare per
rovesciare l’antico regime e creare un nuovo Stato allo stesso tempo giusto e moderno.
L’immagine della rivoluzione russa che i propagandisti del Komintern diffondono nel mondo è
di quelle che i giovani organizzatori e intellettuali trovano estremamente seducenti per
l’avvenire del loro paese.
In queste condizioni, non c’è da stupirsi se all’inizio degli anni 1920 dei partiti comunisti
nascono nei principali paesi del Terzo Mondo - dal 1920 o 1921 in Cina, in India, in Indonesia,
in Turchia e in Iran -. I segretari di questi partiti, almeno quelli che non sono arrestati o fucilati
dai regni in carica, si ritrovano a Mosca in occasione dei Congressi del Komintern, accanto ai
leaders comunisti europei. Le registrazioni di queste riunioni mostrano la diversità del
comunismo agli esordi e quanto gli incontri saranno difficili tra i Russi e i marxisti arrivati da
altri orizzonti.
I sovietici si aspettavano l’opposizione (ben più che una vaga condiscendenza) manifestata dai
marxisti occidentali presenti ai primi congressi del Komintern. Essi sono sorpresi, invece, dalla
capacità e la volontà dei marxisti del Terzo Mondo di segnare la loro indipendenza rispetto alla
visione sociale e politica del comunismo sovietico. Senza criticarlo all’unisono, questi capi
evocano le difficoltà che le generazioni che si sono succedute al Cremlino si riveleranno
incapaci di superare nelle loro relazioni con il Terzo Mondo.
Il giovane indiano comunista Manabrenda Nath Roy, per esempio, criticava Lenin al tempo del
II Congresso del Komintern, rimproverandogli la sua grande reticenza ad affidare un ruolo
importante ai PC del Terzo Mondo nelle rivoluzioni anti-imperialiste condotte nei loro paesi.
Roy conviene con il capo sovietico che i comunisti devono allearsi alla borghesia locale
(nazionalista) contro le potenze imperialiste, ma egli stima da parte sua che i comunisti devono
sviluppare una propaganda per il proprio partito e reclutare in tutti gli strati della società, al fine
di formare “un’avanguardia della classe operaia”, compreso nelle regioni maggiormente agrarie
dove questa classe è molto poco rappresentata. Sebbene ammetta che un’alleanza con l’Unione
Sovietica potrebbe aiutare i paesi del Terzo Mondo a liberarsi dal capitalismo, Roy considera la
possibilità che, almeno in certi paesi, dei partiti comunisti prendano il potere prima che la
formazione della classe proletaria sia del tutto terminata e che essi siano per questo portati a
mettere in piedi “una quantità di riforme piccolo borghesi come la spartizione delle terre”
contemporaneamente al potere proletario (Schmidt – Soltan, 1994)
Una critica emessa dal comunista bachkir Mirsaid Sultan Galiev tocca i Sovietici. Nato nel 1892
in una etnia colonizzata dalla Russia, Galiev considera la rivoluzione il miglior mezzo per
liberare i popoli asserviti.
Sin dal 1914, il fondatore dell’Organizzazione militante tartara dei socialisti internazionalisti
chiama i soldati tartari e bochkirs dell’armata zarista a ribellarsi, poiché “i Russi, non contenti di
aver sottomesso i Tartari, i Bechkirs, i Turkmènes, i Caucasi, ecc., vogliono sottomettere i
Turchi e i Persiani” (Rorlich).
Galiev raggiunge i Bolscevichi a Bakou nel 1917 e non tarda a diventare il capo del partito
musulmano più influente. Nominato a capo del Commissariato delle nazionalità da Stalin, il
comunista bachkir sostiene che “tutti i popoli musulmani colonizzati sono dei popoli proletari”
senza forti contrasti di classi sociali e che la liberazione delle colonie è una condizione
necessaria per le rivoluzioni in Occidente.
“Tanto a lungo quanto l’imperialismo internazionale….conserverà l’Oriente allo stato di
colonia, regnando come padrone assoluto su tutte le ricchezze naturali” predice Galiev, “egli ha
la certezza di un esito favorevole in ogni conflitto economico puntuale con le masse lavoratrici
metropolitane, perché è perfettamente capace di chiudere loro il becco accettando di soddisfare
182
le loro rivendicazioni economiche” (Rarlich; Bennigsen e Lemercier-Qelquejay, 1960, 1986;
Bennigsen e Enders Wimbush, 1979; Carrère d’Encausse e schram, 1969).
Sultan Galiev è arrestato nel 1928 e, come ci si poteva aspettare, giustiziato nella sua prigione
nel 1941.
In quel periodo, per quelli che prima si erano riconosciuti nella lotta anticoloniale, la maggior
parte delle promesse del 1919 erano scomparse dal comunismo mondiale. Se l’anticolonialismo
di Wilson è fallito nel 1919, si può dire altrettanto dell’anticolonialismo di Lenin, dal momento
che l’URSS è diventato uno Stato dotato di colonie proprie. Da questo punto di vista, il 1919,
anno decisivo,è forse stato tanto fondamentale per i movimenti che lottavano contro i sistemi in
carica quanto per i paesi imperialisti che tentavano di fare la pace tra di loro.
183
Referenze
(pag. 222)
184
24. La Grande Guerra: una rottura culturale?
Dimitri VEZYROGLOU
La storia culturale diffida delle rotture. Che sia in materia di rappresentazioni, di forme
artistiche, di correnti intellettuali o di mentalità, essa tende a privilegiare le tendenze a lungo
termine e i lenti cambiamenti, ancorati in un sistema di contesti (sociale, politico, ideologico,
tecnico, ecc.) che imprimono al fatto culturale dei ritmi d’evoluzione a volte concordanti, a
volte discordanti. Un fenomeno storico eccezionale da tutti i punti di vista come la Grande
Guerra, è pertanto l’occasione, per lo storico della cultura, per interrogare questa nozione di
rottura, di confrontarsi con essa.
Innanzitutto perché questo avvenimento delinei chiaramente nella coscienza stessa dei
contemporanei, un prima e un dopo: che questo sentimento sia o non sia giustificato, le società
degli anni 1920 e 1930 hanno avvertito il primo conflitto mondiale come il momento di ingresso
brutale nella modernità. Ma anche perché il fenomeno di lutto, che segna con le sue impronte le
mentalità di questo lungo dopoguerra, costituisce un considerevole prolungamento culturale
della guerra.
Qui si tratta di introdurre una riflessione sulla Grande Guerra nella prospettiva della storia
culturale dell’inizio del ventesimo secolo, e non di fare una storia culturale della Grande Guerra
(vedi, per esempio, Becker, 2005), anche se è indispensabile prendere in considerazione alcuni
dei suoi elementi, così che la disputa che mette contro i sostenitori del “consenso” alla violenza
della guerra e quelli della “costrizione” nel cuore del quale si trova la nozione di
“maltrattamento” che entra in risonanza con le tematiche della storia culturale.
La Grande Guerra come una rottura culturale
1. Un’influenza duratura della cultura di guerra
La Prima Guerra Mondiale ha fortemente investito il campo culturale, in tutti i suoi settori, sia
altolocati che popolari.
Dal romanzo alla cartolina, dal film all’opera e alla canzone di concerto, tutti i supporti sono
stati utilizzati come vettori di una cultura di guerra che combina i leitmotiv patriottici,
l’esaltazione della combattività, lo spirito di sacrificio e la trasfigurazione della guerra in
“guerra di razza e di civiltà” (Audoin-Rouzeau e Becker, 2000 ).
Apollinaire, poeta dell’amore e del desiderio, trova nella guerra (egli si arruola come volontario
nell’esercito francese) allo stesso tempo un soggetto di stupore e un motivo di declinazione del
desiderio. In “Calligrammes” (1913-1916), raccolta di poemi scritti per l’essenziale durante la
guerra, quando Apollinaire si trova al fronte, diversi testi si basano su un parallelo costante tra
la guerra e l’atto d’amore, e tradiscono un vero stupore davanti allo spettacolo della guerra. Così
si può leggere, per esempio, in “Fête“:
“Feu d’artifice en acier
Qu’il est charmant cet éclairage
Artifice d’artificier
Mêler quelque grâce au courage
( ….)
L’air est plein d’un terrible alcool”
E in un poema dal titolo molto significativo, « Merveille de la guerre »: « Que c’est beau ces
fusées qui illuminent la nuit » . Il poeta è sedotto dall’esperienza di guerra tanto come spettacolo
che come azione, che gli procura stupore, ebbrezza, addirittura fascino, nel senso forte –
185
sessuale – delle parole: “Mon désir est devant moi / Derrière les lignes boches”, confessa nel
poema “Désir“.
L’esperienza e l’espressione singolari di un poeta come Apollinaire non devono nascondere il
fatto che la cultura di guerra si è estesa all’insieme delle società belligeranti costrette a
conoscere la stessa ebbrezza, lo stesso fascino per le gesta di guerra. Gli stessi bambini, come lo
ha evidenziato bene Stéphane Audoin-Rouzeau per la Francia (1993) o come lo descrive in
modo così sorprendente per la Germania Sebastian Haffner (200), hanno visto il loro ambiente
culturale invaso dalla guerra. Che si tratti della scuola, dei giochi o degli svaghi familiari, la
guerra è onnipresente fino al mondo dell’infanzia, non solo come contesto, ma persino come
oggetto di illusione. La testimonianza di Sebastian Haffner, nato nel 1907, è a questo proposito
molto illuminante.
“ La guerra è un grande gioco eccitante, avvincente, nel quale le nazioni si affrontano;
essa procura delle distrazioni più sostanziali e delle emozioni più deliziose di tutto ciò
che può offrire la pace: ecco ciò che provarono dal 1914 al 1918, dieci generazioni di
scolari tedeschi.(…) Si andava a scuola, si imparava a scrivere a far di conto, più tardi il
latino e la storia, si giocava con i propri compagni, si andava a passeggio con i propri
genitori, ma tutto ciò poteva riempire un’esistenza? Ciò che dava sole alla vita e colore
alle giornate, erano le operazioni militari: Se una vasta offensiva era in corso, con dei
prigionieri per centinaia di migliaia, dei forti espugnati e “ delle conquiste considerevoli
in fatto di guerra “, allora era la festa, si poteva far lavorare senza fine la propria
immaginazione, si viveva intensamente, come quando un giorno si sarebbe stati
innamorati”. (Haffner, op. cit., pp. 34-9).
Una tale presenza della cultura di guerra non poteva dissolversi prontamente una volta firmati
gli armistizi.
Prima di tutto perché i bambini del periodo del conflitto diventano gli adolescenti, poi gli adulti
degli anni 1920 e 1930 e, segnati dalla guerra all’età della loro apertura intellettuale al mondo,
la loro cultura – cioè il loro modo di intendere il mondo – ne porterà tracce indelebili. Ma anche
perché il dopoguerra europeo è segnato in genere dalla persistenza di alcuni elementi della
cultura di guerra, come lo dimostra l’onnipresenza del discorso patriottico, perfino
nazionalistico in una Europa
che ha consacrato la nazione come forma superiore
dell’organizzazione politica. La pregnanza dello spirito “vecchio combattente” fa perdurare la
cultura di guerra, impedendo il risorgere del ricordo traumatico: l’interiorizzazione e il consenso
alla violenza della guerra dei combattenti erano il tabù assoluto della cultura di guerra.
L’irruzione della cultura di guerra, la sua propaganda così caratteristica del periodo 1914 – 1918
ha dunque trasformato le società europee nel rapporto con la loro identità e indotto ad una
rottura culturale.
Questa rottura prende tuttavia una forma molto più eclatante in ambito artistico.
2. Un momento di splendore delle forme e degli oggetti culturali
Durante la Grande Guerra, una generazione di artisti intraprende un accostamento radicale a
tutte le modalità tradizionali di esistenza dell’arte. Il movimento Dada ne è l’esempio migliore,
non solo per il suo accanimento a sconvolgere l’ordine tradizionale dell’arte, ma anche, e forse
soprattutto, per gli stretti legami che lo uniscono al suo contesto spazio-temporale.
Dada è nato a Zurigo, nel 1916: è in questa isola di pace, nel cuore di una Europa devastata
dalla guerra, in piena battaglia di Verdun, che intorno a Tristan Tzara si è costituito un
movimento che si estenderà mano a mano in tutto il continente- e al di là – e di cui il punto di
partenza e di riunione è il rigetto di tutti gli antichi quadri – estetico, storico, sociale, nazionale –
dell’arte. Dalla poesia alla pittura, dalla scultura alla musica, tutte le arti sono per Dada supporti
186
e oggetti al tempo stesso di una rivolta radicale che mirano non solo ad abolire le categorie
culturali stabilite, ma a far vacillare, perfino crollare, una cultura europea ritenuta sclerotizzata e
sclerotizzante.
Le “ready-made” di Duchamp ne sono una buona dimostrazione. Apponendo la propria firma su
un oggetto manufatto di uso corrente, l’artista realizza una triplice provocazione: nega la
superiorità delle forme artistiche su quelle degli oggetti funzionali e confonde il limite tra arte e
trivialità; si priva poi del processo laborioso attraverso il quale l’artista, almeno dal
Rinascimento, afferma il valore e l’individualità della sua opera; sconvolge, infine, il sistema
delle Belle-Arti che il XVIII e il XIX secolo avevano pazientemente costruito e che isolava la
produzione artistica in un insieme di codici reputati immutabili.
Il fatto che questo movimento sia apparso durante la Grande Guerra non ha niente di fortuito. La
guerra, concepita come l’apocalisse del pensiero europeo, è proprio l’elemento scatenante di
questa rivolta, di cui il nichilismo distruttore sembra autorizzato dalla violenza ambientale.
Dada esprime una profonda nausea davanti a questa autodistruzione di una civiltà, ma gli offre
nello stesso tempo l’occasione e il pretesto della propria impresa di distruzione. Come pure, il
carattere internazionale e cosmopolita di Dada (il movimento si estende in tutta l’Europa, così
come negli Stati Uniti e in Giappone) può essere letto come una reazione alla cappa di piombo
nazionalista che si è abbattuta sull’Europa nel 1914 e di cui la cultura di guerra è la
manifestazione più pesante. Dada si struttura senza contesto intorno all’esperienza e alla
memoria del conflitto. (Becker, A; 2002).
La guerra è dunque contemporaneamente l’origine e il teatro di una rottura fondamentale
nell’ordine artistico. Ma la vecchia concezione europea della cultura perde così terreno di fronte
alla cultura di massa.
3
Lo squilibrio nella cultura di massa.
Il momento della Grande Guerra, vissuto come l’ingresso nella modernità culturale, coincide in
effetti con l’inizio del regno della cultura di massa. Questo movimento di comunione e di
tecnicizzazione culturali contribuisce a far esplodere la rappresentazione tradizionale e di élite
della cultura ereditata dal sistema delle Belle Arti. Il periodo tra le due guerre vede così
trionfare due degli elementi più rappresentativi della cultura di massa del XX secolo: lo sport e
il cinema.
Nell’ambito dello sport, le grandi gare ciclistiche, le partite di calcio o di pugilato diventano
avvenimenti intorno ai quali si riuniscono folle innumerevoli: 120.000 persone assistono nel
1921 a Jersey City, alla partita Dempsey-Carpentier; lo stadio di Wembley, inaugurato nel 1924,
accoglie fino a 250.000 spettatori per la finale della Coppa britannica. La prima coppa del
mondo di calcio si terrà nel 1930 e questo avvenimento diventerà sin dalla sua prima edizione
europea, nel 1934, il simbolo maggiore della nuova cultura popolare, ampiamente comunicato e
con un indice di ascolto sempre crescente.
Il cinema conosce una netta popolarità durante la Prima Guerra Mondiale: svago privilegiato
delle retrovie, divertimento apprezzato dai soldati del fronte, si propaga, nel dopoguerra, fino
alle zone rurali più arretrate.
E’ il vettore di una delle principali rivoluzioni culturali europee, prodotta durante la guerra: la
scoperta dell’America. Sin dal 1915, il mercato europeo è inondato di films americani, tanto a
causa di fattori congiunturali (la caduta della produzione europea a motivo del conflitto:
mobilità del personale, requisizione delle fabbriche…) quanto a causa di fattori strutturali (la
difficoltà del rinnovamento delle forme cinematografiche in Europa degli anni 1900). La
constatazione è senza richiamo: nel 1914, più dei due terzi dei films proiettati nel mondo sono
dei films francesi; nel 1918, più dei due terzi dei films proiettati nel mondo sono americani.
187
Ma la rottura non è solamente economica: la scoperta dei films di David W. Griffith, di Thomas
H. Ince o di Cecil B. De Mille costituisce un duro colpo per i cinedilettanti e i cineasti europei,
senza neanche parlare dello sconvolgimento che rappresenta quella di Charlie Chaplin. La loro
gestione del montaggio, il loro uso delle inquadrature ravvicinate e di primissimi piani,i loro
movimenti di camera, la loro innovazione in materia di regia costituiscono tanti elementi di
rottura formale, quante le lezioni di cui il cinema sarà d’ora innanzi tributario.
E’ d’altronde notevole il fatto che questi cineasti siano stati affascinati dalla rappresentazione
estetica della guerra: Griffith, in Naissance d’une nation (The Birth of a Nation, 1914) e
Intolérance (Intolerance, 1915), Ince in Civilisation (Civilization, 1916) o De Mille in Jeanne
d’Arc (Joan the Woman, 1916) hanno fatto della rappresentazione della guerra un campo di
sperimentazione per la rivoluzione della sintassi cinematografica. Dal grande pubblico
all’avanguardia cinedilettante si impone ormai il modello americano, tanto in campo estetico
quanto nell’ambito commerciale.
Questo squilibrio in epoca di cultura di massa si accompagna dunque, durante la Grande Guerra
e in relazione ad essa, ad un fascino crescente, nella cultura popolare americana, per gli Stati
Uniti.
Il diffondersi in Europa del Jazz e dei suoi derivati o il successo crescente della cinematografia
americana, i grandi avvenimenti sportivi metteranno ormai regolarmente l’America in testa alla
scena culturale europea: la vittoria del pugile americano Dempsey, il 2 luglio 1921 a Jersey
City, contro il francese Carpentier, ne è l’emblema.
Pertanto si può considerare questa idea di rottura, cioè una periodizzazione della cultura
europea, tutto sommato, fortemente legata alla percezione che ne abbiano potuto avere i
contemporanei?
Contro l’idea della rottura culturale
1. Un ingresso nella modernità artistica e culturale largamente sollecitato prima della
guerra
L’esplosione delle vecchie forme in arte, di cui Dada è la manifestazione più clamorosa e più
tangibile, evidentemente non è avvenuta in una sola volta. Le prime incrinature in campo
artistico tradizionale sono apparse sin dalla metà del XIX secolo. Alcune opere hanno
simbolizzato fortemente questo cambiamento, questa emancipazione progressiva nei confronti
delle Belle Arti. Per riferirsi a degli esempi francesi: l’Olympia di Manet, nel 1863, sfidava ad
esempio le regole della rappresentazione del nudo femminile; l’uomo di l’Age d’airain di
Rodin, nel 1876, sembrava annunciare l’alba di una nuova era dell’umanità; i quadri di Monet
che rappresentano la stazione Saint-Lazare, nel 1877, facevano entrare con forza i segni
tangibili della modernità in un ordine pittorico che continuava ad ignorarli.
Lo stesso Dominique Kalifa ha mostrato bene che la cultura di massa è negata nel corso di un
processo che risale alla metà del XIX secolo, perfino agli anni 1830, periodo durante il quale le
società europee vivono un profondo cambiamento culturale legato ad uno spazio crescente per
la tecnica e per l’immagine (Kalifa, 2001). Questo cambiamento si traduce in una
industrializzazione culturale progressiva rispondente alla massificazione del pubblico (è valido
per la stampa come per il libro, il teatro e alla fine del secolo per il cinema), e sbocca in
un’accelerazione del tempo sociale e in una spettacolarizzazione della società (Schwartz, 1998).
E’ a cavallo tra il XIX e il XX secolo che, in tutti gli ambiti artistici e in tutta l’Europa, avviene
la più grande rivoluzione che dà origine alla modernità culturale. In letteratura, gli esempi sono
tanti, si può riportare quello di Apollinaire che, sin dal 1903 con “Les Mamelles de Tirésias
(l’opera è ultimata e rappresentata per la prima volta nel 1916), inventava il termine e la nozione
di “surrealismo”.
188
Lo stesso Apollinaire apriva la sua raccolta “Alcools” (1912) con un poema, “Zone”, che
recitava fin dai primi versi: “Dopotutto sei di là dal vecchio mondo”, e che cantava la poesia del
mondo moderno, esaltando una mistica e un’estetica della trivialità. Con questo testo,
distruggeva le antiche forme poetiche e decretava la nascita di un mondo nuovo e libero del
quale si riproponeva di celebrare la bellezza.
Una rivoluzione simile si attua nel campo teatrale, tanto nella scrittura quanto nella
sceneggiatura, tra gli anni 1870 e 1900 con autori come Ibsen o Tchekhov e compagnie come il
Teatro d’Arte di Stanislavski a Mosca, il Teatro libero di Antoine a Parigi, poi, le esperienze
tedesche di espressionismo teatrale di Max Reinhardt. Il teatro moderno del XX secolo, di cui
Brecht o gli sceneggiatori del “Cartel“ francese (Jouvet, Dullin, Baty, Pitoeff) sono considerati
come primi rappresentanti, trova innegabilmente la sua origine in questo movimento di fine
secolo che si è, per primo, liberato dai canoni del teatro classico.
In pittura, la fine del XIX secolo costituisce anche una svolta maggiore. Dopo la rivoluzione
impressionista, artisti come Munch, Ensor o Van Gogh approfondiscono la ricerca di una
rappresentazione della soggettività permeandola di pessimismo, di dolore, persino di violenza,
aprendo anche la strada a diverse tendenze dell’espressionismo che caratterizzeranno il debutto
del modernismo pittorico.
Questi elementi si realizzeranno in schemi di rappresentazione del mondo con la costituzione di
gruppi come Die Brucke, intorno a Kirchner, poi la Blauereiter a Monaco con Kandinsky e
Macke, parallelamente alla Secessione viennese di Klimt e gli Atéliers viennesi di Schiele e di
Kokoschka, il tutto a cavallo tra il XIX e XX secolo.
Anche l’avvento del cubismo con Braque o Ricasso, nello stesso periodo, annuncia il regno
dell’astrattismo nella pittura e costituisce in tal modo esso stesso una svolta maggiore.
Tutte queste ricerche aprono la strada alla rivolta artistica radicale di Dada o della “Nouvelle
Objectivité” (Grosz, Dix ), fornendo loro strumenti, sintassi ed anche tematiche.
Nella sua stessa radicalità, nel suo furente rifiuto del vecchio mondo, Dada non può essere
concepito come un movimento senza legami e senza genealogia. Sin dal 1909, Martinetti si
serviva di una violenza simile per condannare la stessa sclerosi del pensiero artistico; egli
proclama nel suo primo Manifesto del futurismo:
1. Noi vogliamo cantare l’amore per il pericolo, per l’abitudine, per l’energia e per la
temerarietà.
2. Gli elementi essenziali della nostra poesia saranno il coraggio, l’audacia e la rivolta.
3. La letteratura che ha finora esaltato la staticità del pensiero, l’estasi e il sonno, noi
vogliamo esaltare il movimento aggressivo, l’insonnia ardente, il passo ginnico, il salto
rischioso, lo schiaffo e il pugno.
4. Noi dichiariamo che lo splendore del mondo si è arricchito di una nuova bellezza: la
bellezza della velocità. Un’automobile da corsa con il suo cofano ornato di grossi tubi
come dei grossi serpenti dal soffio esplosivo…un’automobile ruggente, che ha l’aria di
correre sopra la mitragliatrice, è più bella della Vittoria di Samotracia.
5. Noi vogliamo cantare l’uomo che tiene il volante, di cui l’asta ideale attraversa la Terra,
lanciata essa stessa sul circuito della sua orbita.
6. Bisogna che il poeta si spenda con calore, clamore e prodigalità, per aumentare il
fervore entusiastico degli elementi primordiali.
7. Non c’è più bellezza se non nella lotta. Non capolavoro senza un carattere aggressivo.
La poesia dev’essere un assalto violento contro le forze sconosciute per costringerle a
piegarsi davanti all’uomo.(…)
8. Noi vogliamo glorificare la guerra - sola igiene del mondo -, il militarismo, il
patriottismo, l’azione distruttrice degli anarchici, le belle idee che uccidono, e il
disprezzo della donna.
189
9. Noi vogliamo demolire i musei, le biblioteche, combattere il moralismo, il femminismo
e tutte le debolezze opportunistiche e utilitaristiche.(…)
La violenza e l’aggressività sono dunque introdotte come principi vitali dell’arte. Il futurismo
costituisce in tutto ciò una forma di brutalità spirituale che annuncia in qualche modo la cultura
di guerra, ma che prepara anche il terreno al nichilismo dadaista e al volontarismo
rivoluzionario del costruttivismo russo.
Se c’è rottura in ordine artistico, essa non si colloca ,dunque, al momento della Grande Guerra,
che segna piuttosto la realizzazione di un movimento che è penetrato in tutte le arti in prossimità
del XX secolo.
2. Una rottura negata
Conviene d’altronde non confondere la posizione di Dada e dei suoi epigoni nella storia
dell’arte con la sua situazione nel campo artistico dell’epoca, cioè una situazione di marginalità,
peraltro rivendicata e coltivata. L’immediato dopoguerra è infatti segnato, in ambito culturale,
da un “ritorno all’ordine” che fa leva su una sorte di negazione della modernità, un discorso
normativo e moralistico, e un ritorno ostentato ai canoni classici (vedere, per esempio, Silver,
1991). Di qui lo scandalo che suscitano Dada e poi il surrealismo: se rivolta e scandalo c’è, è
proprio perché la società non è pronta a recepire questo appello all’abolizione degli antichi
modelli.
Questo ritorno “all’ordine” nelle arti è peraltro il riscontro di una vera e propria
occultazione del ricordo della guerra. In grande maggioranza, pittori e scrittori hanno fatto
silenzio intorno al ricordo traumatizzante del conflitto (Audoin–Rouzeau e Becker, op. cit.;
Dagen, 1996); essi hanno rifiutato di prendere in considerazione e di rendere conto della
profonda dimensione della brutalità indotta dalla guerra. Il rigetto suscitato da alcune opere che
hanno tentato di affrontare questo argomento (Le Feu di Barbuse, per esempio) testimonia
l’importanza di questo tabù legato all’esperienza del conflitto.
In ogni campo, il discorso culturale dominante del dopoguerra è dunque quello di una rimessa in
ordine della società. Se rottura esiste, essa è fortemente negata da una cultura dominante che
non è pronta a cedere sotto i colpi dei rivoluzionari dell’arte. Per questo, e poiché l’abbandono
dei modelli culturali antichi è avvenuto in tempi lunghi e secondo una cronologia complessa, la
Grande Guerra non segna una “rottura culturale”.
La Grande Guerra, una piattaforma culturale
La guerra come riferimento e motivo culturali
La negazione del trauma per il discorso dominante non impedisce un ritorno ossessivo sulla
guerra nelle arti. In pittura, i Tedeschi Grosz e Dix fanno della guerra un motivo ricorrente della
loro opera, che permette loro di mettere in luce la violenza fondamentale della società moderna,
rivelata e accentuata dalla guerra.
La letteratura di guerra, con i romanzi di Barbuse (Le Feu), Remarque(À l’Ouest rien de
nouveau) o Dorgeles (Les Croix de Bois) per esempio, fornisce numerosi esempi circa
l’impronta della guerra negli animi e il suo imporsi a motivo principale e imprescindibile della
narrazione moderna.
Nel cinema, seguendo le lezioni degli americani, e in particolare di King Vidor (La Grande
Parade, 1925), i realizzatori europei hanno cercato anch’essi di rappresentare l’impresentabile,
di cogliere da una nuova estetica questa nuova e parossistica forma della violenza di guerra. E’
190
il caso, in Francia, di Léon Poirer (Verdun, visions d’histoire, 1928) o di Raymond Bernard (Les
Croix de bois, adattato da Dorgeles, 1932); in Germania, tra innumerevoli esempi, uno dei più
riusciti è certamente quello di “Quatre de l’infanterie” (Westfront ,1918, 1930).
Queste opere testimoniano innegabilmente un ardente bisogno di dire allo stesso tempo il segno,
il dolore e il lutto. Esse testimoniano molto spesso un ritorno impossibile ad una brutalità
indicibile. Molto rari sono infatti gli artisti che riescono, come Dix in alcuni di suoi disegni e
autoritratti o Cendrars nel suo testo “J’ai tué“(1919), ad esprimere la sofferenza per aver non
solo subito la violenza di guerra, ma per esserne stato un attore volontario. Dix arriva, ad
esempio, a cogliere sul proprio viso il ghigno del bruto sanguinario che la guerra aveva fatto di
lui. Se una tale lucidità resta eccezionale, è tuttavia evidente che le produzioni culturali del
dopoguerra sono segnate, tanto nella loro forma quanto nel loro contenuto, dall’esperienza del
conflitto.
2
La complessa temporalità delle “mentalità”
Resta il fatto che le temporalità della storia culturale sono complesse. La Grande Guerra è
certamente un momento critico dell’evoluzione delle mentalità europee, ma è necessario, per
misurarne la portata, esaminare da vicino i fenomeni di rimozione culturale (A. Becker, op. cit.).
L’ ”anelito di guerra nelle menti”, per riprendere l’espressione di Gerd Krumeich (2002), si
manifesta con ritmi e con una intensità peraltro diversi a seconda dei paesi, gli ambienti e le
generazioni. La rimozione culturale è certo più lenta rispetto a quella militare, ma la sua
cadenza è complessa.
D’altronde, conviene mettere a fronte delle grandi rotture artistiche e del cataclisma morale la
forza e l’insistenza del conservatorismo sociale, culturale e morale. Gli “anni folli”, simbolo di
liberazione morale e culturale in un dopoguerra stordito di jazz e di sensualità, sono proprio un
mito. La realtà dello statuto della donna, per esempio, è sintomatico di questo “ritorno
all’ordine” morale e sociale. Malgrado il conseguimento del diritto di voto in alcuni paesi e
l’illusione di una evoluzione del suo statuto sociale a motivo della sua partecipazione al
sacrificio della guerra, la donna europea ritorna molto spesso ai suoi fornelli nel dopoguerra, e
resta sottomessa ad una forte pressione conservatrice in ambito sessuale, come testimonia la
legge francese del 1920 che penalizza la contraccezione e l’aborto. Bisognerà, infine, attendere
ancora mezzo secolo – cioè sino alla fine degli anni sessanta – perché questo conservatorismo
crolli.
3
Conflitto di massa, cultura di massa
Se, infine, la cultura di massa non è nata con il primo conflitto mondiale, è innegabile che il
periodo tra le due guerre veda accentuarsi questo fenomeno: l’Europa entra allora pienamente
nell’era della cultura industrializzata su vasta scala e delle grandi manifestazioni culturali. Nel
cinema Chaplin è oggetto di un culto senza precedenti – e senza uguale poi – nel quale sono in
comunione le élites e le masse; la radiofonia – aspettando la televisione – parteciperà ormai alla
massificazione di ascolto delle grandi prove sportive.
Massificazione accelerata, industrializzazione crescente: questi due fenomeni che interessano le
nuove forme culturali risuonano come delle eco alla Grande Guerra, prima guerra massiccia ed
industrializzata di tale portata. Così in ordine militare come in ordine culturale o politico, il
tempo delle masse era arrivato. Più che una rottura, termine in definitiva ambiguo e poco adatto
alle realtà culturali, la Grande Guerra rappresenta dunque una piattaforma - decisiva - nel
processo attraverso il quale l’Europa è entrata nell’era della sua modernità culturale.
Nel momento in cui si accaniva ad autodistruggersi, l’Europa ha fatto una scoperta che ha
modificato il suo rapporto con il mondo: la scoperta della cultura americana, attraverso la
scappatoia del cinema e della musica. Questa scoperta, che sfocerà nei decenni futuri in una
191
“americanizzazione” tanto consentita quanto temuta, costituisce in definitiva la sola vera rottura
culturale intervenuta in Europa nel 1914-1918. A meno che non gli si aggiunga un’altra
rivoluzione culturale in ordine alle idee politiche: la nascita dell’idea della sicurezza collettiva,
di cui le realizzazioni concrete impiegheranno molto tempo prima di incominciare ad avere
efficacia, ma che in quanto idea e quindi fenomeno culturale, costituisce un’autentica rottura
con il mondo antecedente il 1914.
192
193
PARTE IV
IL 1945 NELLA STORIA EUROPEA
194
195
25. Introduzione all’anno 1945
L’anno 1945 vede finire una guerra che è stata all’origine di una catastrofe umana senza
precedenti. Le escursioni aeree e i bombardamenti dell’artiglieria hanno ridotto numerose città
europee in uno stato simile ad un campo di rovine. La guerra, con il suo corteo di economia
devastata, d’industrie, di strade, di ponti e di ferrovie distrutti, ha ucciso più di 40 milioni di
persone, tra cui numerosi civili. Milioni di esseri umani sono stati sistematicamente sterminati
nei campi di concentramento. Ovunque in Europa, orfani da identificare per poterli riunire a
quello che restava della famiglia, e soldati che tentavano di tornare in paese o prigionieri nei
campi. Ovunque, rifugiati e persone deportate. Molti di loro che tentavano di tornare a casa;
milioni di altri, di cui tedeschi che risiedevano fuori dalla Germania, i Tartari e i Ceceni in
Unione Sovietica, e altre minoranze etniche, cacciati con la forza dalle città e dai paesi che
consideravano la loro patria.
Nel febbraio del 1945, epoca durante la quale i tre leader alleati, Roosevelt, Stalin e
Churchill, si incontravano nella stazione balneare di Yalta in Crimea, sanno che la guerra è
quasi vinta in Europa. Le truppe americane e britanniche hanno attraversato il Reno e avanzano
dal Ovest su Berlino. Le truppe sovietiche sono in Lituania, in Pologna, in Bulgaria e in
Romania; hanno varcato il confine orientale della Germania e sono soltanto a 50 chilometri da
Berlino. Dunque, se è ancora necessario mantenere la cooperazione per potere mettere fine alla
guerra il più rapidamente possibile, la Conferenza di Yalta si preoccupa soprattutto di
organizzare la pace. Durante quella settimana, i leader convengono che la Germania vinta sarà
divisa in più zone di occupazione, che la Francia sarà una delle potenze occupanti, che l’Unione
Sovietica entrerà in guerra contro il Giappone e che le frontiere polacche saranno spostate verso
l’Ovest per ridurre il territorio tedesco e ingrandire quello dell’Unione Sovietica.
Gli articoli presenti in questa parte dell’opera sono stati prima presentati ad una
conferenza, che ha avuto luogo nel 2003 a Yalta, una di queste sedute ha avuto luogo, tramite il
Ministero ucraino dell’Educazione e della Scienza, nella sala di riunione del Palazzo Livadia.
Non è dunque strano che la maggior parte degli autori si erano interrogati sull’importanza della
Conferenza originale di Yalta. Non ci sono dubbi, come fa notare il Professor Borodzej, che
l’influenza di Yalta si è fatta sentire in modo duraturo su numerosi polacchi e altri popoli
dell’Europa centrale e orientale. Il sentimento di essere stati traditi può essersi indebolito col
tempo ma, come il patto Ribbentrop- Molotov negli Stati baltici, Yalta ha continuato a pesare
sulle percezioni dei popoli fino agli anni ‘80. D’altronde come il Professore Westad sottolinea
nel 1° capitolo di questa parte, non è la Conferenza di Yalta che ha condotto alla divisione del
continente ma la situazione militare in Europa alla fine della Seconda guerra mondiale. O, come
Stalin ha detto a Milovan Djilas, “ Questa guerra non assomiglia alle guerre del passato.
Chiunque occupa un territorio impone anche il proprio sistema sociale. Ognuno impone il
proprio sistema fin dove può arrivare il proprio esercito. Non può essere altrimenti”.
Come osservano molti autori, la guerra fredda non è iniziata con Yalta; le sue radici
affondano molto più lontano nel tempo. Ma con la fine della guerra, l’arena che è l’Europa ha
cessato di essere circoscritta dalla minaccia del fascismo per esserlo invece dalla competizione
militare, diplomatica, economica e ideologica tra due super potenze.
196
26. La conferenza di Yalta e l’emergenza della guerra fredda
Odd Arne Westad
I miti di Yalta
Numerosi miti circondano la riunione di Yalta nel 1945; certi sono nati subito dopo la
fine della Seconda guerra mondiale, altri sono di nascita più recente. In qualche paese europeo,
questi miti nascondono altri dibattiti, che risulterebbero molto più utili di discussioni generali
sulle decisioni prese dalle grandi potenze, ma che sarebbero comunque molto più dolorosi visto
che porterebbero ad interrogarsi sui miti nazionali che hanno fatto nascere decisioni prese al
momento in cui la Seconda guerra mondiale si evolveva in direzione di una guerra fredda. Le
questioni associate a questi miti sono, per esempio, l’esodo dei rifugiati tedeschi venuti dall’Est,
la rivolta schiacciata di Varsavia e, anche, il destino dei paesi incorporati nell’Unione Sovietica.
È spesso più semplice, soprattutto nelle aule scolastiche, parlare dell’azione combinata dei
grandi uomini di Yalta.
I principali miti di Yalta sono i seguenti: l’Europa è stata divisa a Yalta; la guerra
fredda è iniziata a Yalta.
“L’Europa è stata divisa a Yalta”
In realtà, non è stata presa nessuna decisione di questo tipo. La divisione dell’Europa è
il risultato di una guerra civile europea iniziata dal 1914. Nel 1945, i principali protagonisti di
questi conflitti, la Gran Bretagna, la Germania e la Francia, avevano smesso di essere delle
grandi potenze capaci di definire l’avvenire del continente. Le uniche vere grande potenze (o
superpotenze, secondo l’espressione consacrata usata di seguito) che esistevano alla fine della
Seconda guerra mondiale, erano l’Unione Sovietica e gli Stati Uniti. I loro obiettivi, nello stesso
tempo ideologici e strategici, si scontravano già prima del 1945 e la linea che delimitava e
divideva le regioni europee messe sotto il loro controllo non era stata tracciata dalla Conferenza
di Yalta, ma dalla situazione militare che regnava in Europa alla fine del secondo conflitto
mondiale.
“La guerra fredda è iniziata a Yalta”
Anche qui, questa affermazione deve essere corretta: la guerra fredda non trova la sua
origine nei contrasti apparsi durante la Conferenza in Crimea, né nelle particolari tensioni che
sono nate durante l’intervallo tra la riunione di Yalta (4-11 febbraio 1945) e l’ulteriore
conferenza (finale) dei capi alleati di Potsdam (17 luglio-2 agosto 1945); le sue cause sono in
effetti diverse e più profonde.
La loro natura e il loro calendario dipendono certo dalla regione d’Europa di cui si
tratta. Il confronto tra il comunismo e i suoi oppositori in Europa e negli Stati Uniti non è
iniziato nel 1945, ma nel 1917. Cosi, per i Polacchi, la guerra fredda era all’apice in Polonia
già dal 1944 (o forse anche dal 1920). L’opinione degli Ucraini è sicuramente la stessa. Nella
maggior parte delle altre regioni, la guerra fredda si è insediata più lentamente; molte cause,
d’ordine militare, diplomatico, sociale e ideologico, hanno contribuito a creare un clima di
confronto.
Visto che si tratta qui di miti di Yalta, quale è dunque “la realtà di Yalta”, cosi come è
stata percepita da quelli che vi hanno preso parte?
Le realtà di Yalta
197
Quando Franklin D. Roosevelt, Joseph Stalin e Winston Churchill si sono riuniti a Yalta
cinquantotto anni fa, stava per concludersi un conflitto maggiore. Ogni partecipante ne aveva
coscienza, anche se la durata della fase finale della guerra o la posizione esatta della forze
armate dopo il crollo del nemico – Germania e Giappone – restavano incerti. La Conferenza
verteva, allo stesso tempo, sulla fine della guerra e sull’organizzazione della pace. Questi due
aspetti erano strettamente legati, perché i tre capi consideravano che se fossero riusciti a
collaborare per mettere fine al conflitto, avrebbero avuto forte possibilità di lavorare insieme
all’organizzazione della pace. E quello che potrebbe essere definito come “tentativo di Yalta”:
vincere la guerra e organizzare la pace in modo tale da non scatenare un conflitto imminente tra
i vecchi alleati.
Se il “tentativo di Yalta” derivava da uno sforzo comune da parte dei tre capi, perché ha
avuto cosi poco successo ? La spiegazione data di solito è naturalmente l’assenza di una vera
franchezza da parte dei partecipanti: nello stesso momento in cui parlavano di cooperazione,
ognuno di loro cercava soltanto di trarre profitto della situazione. In altri termini, questo
tentativo di cooperazione era soltanto una falsa arte del dire che non corrispondeva alla realtà.
Questa interpretazione è sicuramente errata, non perché fa dell’interesse dei capi e dei
loro rispettivi paesi l’elemento determinante delle decisioni prese, ma perché afferma
l’incompatibilità di questi stessi interessi e di quello che appariva come una possibile
cooperazione (o almeno come un’assenza di conflitto). Disponiamo ormai di un gran numero di
archivi redatti prima, durante e dopo la Conferenza di Yalta provenienti dai tre paesi
partecipanti, compresa l’Unione Sovietica. I documenti personali di Stalin, riuniti negli Archivi
nazionali russi di storia moderna di Mosca, comprendono fascicoli essenziali su Yalta, come
anche nei documenti di Molotov, che risultano negli archivi di politica estera della Federazione
di Russia. Gli archivi interni dei tre campi e il
resoconto dei dibattiti fanno risultare che nessuno di loro vedeva un interesse nel far
sorgere un conflitto tra alleati, almeno non a breve.
La maggior parte degli storici che hanno esaminato attentamente la situazione
internazionale nel 1945 dopo la messa a disposizione delle nuove fonti documentarie
dell’Unione Sovietica, concordano nel dire che la rottura della cooperazione è dovuta più al
frutto della posta in gioco e del modo in cui si è evoluta, piuttosto che il prodotto di qualsiasi
intenzione negativa nei confronti dei negoziati da parte di uno degli alleati. L’evoluzione della
situazione politica e militare in Europa e in Asia orientale è stata semplicemente troppo veloce
tra Yalta e Potsdam per permettere il mantenimento di compromessi duraturi, tenuto conto del
fossato ideologico che divideva già in partenza l’Unione Sovietica dagli Stati Uniti e dalla Gran
Bretagna.
Una volta sconfitta la Germania, le discussioni vertevano su tutte le questioni legate alla
ricostruzione dell’Europa. Ognuno dei vecchi alleati voleva vedere la sua Europa realizzarsi,
anche se rischiava di compromettere la cooperazione globale. La posta in gioco futura era
troppo importante per rischiare di scendere a un compromesso.
Questa spiegazione, che associa un certo numero di condizioni strutturali preliminari ad
una situazione politica che cambiava velocemente e che sfuggiva al controllo individuale delle
potenze presenti, sembra essere sempre più privilegiata dagli storici che si cimentano nella
spiegazione della guerra fredda. Questa tendenza è principalmente dovuta alla posizione sempre
più importante che la nuova storiografia di questo periodo attribuisce al ruolo delle ideologie,
sia dal lato americano che da quello sovietico. Queste due potenze si definivano per definizione
tramite la loro ideologia: capitalismo e democrazia liberale per gli Stati Uniti, marxismo e
collettivismo per la parte sovietica. In una situazione dove queste due superpotenze dominavano
i negoziati (i Britannici furono a Yalta come a Potsdam il “parente povero”), la scissione
ideologica, rendeva difficile qualsiasi compromesso ed esigeva, da Washington e da Mosca,
una chiara determinazione politica nel ricercare una soluzione di compromesso alla controversia
se si augurava di mantenere una forma di cooperazione.
198
“La posta in gioco”
Se si tiene in considerazione questa prospettiva, è bene esaminare la posta in gioco
determinante e presente a Yalta e Potsdam (in seguito) per capire le origini della guerra fredda
sulla scena diplomatica. È molto importante osservare le reazioni dei tre capi man mano che si
svolgono gli avvenimenti, tenendo conto delle mie precedenti osservazioni sulle ideologie e il
loro funzionamento. Le idee preconcette non determinano il modo in cui gli individui risolvono
i loro problemi, ma influenzano (e qualche volta limitano fortemente) la scelta apparente delle
opzioni disponibili. Tutti i dirigenti implicati in questi negoziati erano uomini prudenti e
pignoli. Ma la loro prudenza ordinava di adottare una doppia attitudine. Da un lato non
dimentichiamo che avevano bisogno gli uni degli altri, o almeno fino a quando la guerra
continuava, da un altro lato non dare fiducia a delle motivazioni di un nemico ideologico che,
alla fin fine, si augurava di vedere il suo sistema politico trionfare sul vostro.
Permettetemi innanzitutto di evocare brevemente i tre personaggi principali della
Conferenza di Yalta e di dare qualche precisazione sul loro stato d’animo e sulla loro
concezione di diplomazia.
Franklin Delano Roosevelt
Il Presidente degli Stati Uniti, nato nel 1882 da una delle più ricche e illustri famiglie
degli Stati Uniti, era diventato durante il suo mandato il più importante dirigente progressista
della storia americana. I suoi programmi pubblici, come il New Deal, avevano aiutato gli
Americani a sormontare i peggiori effetti sociali della grande depressione e aveva permesso a
dei tecnocrati di sinistra di orientare la politica governamentale in modo tale che lo Stato
giocasse un ruolo senza precedenti nell’economia e nella vita pubblica americane. Certi
elementi permettono tuttavia di pensare che FDR concepiva innanzi tutto questa politica come
mezzo per uscire dalla crisi e per vincere la guerra, come lo ha sottolineato il suo biografo
William Leuchtenburg. Le principali realizzazioni di FDR sono state di raccogliere le sfide
dell’ideologia americana, sia nell’ ambito del paese che sulla scena internazionale, di vincere
l’autoritarismo e, di conseguenza, di accrescere le libertà americane in senso largo: in altri
termini, fare tornare gli Stati Uniti in primo piano sulla scena che avevano lasciato dopo la
Prima guerra mondiale.
Anche se indebolito dalla malattia, il presidente, a Yalta, si è impegnato a realizzare
questo progetto, convinto che ci sarebbe riuscito di più portando i suoi interlocutori a cooperare
piuttosto che a resistere. Cosciente dello statuto di grande potenza degli Stati Uniti, FDR
considerava che nulla poteva essere fatto a Yalta né altrove dagli alleati senza il consenso degli
Stati Uniti. Giocando il ruolo di bilanciere tra il vecchio imperialismo di Churchill e il
comunismo di Stalin, il presidente americano riuscì ad influenzare questi due campi in modo
quasi illimitato. Come lo aveva dichiarato lui stesso ad alcuni dei suoi più vicini collaboratori
nel maggio del 1942:
“Vedete, sono un giocoliere e non tengo mai la mano destra informata su quello che fa
la mia sinistra…. Posso agire in modo totalmente contraddittorio e per di più, sono
perfettamente disposto ad impiegare l’inganno e le bugie, se ciò può aiutare a fare
vincere la guerra”
Joseph Stalin
Il leader sovietico, nato nel 1879, era figlio di un povero calzolaio della città della
provincia georgiana di Gori, nel Caucaso, che era all’epoca una colonia imperiale russa. Di
intelligenza media, salì i gradini della scala del Partito comunista grazie alla sua enorme
capacità di lavorare e al suo gusto sfrenato dell’intrigo e di quello che chiameremo oggi la
“costituzioni di reti”; egli intravide nel marxismo il mezzo fondamentale di governare l’Unione
199
Sovietica e di definire le sue relazioni con il mondo esterno. Dopo essersi sbagliato sulle
intenzioni della sua vecchia alleata, la Germania, credette che l’alleanza con gli Stati Uniti e la
Gran Bretagna sarebbe durata di più, convinto che le rivalità, nell’ambito del campo
imperialista, prenderebbero il sopravvento su quelle che opponevano questo ultimo all’Unione
Sovietica.
Così anche Stalin considerava, sia a Yalta che a Potsdam, che nonostante il carattere
inevitabile a lungo termine di un conflitto tra l’Unione Sovietica e gli Stati capitalisti, le
relazioni tra le grandi potenze sarebbero in pratica segnate alla fine della guerra dalle
preoccupazioni americane e britanniche di ridefinire la divisione della loro egemonia
imperialista e non con uno scontro tra Washington e Londra, da un lato, e Mosca dall’altro. Se
l’Unione Sovietica giocava abilmente questa partita, in altri termini se Stalin riusciva a fare
accettare agli altri due protagonisti la legittimità dell’Unione Sovietica, presentata come una
potenza preoccupata della sua sicurezza, la guerra potrebbe essere respinta e il socialismo
rinforzato prima dell’ultima prova di forza contro l’imperialismo. Attore pieno di talento, Stalin
scelse, durante le due conferenze, di addossare il ruolo del capo di Stato che incontra i suoi
simili, reclamando la sua parte legittima di torta e allontanando in questo modo ogni sospetto
sui suoi veri obiettivi.
Winston Churchill
Il primo ministro britannico, il più anziano dei principali partecipanti di Yalta, nacque
nel 1874 a Blenheim Palace, in una delle famiglie più importanti d’Inghilterra. Data l’età, egli
esercitò funzioni già dal XIX secolo e conservò, durante tutta la sua carriera che esercitò nel XX
secolo, numerosi ideali del secolo precedente. Mentre Roosevelt e Stalin, ognuno a modo loro,
amavano considerare gli altri paesi rispetto al contenuto del loro sistema politico rispettivo,
Churchill riteneva che le relazioni internazionali fossero determinate da una combinazione di
cultura e di geostrategie. Così egli credeva fortemente, per esempio, che la cultura che divideva
il Regno Unito dagli Stati Uniti, avrebbe progressivamente riavvicinato i due paesi. Nonostante
la sua ripugnanza per il socialismo, giudicò, all’inizio, che Stalin inseguiva un obiettivo di
ragionevole sicurezza in Europa orientale. Ma da Yalta, Churchill iniziò ad accorgersi che le
esigenze di Stalin andavano al di là del ruolo molto limitato che Londra aveva intenzione di
assegnare a Mosca nell’ambito della risoluzione del dopo guerra.
Churchill, che aveva una coscienza acuta sulla perdita di potenza e d’influenza
dell’Impero britannico, sperava che gli Stati Uniti avrebbero sostenuto il mantenimento sia di
questo ultimo, sia delle forze americane in Europa, affinché l’equilibrio dei poteri in seno al
continente non andasse troppo a favore della Russia. Tuttavia, cosa abbastanza sorprendente se
si pensa all’ambiente dal quale proveniva, Churchill era assai realista per constatare che se
occorreva scegliere tra due priorità, il Regno Unito avrebbe dovuto privilegiare l’Europa e non
il suo Impero. Dopo avere tentato di ottenere da Stalin un accordo durante la visita a Mosca
nell’ottobre del 1944, sapeva che la firma del dirigente sovietico non costituiva una garanzia
sufficiente e che soltanto la presenza della potenza americana sul continente avrebbe potuto
impedire l’estensione progressiva verso Ovest dall’influenza sovietica.
Nessuna delle posizioni adottate dai principali capi riuniti a Yalta permetteva a lungo
termine di trarre facilmente un compromesso sulle questioni diplomatiche complesse, né di
assicurare il rispetto della sovranità di ogni protagonista. Ma è anche vero che, come le
prospettive considerate da Roosevelt, Stalin e Churchill proprio durante la conferenza, queste si
limitavano ad un breve periodo, e sembrava poco probabile che la grande alleanza sprofondasse
in un rapporto conflittuale e in un’acrimonia reciproca meno di un anno dopo. Per capire la
rapidità con la quale questa alleanza venne meno, conviene esaminare sia le idee in causa e la
loro percezione, sia le questioni concrete con le quali si erano confrontati i principali
partecipanti quando si riunirono qui, nel palazzo di Livadia, il 4 febbraio del 1945.
200
Mi piacerebbe a questo scopo concentrarmi su due punti essenziali evocati a Yalta: i
negoziati su l’avvenire territoriale e politico della Polonia e le discussioni relative all’entrata
dell’Unione Sovietica nella guerra contro il Giappone.
La questione polacca
Certo, considerata in modo diverso da Londra, Mosca o Washington, era stata in parte
all’origine della Seconda guerra mondiale. Per Churchill, il destino della Polonia era stato una
delle cause maggiori del conflitto e il suo governo giudicava essenziale stabilire una forma di
indipendenza polacca alla fine della guerra. Per Stalin, la Polonia permetteva innanzitutto di
misurare il punto di rottura dell’alleanza. Anche se il territorio polacco fu importante per la
sicurezza di Mosca, Stalin non aveva molto insistito, durante il conflitto, sulla forma del regime
politico di cui doveva beneficiare la Polonia nel periodo del dopo guerra. Contava soprattutto
prendere il massimo di quello che poteva ottenere senza compromettere l’alleanza: un governo a
maggioranza comunista se possibile, un governo di coalizione se necessario. Per Roosevelt,
infine, la Polonia costituiva un terreno di negoziati. Aveva meno importanza per lui - molto
meno - determinare quello che ne sarebbe stato di Varsavia piuttosto che fare durare l’alleanza
in un avvenire prevedibile.
Anche se sospettava che Stalin avesse delle mire durature già dal 1944, quando costui
tentò di privare il governo polacco in esilio, di qualsiasi ruolo nella Polonia del dopo guerra, il
presidente continuava a sperare che le sue capacità di negoziatore gli avrebbero permesso di
stabilire una forma di compromesso con il dirigente sovietico.
Le varie operazioni necessarie a riorganizzare il territorio della Polonia erano state
evocate dagli alleati in varie occasioni verso la fine della guerra e in modo abbastanza breve a
Yalta: le sue frontiere orientali furono tracciate leggermente ad Est della linea di Curzon,
all’inizio proposta come vecchia frontiera sovietico-polacca del 1920. La frontiera occidentale
doveva permettere alla Polonia di ottenere compensi da parte della Germania sotto forma di
territorio prussiano situato a est dell’Oder, ma fu convenuto di rimandare la decisione finale alla
futura conferenza di pace. A Potsdam, le tre potenze alleate concordarono per una frontiera
“temporanea” che annetteva l’insieme dei territori tedeschi situati ad est della linea tracciata
dall’Oder e la Neisse (a eccezione delle porzioni della Prussia orientale attribuite all’Unione
Sovietica) nel territorio polacco e approvarono in modo implicito l’espulsione massiva della
popolazioni tedesche presenti in quelle regioni. La “conferenza di pace” non ebbe naturalmente
luogo prima del 1990.
I dibattiti a Yalta avevano per argomento essenzialmente l’avvenire politico della
Polonia. Stalin aveva tentato di imporre un fatto compiuto riconoscendo unilateralmente il
governo polacco di Lublino, diretto dai comunisti, anche prima dell’inizio della Conferenza di
Yalta. Ma i sovietici e i loro alleati occidentali sapevano perfettamente che si trattava più di uno
stratagemma destinato ai negoziati piuttosto che una decisione definitiva; aveva soltanto
importanza, come Churchill con gran rammarico non cessò di ripetere durante tutta la
conferenza, la posizione dell’Armata rossa sul territorio polacco. Nonostante la sua
determinazione a “salvare la Polonia dalle grinfie sovietiche” il Primo Ministro era cosciente
anche prima dell’apertura della conferenza, di potere scendere al massimo, secondo i suoi
termini, ad uno “piccolo sporco compromesso”. Anche se Roosevelt scrisse a Stalin prima della
sua partenza per la conferenza, informandolo del suo “turbamento e della sua profonda
delusione” in seguito alla decisione sovietica di riconoscere ufficialmente il governo polacco, si
rendeva anche conto che gli Stati Uniti avrebbero negoziato in posizione di debolezza, visto che
le loro forze militari si trovavano a centinaia di chilometri dal paese oggetto dei suoi negoziati.
Tuttavia, i negoziati svolti a Yalta a proposito della Polonia sfociarono finalmente in un
compromesso e fu probabilmente Stalin che fece il maggior numero di concessioni sulla carta,
autorizzando la riorganizzazione del governo di Lublin in modo da includervi rappresentanti del
governo in esilio, stabilito a Londra. Ma la Polonia rivelò ugualmente le debolezze del
201
“tentativo di Yalta” perché né gli Stati Uniti, né l’Unione Sovietica erano disposti ad un
compromesso a lungo termine su una questione così fondamentale come quella della forma di
governo che avrebbe diretto il territorio situato tra la Germania e la Russia. “Non vi
preoccupate. Potremo metterlo in opera, a modo nostro in seguito” dichiarò Stalin al suo
ministro degli affari esteri Molotov, una volta stipulato l’accordo. “È il meglio che posso fare
attualmente per la Polonia”, confessò FDR al suo consigliere militare in capo, l’ammiraglio
Leahy.
L’insieme del dibattito sulla Polonia rivelò anche quanto la concezione del mondo fosse
diversa tra le grandi potenze che formavano quest’alleanza. Nonostante il rinvio ad una data
ulteriore, le questioni di legittimità a proposito del compromesso polacco riapparsero
praticamente dalla chiusura della Conferenza di Crimea.
L’entrata in guerra dell’Unione Sovietica contro il Giappone
Queste essenziali differenze di percezione apparvero molto chiaramente anche durante
le discussioni relative all’entrata in guerra dell’Unione Sovietica contro il Giappone; la
questione è raramente associata all’evocazione della disposizioni prese per l’Europa a Yalta, ma
riveste un’importanza fondamentale per la comprensione dei rapporti tra le pressioni della
diplomazia classica e la visione del mondo dei principali capi. Andava da sé che per Stalin,
l’Unione Sovietica avrebbe lanciato, ad un certo punto, un attacco contro il Giappone, (ma
soltanto una volta vinta la guerra in Europa e preferibilmente dopo che i combattimenti nel
Pacifico avessero indebolito l’esercito imperiale giapponese, al fine di garantire una vittoria
facile). Ci dimentichiamo spesso che Stalin e lo stato maggiore sovietico pensavano seriamente,
e fino ad una data così lontana come quella del mese di gennaio del 1945, all’ipotesi di
un’aggressione giapponese contro l’Unione Sovietica e sapevano che i mezzi militari sovietici
erano così disseminati, che una tale eventualità avrebbe avuto della conseguenze catastrofiche
sulle sue disposizioni strategiche, senza parlare della sua capacità d’influenza, verso le fine della
guerra in Europa, grazie ad un connubio di pressioni politiche e militari. Stalin giudicava
inevitabile la guerra con il Giappone perché il capitalismo giapponese considerava l’Unione
Sovietica come il suo nemico mortale (qualunque fossero i conflitti che l’opponevano
all’occidente).
Tuttavia dal punto di vista americano, il conflitto sovietico-giapponese non sembrava
così evidente. Il presidente Roosevelt al contrario, credeva fortemente che gli Stati Uniti
dovessero incitare l’Unione Sovietica ad entrare in guerra. Gli incaricati alle previsioni di
Washington consideravano questo intervento indispensabile per tre validi motivi, e nessuno di
questi derivava dall’ingenuità, a volte attribuita, al presidente. Il primo di questi motivi era che
l’entrata in guerra dell’Unione Sovietica avrebbe permesso di evitare, durante la prima parte
della guerra, la morte dei soldati americani ad un livello che oscurerebbe le perdite elevate che
gli Stati Uniti avevano subito durante la campagna del Pacifico. Il secondo motivo derivava dal
fatto che, nonostante l’elaborazione da parte degli Stati Uniti di una nuova arma che secondo i
suoi partigiani “avrebbe rivoluzionato la guerra”, non esisteva nessuna assicurazione che una
tecnologia atomica, non essendo mai stata oggetto di prove, avrebbe prodotto effettivamente dei
risultati. Senza una tale arma, l’invasione dell’arcipelago nazionale giapponese poteva diventare
un impresa lunga e ardua. In terzo luogo, infine, in assenza di una entrata in guerra dei sovietici
prima della disfatta del Giappone, non solo la posizione degli Stati Uniti in Asia orientale
sarebbe stata indebolita dalle perdite che sicuramente avrebbero subito, ma anche il
mantenimento della neutralità sovietica avrebbe lasciato a Mosca la piena libertà di rinforzare la
sue posizioni altrove, compreso in Europa e in Medio Oriente, mentre il conflitto giungeva al
suo termine.
In altri termini, gli Stati Uniti avevano bisogno, a Yalta, di giungere ad un compromesso
con i sovietici, in modo da difendere meglio i loro interessi nell’ultima fase della guerra e dopo
la fine di questa. Si stimò che la diplomazia americana aveva ottenuto un enorme successo
202
quando Stalin accettò finalmente di impegnarsi a favore dell’entrata in guerra dell’Unione
Sovietica sul teatro delle operazioni dell’Asia orientale, dopo la conclusione dei combattimenti
in Europa. Questo compromesso rivelò che il “tentativo di Yalta” poggiava su quello che i
principali partecipanti alla conferenza consideravano, sempre qui, sessanta anni fa, come una
necessità per le grandi potenze durante l’ultima fase della guerra. Ma, ma mentre il divario
ideologico si allargava troppo per potere essere colmato. in Europa nel momento in cui
conveniva definire la politica del tempo di pace, la percezione del ruolo di ognuno dei
protagonisti evolse considerevolmente in Asia orientale tra le conferenze di Yalta e di Potsdam.
Nonostante la poca fiducia generalmente concessa alle motivazioni di Stalin a Yalta, gli alleati
vedevano le forze militari sovietiche come una risorsa comune. Sei mesi dopo, l’Armata Rossa
divenne velocemente più una minaccia che una risorsa.
Conclusioni
Il tentativo di Yalta – e il suo fallimento - avevano per scopo di portare la Russia ad una
forma di cooperazione con il resto dell’Europa e con gli Stati Uniti. Ho spiegato a lungo perché
aveva fallito nel 1945 e avesse potuto riprendere soltanto alla fine della guerra fredda. Ma al di
là della guerra, ragioni più ampie spiegano perché questo progetto sia stato ed sia ancora critico.
Per poter svilupparsi in quanto Stato, la Russia era passata, come gli Stati Uniti, da una
conquista continentale a occupare una posizione particolare che la poneva naturalmente al
centro delle nazioni che la circondavano. Questa situazione non appare così chiara da nessuna
parte come in Crimea, soprattutto se si risale a duecento anni fa. Credo che la divisione
dell’Europa non sia totalmente superata – è questa la missione di cui è investito il Consiglio
d’Europa – se non quando la Russia evolva, tramite una sua mutazione interna, passando dallo
stadio d’Impero a quello di uno Stato che desideri essere integrato all’Europa per le sue ragioni.
Questo procedimento non è sconosciuto agli altri paesi e impiegherà del tempo. Discutendo
dell’argomento che ci riguardava, contribuiamo a questa evoluzione, ed è la ragione per la quale
mi sento onorato di essere stato invitato a presentarvi questo avvenimento.
27. Yalta, Potsdam e l’emergenza della guerra fredda: la visione del
Regno Unito alla luce di recenti ricerche
Martin McCauley
Nel novembre del 1917, Arthur Balfour, segretario di Stato britannico agli Affari Esteri,
indirizzò una lettera a Lord Rothschild, capo famiglia del ramo inglese di quella dinastia
bancaria ebrea, che prometteva il sostegno del Regno Unito all’azione condotta dal movimento
sionista a favore della creazione di una patria ebrea in Palestina. In un altro documento scoperto
recentemente, Balfour dichiarava che la Gran Bretagna non aveva mai avuto la minima
intenzione di mantenere questa promessa. Si trattava di una manovra tattica, destinata soltanto a
riunire questo movimento al campo britannico durante la Prima guerra mondiale.
Stalin riutilizzò, per conto suo, questa tradizione balfouriana durante la Grande guerra
patriottica dal 1941 al 1945. Fece numerose promesse che non aveva intenzione di mantenere,
soprattutto a proposito della Polonia. I suoi discorsi erano manovre tattiche che avevano lo
scopo di rinforzare la sicurezza dell’Unione Sovietica. Churchill fece lo stesso, come d’altronde
Roosevelt.
203
La conferenza di Yalta
Quale percezione la Gran Bretagna aveva dei suoi interessi a Yalta? Quali obiettivi si
fissarono e in quale misura furono raggiunti?
La situazione militare è la chiave di Yalta. Di fatto, le questioni militari vi occupavano
il primo posto. L’armata Rossa era già presente sul suolo tedesco, in Romania, Bulgaria,
Polonia, Cecoslovacchia, Ungheria e si preparava a prendere la capitale austriaca, Vienna.
L’offensiva delle Ardenne (la battaglia delle Ardenne) lanciata dal dicembre del 1944 al
gennaio del 1945 aveva sorpreso gli alleati occidentali e fatto cadere numerosi capi militari
nello smarrimento: la presa della Germania sarebbe stata più difficile del previsto. Nella
seconda metà dell’anno 1944 l’ottimismo del generale Eisenhower era stato tale, che aveva
scommesso con il generale Montgomery che gli alleati sarebbero stati a Berlino e che la guerra
sarebbe stata conclusa il giorno di Natale del 1944.
Edward Stettinius, segretario di Stato americano, sottolinea la realtà della situazione:
“Non bisogna mai dimenticare che al momento della Conferenza di Crimea, i
consiglieri militari del presidente Roosevelt gli avevano appena fatto sapere che la resa
del Giappone potrebbe probabilmente non avere luogo prima del 1947, o anche più
tardi. Lo avevano informato che senza la partecipazione dell’Unione Sovietica, la presa
del Giappone potrebbe costare un milione di morti all’esercito americano (le stime
britanniche erano di 500.000 morti e altrettanti feriti). Bisogna anche ricordarsi che
all’epoca della Conferenza di Yalta, il perfezionamento della bomba atomica restava
incerto e visto che la battaglia delle Ardenne aveva ritardato la nostra progressione in
Europa, ignoravamo quanto tempo occorrerebbe perché la Germania crollasse…La
speranza fiduciosa di una fine rapida della guerra contro la Germania fu oscurata”.
Per Roosevelt, tre questioni importanti si ponevano a Yalta: la disfatta della Germania;
la disfatta del Giappone; la creazione della Nazioni Unite. L’ONU non poteva imporre nessuna
sanzione senza un voto all’unanimità del Consiglio di sicurezza. Il punto di vista di Roosevelt
era il seguente: “La cosa più importante è mantenere l’unità delle tre grandi potenze, di vincere
contro la Germania, poi di riunirle intorno ad un tavolo per mettere a punto un’organizzazione
mondiale”.
Quali erano le conseguenze per Churchill ? Era messo da parte. Churchill si augurava di
coordinare un approccio comune prima della conferenza, ma questa proposta non suscitò
l’interesse di Roosevelt. Le fonti sovietiche contengono qualche riferimento poco lusinghiero
nei confronti di Churchill. Sergo Beria, il figlio di Laventry Beria che faceva parte della squadra
incaricata di ascoltare le conversazioni a Yalta, fa notare come le guardie sovietiche
rispettassero Roosevelt, ma che scherzassero su Churchill. Quest’ultimo aveva difficoltà a
prendere sonno e faceva un considerevole consumo di alcool. Sapeva che tutte le stanze erano
piene di microfoni e provava un piacere maligno ad esprimersi in un inglese sottile, da
complicare il compito dei traduttori.
Roosevelt aveva riflettuto sui suoi obiettivi politici, e non era affatto il caso che
Churchill gli facesse cambiare parere. Rifiutò semplicemente di discuterne con questo ultimo.
Churchill viaggiava a fianco della jeep che trasportava Roosevelt e tentava di affrontare certe
questioni, ma otteneva come sola risposta che tutto era già stato già discusso e deciso. La
difficoltà derivava in parte dal fatto che Roosevelt considerava l’Unione Sovietica come un
partner nella gestione del mondo del dopo guerra. Gli Stati Uniti avevano intenzione di
smantellare l’impero coloniale britannico e, in questo, Washington aveva più punti in comune
con Mosca che con Londra.
204
Dl punto di vista occidentale, il principale problema era quello della Polonia. Il dominio
sovietico di questo paese era stato concesso a Teheran. L’accordo sulle percentuali fatto tra
Churchill e Stalin nel ottobre del 1944 non citava la Polonia, ma il resto dell’Europa dell’est e
del sud-est, ritagliato in zone di influenze – in particolare la Grecia (90-10%) a favore
dell’ovest, la Romania (90-10%) a favore dell’Unione Sovietica, la Bulgaria (75-25%) a favore
dei sovietici, e anche la Yugoslavia e l’Ungheria (50-50%). Roosevelt e Churchill convinsero
Stalin ad accettare alcuni ministri polacchi di Londra nel governo di Lublin, Churchill
desiderava che fossero loro attribuiti otto o dieci mandati. Churchill non poteva affrontare Stalin
da solo. Tentò di ottenere l’appoggio di Roosevelt, ma quest’ultimo preferiva collaborare con
Stalin e non poteva permettersi di avere discussioni con lui. Churchill aveva certo qualche carta
da giocare a Yalta, ma in conclusione, né lui né Roosevelt furono pienamente soddisfatti del
risultato della conferenza.
Stalin era molto meglio informato di Churchill o di Roosevelt. Burgess e Maclean gli
fornivano dei documenti relativi alla politica britannica e Kim Philby si dava allo spionaggio.
Alger Hiss, agente sovietico del dipartimento di Stato, faceva parte della squadra di Roosevelt a
Yalta. Stalin sapeva esattamente quello che Roosevelt era disposto a concedergli per ottenere la
partecipazione dell’Unione Sovietica nella guerra contro il Giappone. Roosevelt, da parte sua,
non si rendeva conto che Stalin era impaziente di entrare in guerra.
Per Churchill, la Conferenza di Yalta era sfociata in una Dichiarazione sull’Europa
liberata; che parlava di democrazia, di libertà, di sovranità. L’esame dei documenti del Foreign
Office (ministero britannico degli Affari Esteri) rivela che questa dichiarazione sostituiva nel
suo spirito l’accordo sulle percentuali dell’ottobre del 1944. Non era un caso per Stalin.
Churchill ebbe ugualmente un motivo di soddisfazione con la Spagna: Franco restava al suo
posto. La sua caduta avrebbe permesso ai comunisti di prendere il potere e ciò avrebbe causato
dei problemi riguardo allo stretto di Gibilterra. La Russia aveva delle mire sulla Libia e su
Tangeri. Nella ripartizione delle carte nella partita di Yalta, Stalin pensava probabilmente di
possedere tre assi in mano sua; Roosevelt credeva di averne due o tre in mano, mentre Churchill
non ne possedeva alcuno. Di fatto disponeva probabilmente soltanto del due di fiori e del due di
picche!
Gli americani non ignoravano che il pagamento delle riparazioni da parte della
Germania fosse una necessità per l’Unione Sovietica, ma a Yalta non venne stabilita alcuna
somma. Essi pensavano ugualmente che quest’ultima avrebbe avuto bisogno di importanti
prestiti americani dopo la guerra. A causa del conflitto, la Gran Bretagna si trovava sull’orlo del
fallimento ed era cosciente che avrebbe dovuto beneficiare di prestiti americani alla fine della
guerra.
La delegazione britannica fu evidentemente soddisfatta dei risultati della conferenza a
causa della straordinaria impressione che Stalin aveva fatto su di essa, a cominciare da Churchill
e fino all’ultimo dei suoi collaboratori.
“Non ho mai conosciuto un russo che sia così alla mano e così accomodante. Egli ha
dato prova di estrema bontà. E’ un grande uomo e spicca in modo impressionante sugli
altri due statisti che ormai invecchiano”, fece notare Alexander Cadogan,
sottosegretario permanente al Foreign Office.
Stalin si mostrò molto accomodante. Acconsentì, dopo essersi opposto inizialmente, ad
accordare alla Francia una zona ed un seggio in seno alla Commissione alleata di controllo.
Accettò ugualmente, ancora una volta dopo un rifiuto iniziale, la modalità di scrutinio proposta
dagli Americani per il Consiglio di sicurezza, permettendo così la creazione
dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Churchill conservava il ricordo di Neville
Chamberlain, Primo ministro britannico che era stato tratto in inganno da Hitler. “Quel povero
Neville Chamberlain credeva di potersi fidare di Hitler. Si sbagliava. Ma io non penso di
sbagliarmi a proposito di Stalin”.
205
Tra Yalta e Potsdam
L’attitudine britannica cambiò radicalmente dopo Yalta: la soddisfazione lasciò il posto
alle disillusioni. La Gran Bretagna stimò che i Russi non cercassero di risolvere le questioni
relative alla Commissione consultiva europea. La conclusione a cui giungeva era che i Sovietici
sperassero di raggiungere il Reno alla fine della guerra e che fossero stati sorpresi dalla rapida
avanzata degli altri alleati. Avevano deciso così di conservare tutto ciò che detenevano. Un
funzionario del Foreign Office deplorò che i termini “democrazia” e “cooperazione” avessero
un significato diverso in russo. Lì, la democrazia era una “democrazia guidata” e la nozione di
cooperazione significava che ogni potenza potesse agire di testa propria nell’ambito della
propria zona, con il consenso degli altri.
L’Unione Sovietica iniziò ad apparire come un potenziale nemico per l’avvenire. Questa
idea fu espressa per la prima volta dai capi di stato maggiore il 2 ottobre 1944, poi di nuovo nel
maggio del 1945. Essi avevano ricevuto da Churchill il compito di valutare la possibilità di
un’offensiva militare contro l’Unione Sovietica, in caso di conflitto nelle negoziazioni tra
quest’ultima e la Gran Bretagna.
Il 24 maggio 1945, Churchill espresse la sua inquietudine riguardo l’espansione
dell’“orso” in Europa. Incaricò i capi di stato maggiore di elaborare un piano militare per
ricondurre l’orso russo a Mosca prima della smobilitazione delle truppe americane e
britanniche. L’11 giugno 1945, Churchill tracciò un triste bilancio della situazione in Europa: I
Russi sono molto potenti in Europa”.
Churchill avrebbe voluto che gli alleati mantenessero le posizioni raggiunte alla fine
della guerra, allo scopo di negoziare un accordo favorevole sull’accesso ai settori occidentali di
Berlino. Ma gli Americani non erano pronti ad un confronto con Stalin poiché intendevano fare
dell’Armata Rossa un loro alleata nella guerra contro il Giappone. Contrariamente alle
aspettative di Churchill, gli alleati si ritirarono nei limiti convenuti delle loro rispettive zone e
entrarono a Berlino solo all’inizio di giugno. Il pessimo accordo raggiunto sull’accesso degli
Occidentali a Berlino (e sul diritto dei Berlinesi dell’Ovest di andare nella Germania dell’Ovest)
creò alla fine parecchie frizioni tra i vecchi alleati della guerra.
Potsdam
Churchill prese la fatale decisione di non assistere ai funerali di Roosevelt. La ragione
che lo spinse a non cogliere quest’opportunità di incontrare Truman e di tentare di influenzarlo
rimane un mistero. Truman aveva un’ammirazione senza limiti per Churchill. Roy Jenkis, nella
sua biografia su Churchill (Macmillan 2001), lascia intendere che i rapporti tra questi e
Roosevelt mancassero di calore. I due erano unicamente degli alleati tattici. Questo può in parte
spiegare la decisione di Churchill di non recarsi ai funerali di Roosevelt. Quale che sia la
ragione, fu comunque un grave errore da parte sua, che pure di solito dava prova di una
straordinaria intuizione nell’ambito delle relazioni pubbliche. Truman propose di incontrare
Stalin a Potsdam; Churchill li avrebbe raggiunti solo alla fine della conferenza. Quest’attitudine
illustra chiaramente il ruolo accordato alla Gran Bretagna. Non si trattava della riunione dei Tre
Grandi, ma di due giganti e di un nano.
Il 2 luglio 1945, Alexandre Cadogan, Vice Segretario permanente del Foreign Office
britannico scrisse a Churchill:
“Speriamo di preparare a vostro favore la lista delle carte che gli Americani e noi stessi
possediamo. Non sono numerose. La più importante è quella dei fondi a disposizione
degli Americani. Noi abbiamo in nostro possesso la flotta, le installazioni e le risorse
industriali tedesche situate a ovest. Gli archivi tedeschi. Ogni concessione che Stalin
potrebbe augurarsi di ottenere da noi, per esempio riguardo gli stretti o Tangeri”.
206
Truman, ben inteso, disponeva della bomba atomica. Prima di Potsdam, Stalin credeva
di avere tre assi nel suo gioco, ma la Bomba A modificò totalmente la distribuzione delle carte
lasciandogliene solo due. Truman pensava senza alcun dubbio di disporre di tre assi, uno di essi
corrispondeva alla bomba atomica. Churchill, dal canto suo, stimava di possederne almeno uno.
Alanbrook riporta la reazione di Churchill alla notizia dell’esplosione della bomba (il 23
luglio 1945):
“L’impegno dei Russi nella guerra contro il Giappone ormai non è più necessario;
questa nuova bomba è sufficiente a regolamentare la questione. Inoltre, noi disponiamo
oggi di una carta vincente che ci permette di ristabilire l’equilibrio con i Russi! Il
segreto di questo esplosivo e il potere di usarlo modificherà completamente l’equilibrio
diplomatico, che era incerto dopo la sconfitta della Germania! Possediamo oggi un
nuovo vantaggio che risolleva la nostra posizione”, aggiunse sollevando il mento, l’aria
accigliata; “noi possiamo ormai affermare che se si dimostrano troppo insistenti
sull’uno o l’altro punto, non dovremo far altro che cancellare dalla carta Mosca, poi
Stalingrado, Kiev, Kuibyshev, Kharkov, Stalingrado (sic), Sebastopoli, ecc. Che cosa
resta oggi dei Russi!!!”.
Truman era impressionato da Stalin: “Posso trattare con Stalin. E’ onesto, ma furbo
come un diavolo”.
L’attitudine della Gran Bretagna nei confronti dell’Unione Sovietica
La Gran Bretagna aveva sempre avuto coscienza della potenza militare dell’Unione
Sovietica, che considerava un gigante rispetto al nano quale essa era. Dal punto di vista militare,
le negoziazioni di Teheran e Yalta erano state difensive e quasi improntate alla contrizione.
Questo divario poneva politicamente la Gran Bretagna in una posizione di debolezza nella
difesa dei suoi interessi e nella resistenza al dominio dell’Unione Sovietica in Europa dopo la
guerra. In una penetrante analisi, datata 17 aprile 1944, il Foreign Office esamina gli obiettivi
della politica sovietica e le sue probabili conseguenze per l’Europa.
“Stalin rigetta l’idea americana di una pace garantita da un’organizzazione di
cooperazione internazionale. Il capitalismo significa guerra. Stalin vuole la pace e
rimarrà al di fuori dei conflitti se può.
L’Unione Sovietica è intenta a costituire un cordone sanitario lungo le sue frontiere
occidentali. L’obiettivo è di costituire un gruppo di piccoli Stati legati all’Unione
Sovietica, se possibile tramite trattati. Mosca si opporrà ad ogni progetto di federazione,
perché ostacolerebbe la sua influenza diretta su ogni Stato. Questi Stati rivendicheranno
dei territori vicini – la Prussia orientale per la Polonia, la Transilvania per l’Ungheria,
ecc – cosa che li renderà dipendenti da Mosca per la loro sicurezza.
La Russia a bisogno di venticinque anni di pace per diventare una grande potenza
economica; cercherà ad ogni costo di evitare le ostilità con la Gran Bretagna e gli Stati
Uniti nel corso dei prossimi dieci - venticinque anni.
L’Unione Sovietica farà tutto ciò che è in suo potere per evitare una rivoluzione
socialista in Europa, perché destabilizzerebbe la regione e rischierebbe di condurre
all’insubordinazione dei nuovi regimi, cosa che potrebbe renderli difficili da
controllare”.
Il sopraggiunto cambiamento di potere in Gran Bretagna modificò la politica straniera
del paese? Attlee, dimostrò maggiore disponibilità nei confronti dell’Unione Sovietica? No.
L’analisi fatta dal Partito Laburista della politica sovietica dopo il 1945 era quasi identica a
quella del Partito conservatore. Si presupponeva che l’Unione Sovietica si consacrasse ai suoi
207
affari interni e non costituisse una minaccia militare per la Gran Bretagna o l’Europa
occidentale. L’influenza di Ernest Bevin, segretario di Stato agli Affari esteri, fu considerevole.
Bevin odiava i comunisti che aveva combattuto quando era sindacalista. Non sopportava
Molotov.
La politica estera dei laburisti fu simile a quella dei New Labour (nuovo Partito
Laburista). L’alleanza con gli Stati Uniti ne costituiva le fondamenta. Questa posizione fu fonte
di conflitto con l’ala sinistra del Partito Laburista ma Attlee spazzò via ogni forma di
contestazione. Alcuni deputati laburisti fornirono informazioni a Stalin tramite
l’intermediazione di alcuni agenti sovietici.
La politica britannica era influenzata da un fattore essenziale: la debolezza militare ed
economica del paese, che necessitava dell’aiuto americano.
La Germania
Una delle prime preoccupazioni della Gran Bretagna era di assicurarsi che la Germania
non costituisse nuovamente una minaccia per la pace, come era accaduto 20 anni dopo il 1919.
Essa rimase la sua bestia nera fino al 1946, quando la sua opinione cambiò alla luce della
minaccia sovietica.
La paura della Germania esisteva ugualmente nell’Europa dell’est. Il Presidente
cecoslovacco, Eduard Benes, era disposto a fare concessioni a Stalin purché l’Unione Sovietica
garantisse la sicurezza del paese in caso di una rinascita della Germania. I cechi e gli slovacchi
furono sempre meglio disposti nei confronti dei russi di quanto non lo fossero i polacchi. Questo
stato d’animo cambiò radicalmente dopo l’invasione della Cecoslovacchia da parte delle forze
del Patto di Varsavia nell’agosto del 1968.
La percezione britannica di Stalin e dell’Unione Sovietica
Il Foreign Office si mostrò particolarmente preoccupato di analizzare la personalità e la
politica di Stalin e dell’Unione Sovietica. Stalin era essenzialmente un marxista, un pragmatico
o entrambe le cose? Churchill aveva un approccio personale della diplomazia. Giudicava
possibile concludere una trattativa dopo aver incontrato personalmente un capo di stato. La
politica estera si riduceva allo stringere rapporti personali, che si basavano principalmente sulla
fiducia. Una volta stabilito un rapporto di fiducia era possibile prendere decisioni politiche
importanti. Ai suoi occhi era questo il solo modo di garantire l’applicazione reale degli accordi
passati.
Churchill concluse che Stalin era un uomo col quale fosse possibile trattare e che
avrebbe mantenuto la parola data. Ciò significava che si poteva comprendere il suo modo di
pensare e di conseguenza determinare una politica dagli esiti positivi. Churchill scartava
Molotov e gli altri dirigenti del Cremlino che considerava come “Bolscevichi”. In altri termini,
era impossibile comprendere il percorso intellettuale che conduceva alle loro decisioni e, di
conseguenza, riuscire a influenzarli efficacemente.
I diplomatici britannici ritenevano Stalin sottomesso alle pressioni del suo Politburo o
del Consiglio dei Ministri; senza dubbio egli doveva subire i loro rimproveri quando gli
capitava di eccedere nelle concessioni, pensavano essi. Alcuni si spingevano ad immaginare che
Stalin dovesse accuratamente tener conto del parere del comando militare.
Quando Churchill incontrava difficoltà con Stalin, ne concludeva che il problema
derivasse da Stalin stesso.
In un’interessante analisi del 14 agosto 1942, Churchill medita sull’apparente
incostanza di Stalin, conciliante un giorno e intrattabile l’indomani. Per lui, questo cambiamento
si spiega forse con la preoccupazione di veder consegnato questo punto di vista nel resoconto
208
dei dibattiti al fine di potersene valere in seguito e accontentare i commissari (i ministri del
governo).
“Cercavamo una spiegazione a questa sorta di recitazione e alla trasformazione alla
quale assistevamo, quando trovammo la sera della vigilia un terreno d’intesa. La
ragione più probabile mi parve essere che il Consiglio dei commissari non avesse
accolto la mia proposta altrettanto bene di quanto avesse fatto lui. Queste persone
hanno forse più potere di quanto pensiamo e può essere che egli agisca così affinché la
sua posizione risulti nel resoconto finalizzata ad altri scopi, per seguire la loro volontà o
perché prova il bisogno di sfogarsi”.
Da cosa deriva quest’idea che Stalin non fosse il padrone del Cremlino? Dai funzionari
e dai diplomatici del Foreign Office ? Sfortunatamente nessun documento permette di porre fine
alla questione. E’ vero che i diplomatici e gli analisti americani giungevano a conclusioni simili,
così come i canadesi.
In realtà, Stalin era proprio il padrone del Cremlino, anche se naturalmente discuteva
con i suoi collaboratori degli approcci e delle tattiche da adottare. Molotov si oppose
fermamente e a più riprese al punto di vista di Stalin e qualche volta riuscì a fargli cambiare
idea. Viceversa, se Stalin giudicava sbagliate le decisione prese da Molotov nel corso di una
riunione con gli alleati occidentali, lo ricopriva di feroci rimproveri. Un giorno, sotto la violenza
degli attacchi, Molotov scoppiò in lacrime. Gli ufficiali non sfuggivano a questo trattamento.
Ma è giusto sottolineare che Stalin non tollerò mai la formazione di una maggioranza
contestataria in grado di rovesciarlo.
Le origini della guerra fredda
Esiste un avvenimento preciso, che abbia agito da detonatore della guerra fredda? La
risposta è no. La guerra fredda si estese progressivamente. La grande alleanza conclusa tra
Unione Sovietica, gli Stati Uniti e la Gran Bretagna fu sin dall’inizio fonte di tensioni. Stalin
rimase però sulla difensiva fino all’autunno 1943. A partire da questa data, egli acquisì
gradualmente fiducia (si può collocare questo momento alla fine del 1943, quando
l’internazionale che faceva da inno nazionale sovietico fu sostituita da un inno nazionale russo),
fino a diventare pienamente sicuro di se nel 1945. Molotov riconobbe in vecchiaia che nel 1945
Stalin si mostrava vanitoso e che oltrepassava ogni limite. L’attitudine diplomatica della Gran
Bretagna fu difensiva nei confronti dell’Unione Sovietica fino a Potsdam. Si può d’altronde
aggiungere che Londra si tenne costantemente sulla difensiva. Gli Stati Uniti si consideravano
come il membro dominante di questa alleanza, ma giudicavano che la cooperazione con Stalin,
alla fine della guerra, fosse indispensabile per assicurare e per mantenere la pace nel mondo.
Così la Gran Bretagna ricoprì un ruolo minore nel dramma che condusse alla guerra fredda. Il
conflitto oppose essenzialmente le due potenze che stavano per diventare delle super potenze,
l’Unione Sovietica e gli Stati Uniti. Gli altri paesi furono relegati a uno status di semplici
figuranti.
Gli archivi personali di Stalin offrono diversi aspetti della sua personalità e del modo
con cui prendeva le sue decisioni. Egli soffriva regolarmente di una malattia che riduceva senza
dubbio la sua capacità di controllare tutti i dettagli di un problema e poi di prendere una
decisione. Afflitto da un male allo stomaco almeno dal 1936, egli arrivò alla conferenza di
Potsdam con un giorno di ritardo, apparentemente indebolito da un nuovo attacco della sua
malattia.
Si mostrava estremamente geloso degli altri dirigenti, come Molotov e Joukov.
L’interprete britannico, Hugh Lunghi, pensava che trattasse Molotov come “un cane”, cioè in
modo offensivo. Quest’attitudine mirava a mantenere Molotov in uno stato di subordinazione
nei confronti di Stalin, affinché non potesse prendere alcuna decisione di sua iniziativa. Ben
inteso, gli era impossibile controllarlo come un robot, poiché questi a più riprese dovette dar
209
prova di iniziativa. Stalin si comportava allo stesso modo con ogni funzionario che potesse
usurpare i suoi poteri decisionali. A partire dal 1945, passava diversi mesi dell’anno nel sud,
principalmente in Georgia, ma esigeva di essere informato di ogni questione che ritenesse
importante. Esaminava ogni giorno una montagna di documenti e redigeva accuratamente le sue
decisioni ed i suoi ordini, che erano in seguito trasmessi a Mosca. Rifiutava di condividere il
potere. Tenuto conto dell’influenza e del potere crescenti dell’Unione Sovietica, era
assolutamente impossibile che un uomo solo potesse prendere l’insieme delle decisioni
importanti. Un superuomo non ci sarebbe riuscito.
Considerato il suo desiderio di arrogarsi l’insieme dei poteri, un partenariato con gli
Stati Uniti dopo la guerra, gli avrebbe imposto un sovraccarico di lavoro considerevole e
proprio quando la sua salute iniziava a venir meno. Nessun dirigente unico avrebbe potuto
trattare la moltitudine di problemi che si presentavano e che esigevano una soluzione. Avrebbe
potuto tracciare le grandi linee ma, gli sarebbe stato impossibile verificare che ogni funzionario
eseguisse i suoi ordini alla lettera.
Il suo dominio si estendeva ugualmente in politica interna. Egli aveva capito che i
soldati e i civili russi entrati a Parigi dopo aver vinto Napoleone, erano tornati a casa loro con lo
spirito e i bagagli colmi di idee straniere. La rivolta dei Decabristi, che aveva tentato di
rovesciare lo zar Nicola I nel 1825, fu una conseguenza di questo fermento di idee. E’ questo, in
modo particolare, il motivo che spiega la decisione di Stalin di deportare, al loro ritorno, i
prigionieri di guerra sovietici in Siberia e di impedire loro di raggiungere le famiglie.
Stalin aveva sperato di beneficiare dei crediti americani che avrebbero facilitato la
ricostruzione del paese. Ma quando questa speranza non si concretizzò, fu necessario costituire
questo capitale in seno all’Unione Sovietica stessa. La ricostruzione rapida del paese imponeva
lo sfruttamento della popolazione. Al fine di galvanizzare i cittadini e di eliminare ogni
opposizione, scelse allora di promuovere il nazionalismo russo, in particolare nei suoi aspetti
antioccidentali e xenofobi.
L’opera di Montefiore (La corte dello zar rosso, 2003) fornisce numerose indicazioni
sul modo di pensare e di decidere di Stalin. La fatica lo vinse a partire dal 1945; egli passava
generalmente diversi mesi nel sud del paese, ma doveva essere tenuto informato e prendere
personalmente tutte le decisioni importanti. Redigeva un numero colossale di lettere e note di
servizio e si informava costantemente dell’esecuzione fedele dei suoi ordini. Stalin si
considerava un intellettuale – leggeva una quantità fenomenale di opere del mondo intero – e
come tale abilitato a intervenire e pronunciarsi in tutti i domini che giudicava importanti, cioè
quelli che avevano delle incidenze politiche. Detestava i pettegolezzi e i chiacchieroni, ma
voleva essere informato sui minimi dettagli della vita privata dei suoi collaboratori. Senza
dubbio credeva di essere il solo autorizzato a collezionare i pettegolezzi, probabilmente al fine
di farne uso successivamente a detrimento delle persone coinvolte. Uno dei suoi collaboratori
dichiarò che in Stalin vedeva sei personalità differenti, tanto era complicato il capo del
Cremlino. I suoi subalterni dovevano dare prova di una grande abilità per riuscire a determinare
con quale Stalin avevano a che fare.
Una cattiva risposta da parte loro poteva far abbattere su di essi la collera del capo e
mettere fine alla loro carriera.
Stalin era ugualmente un attore consumato, capace di incantare i suoi interlocutori. Ciò
spiega perché l’impressione che poteva dare, variava da una persona all’altra. Egli scelse
talvolta di mostrarsi offensivo con Churchill (nel corso delle negoziazioni dell’ottobre 1948, che
sfociarono nell’accordo sulle percentuali, Stalin si dimostrò così grossolano che Churchill fu a
un passo dal lasciare Mosca. Invitò quindi quest’ultimo a cena in compagnia della sua famiglia
e si mostrò così affascinante che Churchill se ne andò raggiante). In altre occasioni, egli fece
sfoggio di cordialità verso il Primo ministro britannico, e questo funzionò sempre a meraviglia.
210
L’effetto che il dittatore sovietico produceva su Churchill è abbastanza straordinario, se si pensa
all’odio che il premier britannico provò per il comunismo lungo l’arco di tutta la sua vita.
Stalin fece un’impressione simile a Roosevelt, ma il Presidente americano voleva
credere che associati all’Unione Sovietica, gli Stati Uniti avrebbero potuto dirigere il mondo
dopo il 1945. Churchill ebbe sempre coscienza che dopo il 1943 la Gran Bretagna si sarebbe
trovata di fronte a un’Europa suscettibile di subire, dopo la guerra, la dominazione militare, e
forse politica, dell’Unione Sovietica. Ma essa non poteva resistere da sola all’avanzata dell’orso
russo.
D’altra parte Roosevelt manifestò sempre un’aria di superiorità distaccata nei confronti
dell’Unione Sovietica. Questa non rappresentava alcuna minaccia militare né politica per gli
Stati Uniti. Egli si preoccupava molto poco dell’ideologia marxista leninista, persuaso com’era
che il capitalismo liberale e la democrazia avrebbero trionfato. Mentre Stalin era convinto che
l’Unione Sovietica sarebbe divenuta la terra promessa, Roosevelt dal canto suo non dubitava
che gli Stati Uniti incarnassero già questa terra promessa.
Le cause della guerra fredda
Citiamo innanzitutto la presunzione di cui Stalin diede prova dopo il 1943. Egli
desiderava conservare da solo il controllo dell’Unione Sovietica: un partenariato con gli Stati
Uniti avrebbe resa necessaria la presenza di più decisori sovietici e Stalin non sarebbe stato in
grado di imporre la sua volontà in tutti i campi. Era estremamente geloso di tutti gli altri
dirigenti sovietici portati a prendere decisioni, da Joukov a Molotov.
Gli Stati Uniti speravano in un partenariato con l’Unione Sovietica, ma la loro
frustrazione era tanto più grande visto che essi erano convinti di essere i padroni del gioco e che
a loro spettasse di tracciare la politica di questo partenariato. Per loro, l’Unione Sovietica aveva
bisogno dei fondi americani per la propria ricostruzione.
Stalin aveva poca stima di Truman, che giudicava “sprovvisto di istruzione e
intelligenza”. E’ sorprendente che un dirigente prudente come Stalin non abbia cercato di
coltivare di più le sue relazioni con il Presidente americano, nei confronti del quale destava una
certa impressione.
Dopo il 1945 Stalin si mostrò stanco e frequentemente malato.
Non apprezzava neanche Atlee. La Gran Bretagna non ebbe alcun ruolo nello
scatenamento della guerra fredda, ma fu lieta di vedere il mantenimento della presenza
americana in Europa. Il piano Marshall e la NATO furono per lei una benedizione.
E’ impossibile designare un avvenimento preciso che possa essere considerato come il
detonatore della guerra fredda. Essa fu progressiva. Nondimeno, alcuni consiglieri di Truman
manifestarono un’opinione estremamente negativa riguardo all’Unione Sovietica sin dagli inizi
della sua presidenza, come Averill Harriman e George Kennan. Essi non ebbero peli sulla lingua
per designare la minaccia che i sovietici rappresentavano ai loro occhi per l’Europa e gli Stati
Uniti.
Roosevelt e Churchill non “svendettero” l’Europa orientale a Yalta. Durante la
conferenza di Teheran, essi avevano acconsentito affinché l’Unione Sovietica giocasse un ruolo
più importante in Polonia e, una volta che la Polonia fu occupata dall’Armata Rossa, la
dominazione di Mosca sui suoi vicini fu praticamente un fatto compiuto. L’accordo sulle
percentuali dell’ottobre 1944 rivelò che Churchill era disposto a negoziare l’istituzione di zone
d’influenza. Riconosceva così che l’Europa orientale sarebbe stata d’ora in avanti sottomessa
all’Unione Sovietica. La paura di una rinascita della Germania, suscettibile di voler dominare
211
ancora una volta l’Europa occidentale, continuava ad occupare la sua mente. La presenza dei
russi in Europa orientale costituiva così una garanzia che quest’ipotesi non potesse realizzarsi.
212
28. La conferenza di Crimea e le origini della guerra fredda
Alexander Chubaryan
Lo sviluppo della ricerca storica sulla guerra fredda
L’interesse degli storici e dei giornalisti politici del mondo intero per la storia della
guerra fredda è rapidamente cresciuto nel corso di questi ultimi anni. La marcata attenzione su
questo soggetto si spiega per diverse motivi.
In primo luogo, è ormai possibile consultare un notevole numero di documenti,
raggruppati essenzialmente nei fondi d’archivio. A questo riguardo gli archivi della vecchia
Unione Sovietica, una volta inaccessibili, rivestono un’importanza capitale. Malgrado il
malcontento espresso dai ricercatori di fronte al mantenimento del divieto di consultazione di
alcuni archivi, i documenti già disponibili e utilizzati dagli specialisti consentono di definire in
maniera generale le principali tappe di transizione verso la guerra fredda e il confronto fra i due
campi, di comprendere l’essenziale delle intenzioni sovietiche, di ritracciare il processo
decisionale, di valutare il ruolo di Stalin e la logica della sua politica così come la correlazione
tra le questioni ideologiche e le questioni pratiche della Realpolitik. Disponendo anche delle
pubblicazioni e degli archivi americani, britannici, francesi e tedeschi, i ricercatori possono
ricostruire una panoramica dell’evoluzione della guerra fredda comparando le diverse fonti e
attingendo alle numerosissime memorie dei contemporanei.
In secondo luogo, occorre sottolineare che nel corso degli ultimi dieci anni hanno avuto
luogo centinaia di conferenze e di riunioni diverse, consacrate ai differenti aspetti della guerra
fredda, ivi comprese quelle che hanno accolto testimoni dell’epoca. All’inizio degli anni ’90, il
centro Woodrow Wilson di Washington ha lanciato il progetto “Storia internazionale della
guerra fredda”. Oltre alle dozzine di conferenze e di seminari, esso comprende un Bollettino
speciale (dodici numeri sono finora già stati pubblicati) nel quale i documenti d’archivio prima
sconosciuti dal mondo scientifico, sono regolarmente pubblicati. Oltre che a Washington, centri
di ricerca sono stati creati in numerosi paesi – nella Federazione Russa (in seno all’Istituto di
Storia mondiale dell’Accademia russa delle scienze), nel Regno Unito (al King’s College di
Oxford), in Germania (all’Università di Essen). Un gran numero di conferenze sono state
peraltro organizzate in Francia, in Italia, nella Repubblica Ceca, in Slovacchia, in Cina, in
Giappone, in Vietnam e in altri paesi ancora. Queste attività hanno consentito la costituzione di
una rete che raccoglie diverse centinaia di specialisti della storia della guerra fredda.
In terzo luogo, centinaia di opere e di articoli, pubblicati nel corso dell’ultimo decennio,
chiariscono diversi aspetti delle cause, dell’evoluzione e della fine della guerra fredda. I punti
di vista dei diversi autori divergono spesso radicalmente e ciò fornisce motivi di discussione e
confronto.
In quarto luogo, la ricerca in questo campo è facilitata dal fatto che la guerra fredda
costituisce un’epoca passata e ciò consente di analizzare il fenomeno nella sua totalità.
Disponiamo per questa ragione di un quadro completo della guerra fredda, che comprende una
valutazione delle sue cause, l’analisi delle sue tappe e i fattori che hanno determinato il suo
abbandono. I ricercatori possono così confrontare gli obiettivi iniziali dei protagonisti e il
risultato finale delle loro azioni.
Infine, la guerra fredda deve essere ricollocata in un contesto più ampio. Come si sa, la
Seconda guerra mondiale creò un nuovo ordine mondiale, quello di Yalta e di Potsdam.
Il XIX e XX secolo di fatto, non hanno dato la vita che a qualche raro sistema
internazionale nel mondo: il sistema di Vienna (istituito dopo le guerre napoleoniche e la
213
disfatta della Francia), il sistema di Versailles (istituito dopo la Prima guerra mondiale) e,
infine, il sistema di Yalta-Potsdam di cui abbiamo appena parlato.
Gli storici hanno la possibilità di confrontare l’evoluzione di questi sistemi, le
circostanze della loro nascita e il loro funzionamento, di definire la loro tipologia, le loro
caratteristiche comuni e le loro particolarità. Lo studio del ruolo svolto dal sistema YaltaPotsdam è, in più, facilitato dalla sua scomparsa avvenuta contemporaneamente alla guerra
fredda.
Le ricerche anteriori sulla guerra fredda e il sistema di Yalta-Potsdam hanno peraltro
rivelato la necessità di un approccio interdisciplinare, in vista di un’azione concertata degli
storici, dei politologi, dei giuristi, dei sociologi e degli economisti. Quest’approccio risulta
particolarmente indispensabile, perché è praticamente impossibile capire i molteplici aspetti
della questione senza un’analisi dei suoi fattori economici e giuridici.
Inoltre, lo studio storico di questi ultimi quaranta anni ha dimostrato la considerevole
efficacia di un approccio sistemico, di un’analisi che ricorra ai metodi applicati dai politologi a
diversi sistemi, ivi compresi i sistemi internazionali.
Infine, è apparso necessario includere gli specialisti della storia nazionale di diversi
paesi nel quadro delle ricerche sulla guerra fredda. Numerosi aspetti della politica estera –
quella dell’Unione Sovietica , per esempio – possono essere compresi e spiegati solo nel
contesto dei meccanismi interni propri al sistema staliniano, dell’interconnessione dei fattori
politici e ideologici, delle particolarità dell’origine e del ruolo del complesso militare industriale sovietico, così come il suo confronto con i complessi militari – industriali americani
e di altri paesi.
L’interesse scientifico su questo soggetto nei diversi paesi e i risultati abbastanza
sostanziali ottenuti dagli studi consacrati alla storia del dopoguerra nel corso degli ultimi dieci
anni sono stati predeterminati dall’insieme delle circostanze precitate.
E’ opportuno notare che queste questioni storiche hanno ugualmente suscitato
l’interesse di un largo pubblico. Una serie di documentari sulla storia della guerra fredda,
cooprodotta dai Britannici e dagli Americani è stata diffusa sui canali televisivi di più paesi,
compresa la Federazione Russa. Un gran numero di altre trasmissioni televisive e film
consacrati a questa questione sono stati recentemente realizzati in diversi paesi, tanto in Europa
che in Asia. Peraltro, parecchie opere di successo e brochures sono state pubblicate
sull’argomento. Un progetto di manuale scolastico d’insegnamento secondario sulla guerra
fredda è ormai all’ordine del giorno.
Su iniziativa di specialisti russi e britannici, nel 1999 è stata creata a Londra una rivista
internazionale specializzata, Cold War History ( Storia della guerra fredda). Possiede una
squadra editoriale comune russo-britannica e un comitato di redazione internazionale
rappresentativo. Fino a questo momento sono stati pubblicati dodici numeri. Anche l’Università
di Harvard negli Stati Uniti pubblica una rivista consacrata alla storia della guerra fredda.
La guerra fredda e il sistema globale delle relazioni internazionali
E’ possibile affrontare un punto che da molto tempo attira l’attenzione degli specialisti:
i rapporti tra la guerra fredda e il sistema globale delle relazioni internazionali esistenti dalla
fine della Seconda guerra mondiale fino alla fine degli anni ‘80. Grazie a quest’approccio,
possiamo costatare che la guerra fredda rappresenta un elemento importante e decisivo, ma solo
uno degli elementi dell’evoluzione generale delle relazioni internazionali e dell’insieme del
sistema politico internazionale del dopoguerra. Si tratta quindi, a mio avviso, di un approccio
fruttuoso e allo stesso tempo interessante.
214
Nel corso degli ultimi dieci anni, parecchi dibattiti e pubblicazioni hanno sollevato un
certo numero di questioni concernenti la storia dei negoziati internazionali svoltisi durante
l’ultimo periodo della Seconda guerra mondiale, così come durante la stessa guerra fredda. Non
basta una sola esposizione per rappresentare l’insieme dei problemi che hanno suscitato
l’interesse degli specialisti. Ragion per cui affronteremo qui solo una parte di questi, cioè quelli
che suscitano più discussione.
Soffermiamoci innanzi tutto sulla questione del punto di partenza della guerra fredda.
Secondo una tesi diffusa nella storiografia americana dopo la pubblicazione dell’opera di
Fleming, la guerra fredda è iniziata subito dopo la Rivoluzione russa del 1917. Questo punto di
vista è generalmente condiviso dagli storici “di sinistra”. Ma una schiacciante maggioranza di
specialisti, compreso l’autore di questa presentazione, ritiene che la guerra fredda sia iniziata
dopo la fine della Seconda guerra mondiale.
Un’altra questione oggetto di discussione è quella della comparsa dei primi segni del
futuro scontro fra gli alleati. Gli storici hanno scoperto una nota del NKVD (commissariato del
popolo agli Interni) indirizzata a Stalin nell’estate del 1943. Gli autori indicano gli Stati Uniti
quale principale avversario dell’Unione Sovietica dopo la guerra e rilevano la necessità di
prendere in considerazione quest’elemento e di conseguenza di prepararsi. I ricercatori hanno
anche scoperto negli archivi nazionali americani alcune note redatte durante la guerra e anche
altri documenti che indicano a loro volta l’Unione Sovietica come il principale futuro avversario
degli Stati Uniti.
Trattandosi delle relazioni tra gli alleati, non bisogna dimenticare che le divergenze che
li opponevano durante la guerra – sull’apertura del “secondo fronte”, i carichi spediti in leasing
ecc.- nel 1945 si erano aggravate considerevolmente, man mano che si avvicinava la vittoria. I
punti principali di disaccordo presero progressivamente forma, prima di degenerare
successivamente in un accanito scontro. La divergenza principale riguardò il destino dei paesi
dell’Europa centrale, orientale e del sud-est liberati dall’occupazione tedesca. Mosca prevedeva
di porli sotto il suo controllo e di installarvi, con l’aiuto delle truppe sovietiche che vi erano
spiegate, dei governi comunisti subordinati all’Unione Sovietica.
Gli alleati occidentali tentarono di opporsi a questa evoluzione e di mantenere quei
paesi nell’orbita del mondo occidentale. Tutti gli aspetti di questa lotta si concentrarono nelle
negoziazioni sull’avvenire della Polonia. Ogni posto ministeriale diede luogo a contestazione.
Impiegando una tattica di progressione a tappe e di compromesso di facciata, l’Unione Sovietica
riuscì finalmente a sistemare governi dominati dai comunisti in Polonia, Cecoslovacchia,
Bulgaria, Romania, Albania e Yugoslavia. Questi paesi annunciarono ben presto la loro
intenzione di costruire un socialismo sul modello sovietico, prendendone tutti i suoi attributi (il
principio di fatto del partito unico, la nazionalizzazione delle industrie, le purghe lanciate contro
i dissidenti, le critiche ideologiche del sistema capitalista, ecc.).
L’attuale storiografia occidentale, particolarmente negli Stati Uniti, contiene un certo
numero di opere che accusano Roosevelt di aver consegnato l’Europa dell’est all’Unione
Sovietica. Retrospettivamente si può certo affermare che Roosevelt e Churchill finirono per
cedere davanti a Stalin sulla questione dei regimi politici dei paesi dell’Europa orientale. Ma
oggi è altrettanto noto che quel compromesso, che rifletteva il grado di cooperazione esistente
tra i membri della coalizione anti-hitleriana, era stato in realtà ottenuto per costrizione. Le
truppe sovietiche stazionavano già sul territorio dell’insieme di quei paesi; Mosca disponeva
così di tutti gli strumenti che le permettevano di esercitarvi la propria influenza. Roosevelt e
Churchill non avevano alcun vero mezzo e non disposero di occasione alcuna per impedire
questo tipo di evoluzione, ad eccezione di un conflitto armato diretto ( che era a sua volta
impossibile e insensato). Gli alleati occidentali potevano opporre solo la retorica del loro
discorso e la loro insistenza per ottenere qualche concessione.
215
I paesi dell’Europa centrale e orientale, che costituirono il “campo socialista” con
l’Unione Sovietica, adottarono il modello di sviluppo interno sovietico e parteciparono al
movimento generale di competizione e scontro con l’Ovest. La consultazione degli archivi
nuovamente disponibili rivela che, in seguito, in particolare negli anni ‘70 e ‘80, contrariamente
a ciò che si pensava un tempo, questi paesi disposero spesso di una indipendenza più rilevante
nei confronti di Mosca di cui essi non avevano beneficiato fino a quel momento. I loro dirigenti
ostentarono una linea ideologica ancora più dura di quella del Cremlino o ebbero l’audacia di
adottare un atteggiamento più accorto verso l’Ovest.
La questione tedesca rappresentò un altro punto di disaccordo. Le divergenze tra alleati
divennero qui particolarmente marcate dalla fine dell’anno 1945. Le due parti della Germania
divisa presero direzioni diverse. La Germania divenne il teatro dove si affrontarono i sistemi di
valore e gli interessi politici opposti dei vecchi alleati. La questione tedesca fu causa
permanente di crisi, le quali portarono spesso i due campi sull’orlo di un conflitto aperto.
Ognuno di essi temeva tuttavia la riunificazione della Germania: l’Unione Sovietica la
considerava come una minaccia di rinascita di una Germania borghese e antisovietica, i paesi
occidentali temevano la prospettiva della diffusione all’ Ovest del sistema totalitario della
Germania Est. Il simbolo della guerra fredda fu in Germania il Muro di Berlino, la cui
distruzione simbolizzò parallelamente la fine della guerra fredda. Dal punto di vista ideologico,
la situazione nella Repubblica democratica tedesca pose ugualmente qualche problema ai
dirigenti sovietici, poiché la classe dirigente della Germania Est si distingueva per il suo
estremo dogmatismo e l’adozione di una linea dura senza compromessi.
La corsa agli armamenti costituì il principale avvenimento della guerra fredda. Il
monopolio nucleare degli Stati Uniti conferì loro innanzi tutto un solido vantaggio nel loro
scontro con l’Unione Sovietica. Quest’ultima compensò questo disequilibrio con una
considerevole preponderanza nel campo delle forze convenzionali e degli armamenti spiegati in
Europa. L’equilibrio fu ristabilito successivamente con la messa a punto della bomba atomica e
della bomba a idrogeno da parte dell’Unione Sovietica.
Ne risultò una parità di armamento nucleare, che rappresentò una delle caratteristiche
principali del “mondo bipolare” e i due campi non risparmiarono nessuno sforzo per mantenere
questo equilibrio. Conviene notare che, malgrado la messa in campo di alcune misure di
limitazione degli armamenti a conclusione di lunghissime trattative, la parità nucleare si
mantenne a un livello abbastanza alto ed ebbe conseguenze disastrose per l’economia sovietica.
Il bilancio del paese era gravato dalle spese militari e questa situazione emerse in maniera
eclatante nella crisi generalizzata dell’economia sovietica alla fine degli anni ‘80.
La guerra fredda si avviò in Europa e si estese in tutto il mondo. Il teatro degli scontri o
delle lotte di influenza si trasferì fino all’Africa e all’Asia. La concorrenza tra i due campi prese
molto spesso la forma di lunghi conflitti nazionali o etnici, se non addirittura di scontri diretti tra
i due sistemi, come fu il caso della guerra di Corea. Successivamente, la guerra fredda provocò
interminabili conflitti in Angola, Mozambico e Etiopia. Lo scontro della guerra fredda assunse
così una dimensione mondiale. Si estese anche in diversi campi, comprese le attività delle
organizzazioni internazionali, di cui l’ONU costituisce l’esempio più patente.
In questo contesto di conflitto generale, l’ideologia giocò un ruolo maggiore. Al
momento attuale, dopo parecchi anni di dibattiti animati e di ricerche in seno a nuovi documenti
, gli storici non giungono sempre a determinare il fattore principale di scoppio e di sviluppo
della guerra fredda, soprattutto per ciò che riguarda l’Unione Sovietica. Fra gli storici americani
si contrappongono due correnti, senza parlare dei loro colleghi europei. La prima corrente
spiega l’azione di Stalin e del suo entourage con motivazioni ideologiche e ambizioni più
tradizionali, cioè la combinazione dell’idea di “rivoluzione mondiale” e degli “eterni” obiettivi
di espansione imperiale russa. L’ altra tesi ritiene che Stalin e i suoi collaboratori erano guidati
prima di tutto da intenzioni puramente pragmatiche conosciute sotto il vocabolo di Realpolitik.
216
Secondo me, queste due nozioni sono in parte fondate, ma peccano entrambe di un
approccio troppo esclusivo alla situazione, poiché gli obiettivi strategici della politica estera
sovietica erano in realtà più complessi. I documenti scoperti negli archivi russi dimostrano che
dall’autunno 1945, su direttiva personale di Stalin, il Cremlino aveva lanciato una violenta
campagna ideologica contro l’Occidente. Nel novembre del 1945, essa era diretta
principalmente contro la Gran Bretagna, ma gli Stati Uniti non tardarono a divenirne il
bersaglio. I diritti dei giornalisti occidentali accreditati in Unione Sovietica vennero ridotti, la
circolazione e la vendita delle riviste occidentali, che erano state diffuse in tutto il paese durante
la guerra, furono ridotte in modo drastico e vennero adottate altre misure simili.
Questa campagna contro l’influenza occidentale raggiunse il suo parossismo nel corso
della famosa “lotta contro il cosmopolitismo”. Parecchie migliaia di intellettuali sovietici –
personalità della
cultura, artisti, scienziati – furono oggetto di aspre critiche per essersi dedicati alla propaganda
delle idee occidentali e aver dato prova di “servilismo” nei confronti dell’Occidente. Un gran
numero di essi perse il proprio lavoro, altri furono vittime di purghe. Queste campagne su vasta
scala proseguirono fino alla morte di Stalin nel marzo del 1953.
La componente ideologica della guerra fredda continuò tuttavia a giocare un ruolo
fondamentale anche dopo la scomparsa del capo. Essa motivava le purghe praticate contro i
dissidenti e le campagne generali destinate ad assoggettare ogni forma di non-conformismo.
Conviene però notare che l’ideologia occupò un posto importante anche nella parte occidentale.
La campagna lanciata dal senatore McCarthy, una persecuzione dei cittadini americani
sospettati di simpatizzare per il comunismo, oltre ad una “offensiva” generale contro le idee
comuniste e la minaccia sovietica, rappresentò una parte molto importante dello scontro tra
l’Ovest e l’Unione Sovietica.
Gli studi condotti su questo aspetto della guerra fredda ci permettono di trarre delle
conclusioni più generali sul ruolo dell’ideologia e i suoi rapporti con la politica. Essi affrontano
anche questioni relative all’origine della “rappresentazione dell’altro” e al consolidamento dei
“clichés” tanto nel pensiero dell’ “élite” quanto nella mentalità della gente comune. I “clichés”
radicati profondamente sono duri a morire, farli scomparire rappresenta un’impresa difficile,
spesso fonte di controversie.
Il problema dei dirigenti ha ugualmente contribuito allo slittamento verso la guerra
fredda. Per Stalin, i suoi rapporti con i dirigenti britannici e americani costituivano
un’esperienza completamente nuova. Era rimasto per decenni in un isolamento di fatto e si
ritrovava di colpo sullo stesso piano di Roosevelt e Churchill. Questi ultimi espressero il rispetto
e persino l’ammirazione che avevano per lui. Nel 1944, Stalin e Churchill divisero l’Europa
dell’Est e nel 1945 i tre capi elaborarono insieme il sistema politico internazionale del
dopoguerra. Tutti questi avvenimenti accrebbero considerevolmente il prestigio del capo
sovietico e la stima che egli aveva di sé stesso. Numerose persone si interrogavano sulla durata ,
a conclusione della guerra, della cooperazione e della mutua fiducia che si erano stabilite tra le
tre potenze. Ma questa situazione cambiò brutalmente e radicalmente.
Roosevelt morì alla vigilia della Conferenza di Potsdam. Durante il vertice, il partito di
Churchill subì una disfatta elettorale che gli fece perdere il suo posto di Primo ministro. Stalin si
ritrovò così a Potsdam di fronte a due nuovi omologhi occidentali con i quali non aveva mai
avuto contatti prima. Secondo testimoni del periodo, questa situazione irritava Stalin; perdeva
fiducia e trattava i suoi nuovi interlocutori con diffidenza. Inoltre, il nuovo presidente
americano Truman proseguiva in segreto le prove della bomba atomica, rafforzando così
l’animosità di Stalin nei suoi confronti.
Questi elementi crearono una nuova atmosfera psicologica tra i capi alleati che ebbe
ripercussioni sulle relazioni tra gli Stati. Abbiamo già ricordato le direttive date da Stalin nel
217
novembre e dicembre 1945. si può aggiungere che nelle sue “Lettere dal sud” (redatte quando vi
passava le sue vacanze) Stalin si lasciò andare ad aspri commenti su Churchill, accusando i suoi
più vicini luogotenenti del Politburo di “piegare la schiena” davanti al dirigente britannico e
all’Ovest in generale. Nello stesso momento, la Pravda, l’organo di stampa del PCUS, pubblicò
il discorso pronunciato da Churchill davanti al parlamento, nel quale il Primo ministro in
pensione faceva gli elogi di Stalin e del suo ruolo nella vittoria sul nazismo. Stalin reagì
duramente per iscritto: non aveva alcun bisogno che un rappresentante ben conosciuto negli
ambienti imperialisti britannici e vecchio nemico dell’Unione Sovietica facesse il suo elogio. La
collera di Stalin trovò una nuova fonte d’ispirazione nel discorso di Churchill a Fulton, che la
propaganda sovietica qualificò come manifesto della guerra fredda. Il passaggio alla guerra
fredda e allo scontro si spiega anche in parte attraverso fattori psicologici individuali.
Storici, diplomatici e giornalisti dei due campi si rimproverarono reciprocamente, per
molti anni, la responsabilità della guerra fredda. Negli anni ‘50 e ‘60, storici americani
“revisionisti” cominciarono a parlare della responsabilità degli Stati Uniti, durante la
distensione, Zbigniew Brzezinski ricordò il cumulo fatale delle circostanze che avevano
condotto alla guerra fredda. Malgrado i regolari tentativi finalizzati fino ad oggi a far ricadere la
colpa della guerra fredda sul campo avverso, noi condividiamo l’opinione di coloro che
credono che essa fu il prodotto di intenzioni, obiettivi e azioni conflittuali da una parte e
dall’altra, che contribuirono ad alimentare le reciproche critiche, all’adozione di una linea di
condotta basata sullo scontro e a una lotta feroce. Una volta sistemati questi elementi, la guerra
fredda finì per acquisire la sua propria logica: ogni di lotta e situazione di scontro generava le
conseguenze e accresceva le tensioni internazionali.
Gli storici e i politologi discutono ancora oggi sull’essenza del sistema di YaltaPotsdam e dell’entità dei suoi rapporti con la guerra fredda, al fine di determinare se questo
sistema è all’origine della guerra fredda o se non abbia finito per alimentarla dandole un
costante impulso.
Il sistema politico internazionale di Yalta-Potsdam è un fenomeno complesso e
controverso. I suoi fondatori tentarono di edificare un nuovo ordine mondiale, per evitare la
riproduzione di tragici conflitti paragonabili a quello che si era appena concluso. L’ONU è stata
creata a questo scopo come garante principale della pace e della sicurezza. Questo sistema
poggiava nello stesso tempo sul nuovo equilibrio delle forze che si delineava a conclusione
della vittoria sulla Germania nazista.
Le decisioni prese a Yalta e a Potsdam definirono i principi e le posizione comunemente
ammessi, ma parallelamente generarono le ulteriori controversie. I loro autori hanno confermato
una forma di status quo tra l’Unione Sovietica e l’Ovest (essenzialmente cioè gli Stati Uniti).
Generalmente si crede che questo sistema poggiasse in larga misura sul principio della
bipolarità, che è perdurato fino alla fine della guerra fredda.
Lo scontro e la guerra fredda tra i due campi rappresentano la parte più visibile e più
evidente del sistema di Yalta-Potsdam, ma la sua essenza non si riduce a questi due elementi.
Dal 1945 alla fine degli anni ‘80, l’evoluzione delle relazioni internazionali ha conosciuto un
gran numero di ondeggiamenti. Talvolta il mondo si ritrovò a due passi da un conflitto
mondiale, come fu nel corso della crisi dei missili cubani del 1962 o, piuttosto ancora, durante
la crisi di Berlino del 1948. Ma anche questo sistema ebbe ugualmente dei periodi di
distensione: il primo, dopo la morte di Stalin, e il secondo, più lungo, alla fine degli anni ‘60 e
agli inizi degli anni ‘70, che fece nascere un’immensa speranza e si concretizzò con
un’importante realizzazione, l’Atto finale di Helsinki e il processo di Helsinki nel suo insieme.
Il sistema di Yalta, con il mondo bipolare al quale diede vita, affrettò certamente lo
scontro mondiale tra i due blocchi, ma instaurò anche un equilibrio relativamente stabile.
218
E’ impossibile liberarsi dell’impressione che i suoi principali protagonisti hanno messo
in scena (intenzionalmente o accidentalmente) alcune regole che hanno evitato lo scoppio di un
conflitto generalizzato. Sembra che questo scontro si sia fermato sull’orlo di un conflitto (alcuni
ideologi e uomini di Stato considerarono anche questa situazione come “politica a due passi
dalla guerra”) senza tuttavia oltrepassare mai questo confine.
Numerosi conflitti locali, come guerre talvolta violente, scoppiarono nel corso dei
quaranta anni di guerra fredda, ma i principali attori, cioè l’Unione Sovietica, gli Stati Uniti e i
loro alleati riuscirono ad evitare una grande guerra e un conflitto diretto.
Gli argomenti a favore di una politica di “dissuasione” e di “arginamento” sono stati
elaborati dai teorici e ideologi dei due campi. Il mondo conobbe talvolta situazioni di estrema
tensione, ma ogni volta le due potenze avversarie diedero prova di molto buon senso e buona
volontà per evitare di farlo precipitare in una guerra nucleare generalizzata.
Il periodo del dopoguerra si caratterizzò per l’interconnessione e l’intrecciarsi di fattori
esterni, come lo rivelò in modo eclatante la fine degli anni ‘80. Il crollo dei regimi comunisti
nei paesi dell’Europa centrale e orientale, l’avvio di cambiamenti radicali nell’Unione Sovietica,
che portarono alla creazione di un nuovo sistema, sconvolsero notevolmente la distribuzione nel
campo delle relazioni internazionali. La guerra fredda era finita, il muro di Berlino era caduto e
i vecchi paesi socialisti dell’Europa dell’Est ritrovarono il loro ordine sociale ante guerra.
Conclusione
Il crollo dell’Unione Sovietica comportò anche la caduta del sistema politico
internazionale di Yalta-Potsdam. Lo scontro puro e duro dei due campi appartiene al passato,
compreso il campo della strategia militare. La transizione della Russia verso un’economia di
libero mercato e un regime politico democratico ha posto fine all’antica era dei conflitti
ideologici acuti.
L’umanità si confronta ormai con nuove minacce e nuove poste, di cui il terrorismo è il
più inquietante. Un gran numero di complessi problemi, talvolta gravi, sorgono nei rapporti tra
la Russia e l’Occidente, ma sono risolti oggi secondo altri metodi e con diversi mezzi. Il tenore
delle questioni internazionali si è modificato considerevolmente; il mondo deve adesso
raccogliere un’altra sfida: edificare un sistema politico internazionale che riveli obiettivi
mondiali e un equilibrio di forze all’alba del XXI secolo.
219
29. Yalta, nella prospettiva polacca
Wlodzimierz Borodziej
Prima di iniziare la propria esposizione, ogni intervenuto ha probabilmente dovuto
rispondere a due domande: quale è il soggetto preciso e se la nostra percezione della conferenza
é stata modificata dalle “recenti ricerche” su Yalta o la nostra riflessione sul recente passato è
piuttosto influenzata dalla rivoluzione del 1989?
Gli studi su questo problema redatti in polacco sono estremamente numerosi e poggiano
per la maggior parte sulle recensioni americane e britanniche. Gli archivi polacchi forniscono un
complemento importante; essi ci rivelano le alternative e gli argomenti sia dei polacchi esiliati a
Londra e sia della società polacca in un paese che era ancora in parte occupato. Ma suppongo
che la pertinenza di tutti questi documenti non risieda tanto nel fatto che essi ci permettono di
ricostituire le misure concrete che sono state adottate o le strade che non sono state prese;
l’interesse della conferenza di Yalta risiede maggiormente nella delusione che ha fatto nascere
piuttosto che nella decisione che essa rappresenta, come anche in seguito il mito che ha formato
l’immaginario di due generazioni di polacchi e ha impedito ogni vero dibattito pubblico prima
del 1989. Così la mia intenzione è di dimostrare, nel poco tempo che mi è concesso,
l’interazione tra mito e realtà nel 1945 e nel corso dei decenni successivi.
Ad eccezione degli archivi sovietici, tutti gli altri sono stati sfruttati dagli storici dagli
anni ‘50. Recentemente, negli anni ‘90, una buona parte dei “dossier” staliniani e diventata
accessibile. E’ la ragione per cui è difficile presentare nuove conclusioni, trattandosi almeno di
documenti, di fatti, di cifre. D’altra parte, e questo ci porta al punto probabilmente più
importante, è singolare che una conoscenza dei fatti perfettamente stabilita non dia luogo a più
interpretazioni successive. L’interpretazione dei fatti di cui ci occupiamo si è evoluta soprattutto
nella storiografia americana, che ha giocato e gioca ancora un ruolo rilevante in materia. Come
si sa, questa evoluzione è iniziata con un rifiuto totale di Yalta, considerato all’inizio degli anni
‘50 come un evento vergognoso e spiacevole; il decennio seguente non ha modificato questo
giudizio; gli anni ‘70 sono stati l’epoca delle accuse lanciate, in seguito alle investigazioni,
contro gli Stati Uniti, indicati come i principali responsabili della situazione; infine la
storiografia è giunta a una sorta di “nuovo consenso” che riconosceva contemporaneamente i
meriti e i fallimenti di Franklin D. Roosevelt.
La storiografia polacca non si è evoluta cosi rapidamente e si potrebbe persino rischiare
di dire che non si è evoluta affatto. Al tempo dell’esilio del governo, Yalta fu fin dall’inizio
considerata come il simbolo del male e del tradimento; la storiografia ufficiale della Repubblica
popolare della Polonia in realtà non si è pronunciata su Yalta. La conferenza di Potsdam, che
simbolizzava la decisione presa in favore della frontiera occidentale, suscitò molto più interesse
e diede vita alla idea degli accordi di Yalta-Potsdam, che riuniva le modifiche essenziali in
materia politica e di frontiera. Negli anni ‘80, quelli che abbiamo chiamato gli storici
indipendenti (i cui scritti venivano pubblicati fuori dalla portata della censura) posero un nuovo
sguardo sulla questione. Le loro conclusioni, cosa non strana, si avvicinarono più alla
storiografia degli esiliati che a quella della Repubblica
Popolare di Polonia. Dopo questo consenso nazionale, la questione di Yalta non fu
praticamente più oggetto di dibattito.
Come tutti sappiamo, la questione polacca fu il fulcro della conferenza, soprannominata
da Roosevelt ”l’emicrania del mondo”, e venne affrontata nella maggior parte delle sessioni
plenarie. Tenterò di spiegarne la ragione; questa interpretazione sarà seguita da una
presentazione delle reazioni polacche all’inizio dell’anno 1945 e, infine, un’ultima parte sarà
consacrata alle ripercussioni del mito di Yalta sulla Polonia durante la guerra fredda.
220
Dal patto Molotov-Ribentrop alla conferenza di Yalta
La questione polacca non sarebbe esistita nel corso della Seconda guerra mondiale se
l’Unione Sovietica, alleata della Germania, non avesse attaccato la Repubblica Polacca e
annesso più della metà del suo territorio nel settembre 1939. L’alleanza conclusa tra il Reich
nazista e l’Unione Sovietica aveva creato immediatamente una situazione delicata tra il 194041, quando la Gran Bretagna finì per non indicare a Mosca che essa era disposta ad accettare la
nuova frontiera sovietica occidentale se il Cremlino si decidesse a raggiungere il campo degli
alleati. Il governo in esilio sollevò più di una protesta contro queste proposte britanniche poiché
considerava la restituzione integrale del territorio della Repubblica nelle sue frontiere anteguerra
come l’obiettivo principale della guerra e come un obbligo costituzionale. L’attacco dell’Unione
Sovietica da parte della Germania complicò ancora di più la situazione, benché Londra non
avesse accettato l’idea di un protocollo segreto che garantiva la nuova frontiera occidentale
russa presentata a Eden dai Sovietici nel 1941. Qualche giorno prima, il Primo ministro polacco,
il generale Wladyslaw Sikorski, aveva ugualmente rifiutato la proposta di discussione delle
questioni di confine tra la Polonia e l’Unione Sovietica fatta da Stalin, questa volta disposto a
modificare, ma soltanto di poco, il tracciato della frontiera (quando le truppe tedesche erano
quasi visibili dalle finestre del Cremlino).
Sikorski non approfittò della debolezza dell’Unione Sovietica, poiché si aspettava
probabilmente il crollo dell’impero stalinista e l’entrata in guerra degli Stati Uniti in Europa. Ma
l’impero sovietico sopravvisse alla crisi del 1941 e Washington non considerò più la Polonia
come la pietra di paragone delle relazioni americano-sovietiche; anche i termini del mercato non
cessarono di piegarsi per il governo polacco in esilio. Quando nel 1942 l’esercito polacco
costituito da vecchi prigionieri sovietici lasciò l’Unione Sovietica, le relazioni si deteriorarono,
fino a diventare ostili, dopo l’annuncio, di Berlino nel 1943, della scoperta di fosse comuni di
ufficiali polacchi nei pressi di Smolensk. Siccome il governo polacco in esili sosteneva la
proposta di esame delle fosse comuni da parte di una commissione messa sotto l’autorità della
Croce Rossa internazionale, Stalin utilizzò questo pretesto per rompere le relazioni con gli
“emigrati polacchi di Londra”.
A Mosca vennero costituiti un comitato polacco, composto da comunisti, e una
divisione sotto il comando comunista polacco. Quando nell’estate del 1944 l’Armata Rossa
oltrepassò la nuova frontiera sovietico-polacca, i comunisti diedero forma alla nuova
amministrazione del paese. La resistenza antitedesca che si era fin qui mostrata leale al governo
in esilio fu disarmata e parecchi ufficiali furono giustiziati o deportati in Unione Sovietica,
mentre divenne impossibile la creazione di partiti politici fuori dal controllo dei comunisti. Nel
gennaio 1945, il comitato di liberazione nazionale, che pretendeva già di assumer il ruolo di
autorità suprema e unica dello Stato, si ribattezzò Governo Polacco Provvisorio.
Gli avvenimenti sopravvenuti nel 1944 nella parte liberata del territorio polacco
ridussero il governo in esilio a una forza secondaria. Non era disposto né a negoziare sulla
questione delle frontiere né in grado di farlo. Dopo “l’affare di Katyn”, Mosca trattava i “circoli
polacchi emigrati” come reazionari e pro-fascisti. L’unica opzione proposta dai Sovietici era di
includere nel comitato comunista polacco alcuni emigrati e uomini politici “progressisti” e
“realmente democratici”, nati dalla resistenza a condizione che essi accettassero la nuova
frontiera sovietico-polacca. Nell’ottobre 1944, nel momento stesso in cui Churchill redigeva il
suo famoso accordo sulle percentuali, i negoziati col Primo ministro polacco Stanislaw
Mikolajczyk furono abbandonati. Mikolajczyk lasciò le sue funzioni qualche settimana più
tardi; il gabinetto rimaneggiato dal suo successore si tresentò come un “governo di protesta
nazionale”, ma non venne mai trattato da Londra e Washington come un vero partner. Così nel
gennaio 1945, la Polonia aveva un governo in esilio, riconosciuto dalla quasi totalità degli Stati
ad eccezione dell’Unione Sovietica, e un governo provvisorio che non beneficiava affatto della
riconoscenza di Mosca. Il paese in rovina non aveva alcuna frontiera internazionalmente
riconosciuta ad est, ad ovest e a nord; non veniva contestato solo l’antico tracciato della
frontiera con l’Ungheria a sud-est, diventata quella della Repubblica Cecoslovacca nel 1918.
221
Da Yalta all’instaurazione di un regime stalinista nel 1948
Il paragrafo seguente rievoca il più brevemente possibile il contesto dei dibattiti
concernenti la questione polacca al momento della conferenza di Crimea. Mi soffermerò
soltanto sui quattro punti più importanti.
E’ chiaro che Yalta non fu né la prima né l’ultima occasione di discussione dei Tre
Grandi sulla Polonia. Già a Mosca nell’ottobre 1943, era diventato evidente che gli argomenti
sovietici avevano avuto la meglio sulla fragile linea di difesa presentata dai Britannici. A
Teheran, Stalin ottenne il consenso generale dei suoi interlocutori per spostare la Polonia verso
ovest, Churchill prese la difesa del governo polacco in esilio ed era apparentemente persuaso
che fosse possibile un accordo equo. Roosevelt non sollevò alcuna obiezione e chiese soltanto a
Stalin di rimandare la decisione finale dopo le elezioni americane. Durante la riunione di Mosca
nell’ottobre dell’anno seguente, che abbiamo già ricordato, apparve chiaramente che il governo
polacco in esilio non aveva nessun ruolo da giocare nei negoziati, poiché la decisione di
Teheran sulla questione delle frontiere aveva totalmente minato la sua posizione e non lasciava
spazio ad una politica alternativa. “Voi altri polacchi, voi siete come gli irlandesi” dichiararono
responsabili politici britannici a un inviato del governo in esilio dall’inizio del 1944, “siete
soltanto capaci di pensare riferendovi al passato”; in effetti secondo i Britannici, Stalin non
aveva alcuna intenzione di far propria la Polonia e, per di più, l’Unione Sovietica non aveva
altra scelta dopo la guerra se non di cooperare con l’Ovest (Dülffer, 1998, p.28). da questo
punto di vista, Yalta non modificò in nessun modo la questione della frontiera orientale della
Polonia, ma rese soltanto pubblica la decisione presa a Teheran. La conferenza rappresentò
un’altra tappa importante del regolamento del problema del futuro governo a scapito del
governo in esilio, ma non portò a nessuna decisione finale sulla frontiera occidentale, che venne
regolamentata solo sei mesi più tardi a Potsdam.
Stranamente, il problema della frontiera occidentale fu dibattuto dai Tre Grandi come se
non avesse alcun legame con la questione tedesca. Solo i Britannici avevano in quella occasione
studiato il
problema del trasferimento della popolazione. Essi conoscevano vagamente cifre di milioni di
persone interessate e opposero questo argomento a quello di Stalin che si pronunciò in favore
della Neisse occidentale; ma essi apparentemente considerarono questo argomento in primo
luogo come uno strumento tattico e, in secondo luogo, come un elemento pratico nel quadro
della futura politica d’occupazione in seno alla zona britannica in Germania. Nessuno dei
protagonisti, Stalin compreso, sembra abbia valutato la sostanza del problema: più i territori
tedeschi promessi alla Polonia e il numero dei tedeschi espulsi verso il restante territorio erano
importanti e più si assottigliavano le possibilità di un’esperienza comunista tedesca. In questo
senso, la tesi del futuro Stato della Germania dell’Est considerato come “il figlio non
desiderato” di Stalin (Wilfried Loth) sembrerebbe meritare ancora la nostra attenzione.
Benché la questione della frontiera occidentale rimanesse in sospeso, sulla carta le
decisioni concernenti il futuro della Polonia avevano persino l’apparenza di una buona
soluzione. L’instaurazione della democrazia e lo svolgimento di elezioni libere, il
rimaneggiamento del governo provvisorio con la presenza di responsabili politici importanti in
esilio o nati dalla resistenza sotto il controllo degli americani e dei britannici, tutti questi
elementi potevano essere considerati come la promessa di una quasi sovranità, se non addirittura
una sovranità per tre quarti, della Polonia. La soluzione di una Polonia democratica sistemata in
seno alla sfera d’influenza sovietica, la cui politica estera e di sicurezza sarebbe stata
probabilmente limitata, e che s’inscriveva nella visione del “mondo unico” dove la
cooperazione tra i Tre Grandi avrebbe chiaramente prevalso sulle tensioni manifestamente
visibili, poteva ancora essere concepita come il mezzo migliore per risolvere “l’interminabile
imbroglio polacco” (Yergin,1980). Questa lettura delle decisioni prese a Yalta si rivelò tuttavia
sbagliata durante le settimane che seguirono, innanzitutto a causa dell’arresto e del giudizio dei
capi della resistenza che avevano voluto negoziare con Mosca sulla base dell’accordo di Yalta.
222
Questa situazione e tutte le successive violazioni dell’accordo mostrano quanto fosse limitata
l’influenza della conferenza di Crimea; è opportuno comunque sottolineare che si trattava di
azioni e di decisioni unilaterali da parte di Mosca che chiaramente non rispettava né la lettera,
né lo spirito dell’accordo di Yalta.
Adesso interroghiamoci sulla reazione dei polacchi all’annuncio delle decisioni prese
nel febbraio 1945. possiamo distinguere tre tipi di reazioni. I comunisti ne furono incantati: la
riconoscenza ben presto conferiva loro una dimensione internazionale e la formula di un
“rimaneggiamento” del governo indicava chiaramente che il nocciolo della struttura esistente
sarebbe stata preservata. Il governo polacco in esilio, d’altra parte, vedeva in Yalta la conferma,
persino nella sua versione scritta (senza la particolare messa in opera che non tarderà a seguire),
dei suoi peggiori timori: la Polonia stava per perdere quasi la metà del territorio ante guerra, la
quantità di territori tedeschi che le erano stati attribuiti come compensazione restava incerta e il
riconoscimento veniva messo da parte come se non esistesse. Le decisioni prese in Crimea,
avvertì il governo, “creano una situazione nella quale il resto della Polonia è costretto a
diventare uno Stato satellite della Russia” (Kersten,1989, p.103 Dülffer,1998, p.101). Era
esattamente quello che all’inizio George F. Kennan aveva predetto in una serie di telegrammi
che nessuno a Washington aveva apparentemente preso sul serio o, più precisamente, che
nessuno aveva giudicato sufficientemente importanti. La censura britannica nascose al governo
in esilio il citato telegramma indirizzato al comando della resistenza, come fece con altre
numerose comunicazioni , ma la politica di “protesta nazionale” proseguì, questa volta in
opposizione alla “nuova divisione della Polonia” (Kersten, op. cit. p.104) ; finì senza sorprese
con il ritiro del riconoscimento ufficiale del governo in esilio da parte del Regno Unito e degli
Stati Uniti nel luglio 1945.
Le reazioni più interessanti e politicamente più importanti furono quelle del Partito
Contadino (al quale Mikolajczyk apparteneva) e del Partito Socialista, entrambi operanti nella
clandestinità. Il Partito Contadino era probabilmente il più potente in seno alla resistenza e
occupava una posizione chiave in esilio; esso scontava su una vittoria schiacciante nel corso
delle promesse libere elezioni. I socialisti erano numericamente meno importanti ma contavano
su parecchi uomini politici conosciuti, che avevano sempre giudicato remota la negoziazione
con l’Unione Sovietica. I due partiti subirono comparativamente delle deboli perdite durante
l’occupazione tedesca e sovietica. Il Partito Contadino decise di conformarsi a Yalta, nella
speranza che il ritorno di Mikolajczyk e le elezioni libere avrebbero portato i loro
rappresentanti al potere. I socialisti in esilio rifiutarono l’accordo, mentre quelli rimasti in
Polonia sostennero la posizione del partito contadino. Il Consiglio di Unità Nazionale, autorità
civile suprema della resistenza, si pronunciò il 22 febbraio in favore dell’accettazione delle
decisioni di Yalta. Il paese era troppo esangue per resistere all’invasione sovietica; alla fine
dell’occupazione tedesca, la popolazione aspettava di poter ritornare a una vita normale e, se
Stalin e i comunisti polacchi avessero accettato la presenza di altri responsabili politici polacchi
nelle negoziazioni future, si poteva forse sperare di ridurre le perdite territoriali prevedibili
all’est.
Nei mesi che seguirono, la messa in pratica delle decisioni di Yalta vide svanire la
maggior parte delle speranze che i polacchi avevano riposto in esse. La Polonia, che poteva
essere considerata come un membro fondatore della coalizione antihitleriana, non ebbe il diritto
di prendere parte alla prima sessione dell’Organizzazione delle Nazioni Unite in aprile. I capi
delle resistenza contro la Germania, che uscivano dalla clandestinità per cominciare a negoziare
con i Sovietici, furono fermati e condannati a Mosca; il capo delle resistenza civile e il
comandante in capo morirono presto in una prigione sovietica, mentre gli altri condannati
furono liberati e ritornarono in Polonia dove un gran numero di essi fu di nuovo arrestato,
questa volta dalla polizia segreta polacca. Nel momento stesso in cui si svolgeva il processo dei
capi della resistenza iniziarono le trattative fra Mikolajczyk, capo dei “ Polacchi in esilio”, e i
Comunisti; fu nel corso di queste negoziazioni che il segretario del Partito Comunista pronunciò
questa celebre frase: “ noi non restituiremo mai il potere una volta che l’avremo preso”. La
popolazione polacca non seppe niente di questa affermazione; a giudicare dall’accoglienza
223
entusiasta riservata a Mikolajczyk al suo arrivo a Varsavia alcuni giorni dopo, molti credevano
ancora che la Polonia sarebbe potuta sfuggire in un modo o l’altro alla dominazione sovietica.
Tutte queste speranze presero svanirono con il terrore poliziesco e la soppressione inesorabile
dell’opposizione anticomunista, il referendum del 1946 e le elezioni del 1947, entrambe truccate
e infine, l’instaurazione di un regime staliniano totalitario nel 1948.
L’era comunista e l’eredità di Yalta
Yalta divenne così per la Polonia il simbolo di un tradimento. Non si potrebbe
sottolineare troppo il cambiamento operato dal 1945 al 1947 nell’opinione pubblica: coloro che
contestavano la Conferenza di Crimea nella primavera 1945 protestavano contro le sue
conclusioni, la perdita delle province orientali e la perdita della sovranità nazionale. La
violazione di queste decisioni ufficiali, l’inizio della guerra fredda e l’esistenza di un volto
crudele della cortina di ferro modificarono l’opinione riguardo il soggetto di Yalta, che in realtà
andò ben aldilà di ogni dubbio della primavera 1945. La Conferenza di Crimea cominciò a
simbolizzare molto più ancora: il tradimento non solo dell’Unione Sovietica, ma anche delle
potenze occidentali che non avevano preso alcuna precauzione per assicurare la messa in opera
dell’accordo. Sul piano interno, Yalta fornì un motivo di rifiuto di ogni discussione con i
comunisti e di fiducia nelle loro dichiarazioni. Ella sperimentò la divisone fra “noi” (cioè la
società) e “ loro” (le autorità), che modellò la storia politica della Polonia almeno alla fine degli
anni ‘70 e negli anni ‘80: se vi è impossibile fidarvi della minima affermazione dell’ avversario
, nessuna negoziazione in pratica è possibile.
Al di là di queste incidenze pratiche, “ Yalta” divenne il simbolo del carattere disperato
del posto che occupava la Polonia fra Est e Ovest durante l’intera guerra fredda. Timothy
Garton Ash comincia la sua opera Polish Revolution – Solidarity ( La rivoluzione polacca –
Solidarietà ) con un’impressione personale:
“ Al mio primo viaggio in Polonia, sentivo sempre una parola estremamente strana. “
Yowta”, sospiravano le mie nuove conoscenze, “ yowta” e la conversazione
sprofondava in un silenzio malinconico. “ Yowta”, significava il destino, mi chiedevo,
si trattava di un’espressione equivalente a “è la vita ..”?”.
“Yalta” ( che si pronuncia in polacco “ yowta” ) rappresentava l’elemento primo
dell’esistenza nella Polonia contemporanea. E’ a Yalta che inizia la storia di Solidarietà. Per i
Polacchi, “Yalta” significa che, poiché la loro armata era stata la prima a resistere a Hitler, che
la Gran Bretagna era entrata in guerra per difendere l’indipendenza della Polonia e che i soldati
polacchi si erano battuti coraggiosamente per la difesa del Regno Unito, che sei milioni dei loro
compatrioti ( un cittadino su cinque della Repubblica polacca prima della guerra) avevano
trovato la morte nel corso della guerra, malgrado tutte queste prove, i loro alleati occidentali
britannici e americani gli avevano consegnati alle famose tenere cure di “zio Joe” .Stalin.
Benché si possa sostenere che Churchill e Roosevelt non avessero altra alternativa,
poiché al momento in cui i Tre Grandi si riunivano a Yalta in Crimea nel febbraio 1945
l’Armata Rossa occupava già il territorio dell’antica Repubblica polacca, e sebbene, nel
comunicato di questa riunione, Stalin avesse promesso solennemente “la gestione appena
possibile di elezioni libere e senza impedimento, a suffragio universale e con voto segreto”
questa liberazione fu per la popolazione polacca una benedizione oscura. Ma se si vuol
comprendere perché la prima rivoluzione operaia contro uno “ Stato operaio” ebbe luogo
precisamente in Polonia nell’agosto 1980, conviene capire perché la prospettiva di una
“liberazione” sovietica fu spaventosa per la maggior parte dei Polacchi nel 1945.
L’annientamento di “Solidarietà” dall’armata il 13 dicembre 1981 rinforzò la
convinzione generale che “Yalta rappresentasse l’elemento primo dell’esistenza nella Polonia
contemporanea“. Gli Stati Uniti e gli Stati dell’Europa occidentale reagirono elevando proteste e
infliggendo sanzioni, ma se certi dirigenti di “Solidarietà” speravano di vederli adottare una
224
inclinazione ”bellica”, non tardarono ad essere delusi. Yalta rimaneva; la partecipazione della
Polonia alla Seconda guerra mondiale prescriveva i limiti delle reazioni occidentali.
D’altronde, né l’elezione di un papa polacco, né l’apparizione del sindacato
“Solidarnosc”, erano state previste al tavolo delle negoziazioni della conferenza di Crimea. Per
spiegare in alcune parole l’importanza di questi fenomeni, ricordiamo che milioni di Polacchi
assistettero alla prima visita di Giovanni Paolo II in Polonia nel 1979 e che si stima in dieci
milioni di persone circa il numero degli aderenti a “Solidarnosc” nel 1980-81. Al suo ritorno in
Polonia nell’estate 1945, Mikolajczyk aveva posto tutte le sue speranze nelle elezioni libere
promesse a Yalta. Questo scrutino “permetterà di contarci”, sottolineava lui senza sosta, un
modo per dire che avrebbe dimostrato che la maggioranza dei suoi concittadini erano favorevoli
alla democrazia e contrari al comunismo. I comunisti impedirono nel 1946 e 1947 ai Polacchi di
“contarsi” e solo gli avvenimenti del 1979 – 1981 portarono la prova che il socialismo di Stato
non era che un’opzione scelta in favore di una minoranza. Questa dimostrazione segnò il punto
di partenza dell’ultimo capitolo della Repubblica Popolare Polacca alla fine degli anni 1990,
quando le autorità decisero di aprire negoziazioni con ciò che restava del sindacato
“Solidarnosc”. Una volta ancora Yalta giocò il suo ruolo. Inizialmente i dirigenti di
“Solidarnosc” espressero forti riserve su queste negoziazioni, persuasi che i comunisti
avrebbero dato ancora una volta prova di voler imbrogliare e che il loro obiettivo era di reiterare
il loro piano del 1945 – 1947.
In secondo luogo, e questo elemento è più importante ancora, la convinzione restava che
Yalta continuava a definire il quadro delle trattative diplomatiche polacche. Le recenti
esperienze della società provano, dichiarava Bronislaw Geremek all’inizio dell’anno 1989, che
essa deve rinviare le sue aspirazioni a dei “ limiti ragionevoli” questo significava che la
trasformazione augurata dalla Repubblica Popolare Polacca verso la normalità si sarebbe
effettuata progressivamente e in maniera progressiva, tenendo sistematicamente conto del ruolo
particolare ricoperto da Mosca in virtù delle decisioni prese in Crimea e della loro
interpretazione.
Le ingerenze nella stampa dell’epoca rivelano l’apparizione di un’altra dimensione
pratica della sindrome di “Yalta”. Nel corso delle discussioni che avevano preceduto la
riunificazione della Germania, un vecchio diplomatico comunista aveva denunciato la nuova
politica straniera, cioè l’apertura verso l’Ovest, del governo “Solidarnosc” nel 1989 sotto il
titolo “ Yalta resta valida”, significando che Varsavia restava nella sfera d’influenza sovietica e
che doveva obbedire alla voce del suo padrone. Uno dei suoi oppositori replicò: “Yalta non è
eterna”. La spartizione della Germania aveva concretizzato la divisione dell’Europa, la
rivoluzione polacca scalzò inizialmente la divisione della Germania, poi la cortina di ferro e
finalmente la struttura completa del mondo stabilito à Yalta ( Ludwig, p. 37/ 63, 27/40, Senato
23 X 91); felicemente , egli aveva ragione.
Yalta fu bruscamente messa da parte dalla “rivoluzione” (T. Garton Ash ) dal 1989 ? In
pratica, non c’è alcun dubbio. Eppure, le nozioni fondamentali che hanno plasmato
l’immaginario politico di due generazioni rimangono presenti sotto la forma di correnti
sotterranee o di elementi di riferimento, anche dopo la loro classificazione negli archivi delle
idee politiche; è la ragione per la quale i dibattiti attuali sul terrorismo, il Medio Oriente o la
Cecenia evocano talvolta l’idea di una “nuova Yalta”. E’ difficile contenersi nelle discussioni
relative alla politica estera polacca contemporanea. Qui affiora un altro aspetto del nostro
argomento, la questione delle frontiere.
La frontiera sovietico–polacca è stata tracciata da Hitler e Stalin, poi complessivamente
confermata da Churchill e Roosevelt. La frontiera tedesco-polacca fu un’idea di Stalin,
approvata ad un tempo dagli Stati Uniti e dal Regno Unito, con alcune riserve. Le due soluzioni
formarono un insieme, ciò che rendeva l’approvazione degli Anglo-Americani definitiva,
prevedendo la messa in opera dell’idea di “popoli puri” ossia il trasferimento forzato di milioni
225
di Tedeschi, di alcuni milioni di Polacchi, di centinaia di migliaia di Ucraini e di un numero
minore di Bielorussi e di Lituani.
Questo metodo ebbe come conseguenza quella di creare un’Europa centrale e orientale
dove, per la prima volta in ottanta anni, i problemi di frontiere e di minoranze non guidavano
più le relazioni; il successo o il fallimento della trasformazione di un paese non può più essere
attribuita alla presenza degli “altri”, ma riposa essenzialmente sui nostri propri meriti o il nostro
fallimento personale. E’ qui senza dubbio una conseguenza di Yalta che nessuno degli
protagonisti, partecipanti o vittime, aveva previsto.
226
Referenze e bibliografia
Ash, Timothy Garton, La Rivoluzione Polacca: Solidarietà, 1980- 1982, Londra 1983
Dülffer, Jost, Jalta. 4. Februar 1945: Der Zweite Weltkrieg und die Entstehung der bipolaren
Welt. Monaco, 1998.
Gaddis, John L., We know now, Oxford University Press, Oxford, 1989.
Nicieja, Stanislaw (ed), Jalta z perspektywy polwiecza, Opole, 1995.
Kersten, Krystyna, Jalta w polskiej perspektywie, Londra e Varsavia, 1989.
Zubok, Vladislav, e Konstantin Pleshakov, Inside the Kremlin’s Cold War: From Stalin to
Khrushckev, Harvard University Press, Cambridge, MA, 1996.
227
30. Yalta, Potsdam e l’emergenza della Guerra fredda: la visione della
Germania dopo le recenti ricerche.
Wolfgang Benz
La Germania e la conferenza di Yalta.
La riunione dei “Tre Grandi”, Roosevelt, Churchill e Stalin a Yalta dal 4 all’11 febbraio
1945 entrò nella leggenda più di qualsiasi altra conferenza organizzata durante la guerra dai
membri della coalizione antihitleriana (Smyser, 1999; Graml 1985, Dulffer 1998). La
conferenza del palazzo
di Livadia fu quasi immediatamente presentata in Germania come
una cospirazione contro l’Europa e un accordo con l’obiettivo della divisione del mondo e in
questo senso, di abbandonare l’Europa orientale alla dominazione sovietica (vedere, per
esempio, Stover, 2003; Mastny e Schmidt, 2003; Ressing 1970; Laloy, 1990).
Le ricerche storiche hanno messo in luce che la preoccupazione essenziale di Stalin a
Yalta era di confermare il riconoscimento di una sfera d’influenza sovietica in Europa dell’Est
e del Sud- Est oppure, poiché Churchill frenava così violentemente queste ambizioni, almeno di
delimitare chiaramente il tracciato delle frontiere polacche (cioè l’esigenza di un accordo su una
frontiera orientale lungo la linea Curzon e su una frontiera occidentale lungo la linea OderNeisse) e il ruolo dell’Unione Sovietica negli Stati Balcanici. Inoltre Stalin sperava di
determinare il totale delle riparazioni imposte alla Germania e la parte che doveva ritornare alla
Unione Sovietica. Egli propose la somma totale di 20 miliardi di dollari (USD), di cui 10
miliardi all’Unione Sovietica; quest’esigenza doveva in origine essere discussa a Yalta. Sei mesi
dopo a Potsdam, il principio di questi “10 miliardi” contribuì in maniera decisiva al
deterioramento delle relazioni fra l’Unione Sovietica e le potenze occidentali. La questione delle
riparazioni mantenne la divisione della Germania parecchi decenni dopo Potsdam, poiché era
stato deciso che ogni potenza occupante avrebbe ottenuto riparazione nella propria zona di
occupazione.
A Yalta il presidente Roosevelt si preoccupava soprattutto di ottenere da Stalin
l’impegno dell’entrata in guerra dell’Unione Sovietica contro il Giappone (dopo la disfatta della
Germania) e di assicurare la cooperazione dell’Unione Sovietica per la creazione delle Nazioni
Unite. La Costituzione di una organizzazione di pace permanente rappresentò in definitiva il più
importante obiettivo di guerra alleato dalla dichiarazione solenne pronunciata al momento della
firma della Carta Atlantica nel 1941. Come Churchill, Roosevelt voleva d’altronde evitare una
ascesa incontrollata della spinta espansionista sovietica in Europa dell’Est e del Sud – Est,
tentando di regolarla con una sorta di cordiale sfiducia.
I negoziati intrapresi a Yalta furono caotici, per svariate ragioni: gli alleati occidentali
non avevano fiducia nel loro partner orientale; inoltre dei grandi sconvolgimenti potevano
essere instaurati visto che il futuro restava incerto; infine, gli interessi dei principali protagonisti
e dei loro paesi satelliti erano profondamente divergenti. Le conseguenze di certi accordi non
apparvero che molto più tardi, come nel caso delle centinaia di migliaia di cittadini sovietici che
avevano lasciato la loro patria sulla scia dell’armata tedesca in ritirata, sia volontariamente, sia
sotto costrizione. Dopo l’8 maggio 1945, essi furono rimandati d’ufficio dalla Commissione di
rimpatrio in Unione Sovietica, dove la maggior parte di loro conobbero un tragico destino.
Trattandosi della Germania o più precisamente di ciò che doveva rimanere, i “Tre
Grandi” decisero di procedere al disarmo e alla demilitarizzazione completa del paese e
all’imposizione di tasse considerevoli per la ricostruzione. L’altro accordo importante fu quello
che invitò la Francia (cioè il governo provvisorio diretto da Charles de Gaulle, ufficialmente
riconosciuto dalle potenze occidentali nell’autunno 1944 e dal Cremlino qualche tempo dopo) a
partecipare al controllo esercitato dagli alleati sulla Germania, divenendo la quarta potenza
228
dotata della propria zona di occupazione. Quest’ultima doveva essere situata nel sud-ovest della
Germania e prelevata dalle zone occupate dagli Americani e Britannici, mentre la zona
sovietica restava inalterata.
Quattro obiettivi principali erano proposti da De Gaulle dall’estate 1944: la
federalizzazione del Reich tedesco, ossia il suo smantellamento in diverse entità autonome; la
separazione della Renania dal resto della Germania, al fine di garantire la sicurezza della
Francia; la messa sotto controllo internazionale della Ruhr; e infine l’affiliazione o
l’incorporazione nella Francia della Sarre e delle sue miniere di carbone. Gli interessi francesi e
sovietici si riavvicinavano su alcuni punti. Quando De Gaulle accettò la linea Oder-Neisse come
futura frontiera orientale della Germania nel corso della sua visita a Mosca nel dicembre 1944,
egli sperava che di ritorno Stalin avrebbe riconosciuto il tracciato di una frontiera occidentale
lungo il Reno; il controllo internazionale della Ruhr (con la partecipazione dell’Unione
Sovietica) rappresentava un obiettivo estremamente allettante per il Cremlino ( Wolfrum 1999,
pp 60-72).
Questi ambiziosi piani francesi si rivelarono totalmente illusori, precisamente perché la
Francia era considerata al massimo come un partner subalterno nel gruppo delle grandi potenze.
De Gaulle non fu invitato a partecipare alla Conferenza di Potsdam nel luglio 1945 così come
non lo fu al summit di Yalta nel precedente mese di febbraio. La Francia fu profondamente
ferita nel momento in cui capì di essere considerata e trattata come una potenza di secondo
piano. Questa situazione ebbe conseguenze maggiori sull’orientamento della politica francese
dinanzi alla Germania negli anni successivi.
I piani e le riflessioni per la divisione della Germania furono rapidamente superati nel
corso della fase finale della guerra. Già nell’autunno 1944, il personale militare britannico
incaricato della realizzazione degli studi di previsione era pervenuto alla conclusione che le
ripercussioni di uno smantellamento politico della Germania sarebbero state così incresciose per
la sua economia che esse avrebbero potuto far nascere dei gravi problemi, collocando gli Stati
recentemente creati in una situazione di dipendenza dinanzi ad altri paesi, e provocando un
abbassamento del tenore di vita che avrebbe compromesso l’indipendenza di questi nuovi Stati e
limitato la capacità della Germania di sdebitarsi. Gli esperti britannici avanzavano in appoggio a
questa tesi un ulteriore argomento: la divisione della Germania avrebbe comportato
l’impoverimento del paese, rallentato il risanamento del mondo nel suo insieme, indebolito dai
danni causati dalla guerra, e di conseguenza, avrebbe portato ugualmente danni agli interessi
economici del Regno Unito.
Il cancelliere dello scacchiere britannico, Anderson, si era opposto al piano di divisone
della Germania dall’inizio del mese di marzo 1945 (rendendo chiaro il suo scetticismo riguardo
ai risultati della Conferenza di Yalta); la su opposizione si basava anch’essa su delle
considerazioni economiche esposte in un memorandum: secondo lui, la Gran Bretagna doveva
scegliere fra una politica di riparazione e una politica di taglio, ma non poteva sperare di
condurle entrambe allo stesso tempo.
L’intenzione di procedere alla divisione della Germania, manifestata in occasione del
summit di Teheran, che aveva riunito nel novembre 1943 la coalizione antihitleriana, e
apparentemente confortata e resa ufficiale dalla creazione di una commissione competente a
Yalta, era infatti già sepolta nel febbraio 1945, prima della capitolazione del III Reich, e apparve
finalmente come una minaccia. Poiché Stalin non voleva rinunciare alla ricchezza tedesca
ch’egli contava di sfruttare, i responsabili politici a Washington e a Londra, preoccupati dal
punto di vista economico, non rivolgevano certamente la lama contro se stessi: il controllo
dell’industria tedesca, unito al disarmo e alla demilitarizzazione del paese, garantivano la
sicurezza e si avvicinavano agli interessi economici britannici. Il ministro britannico degli
Affari Esteri, Eden, tentò di convincere i responsabili politici revanscisti di questa realtà: la
creazione di una serie di piccoli Stati tedeschi sarebbe stata allo stesso tempo un peso
economico per i vincitori della guerra e un errore politico; e la combinazione di questi due
229
fattori avrebbe costituito un insormontabile handicap per condurre l’Europa sulla via del nuovo
ordine internazionale in cui essa sperava (Benz, p.45).
Le reazioni in Germania
In Germania, l’opinione pubblica riguardo la Conferenza di Crimea rimaneva
controllata e manipolata da Goebbels. La stampa tedesca (Völkischer Beobachter, VB), creò
degli slogans che rappresentavano l’idea che i tedeschi si facevano di Yalta e che in parte
continuano a farsi tutt’oggi. Mentre prima della conferenza essa dichiarava che in seguito alle
proposte britanniche, milioni di tedeschi sarebbero stati inviati come schiavi in Siberia, il
Völkischer Beobachter presentava sul momento la divisione del Reich tedesco e “la distruzione
completa del popolo tedesco” come gli obiettivi militari ufficiali della coalizione antihitleriana
(VB, 3 febbraio 1945). Dinanzi al comunicato diffuso dopo la chiusura della Conferenza di
Crimea, i giudizi della stampa furono ugualmente dello stesso tenore: Stalin aveva “spennato” le
potenze occidentali, Roosevelt e Churchill avevano “preso i loro ordini da Stalin per nove
giorni” ed erano stati costretti a fare propri “gli slogans di sterminio e di odio“ del dirigente
sovietico (VB, 14 febbraio 1945). Essa pretendeva che Stalin avesse riservato alle sue comparse
solo un ruolo minore a Yalta, affermazione diffusa con dei titoli come “Roosevelt e Churchill
trainati dai rivoluzionari bolscevichi mondiali” (VB, 15 febbraio 1945), e che “il decreto di
morte” dell’Europa era stato firmato. La Germania rappresentava ormai la sola potenza capace
di opporsi a Mosca:
“ Mentre la stampa inglese e americana tentano di cancellare l’impressione di sconfitta
totale di Roosevelt e Churchill a Yalta, la maggior parte degli osservatori neutrali
considerano che i Sovietici hanno riportato una vittoria totale e hanno fatto progredire la
rivoluzione bolscevica mondiale in maniera decisiva. I piani di sterminio elaborati
contro la Germania hanno seminato il germe di nuove guerre; i decreti tirannici che
decidono il destino della Polonia e della Yugoslavia significano la fine di tutte le
nazioni. Appare sempre più chiaro che se si è parlato della questione tedesca, è in realtà
dell’Europa che si trattava e che con lo sradicamento del popolo tedesco il Continente
perderà il suo punto di equilibrio e sarà assoggettato alla tirannia senza limiti dei
Bolscevichi” (VB, 16 febbraio 1945).
Gli attacchi si susseguirono sullo stesso tono. Pur precisando che Yalta era il “prodotto
di cervelli che rappresentavano un pericolo per la popolazione”, la stampa annunciava che tutta
la popolazione dei paesi nemici cominciava “a sospettare che si progettasse a Yalta un crimine
le cui conseguenze sarebbero state terribili per l’intera umanità” (VB, 17 febbraio 1945). Questa
affermazione era pertanto il frutto dell’immaginazione della propaganda nazista, come quella
lanciata in un altro titolo della stampa nazional-socialista, secondo il quale il progetto
bolscevico di dirigere l’Europa faceva parte di un vecchio piano elaborato dagli Ebrei per
rinforzare il loro dominio sul mondo (NS- Kurier Stuttgart, 11 marzo 1945). Tutti i mezzi
possibili e immaginabili furono impiegati per trarre vantaggio da Yalta in favore della
propaganda tedesca e dei suoi appelli al riallineamento.
L’organo nazista più autorevole, Das Reich, evocava ugualmente “il nuovo ordine
voluto da Stalin” e “la sottomissione anglosassone”; con stupore, vi si trova già la metafora
della “cortina di ferro”, di cui la paternità sarebbe stata attribuita a Churchill nel 1946, in
occasione del suo discorso di Fulton:
“Malgrado il viaggio per avanzare richieste intrapreso da Churchill a Mosca, e prima
dell’elezione di Roosevelt, la cortina di ferro del fatto compiuto bolscevico si era abbattuta
sull’insieme dell’Europa del Sud – Est” (Noelle e Neumann, 1956, p.140).
Gli slogans della propaganda nazista continuarono a influenzare a lungo
l’immaginazione dei Tedeschi dopo il crollo dello Stato nazista. Dal momento della loro
230
utilizzazione nel corso della guerra fredda a Ovest, gli slogans anticomunisti furono
particolarmente efficaci e durevoli pur offrendo una sorta di consolazione in mezzo alle rovine
della disfatta. Questi slogans facilitarono ugualmente la sottomissione ai vincitori occidentali,
poiché permisero rapidamente di avvertirli come dei protettori contro l’Unione Sovietica
stalinista. Inoltre questa ostentazione di anticomunismo nel giorno fatidico alimentò una
menzogna tuttora creduta da un buon numero di tedeschi, l’illusione che la Germania avrebbe
potuto e dovuto, alleandosi con le potenze occidentali, proseguire immediatamente nel 1945 il
combattimento contro il nemico bolscevico all’est.
L’idea del fallimento delle potenze occidentali a Yalta e Potsdam nel loro scontro con
l’Unione Sovietica era quella di Goebbels. La propaganda tedesca e i suoi successori non
vollero riconoscere che le due conferenze non erano un scontro, ma delle riunioni fra partners
alleati.
Comunque sia, un sondaggio effettuato nella Repubblica Federale Tedesca nel
settembre 1951 chiese alle persone interrogate quale fosse stato il più grande errore delle
potenze occupanti. Il 15% rispose “il loro errore di predisposizione nei confronti dei Russi
(Yalta, Potsdam)”. Si trattava della seconda risposta data più frequentemente (dopo lo
“smantellamento e la distruzione dell’industria”, 21%) che precedeva l’accusa della ”espulsione
dei Tedeschi dai Territori dell’Est” (risposta data dal 3% dalle persone interrogate).
Questo rapporto fra la ripartizione delle accuse è ugualmente interessante, nella misura
in cui i Tedeschi erano abbastanza ben informati sulle espulsioni dai territori orientali, mentre il
cittadino medio sapeva poche cose sulle altre questioni negoziate a Yalta e Potsdam. E’ ciò che
si evince da un’altra inchiesta condotta nel novembre 1951. Interrogati sui punti più importanti
degli “Accordi di Potsdam”, il 20% delle persone citarono la “cessione dei territori dell’Est,
l’ingiustizia fatta agli espulsi”. Il 19% risposero “ la divisione della Germania”. La risposta
seguente, data dal 12 % delle persone, evoca l’asservimento della Germania e la fine
dell’indipendenza tedesca”. Facevano seguito dunque per l’11 % “la demilitarizzazione, la
denazificazione, i processi dei criminali di guerra” e per l’8 % lo smantellamento dell’industria.
Il 10% delle persone interrogate non diedero alcuna risposta chiara e più della metà, cioè il 55
% non avevano la minima idea del contenuto degli Accordi di Potsdam ( Mannheimer Morgen,
29 maggio 1953).
La riunificazione tedesca e l’eredità di Yalta e Potsdam.
Via via che il periodo trascorso dall’avvenimento si allontanava, veniva a mancare la
conoscenza dettagliata delle discussioni e delle decisioni di Yalta e Potsdam e la guerra fredda
fece di “Potsdam”, o della violazione dei suoi accordi, una formula suscettibile di essere
sfruttata politicamente e di venire spesso contrapposta in campo avverso.
Uno degli aspetti essenziali della disponibilità degli alleati occidentali fu l’accento posto
sul carattere temporaneo delle risoluzioni di Potsdam relative alle ricostruzione,
all’eliminazione del nazismo, alla demilitarizzazione ed al ristabilimento della democrazia in
Germania; l’idea che Potsdam sarebbe la prima tappa verso la creazione di una pace che,
preparata da un Consiglio dei ministri degli esteri riconosciuto giuridicamente, culminante in un
trattato di pace con la Germania, rappresentò un altro aspetto dell’immediato dopoguerra. La
speranza dei Tedeschi si basava proprio su questo processo politico. A ciò si affiancava
inizialmente l’idea di riunificazione delle quattro zone di occupazione in un nuovo Stato
tedesco, unitamente alla speranza che almeno una parte dei territori perduti a Est forse sarebbe
stata recuperata. Dopo il fallimento della quarta Conferenza dei Ministri degli esteri tenutasi a
Londra nel Dicembre 1947, nel corso della quale le grandi potenze non raggiunsero un accordo
su una politica comune per la Germania, la speranza di una soluzione della “questione tedesca”
in un vicino futuro venne quasi completamente abbandonata.
231
Una volta che i Tedeschi della repubblica federale accettarono lo status quo, che si
tradusse principalmente in una facile integrazione occidentale a fianco della potenza
soccorritrice degli Stati Uniti, anche attraverso la svolta in favore dell’idea di un’Europa unita, e
quando la divisione della Germania e la separazione causata dalla guerra Fredda diventarono
realtà stabile, i dettagli degli accordi di Potsdam poco a poco scomparvero.
Uno dei principali quotidiani regionali della Repubblica Federale espose questa idea nella
primavera del 1953 in un articolo intitolato “ Cosa fu esattamente Potsdam ? “. Dopo aver
descritto l’oggetto e i risultati della conferenza, dichiara a proposito degli “ Accordi di Potsdam
“:
“ Nel frattempo, la storia li ha dimenticati. I loro articoli rimangono validi de facto solo
per i Sovietici, ma unicamente perché essi considerano che potrebbero servire ai propri
interessi politici “ (Neues Deutschland, 15 febbraio 1955 ).
Nella Repubblica democratica Tedesca, l’organo ufficiale del SED e portavoce del
Partito e del governo (Neues Deutschland) diffondeva al contrario la versione accreditata
all’Est, secondo la quale le potenze occidentali avevano propagandato a Yalta l’idea di divisione
della Germania, mettendo in opera in seguito questa politica a Potsdam, per cui:
“ Il ripetuto rifiuto delle proposte sovietiche di creare organi amministrativi centrali, la
riforma monetaria separata [e] la creazione di un distinto Stato tedesco dell’Ovest rappresentano
gli anelli si una stessa catena, destinata a dividere la Germania, che sarà presto perfezionata
grazie ai patti di guerra di Parigi, che creano un esercito di mercenari NATO della Germania
Ovest, … Al contrario, questi ultimi dieci anni, la politica sovietica nei confronti della
Germania era guidata dai principi stabiliti a Yalta e sanciti negli Accordi di Potsdam. Questi
principi, come conferma tutta l’evoluzione del periodo antecedente la guerra, sono vicini agli
interessi del popolo tedesco. Mentre la politica delle potenze occidentali ha cercato di spaccare
la Germania e di coinvolgere il popolo tedesco in una guerra nucleare fratricida e suicida sul
territorio tedesco, il governo dell’Unione Sovietica ha avanzato proposte senza sosta, in vista
della riunificazione pacifica della Germania. (Si troveranno degli estratti, ad esempio, nel
Frankfurter Allgemeine Zeitung del 23 e del 30 novembre 1995).
Gli accordi firmati a Yalta e Potsdam ebbero poco interesse per il comune cittadino
della Repubblica Federale durante la guerra fredda e gli anni di scontro politico, e senza alcun
dubbio poco di più per quello della Repubblica Democratica,. Tutti erano occupati dai problemi
della vita quotidiana: bisognava anzitutto ricostruire e poi guadagnarsi la giornata. Nella
Repubblica Democratica lo spirito di Potsdam era invocato in occasione delle commemorazioni
o in occasioni simili. L’Ovest mostrava sistematicamente la sua versione dei fatti, ricordando
quando e come l’Unione Sovietica avesse violato altri patti firmati a Potsdam e affermando
come essa sola fosse responsabile dello status quo.
Nel corso degli anni ‘50 e ‘60 l’opinione pubblica occidentale era tormentata da una
domanda, instancabilmente posta e dibattuta dai mezzi di informazione, cioè quella dei presunti
accordi segreti firmati a Yalta: un’altra domanda ossessiva riguardava la discussione
sull’annessione del territorio tedesco, frutto dell’ignoranza in materia di geografia e del
disinteresse di cui avevano dato prova gli Americani e gli Inglesi. Si trattava principalmente, in
questa occasione, di Settin, che era stata attribuita alla Polonia mentre in realtà era situata a
ovest dell’Oder, dell’opportunità della cessione completa della Slesia, cui si sarebbe preferita la
cessione della sola parte orientale, e del problema di sapere se la scelta della Neisse occidentale
di Görlitz per il tracciato della frontiera era stata prevista sin dall’inizio o non si dovesse parlare
piuttosto della Neisse orientale. Ci furono in seguito discussioni intellettuali e teoriche sulla
validità delle frontiere del 1937 per ciò che concerne il diritto internazionale: si trattava di
determinare se i territori situati a est della linea Oder – Neisse fossero effettivamente e
irrimediabilmente perduti da parte della Germania. L’ostinazione con la quale il tracciato delle
frontiere del 1937 era propagata ed argomentata nei manuali scolastici sino agli anni ‘70 e la
232
accresciuta ottusità con cui si discuteva della carta metereologica nella televisione della
Germania Ovest (i territori a est dell’Oder dovevano figurare sulla carta come facenti parte della
Germania) non cambiarono per niente il fatto che i Tedeschi semplicemente non diedero grande
importanza a queste pratiche di guerra fredda.
Le decisioni territoriali prese a Potsdam e le loro conseguenze perdurarono nella
memoria collettiva dei Tedeschi in altro modo, e non associate alla Conferenza di Potsdam.
Esse restarono più presenti nelle disposizioni economiche e sociali (demilitarizzazione e
democratizzazione) poiché queste colpivano direttamente l’esistenza di un gran numero di
persone (Timmermann, 1997).
Al tempo della Conferenza di Potsdam nell’estate del 1945, le tre grandi potenze
avevano ratificato ciò che era già stato deciso molto tempo prima: l’espulsione delle minoranze
tedesche da Polonia, Cecoslovacchia e Ungheria. Secondo le affermazioni di Stalin a Potsdam, i
territori della Germania orientale che dovevano essere ceduti alla Polonia e quelli che l’Armata
Rossa aveva già posto sotto l’autorità amministrativa del Governo provvisorio polacco erano
stati abbandonati. Tutta la popolazione tedesca era fuggita. Grazie a questa affermazione, Stalin
rassicurò i suoi partner presenti alla Conferenza, semprechè questi ne fossero preoccupati,
riguardo la sorte dei civili tedeschi di fronte alla prospettiva del loro “trasporto ordinato e
appropriato” al di fuori di Polonia, Cecoslovacchia e Ungheria. Si doveva procedere
all’espulsione dando prova di umanità. Nel dicembre 1944, in un discorso pronunciato dinanzi
alla Camera dei Comuni, Churchill giudicò questa espulsione come “il mezzo più soddisfacente
e duraturo” per stabilire la pace:
“Non ci sarà alcuna di quelle unioni forzate di popolazioni che portano alla nascita di
conflitti interminabili, come ci fu nel caso dell’Alsazia–Lorena. La questione sarà
regolamentata”. (Churchill, 1974, pp. 7213-14).
Il termine di “pulizia etnica” non esisteva ancora, ma è proprio di questo che si trattava.
Un’immenso flusso di rifugiati si riversò, alla fine della guerra e nel periodo che ne
seguì, in una Germania con nuovi confini, devastata e divisa in quattro zone di occupazione.
Alla fine dell’ottobre 1946, si contavano più di 9.600.000 espulsi. Al momento del censimento
effettuato nel settembre del 1950, il loro numero era aumentato di due milioni; ci furono
complessivamente più di 16 milioni di persone, che dopo essere state costrette a fuggire e a
subire il destino degli esuli, avevano ottenuto il diritto di vivere nella Repubblica Federale e
nella repubblica Democratica. Queste persone furono inizialmente considerate come stranieri,
una sorta di pericolo, di poveretti indesiderati, con abitudini e modi di vestire insoliti. Le
popolazioni locali gli fecero capire di considerarli degli stranieri. Ma molto presto,
l’integrazione dei rifugiati e degli esuli diventò una realtà. Fu proprio questo, forse, il vero
miracolo della Germania post-hitleriana.
La perdita d’importanza dei gruppi di pressione e del partito dei rifugiati, il “Blocco
degli espulsi e delle persone private dei loro diritti” dà un’idea della rapidità e della completezza
dell’integrazione degli espulsi nella loro nuova patria. Il partito dei rifugiati, che fu nella prima
parte degli anni 1950 partner di una coalizione popolare ottenendo notevoli successi elettorali,
sia a livello federale che nelle Länder, scomparve totalmente dalla scena politica agli inizi degli
anni ‘70. Visto che era sempre stato un partito che rappresentava gli interessi di un gruppo
strettamente definito, la sua scomparsa fu il segno che l’identità collettiva dei suoi elettori non
sussisteva più e che gli espulsi si erano ormai installati nella loro nuova patria.
Una tale situazione non era immaginabile nell’agosto 1950, quando gli oratori della
Landsmannschaft (una associazione sociale e culturale) ed i responsabili delle associazioni degli
espulsi, “coscienti della loro responsabilità davanti a Dio e agli uomini”, formularono la “Carta
dei rifugiati di etnia tedesca”. Al tempo del raduno di Stuttgard, dove la Carta fu presentata
rinunciando solennemente a qualunque spirito di rivalsa e di punizione, si dichiarò il “diritto a
233
una patria, che costituisce uno dei diritti fondamentali del genere umano, che ci è stato concesso
da Dio”. Questa formulazione fu interpretata, soprattutto in Polonia e Cecoslovacchia, come
espressione di un desiderio di rivincita, e gli espulsi del mondo politico della Germania Ovest
vegliarono in modo che questi malintesi non mettessero radici. Questa attitudine fu
particolarmente evidente nella resistenza indomabile che essi opposero alla Ostpolitik dei socialliberali agli inizi degli anni ‘70 e nel corso di una riunione degli espulsi dalla Slesia nel 1985, il
cui slogan affermava “La Slesia resta nostra !”.
Questi sfortunati propositi tenuti a Ovest furono sempre accolti con gratitudine nella
Repubblica Democratica tedesca; dopotutto le riunioni annuali organizzate dalla
Landsmannschaft a Whitsun, considerati come “Riunioni di rivendicanti”, confortavano la
percezione ufficiale che aveva di essa stessa questa Germania migliore, che aveva ben capito le
lezioni antifasciste, mentre la Repubblica Federale era percepita come pronta ad attendere il
giorno della propria rivincita.
L’integrazione realizzata nella Repubblica Democratica era simile sotto tutti gli aspetti
agli sforzi impiegati e ai risultati ottenuti dalla repubblica Federale. Certo, il suo modo di
risolvere i problemi finì per farne un tabù, visto che questa parlò fondamentalmente ed
esclusivamente di semplici “persone reinstallate” e che le riunioni di espulsi non erano neanche
autorizzate.
Conclusioni
Si può vedere come i Tedeschi accettarono lo statuto territoriale ed etnico definito a
Potsdam nel 1945. Solo una minoranza di simpatizzanti dell’estrema destra, e in nessun caso la
maggioranza dei Tedeschi, ripensò ai confini della Germania del 1937, ma essa non ebbe alcuna
influenza ne peso politico. Il sommovimento occasionale delle associazioni di espulsi e dei loro
responsabili politici, come quello che ribadì lo slogan “La Slesia resta nostra !” nel 1985, non
costituì il segno di una speranza e di un desiderio largamente condiviso di una revisione
territoriale degli Accordi di Potsdam.
In occasione del 50° anniversario della Conferenza di Potsdam un’importante articolo
venne pubblicato nel quotidiano più letto e più autorevole della Germania. Questo articolo si
intitolava “Storia di una salutare umiliazione. Cinquanta anni fa, gli alleati decidevano la sorte
dei Tedeschi a Potsdam”. In conclusione, mi piacerebbe citare le ultime frasi di questo articolo,
poiché esse danno un’indicazione precisa sullo stato d’animo dominante nella maggioranza dei
Tedeschi. Sono trascorsi cinque anni da quando la riunificazione della Repubblica Democratica
e della Repubblica Federale ha avuto luogo, una unificazione temuta da tanti:
“Eccetto i risultati concreti della Conferenza di Potsdam, che furono diversi e, per parte,
non molto durevoli, ci resta da notare come mai nel corso della storia moderna, delle
potenze sconfitte di tale statura fossero state umiliate quanto la Germania ed il
Giappone nel 1945. Ma è proprio questa umiliazione che si è rivelata salutare per i due
Paesi. Questa è l’impressione ineluttabile che si ha mezzo secolo dopo.” (Süddeutsche
Zeitung, 29 e 30 luglio 1995).
234
Referenze
Benz, Wolfgang, Potsdam 1945: Besatzungssherrschaft und Neuaufbau im Vier-ZonenDeutschland, Monaco, 1944.
Churchill, Winston S., His complete speeches, 1897-1963, New York, 1974, Vol. VII, pp. 721314.
Dülffer, Jost, Jalta, 4 Februar 1945: Der Zweite Weltkrieg und die Entstehung der bipolaren
Welt, Monaco, 1998.
Graml, Hermann, Die Aliierten und die Deutschands: Konflikte und Ents cheidungen, 19411948, Francoforte, 1985.
Jacobsen, Hans-Adolf, Der Weg zur Teilung der Welt : Politik und Strategie, Coblenza et Bonn,
1977.
Laloy, Jean, Wie Stalin Europa spaltete: Die Wahrheit über Jalta, Vienna et Darmstadt, 1990.
Mastny, Vojtech, e Gustav Schmidt, Konfrontationsmuster der Kalten Krieges, 1946-1956,
Monaco, 2003.
Noelle, Elisabeth, e Erich Peter Neumann (ed), Jahrbuch der öffentlichen Meinung, 1947-1955,
Allensbach, 1956.
Ressing, Gerd, Versagte der Westen in Jalta und Potsdam? Ein dokumentierter Wegweiser
durch die alliierten Kriegskonferenzen, Francoforte, 1970.
Smyser, William R., From Yalta to Berlin: the Cold War struggle over Germany, Basingstoke,
1999.
Stöver, Bernd, Der Kalte Krieg, Monaco, 2003.
Timmermann, Heiner (ed) Potsdam 1945: Konzept, Taktik, Irrtum?, Berlino, 1997.
Wolfrum, Edgar, “Französische Besatzungspolitik“ in Wolfgang Benz (ed), Deutschand unter
alliierten Besatzung, 1945-1949/55, Berlino, 1999, pp. 60-72.
235
236
31.
Note: una visione ucraina
Mikhailo Kyrsenko
La Conferenza di Yalta fallì nella sua ambizione di stabilire un dispositivo di pace e di
sicurezza affidabile a causa della profonda sfiducia che regnava tra l’ovest ed i Sovietici. La
corsa agli armamenti e la caccia alle streghe ideologiche della guerra fredda danno un limite a
questi nobili principi e promesse. Yalta merita però di essere analizzata in un contesto moderno.
Quindi noi esamineremo i suoi principali aspetti mondiali, regionali, nazionali, locali, esteri ed
interni.
Dal punto di vista del mondo bipolare, del confronto e dell’equilibrio della potenza
militare, fu un vano tentativo di divisione dell’Europa in sfere d’influenza imperialiste. Si
ricordi lo scambio di proposte senza successo tra Churchill e Stalin riguardo alla percentuale
comparativa delle rispettive influenze in Albania, Bulgaria, Grecia, Romania e Jugoslavia. Un
accordo fondato sulla parola d’onore di un criminale non poteva essere uno strumento
affidabile.
I partiti agrari, liberali, social-democratici e altri partiti moderati erano apparentemente
rappresentati nei governi dell’Europa centrale e dei Balcani. Solo i partiti conservatori e clericali
di destra ne erano esclusi. I comunisti parteciparono ugualmente ai governi Italiano, Francese e
di altri Paesi europei. Essi perdettero le elezioni e fecero gioire l’opposizione democratica. La
situazione fu differente a Est.
Le effimere democrazie terminarono la loro breve esistenza nella brutale usurpazione
del potere da parte dei comunisti. La repressione si abbatté sulla resistenza armata in Ucraina e
nei Paesi del Baltico, così come sulle sollevazioni spontanee apparse in Germania, Polonia,
Ungheria e Cecoslovacchia. I sogni fatti dai dissidenti di un “socialismo dal volto umano” si
rivelarono essere solo una illusione. La felicità degli individui era impossibile in un’Europa
divisa, di cui il Muro di Berlino rappresentava il simbolo visibile.
La politica è l’arte del possibile. Eppure, il prezzo pagato dall’Ovest in cambio di una
prosperità incerta sembrava elevato. Alla distensione relativa dell’Unione Sovietica e dei paesi
satelliti fantoccio succedette l’immobilismo post-totalitario. L’opinione pubblica assistette
disperata all’egoistica indifferenza delle grandi potenze. Lo spirito di Yalta rese possibile questa
situazione. E’ poco probabile che abbia preservato la pace, anche se la storia ignora il
condizionale.
L’indipendenza nazionale è solo uno slogan tenace nel nostro mondo interdipendente. Il
problema è di sapere se si dispone di una vera sovranità, di una possibilità di definire
coscientemente e liberamente in qualunque momento di priorità, forme, misure e durate ottimali
della volontaria dipendenza. E’ difficile parlare in termini reali di Stato quando si evocano le
repubbliche socialiste dell’Europa centrale e orientale, tanto all’interno che all’esterno di una
Unione Sovietica fortemente centralizzata.
A quell’epoca, l’Ucraina non esisteva come soggetto sovrano di diritto internazionale.
Sotto il regime totalitario, il paese perse almeno un terzo della popolazione in seguito alle
persecuzioni ed a una carestia deliberatamente organizzata. Nessuno si faceva la minima
illusione riguardo lo status di membro delle Nazioni Unite accordato all’Ucraina. Il paese non
possedeva neanche le prerogative ufficiali della sua identità nazionale, come emblemi, bandiera
e inni nazionali. I colori nazionali, giudicati “nazionalisti borghesi” erano vietati.
I nazionalisti polacchi probabilmente conservarono il ricordo più doloroso di Yalta.
Rappresentava per loro una “quarta divisione” della loro madre patria. Questo numero è
comunque errato, poiché non tiene conto di tutte le ripartizioni territoriali sopraggiunte all’inizio
237
del XIX secolo. Ma si trattava senz’altro di un atto di violenza perpetrato contro la legalità
dell’Unione polacco-lituana del 1569-1795 e della Seconda Repubblica del 1918-1939. Qui il
contesto ucraino ebbe importanza cruciale.
Per un Polacco, la frontiera orientale tracciata a Yalta era totalmente fittizia, poiché
separava dal paese le città di Vilnius, Grodna e Lviv (in polacco Wilnia, Grondo e Lwów). Il
fervore patriottico ne recriminava il ritorno. Non ci fu comunque nessun desiderio di rinunciare
alla frontiera tedesco-polacca stabilita sulla linea Oder-Neisse (in polacco Odra-Nysa) a Yalta.
La sua revisione avrebbe potuto compromettere na nuova acquisizione di Gdansk, Shszecin e
Wroclaw (in tedesco Danzig, Stettin e Breslau).
Per un Ucraino, il tracciato arbitrario della frontiera con la Polonia era insopportabile,
poiché privava l’Ucraina di Peremyshl e Kholm, così come di Lemko e di altre regioni ancora.
Ciò che è stato definito scambio di popolazione da una parte all’altra della frontiera fu in verità
una deportazione forzata. Le accuse di massacri a Volhynia e oltre accentuarono le tensioni
interetniche provocate da Mosca tra Kiev e Varsavia.
Questa situazione facilitò il soffocamento, da parte delle forze di sicurezza nazionali
comuniste, della guerriglia portata avanti dall’Armata polacca dell’interno (Armija Krajow –
AK) e dall’Armata insurrezionale ucraina (UPA). Sotto il regime totalitario, i membri dell’AK
furono perseguitati in Polonia come volgari banditi, sebbene oggi siano stati riconosciuti come
combattenti. I loro omologhi ucraini devono ancora arrivare a provare che la loro lotta contro i
nazisti ed i sovietici fosse una lotta di liberazione nazionale.
Ancora oggi, alcuni gruppi finanziati dall’estero si lanciano in provocazioni. Tuttavia,
tanto sul piano ufficiale che da un punto di vista intellettuale, l’Ucraina non conosce alcuna
controversia territoriale con la Polonia o uno dei paesi confinanti. Tutti gli stati dell’Europa
centrale ed i paesi Baltici hanno aderito all’Alleanza Nord Atlantica e sono ormai sul punto di
aderire all’Unione europea. L’Ucraina non cessa di dichiarare che quello è il suo obiettivo
finale.
La Conferenza di Yalta ha senza alcun dubbio rappresentato un importante passo in
avanti nel consolidamento delle forze alleate in vista della vittoria sul loro nemico comune, i
nazisti. I pareri divergono sul ruolo positivo giocato da Yalta nel futuro dell’Europa. Questa
divergenza è visibile nella terminologia. I comunisti favorevoli ad una linea dura glorificavano
la “Grande guerra patriottica”. E’ vero che si tratta per l’Unione Sovietica della sola guerra
difensiva della sua storia. Anche la Russia imperiale conobbe una sola guerra patriottica, quella
portata avanti contro Napoleone. Il resto delle sue campagne militari furono campagne
d’aggressione, appena velate di messianica demagogia. Il mondo considera la guerra tedescosovietica come un capitolo della Seconda guerra mondiale. Ma al contrario dell’Ovest, gli
Ucraini e gli altri paesi dell’Europa centrale e orientale dovettero subire un altro totalitarismo,
che fece milioni di vittime.
L’Ovest non prestò molta attenzione alla simbolica manifestazione di surrealismo
totalitario che rappresentava la conduzione della Conferenza di Yalta praticamente in un
deserto. La Crimea era in effetti disabitata dopo la recente deportazione dei Tartari e degli altri
popoli minori della regione. La frontiera amministrativa separava la penisola dalla sua patria
naturale, l’Ucraina. Essa sembrava ed era d’altronde praticamente un paese dove era stata fatta
tabula rasa del proprio passato, ancor più che nel resto dell’Europa del dopoguerra. Così
l’Ucraina era in apparenza presente, ma de facto assente dalle nazioni vincitrici del dopoguerra.
Altra coincidenza, si commemora l’anniversario di Yalta in un luogo che, appena dieci anni fa,
sarebbe potuto divenire il punto di partenza di un sanguinoso conflitto nello territorio postsovietico, cosa che fortunatamente non avvenne. Alla vigilia del crollo sovietico, gli ultraconservatori del regime fecero il possibile per respingere, se non addirittura evitare, la
disintegrazione finale. Al fine di impedire la progressiva deriva delle repubbliche dell’Unione
Sovietica verso la loro sovranità, Mosca sostenne i separatismi locali che esistevano in seno a
238
queste repubbliche. Il Caucaso, gli Stati Baltici, la Moldavia e l’Ucraina ne forniscono numerosi
esempi. Gli ex funzionari ristabilirono l’autonomia della Crimea tenendo le popolazioni locali il
più lontano possibile da questi affari.
Talvolta assistiamo ancora a tentativi di incitamento a tensioni o conflitti interetnici
intorno alla flotta russa del Mar Nero, con base a Sebastopoli, non lontano dalla marina ucraina.
Alcune autorità locali negano ai Tartari dell’Ucraina e della Crimea una struttura identitaria
nella loro stessa patria.
L’insieme del patrimonio presente sul suolo di un paese fa parte della sua memoria
ufficiale. Le città-stato greche dell’antichità e i popoli vicini, le comunità italiche, armene e
giudee dell’epoca medievale, così come il khanat tartaro costituiscono altrettanti capitoli della
storia ucraina. Kiev non l’ha mai conquistata. La Crimea di maggioranza russofona è una parte
inalienabile dell’Ucraina, mentre la limitrofa regione ucrainofona di Kouban appartiene alla
Russia.
Le nazioni moderne si definiscono per un patriottismo fondato sul diritto sul territorio
ed un patriottismo fondato sul diritto di discendenza. I Nordamericani anglofobi non si
considerano soggetti britannici. La lealtà politica non sempre va di pari passo con la lingua
materna. Gli Ucraini, come gli altri Europei, dovrebbero parlare almeno la loro lingua
nazionale, un dialetto etnico minoritario oppure locale (per esempio il russo) e l’inglese, in
modo da disporre di un mezzo di comunicazione internazionale.
Nel momento in cui i Tre Grandi discutevano e decidevano del futuro dell’Europa
centrale e orientale a Yalta, le nazioni della regione avevano già conosciuto esperienze diverse
in epoche precedenti. Polacchi, Cechi, Estoni, Lettoni e Lituani conservavano nella loro
memoria la fruttuosa evoluzione, che comunque non fu senza problemi, che essi avevano
conosciuto nel periodo tra le due guerre. La rinascita ucraina era stata interrotta e l’élite
intellettuale ed il potenziale umano avevano sofferto terribilmente durante e dopo il grande
terrore. Non stupisce che la ripresa di questo paese sia così lenta. La politica portata avanti
dall’Ucraina manca spesso, ed in modo prevedibile, della necessaria coerenza per lottare contro
la corruzione e per riformare la società. Ciononostante, la nazione non ha altra alternativa se non
la propria reintegrazione in seno alla famiglia europea, oppure un lento suicidio.
Yalta propose due opzioni. La prima ha portato in un vicolo cieco. Secondo una battuta
amara, il comunismo è la strada più lunga per andare di capitalismo in capitalismo. L’altra
opzione ha portato all’integrazione europea, fondata su principi accettati universalmente come
l’uguaglianza dei cittadini, il pluralismo politico, la proprietà privata, il governo elettivo, la
libertà democratica e i diritti civili. L’equilibrio dei poteri è stato sostituito dal consenso in
favore dei comuni interessi.
La diplomazia del XIX secolo ha inventato l’accordo delle sei grandi nazioni europee:
l’Austria-Ungheria, la Francia, l’Italia, così come gli imperi britannico, tedesco e russo. Senza
vere regole chiare e realiste, le Nazioni Unite non sarebbero oggi in grado di prevenire conflitti
distruttivi e di mantenere la pace, così come non lo seppe fare la Società delle Nazioni di un
tempo. Il tempo degli imperi è scomparso per sempre. L’Europa è ormai composta di Statinazione. Nessuno di essi desidera con di rinunciare alla propria sovranità. Tutti sono pronti ad
abbandonare alcune delle loro prerogative a vantaggio di organi comuni di coordinamento, in
vista di rinforzare la propria sicurezza. Yalta e Potsdam sono il simbolo di un’Europa divisa in
campi militanti dalla frontiera invisibile del crollo ideologico e politico. Maastricht e Schengen
simbolizzano ormai l’Europa integrata grazie ad una tradizione, una ricchezza ed una stabilità
comuni.
Il territorio ucraino ha fatto parte della civiltà bizantina, dei principati feudali slavi, del
Granducato di Lituania, dei regni ungheresi e polacchi, degli imperi ottomano e russo, così
come dell’Austria-Ungheria e degli stati che gli sono succeduti, come la Cecoslovacchia e la
239
Romania. Ortodossa, ma allo stesso tempo cattolica e protestante, l’Ucraina ha condiviso i
valori intellettuali del Rinascimento, del barocco, del classicismo, del romanticismo e di altri
fenomeni ancora.
Repubblicani e realisti si sono succeduti in Europa a più riprese. Ma la storia non
conserva nessun esempio di restaurazione di un impero plurinazionale. Conviene semplicemente
persuadere la Russia a non sostenere pericolosi orientamenti. La Grande Muraglia cinese ed i
limes romani si sono alla fine rivelati incapaci di fermare le invasioni barbare. Edificare una
nuova cortina di ferro, stavolta tra Polonia e Ucraina, non sarebbe per l’Europa la migliore delle
soluzioni.
L’eventuale pacificazione o partecipazione della Russia è realizzabile solo a condizione
che l’Ucraina conservi la propria indipendenza verso se stessa e rimanga uno stato europeo.
Oggi Kiev deve scegliere tra una inevitabile miseria ed una libertà responsabile, anche se piena
di sacrifici. Resta comunque all’Occidente decidere se voglia accogliere in futuro l’Ucraina o
abbandonarla definitivamente con un tradimento comparabile a quello di Yalta, con i rischi
imprevedibili che questa soluzione comporterebbe.
L’Europa prosegue tutt’oggi il suo progressivo mutamento, dagli Imperi arcaici alle
nazioni, in seguito dalle nazioni ad una rete di regioni autonome. Questo consolidamento e
rafforzamento delle opportunità grazie alla diversità culturale è possibile solo all’interno di
questo spazio economico unito e volto a Ovest. Il potenziale di cui dispone l’Ucraina, che è non
solo uno stato mediterraneo, ma anche il più grande stato dell’Europa centrale ed orientale,
apporterebbe enormi benefici a questa costellazione di Stati, nel loro interesse e per il loro
progresso. L’Ucraina non è né la sorella gemella della Russia, né un ponte gettato tra Asia ed
Europa. Il suo ritardo è temporaneo, mentre la sua posizione geopolitica ed i suoi interessi
strategici sono permanenti. Niente potrà essere fatto con un colpo di bacchetta magica, ma
respingere l’Ucraina sarebbe certamente un grave errore.
240
PARTE V
IL 1989 NELLA STORIA EUROPEA
241
242
32. Introduzione all’anno 1989
All’inizio del 1989, pochi sarebbero stati gli osservatori specializzati in grado di
prevedere i cambiamenti cruciali che si sarebbero prodotti in quell’anno in Unione sovietica e
nell’Europa centrale ed orientale.
Nell’autunno del 1987 negli Stati Baltici si svolgono manifestazioni di massa. Un anno
più tardi, l’Estonia sì auto- proclama repubblica autonoma. In Polonia, durante l’estate del 1988,
la direzione del partito comunista polacco accorda uno status giuridico ai gruppi
dell’opposizione, tra i quali troviamo il sindacato indipendente Solidarnosc. Alle elezioni il
Partito Comunista registra risultati mediocri. Il generale Jaruzelski, non essendo riuscito a
formare un governo di coalizione, domanda al redattore capo del giornale Solidarnosc, Tadeusz
Mazowiecki, di costituire il primo governo dell’Europa centrale ed orientale dalla fine degli
anni ‘40 che non sia sotto il controllo comunista.
Nel mese di settembre, l’Ungheria apre le frontiere all’Austria per attirare l’attenzione
internazionale sulla difficilissima situazione in cui vive la minoranza ungherese in Romania.
Migliaia di tedeschi dell’est approfittano di tale occasione per fuggire all’Ovest. Mentre
numerosi “turisti” tedeschi dell’est si dirigono verso la Germania dell’Ovest via Austria, altri
assediano le ambasciate della Germania dell’Ovest a Varsavia ed a Praga cercando di ottenere
visti d’uscita. Dresda e Leipzig sono anch’esse teatro di tumulti e manifestazioni. Quando, il 9
novembre, Egon Krenz, segretario generale del partito comunista della Repubblica Democratica
Tedesca, sembra aver ordinato di aprire i varchi del Muro di Berlino, i tedeschi dell’Est
cominciano a passare in massa dall’altra parte. I giorni seguenti la popolazione comincia la
demolizione del Muro senza che gli agenti di frontiera oppongano alcuna resistenza.
Gli avvenimenti di Berlino servono da detonatore ad altri cambiamenti che avvengono
altrove in Europa orientale. In Bulgaria, il regime comunista lascia il potere l’indomani della
caduta del muro di Berlino. In Cecoslovacchia, il governo comunista tenta di introdurre delle
riforme ed un governo composto da alcuni membri non comunisti, viene formato nel dicembre
1989; ma l’opposizione non lo accetta pertanto viene rimpiazzato da un nuovo governo non
comunista. Tali cambiamenti si svolgono in un contesto sorprendentemente calmo. Vengono
commesse brutalità da parte della polizia in Cecoslovacchia e Germania dell’Est, ma solo la
Romania è per lungo tempo teatro di rivolte interne. Gli avvenimenti sanguinosi che avrebbero
condotto alla disintegrazione dell’ex Iugoslavia dovevano ancora arrivare.
Nessuno avrebbe potuto predire all’inizio del 1989 l’effetto domino che è seguito alla
prima breccia aperta nella Cortina di ferro. La caduta di ogni regime ha apparentemente
scalzato la legittimità, la credibilità e la stabilità di tutti gli altri. Inoltre, l’opinione pubblica, che
ogni giorno constata la vastità delle manifestazioni attraverso gli schermi televisivi, si rende
conto che spesso la risposta dello stato non è così violenta. Elemento fondamentale: il capo
sovietico Mikail Gorbatchev deliberatamente non interviene militarmente a sostegno dei regimi
satelliti. Paradossalmente tale decisione viene presa perché Mosca possa dedicarsi a mantenere
in vita il Comunismo in Unione Sovietica. Nonostante ciò, meno di due anni più tardi,
Gorbatchev non riesce ad impedire la frammentazione della stessa Unione Sovietica.
243
33. 1989: in retrospettiva, l’anno dei miracoli.
Jussi Hanhimäki
Il 1989 è stato denominato l’anno dei miracoli; fu in effetti l’anno nel corso del quale un
ordine antico fu spazzato via e dove fu eretto un nuovo sistema internazionale o almeno
europeo.
Un anno che vide crollare uno dopo l’altro i governi totalitari, contro ogni aspettativa, a
dispetto delle previsioni degli osservatori ben informati, che fossero giornalisti, responsabili
politici, storici od altro. Quell’anno, la Polonia, L’Ungheria e gli altri paesi detti del blocco
sovietico ritornarono improvvisamente “liberi”, cosa che suggellò, almeno retrospettivamente, il
carattere praticamente inevitabile dell’ultima dissoluzione dell’Unione Sovietica.
In verità, il 1989 fu allo stesso tempo segnato da una certa apprensione. Poiché dopo
quattro decenni di guerra fredda, pareva fosse quasi impossibile che uno degli elementi
costituenti dell’ordine internazionale, l’Unione sovietica e la sua egemonia sull’Europa centrale
ed Orientale, potesse finire senza combattimenti. Durante la spettacolare successione degli
avvenimenti – introduzione del multipartitismo in Ungheria, la legalizzazione in Polonia del
Movimento Solidarnosc, la caduta del muro di Berlino, l’esecuzione del dittatore rumeno
Nicolae Ceausescu – l’incredulità nei confronti della realtà della situazione si accrebbe
dell’inquietudine che non gli subentrasse, da un momento all’altro, una reazione brutale. In
effetti, numerosi osservatori apparentemente bene informati avvertivano che “ i carri armati non
avrebbero tardato ad entrare in azione” per reprimere le manifestazioni in Europa centroorientale (la Romania conobbe alla fine del 1989 un periodo di violenti combattimenti che
causarono diverse centinaia di morti e feriti); la Cina aveva d’altronde dato esempio di una
brutale soppressione del movimento democratico nel corso dell’estate 1989. Tali apprensioni
perdurarono del resto fino alla caduta finale dell’Unione Sovietica alla fine del 1991.
E tuttavia ciò che pareva impossibile si produsse nel 1989: un gran numero di nazioni
dell’Europa centro-orientale “si liberarono” dal giogo che faceva pesare su di loro da decine
d’anni una potenza egemonica esterna e cominciarono ad instaurare (anche se con tempistiche
diverse).
Un regime democratico all’interno delle proprie frontiere. La domanda sulla quale il
presente articolo intende meditare è semplice. Perché? Perché il sistema comunista è crollato in
Europa centro-orientale nel 1989?
Una puntualizzazione è d’obbligo. La posizione dello storico è felice: tenta di dare un
senso a degli avvenimenti che si sono già svolti, ma gli è raramente chiesto di dare un giudizio
sul prossimo sconvolgimento che la storia ci riserverà o di elaborare teorie su ciò che sarà il
mondo tra 10 anni. Tale situazione è sicuramente un lusso, ma è anche una trappola nella quale
risulta facile cadere, poiché la storia non assomiglia per niente ad una locomotiva
irresistibilmente lanciata su di una traiettoria che la condurrà ad una destinazione prestabilita. Il
suo corso dipende da un evento fortuito, e più precisamente, dall’azione degli individui. E anche
il caso di sottolineare un punto essenziale riguardo alle rivoluzioni del 1989: tali cambiamenti
radicali non erano, all’inizio, inevitabili. Tuttavia, quando si tratta di dare un senso al passato,
compito essenziale dello storico, non si può sottrarsi alla tentazione di strutturare il contesto nel
quale s’inserisce questo imprevedibile racconto. In quanto grandi mutamenti avevano creato le
condizioni che spinsero poi le popolazioni alle scelte che fecero nel 1989.
Dopo un breve escursus sugli avvenimenti di rilievo dell’anno 1989, questo saggio si
concentrerà su due evoluzioni centrali e generali. Innanzitutto quella che conobbe la guerra
fredda durante gli anni ’80, al punto da diventare irriconoscibile; fu dovuta in gran parte ai
cambiamenti sopraggiunti in Unione Sovietica, ma allo stesso tempo ad altre evoluzioni della
scena mondiale, che attenuarono considerevolmente l’ascendente della guerra fredda sulle
relazioni internazionali. In secondo luogo, man mano che il contesto mondiale si trasformava,
244
l’Europa nel suo insieme cominciava a cambiare al punto di rendere la divisione dell’Europa
stessa meno accettabile, anzi totalmente impossibile.
Questo articolo terminerà con una messa in risalto della dimensione umana dell’anno
1989. Poiché, in definitiva, mentre la congiuntura(situazione) e le strutture possono offrire un
quadro propizio all’azione, gli individui rimangono di fronte ad una scelta o ad un ventaglio di
scelte. Il fatto più degno di nota del 1989 è forse che un così grande numero di persone, arrivate
da orizzonti diversi, ed in così tante nazioni scelsero di prendere strade che modificarono
radicalmente il corso della storia europea contemporanea.
Le rivoluzioni del 1989
Le rivoluzioni iniziarono in due nazioni che avevano affermato una volontà di
indipendenza già dai decenni precedenti: l’Ungheria e la Polonia.
In Polonia, il movimento Solidarnosc guidato da Lech Walesa, che era stato dichiarato
illegale al momento dell’applicazione della legge marziale circa dieci anni prima, intavolò dei
negoziati con i membri del governo polacco all’inizio del mese di febbraio 1989. Solidarnosc fu
nuovamente reso legale il 7 Aprile. Poco tempo dopo, la Chiesa cattolica romana si vide
accordare una personalità giuridica, mentre al contrario la tradizionale sfilata del 1° maggio fu
annullata a Varsavia. In Giugno, Solidarnosc incredibilmente ottenne il 99% dei seggi
liberamente eletti, più precisamente il 35% di quelli della Camera bassa (il Sejm) e la totalità di
quelli della camera alta. Il generale Wojciech Jaruzelski rimase presidente (ancora per un anno),
ma il nuovo governo costituitosi ad agosto fu diretto dal giornalista e militante di Solidarnosc
Tadeusz Mazowiecki. La Polonia fu così fiera di possedere il primo governo non comunista
dell’Europa orientale dopo il colpo di stato organizzato in Cecoslovacchia nel 1948. Alla fine
dell’anno, il Parlamento polacco aveva adottato una nuova Costituzione che metteva
effettivamente termine alla storia del regime socialista in Polonia.
Così come in Polonia, lo smantellamento dello Stato socialista si produsse rapidamente
e relativamente con calma anche in Ungheria. Sebbene la contestazione popolare vi avesse
giocato un ruolo importante, il partito comunista ungherese facilitò tale evoluzione legiferando
lui stesso in favore della sua scomparsa. Alla fine del 1988ed inizio 1989, il Parlamento
ungherese adotto nuove leggi che garantivano la libertà di associazione e riunione. Nel giugno
1989, il partito annunciò la prossima costituzione di una commissione d’inchiesta per far luce
sulla repressione della sommossa del 1956 che fino ad allora era stata qualificata quale odioso
atto contro-rivoluzionario. I Febbraio, fu ufficialmente reintrodotto il multipartitismo nei mesi
che seguirono si susseguirono la denuncia del lungo regime di Janos Kadar, lo scioglimento
dell’organizzazione dei giovani comunisti e le trattative con l’opposizione. Il 16 giugno 300.000
ungheresi assistettero ai funerali di Imre Nagy e di quattro altre vittime dell’era Kadar, oramai
riabilitate ed inumate quali eroi nazionali. Un osservatore inglese rilevo tuttavia che tale
avvenimento, lungi dal limitarsi alla cerimonia di sepoltura di Nagy, rappresentava in realtà “il
funerale di Janos Kadar”. Quest’ultimo rese simbolicamente l’anima tre settimane più tardi (il 6
luglio1989). Il 23 ottobre, trentatre anni dopo la storica marcia degli studenti verso la statua di
Stalin a Budapest, che aveva segnato la fine di una repressione sanguinaria, la Repubblica
popolare di Ungheria divenne semplicemente la Repubblica di Ungheria.
Gli ungheresi avevano anche contribuito a velocizzare la caduta del blocco sovietico. Il
3 agosto, il governo ungherese annunciò che avrebbe offerto asilo politico ai cittadini della
Germania dell’Est. Ne arrivarono migliaia. Il 10 settembre, il governo di Budapest decise di
aprire la sua frontiera con l’Austria ed il giorno seguente – l’11 settembre, questo giorno tra
tanti – iniziò a smontare le recinzioni di filo spinato. Durante questa prima giornata di
demolizione materiale della cortina di ferro, circa 125.00 tedeschi dell’est passarono in Austria.
Tenendo conto delle innumerevoli defezioni dei suoi stessi cittadini, i giorni della
Repubblica Democratica tedesca erano oramai contati. Agli inizi del mese di ottobre, il
245
quarantesimo anniversario della creazione della Repubblica democratica tedesca fu segnato dai
“Gorbi Gorbi” che la folla scandì quando il capo del partito, Erich Honecker, che si trovava a
fianco del dirigente sovietico Mikhaïl Gorbatchev, tentò di parlare a Berlino. Dieci giorni più
tardi, Honecker era destituito; nello spazio di un mese, nel novembre 1989, il muro di Berlino, il
simbolo più forte e pubblico della divisione della Germania e dell’Europa durante la guerra
fredda, si aprì e finì per crollare. Un anno dopo, il 3 ottobre 1990, ciò che pareva una vota
impensabile avvenne: la Germania non solo fu riunita, ma divenne membro dell’OTAN.
In Cecoslovacchia, l’anno 1989 era iniziato in modo inquietante con l’arresto di 14
eminenti militanti della Carta 77. Ma quando nel mese di maggio questi ultimi, tra i quali
figurava Vaclav Havel, furono liberati, apparve chiaramente che la repressione si stava
attenuando. In agosto la polizia intervenne appena durante le manifestazioni a commemorazione
dell’invasione del 1968 da parte delle forze del Patto di Varsavia. I negoziati tra il regime di
Jakes ed i gruppi di opposizione (il Forum civico ceco ed il suo equivalente slovacco il Pubblico
contro la violenza) iniziarono a novembre. Dopo numerosi rimpasti ministeriali durante il mese
seguente, la Rivoluzione di velluto della Cecoslovacchia raggiunse infine il suo apogeo alla fine
di dicembre, con l’elezione di Vaclav Havel alla presidenza del paese. Alexander Dubcek, capo
dei socialisti riformatori oppressi nel 1968, divenne presidente dell’Assemblea federale.
Importanti riforme costituzionali seguirono all’inizio del 1990, mentre la Cecoslovacchia
divenne la repubblica federale ceca e slovacca (e si scisse poi in due stati).
Qualche giorno prima dell’elezione di Havel, la Romania aveva conosciuto il punto
culminante della sua propria rivoluzione del 1989, che fu ben più violenta. Il giorno di Natale,
Nicolae Ceausescu e sua moglie Elena furono giustiziati dopo una parodia di processo. Il
dittatore, al potere da lungo tempo, aveva senza successo tentato di conservarlo e di reprimere
l’opposizione crescente. Tale repressione in realtà non fece altro che scatenare una lotta tra le
forze della Sicurezza di Ceausescu ed i partigiani del fronte di salvezza Nazionale. Le vittime
furono nell’ordine delle centinaia e la natura del colpo di stato contro Ceausescu sollevò in
seguito un certo numero di questioni. Ma la realtà evidente fu, qui come altrove, la scomparsa di
una dittatura comunista e la riapparizione dei partiti politici tradizionali della Romania.
Questo fu ugualmente vero per la Bulgaria, dove il partito comunista aveva obbligato il
dirigente Todor Zhivkiv, al potere da tempo, alle dimissioni il 10 novembre, l’indomani della
caduta del muro di Berlino. Malgrado l’assenza di una vera e propria rivoluzione nel 1989 (fu,
in effetti, più una rivoluzione di palazzo), la Bulgaria organizzò le sue prime elezioni libere nel
1990, nel corso delle quali l’ormai Partito Socialista ottenne il 47% dei suffragi. Come in
Romania, si preparavano dei cambiamenti, ma ad un ritmo più lento. Fortunatamente la
Bulgaria non conobbe né violenze né esecuzioni comparabili con quelle della Romania.
Le rivoluzioni in Europa centro-orientale influenzarono anche l’evoluzione dei Balcani.
In Iugoslavia, lo scredito gettato sul comunismo contribuì senza dubbio molto all’ascesa del
nazionalismo, delle tensioni etniche e delle violenze brutali, anche se il cambiamento che portò
alla disintegrazione dell’antica federazione di Tito era iniziato prima della caduta del muro di
Berlino. In Albania, paese isolato dalla maggior parte degli altri paesi del mondo, le
manifestazioni pubbliche, ed infine le riforme, apparvero un po’più tardi. Ma anche qui un
governo non comunista arrivò al potere nella primavera del 1992.
Tutti questi avvenimenti – il crollo del comunismo in Europa orientale, l’unificazione
della Germania e l’ulteriore disfacimento del Patto di Varsavia - sfociarono infine nella
disintegrazione della stessa Unione sovietica. A lungo represso, il nazionalismo esplose sotto la
forma di numerose dichiarazioni di indipendenza dai paesi baltici alla Georgia, l’Armenia e
l’Azerbaidjan. In verità, la contestazione popolare alla dominazione sovietica si era propagata a
partire dal 1988 in Estonia, Lituania e Lettonia. Tale movimento non terminò nel 1991 con la
sola scomparsa del “blocco sovietico”: l’Unione Sovietica aveva anch’essa cessato di esistere.
246
Il 1989, come pure il processo collegato a tale anno, non fu niente di meno che una
gigantesca rivoluzione, che passò le frontiere nazionali e sconvolse l’antico ordine attraverso un
immenso spazio nel blocco continentale eurasiatico. Nel giro di un anno, i fondamenti della
guerra fredda, che aveva costituito per più di quaranta anni il paradigma centrale del sistema
internazionale, furono abbattuti. Il 1989 rappresenta dunque un sisma (terremoto), una
mutazione sotto forma di cataclisma della recente storia internazionale.
Quali ne sono le ragioni? Perché questi avvenimenti si produssero nel 1989? Perché il
crollo del comunismo fu così rapido e non incontrò alcuna resistenza da parte dei detentori del
potere?
La Guerra Fredda. Le Grandi Linee
La risposta a questa domanda sembra molto semplice: le grandi linee della situazione
erano cambiate; negli anni ’80 la guerra fredda non era più un elemento cruciale delle relazioni
internazionali.Contrariamente ai decenni precedenti la scissione tra l’est e l’ovest e tra il
capitalismo e il comunismo non era più determinata da un rapporto di forza equilibrato.
Per capire ciò, è necessario superare il conflitto propriamente detto tra le superpotenze.
Tenuto conto dei numerosi cambiamenti sopraggiunti in questo periodo, sembrava sempre meno
probabile che la guerra fredda restasse la principale scissione della politica internazionale. I
cambiamenti più profondi erano particolarmente di ordine economico, come l’aumento degli
scambi internazionali, la crescita economica dell’Asia orientale (soprattutto del Giappone e
delle “tigri” economiche del sud-est asiatico) e la discesa dei prezzi delle materie prime (in
modo particolare dl petrolio negli anni ’80). Questi cambiamenti avevano un denominatore
comune: aumentavano le risorse finanziarie dei paesi capitalisti, limitando quelle dl blocco
sovietico e dei suoi alleati del terzo mondo. Innovazioni tecnologiche notevoli, ad es. nel settore
delle comunicazioni e dell’informatica, la cui quasi totalità era messa a punto in Occidente e
solo in parte nell’Unione sovietica, aumentavano ancora questo divario.
Tuttavia era difficile prevedere in quel momento gli effetti politici di questa evoluzione
economica e tecnologica. Ironicamente, all'inizio degli anni 1980, numerosi osservatori
giudicavano i nodi da sciogliere dall’Occidente senza dubbio più importanti di quelli ai quali era
confrontato il blocco sovietico. Molti americani pensavano che il Giappone avrebbe superato
rapidamente gli Stati Uniti sul piano della produttività e della gestione e temevano le
conseguenze economiche a lungo termine che avrebbero causato la perdita del ruolo dominante
del loro paese nell’economia mondiale. Così l’elezione di un repubblicano di destra, Ronald
Reagan, alla presidenza nel 1980, rappresentava non solo la presa di coscienza dei giochi
politici sulla scena internazionale – la fine della distensione, l’invasione sovietica
dell’Afghanistan e la rivoluzione iraniana – ma ugualmente il sentimento generale di un declino
del ruolo degli Stati Uniti nel mondo, che esigeva una risposta più energica. La politica adottata
da Reagan fu il riflesso di questo stato d’animo, con i suoi eccessi retorici (l’impero del male),
la sua volontà d’intervenire contro i regimi rivoluzionari e il rafforzamento massiccio della
potenza militare americana.
Per contro, i dirigenti sovietici vollero credere all’inizio degli anni 1980 al
mantenimento di una tendenza mondiale favorevole al socialismo. Dopo tutto, quest’ultimo
aveva trionfato nel sud est dell’Asia e in diverse regioni dell’Africa all’inizio degli anni ’70. Ma
alla morte di Breznev nel 1982 (forse prima), l’idea che la storia era più vicina all’Unione
Sovietica e al socialismo svanisce. L’economia sovietica sembrava incapace di seguire quella
dell’Occidente e l’aumento delle spese militari alla fine degli anni ’70 e all’inizio degli anni ’80
avevano provocato una carenza di beni di consumo. La guerra in Afghanistan prendeva una
piega inquietante per i Sovietici e il costo degli aiuti accordati ai loro alleati del terzo mondo
aumentava quando Reagan iniziò un’offensiva anti-rivoluzionaria (concentrata soprattutto
sull’America Centrale, l’Afghanistan e l’Angola). La situazione del mondo si presentava sempre
247
più negativa per i segretari generali arcigni che erano succeduti a Breznev, Yuri Andropov
(1982-84) e Costantino Tchernenko (1984-85).
Ma gli anni 1980 non furono solo l’ascesa di un settore e il declino di un altro nella
guerra fredda. Per molto tempo quest’ultima, così come il confronto russo-americano, fu in gran
parte senza grande interesse. Bisogna ricordare che l’ascesa dell’islam o dell’islamismo a partire
dalla fine degli anni ’70 rappresenta il segno principale del ritorno della dicotomia della guerra
fredda, che non rappresentava più la scissione principale nell’ideologia mondiale. Basando la
loro dottrina politica sul corano, criticando sia la democrazia liberale e il comunismo (i due
Satana, secondo la qualifica che era riservata a loro), i gruppi islamici cominciarono ad opporsi
ai regimi che consideravano i sudditi dell’occidente. La rivoluzione Iraniana del 1978/1979,
nella quale i gruppi islamici contribuirono notevolmente a rovesciare la dittatura dello Scià
sostenuta dagli Stati Uniti, incitò i giovani mussulmani a riunirsi in questi movimenti negli altri
paesi, quando anche il loro messaggio politico e religioso era diverso da quello dell’Ayatollah
Khomeyni. La guerra condotta dai sovietici in Afghanistan si rivelò un terreno fertile per i
gruppi islamici radicali, i quali curarono i rifugiati e, malgrado i loro discorsi anti-occidentali,
beneficiarono del sostegno degli Stati Uniti e dei regimi arabi conservatori per il fatto della loro
importanza nelle lotta contro i sovietici ( fu in Afghanistan che Ben Laden, nato in Arabia
Esaudita, si fece una reputazione di convinto combattente antisovietico).
Mikhail Gorbatchev fu eletto segretario generale del partito comunista sovietico nel
1985, in un’epoca in cui il blocco sovietico conosceva una situazione economica disastrosa, gli
Stati Uniti aumentavano i loro sforzi per classificare l’URSS come l’impero del male e
combattere Mosca nel mondo e la dove i fondamenti ideologici della guerra fredda erano ancora
forti, malgrado il discorso combattivo di Reagan.
Gorbatchev conosceva l’importanza dei problemi, ma non aveva nessun progetto
definito che potesse diventare operativo. Al di la di questo, G. cercò di allentare le tensioni con
gli Stati-Uniti e l’Europa Occidentale, al fine di guadagnare tempo per riorganizzare l’economia
sovietica. Le iniziative prese da G. portarono ad una serie di accordi aventi come obiettivo
quello di limitare la corsa agli armamenti nucleari, anche oltre quello che era stato previsto
durante la distensione.
Questo atteggiamento portò l’amministrazione Reagan a ritenere che il comunismo
sovietico si ritirava dalla scena internazionale. Pertanto Reagan non esitò a ridurre i rischi di
conflitto nucleare dato che la storia, in definitiva, era dalla parte degli Stati-Uniti. Questo
cambio di marcia non fu di grande aiuto per G. Nel 1986/1987, l’incidente nucleare di
Chernobyl e la resistenza incontrata nell’ambito del suo stesso partito lo costrinsero a rendere
più radicale la sua politica, nell’ambito della ricerca di una “perestroika” (ristrutturazione),
accordando nel contempo una certa forma di libertà di espressione (glasnost-trasparenza). Alla
fine del decennio, l’Unione Sovietica e la guerra fredda parvero entrambi impegnate in un
cambiamento radicale e rapido.
Pertanto, le rivoluzioni del 1989 si verificarono in un momento in cui la struttura
fondamentale delle relazioni internazionali, attivata dalla fine degli anni 1940 e l’inizio degli
anni 1950, cessò la sua funzione. Le nuove poste in gioco sulle quali si confrontavano negli anni
1980 le due superpotenze, ma soprattutto l’Unione Sovietica, andavano verso profondi
cambiamenti nelle relazioni internazionali. Tuttavia ciò non fu sufficiente a spiegare il dramma
del 1989 o le cause di avvenimenti accaduti nell’Europa centro–orientale.
Un Continente che Cambia : L’Europa Degli Anni 1980
Nell’ambito delle grandi sfide del sistema internazionale della guerra fredda,
un’evidente atmosfera di cambiamento coinvolse il continente europeo negli anni 1980. In
effetti la divisione dell’Europa parve sempre più artificiale agli occhi degli europei e la
sottomissione e la dipendenza da parte di un controllo esterno risultò sempre più facile da
accettare. Il totalitarismo sotto tutte le sue forme cadde in un discredito generale in buona parte
248
dell’Europa durante gli anni 1970 e 1980. D’altronde all’inizio degli anni 1980 si cominciarono
a cercare delle soluzioni economiche per i numerosi problemi di cui soffriva allora il continente
“stagnante”. Questi cambiamenti e queste strategie avevano tuttavia un ruolo diverso dai due lati
di quella che era ancora la cortina di ferro.
L’Europa occidentale e il progetto europeo negli anni 1980
L’integrazione europea aumentò velocemente nell’Europa occidentale a partire dalla
metà degli anni ’80. Si può affermare che questo movimento fu la conseguenza di due fasi
evolutive importanti.
Dapprima l’Europa occidentale aveva conosciuto negli anni ’70 una sua rivoluzione
democratica.
La Spagna, il Portogallo e la Grecia si erano infatti liberati dai loro regimi autoritari. La
morte di Franco nel 1975 ,la caduta della dittatura portoghese un anno più tardi e la fine della
giunta di colonnelli in Grecia quello stesso anno 1974, avevano aperto la via ad un allargamento
verso sud della CEE. La Grecia fece il suo ingresso nella CEE nel 1981 e la Spagna e il
Portogallo vi aderirono nel 1986. I nuovi Paesi divennero i 12. Pochi rivelarono che la
Groenlandia lasciò la CEE in quello stesso momento.
Questo ampliamento verso il sud fu sintomatico della seconda principale evoluzione
dell’Europa occidentale: la ripresa del progetto europeo a metà degli anni 1980. Più
precisamente, i negoziati dell’Atto Unico Europeo (AUE) entrarono in vigore nel 1987; questo
prevedeva la costituzione di un mercato unico europeo pienamente integrato nel 1992. Come
viene detto nel testo l’obiettivo dei firmatari era “realizzare uno spazio nel quale le persone, le
merci e i capitali circolino liberamente in condizioni simili a quelle prevalenti all’interno di uno
Stato membro”. Ma andava ancora più lontano. L’AUE comprendeva delle misure miranti a
stimolare la cooperazione politica e a trasferire le competenze degli stati membri verso le
istituzioni centrali europee. In breve, l’AUE fu il precursore del trattato di Maastricht del 1992 e
l’antenato dell’UE. L’AUE diede il segnale di un cambiamento radicale in Europa occidentale
alla fine degli anni 1980. Se l’inizio del decennio aveva visto l’invenzione del termine
“eurosclérose” per indicare l’economie dell’ovest del continente, la sua disoccupazione a due
cifre e la rete politicamente varia degli Stati nazione, la seconda metà del 1980 conobbe un
miglioramento della situazione economica e un rafforzamento della cooperazione politica. Poco
importa sapere se queste evoluzioni furono strettamente legate o no. Il fatto è che nel 1989
“l’euforia” aveva sostituito, anche solo per un momento, ”l’éurosclérose” e “l’éuroscepticisme”.
L’Europa orientale I: il ristagno economico
L’integrazione rafforzata dell’Europa occidentale e la sua ripresa economica
contrastarono fortemente con lo stato delle economie del blocco sovietico. Di fatto, la vera
“éurosclérose” fu precisamente quella dei paesi che parteciparono alle rivoluzioni del 1989.
Negli anni ’80, l’Europa centrale e l’Unione sovietica si trovavano infatti in una situazione di
ristagno economico cronico.
Alcune cifre permettono di illustrare questo punto. Prendiamo in esame il tasso di
crescita economica. Le cifre del blocco sovietico prima del 1989 non presentavano nessuna
affidabilità, ma ne deriva la tendenza generale seguente. Negli anni 1950 e1960, i Paesi
dell’Europa orientale conobbero una crescita il cui tasso (cioè il tasso di crescita del PIB per
abitante) si pose in media tra il 5,5 e il 7,6% annuo. Questi tassi erano superiori a quelli
dell’ovest e sembravano indicare che il sistema di economia pianificato manteneva le promesse:
condizioni migliori di vita per tutti. La situazione si evolve negli anni ’70, quando la maggior
parte dei paesi registra un PIB per abitante inferiore al 3%. Questo rallentamento aumenta negli
anni ’80: la crescita non raggiunge l’1% nella maggior parte di paesi e talvolta risulta negativa
249
in certi altri paesi. Nel 1989, l’Ungheria rileva un tasso di crescita del –1%, mentre la Romania
si mantiene sul livello negativo di –11%.
D’altronde si deve notare che queste percentuali non tengono conto del ruolo del
mercato nero, che rappresentava spesso la sola fonte di approvvigionamento di prodotti di base
per numerosi cittadini. La forte inflazione degli anni ’80 si tradusse sul mercato nero con un
aumento rapido del tipo di vita. Secondo le stime, gli stipendi diminuirono in pratica, nella
prima metà degli anni ’80, del 17% in Polonia,del 25% in Yugoslavia e in proporzioni ancora
più importanti in Romania.
Come spiegare questa situazione?
Globalmente le cifre citate presentano una crescita economica sofferente un modello di
sviluppo economico che, dopo essere stato trasformato in sistema statale, presentava una rigidità
che lo rendeva incapace di rinnovarsi. In altri termini i paesi dell’Europa Orientale ripresero alla
fine della Seconda Guerra Mondiale un modello di sviluppo sovietico, che generò una certa
forma di crescita economica quando la concezione staliniana di socialismo in un solo paese fu
sostituita da quella di socialismo in un solo blocco. L’industrializzazione forzata e l’accento
messo sulla creazione di un’industria pesante, che non aveva mai rappresentato una componente
essenziale nelle economie dell’Europa Centro Orientale impiegavano una manodopera
abbondante in nuovi impieghi; non è quindi affatto sorprendente che le stesse abbiano registrato
tassi di crescita globali abbastanza elevati. Tuttavia le industrie di consumo non godettero si
nessuna crescita significativa. Questi due fattori produssero da soli le condizioni per un ristagno
economico e notevole scontento. Negli anni ’60 e ’70 era ancora possibile contenere i problemi
dell’industrializzazione con diverse valvole di sicurezza. Il sistema conobbe qualche
adattamento di fortuna e leggeri successi a breve termine grazie a una decentralizzazione
economica limitata. In secondo luogo, le sovvenzioni sovietiche mantenevano le economie dei
paesi dell’Est europeo, permettendo loro di importare fonti di energia e materie prime a basso
prezzo, mentre esportavano verso l’URSS la loro produzione industriale che non sarebbe stata
competitiva in nessun altro mercato. In terzo luogo, gli scambi internazionali cominciarono a
svilupparsi leggermente con i paesi dell’Occidente negli anni ’70, spesso grazie ai capitali
occidentali.
Ma questo triplo rinforzo si disgregò negli anni ’80. Alcuni consideravano infatti la
decentralizzazione come una protesta inquietante del sistema politico in vigore; le stesse autorità
politiche rifiutarono qualunque rimaneggiamento all’interno di questo sistema.
Il rimaneggiamento delle sovvenzioni versate dall’Unione Sovietica alle economie dei
Paesi dell’Est in seguito alle crisi del petrolio degli anni ’70 fu un fattore senza dubbio
determinante. I sovietici infatti avevano tratto vantaggi dall’aumento dei prezzi del petrolio
vendendone più ad Ovest, ciò permetteva loro di incassare valute forti. Questo meccanismo
durò fin che i prezzi restarono elevati: i benefici ottenuti permettevano di finanziare l’Europa
orientale. La caduta brutale del prezzo del petrolio nel 1983/84 ridusse le riserve sovietiche di
valuta forte. L’Unione Sovietica chiese allora all’Europa dell’Est di pagare le importazioni del
petrolio al prezzo di mercato o simile; fu la fine delle sovvenzioni.
Nell’ambito di un sistema di baratto sul quale si basava l’economia del blocco sovietico,
ciò significava in pratica che i paesi dell’Europa dell’Est erano obbligati a fornire più merci in
cambio della stessa quantità di petrolio. Un esempio spiega questa situazione: nel 1974
all’Ungheria bastava scambiare 800 autobus Ikarus per ottenere un milione di tonnellate di
petrolio sovietico; questa cifra passò da 2300 bus nel 1981 poi a 4000 unità nel 1988. Si verificò
così quello che si potrebbe chiamare una “inflazione del baratto”.
Si deve notare che il ribasso del prezzo del petrolio ebbe ripercussioni esattamente
inverse in Occidente: la fattura energetica diminuì, ciò favorì le industrie e le economie. Non ci
si poteva augurare una situazione migliore per il funzionamento delle economie dell’Europa
dell’Ovest e dell’Est sulla base di due sistemi totalmente distinti.
250
Inoltre siccome le riserve in valuta forte si riducevano nel blocco sovietico, gli europei
occidentali, che avevano ritenuto che l’URSS avrebbe garantito in pratica il debito dei paesi
dell’Europa dell’Est grazie agli scambi di petrolio in valuta forte, cessarono di fornire capitali a
questi ultimi. Gli scambi Est-Ovest iniziarono ad affievolirsi. Il passivo in valuta forte dei paesi
dell’Europa dell’Est aumentarono a dismisura nel corso degli anni ’70 e ’80, passando da 8,7
milioni di dollari nel 1970 circa 10 volte di più a metà degli anni ’80. Al momento delle
rivoluzioni del 1989, numerosi paesi, fra i quali l’Ungheria la Polonia e la Bulgaria
evidenziavano un debito estero totale superiore al valore annuale delle loro esportazioni. Così la
cifra del debito estero della Polonia rappresentava il triplo delle sue esportazioni annuali. La
morale di questa storia è che la decadenza del blocco sovietico negli anni ’80 fu un disastro per i
regimi politici della regione. In definitiva il socialismo prometteva ricchezza per tutti, ora era
evidente che non avrebbe più potuto garantirla. Come ha detto uno storico, “l’aumento del
livello di vita, che aveva rappresentato un tempo un caratteristica così determinante della
propaganda comunista, causava ormai imbarazzo, perché la pratica si contraddiceva
all’ideologia, la teoria del pauperismo dei lavoratori formulata da Marx sembrava una
descrizione più attinente il socialismo che il capitalismo”.
Il contesto europeo si poteva così sintetizzare: mentre l’Europa Occidentale conosceva
una ripresa del processo di integrazione e passava dal ristagno a una sorta di dinamismo,
l’Europa Orientale subiva un processo inverso. Il livello di vita era cresciuto fino agli anni ’70,
ma gli anni ’80 erano stato quelli del caos economico, dello sviluppo di un mercato nero molto
inflazionista e dell’abbassamento del livello di vita.
L’Europa Orientale II: la fine dell’isolamento e il desiderio di cambiamento.
Parallelamente alle evoluzioni economiche e politiche che riguardavano l’Europa intera
e riproponevano la questione della legittimità del sistema comunista, bisogna notare che il
cambiamento del contesto europeo fu accompagnato da un aspetto supplementare: alla fine degli
anni ’70 e durante gli anni ’80, la legittimità politica del regime del partito unico fu messa a
dura prova.
Due esempi illustrano questa situazione. In primo luogo, l’organizzazione della CSCE
(Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa). Gli accordi di Helsinki del 1975
avevano introdotto nuove norme internazionali che, anche se non erano rispettate dalla totalità
dei 35 governi che avevano partecipato alla stesura, rappresentavano un manifesto al quale gli
oppositori del regime totalitario potevano far riferimento per rivendicare la libertà di
espressione, la libertà di riunione e altre esigenze di questo tipo. L’esistenza del cosiddetto
“Paniere III” fu forse ancora più importante, perché permetteva di ricordare , ad esempio, ai
governi sovietici, polacchi o cechi che avevano firmato un patto che garantiva il rispetto di un
certo numero di libertà fondamentali dell’individuo. Negli anni che seguirono la firma degli
accordi di Helsinki, la bandiera dei diritti dell’uomo fu così innalzata dalla Carta 77 in
Cecoslovacchia, il movimento solidarietà in Polonia e diversi gruppi di controllo nella
Germania dell’Est, in Unione Sovietica e in altri paesi. Questi movimenti erano stati coordinati
ma nacquero spontanei nel momento della decadenza morale del regime comunista, mentre si
verificava il marasma economico. Di fatto, come ricorda il giornalista Martin Walker gli accordi
di Helsinki divennero l’arma segreta dell’Occidente, una bomba a orologeria posta nel cuore
dell’Impero Sovietico. In secondo luogo, l’accesso all’informazione e alla sua diffusione
aumentarono. La firma degli accordi di Helsinki ha un significato, ma la capacità di diffusione è
altro. Come dichiarò lo stesso Gorbatchev in un discorso del 1989 pronunciato davanti
all’Assemblea generale delle Nazioni Unite, “oggigiorno è impossibile per una società restare in
un vaso chiuso”.
Questa situazione ebbe, ad esempio, come conseguenza pratica negli anni ’80, la
scomparsa dell’oscuramento delle stazioni radio occidentali nella maggior parte dei paesi
dell’Europa dell’Est. La BBC, Deutsche Welle, Voice of America e Radio Vaticano
251
incrementarono così in modo rilevante il numero dei loro ascoltatori. La televisione ebbe un
ruolo ancora più importante sia direttamente sia attraverso le video-cassette. I Tedeschi dell’Est,
i Cechi e gli Slovacchi riuscivano così a vedere la televisione della Germania Ovest, gli Estoni
potevano seguire la televisione finlandese e gli Albanesi la televisione italiana, mentre numerosi
Bulgari riuscivano a captare la trasmissioni turche.
Numerose furono le ripercussioni di questa situazione. Offriva alle popolazioni
dell’Europa Orientale un’altra fonte di informazione. Nessuna stazione radio né rete televisiva è
esente dall’essere imparziale, ma sembra che i radiodiffusori occidentali offrissero almeno una
fonte di informazione contraddittoria, senza dubbio più affidabile. Inoltre, nel 1989, la
televisione e la radio ebbero un ruolo considerevole diffondendo informazioni sugli avvenimenti
accaduti negli altri paesi dell’Europa Centrale e Orientale; la notizia delle proteste in Polonia e
in Ungheria spinse senza dubbio i cittadini degli altri Stati a seguire questo esempio. Il fatto che
gli europei dell’est fossero stati esposti a quello che si potrebbe chiamare “l’effetto di
scintillamento” ha avuto un ruolo importante, addirittura determinante. Le trasmissioni diffuse
dalle reti televisive occidentali mostravano uno stile di vita diverso, delle società ricche di beni
di consumo, che nei paesi dell’Europa orientale si trovavano solo al mercato nero a prezzi
elevati, sempre che fosse possibile procurarseli. In altri termini, l’Occidente esercitava una
forma di attrazione sulle popolazioni dell’Est, ciò spiega, ad es.,come i Tedeschi dell’Est
abbiano intensamente desiderato recarsi nella Germania occidentale.
La diminuzione delle restrizioni negli spostamenti in seguito agli accordi di Helsinki
rientra in questo contesto. Nel 1988, ad es., le restrizioni negli spostamenti erano notevolmente
ridotte per i bulgari, gli ungheresi e i polacchi. Questa situazione non risultava essere la stessa in
tutti i paesi: gli albanesi non potevano lasciare il territorio nazionale e i rumeni erano costretti a
rigide limitazioni. Sta di fatto che i cittadini di un certo numero di paesi dell’Europa dell’Est
non conoscevano l’Occidente solo attraverso le immagini televisive e le trasmissioni
radiofoniche, ma potevano in numero sempre maggiore visitarlo personalmente.
Analizzati a uno a uno, che significato avevano questi diversi elementi? Gli eventi del
1989 avevano un carattere inevitabile, conseguenza della recessione e del marasma economico,
di numerosi altri problemi strutturali che nuocevano alla legittimità del sistema socialista e della
possibilità che avevano le popolazioni dei paesi interessati di constatare e imparare che
esistevano altri sistemi economici e politici dove regnava abbondanza di beni di consumo? Non
esattamente. Si può piuttosto dire che tutte queste cause erano indubbiamente indispensabili allo
scoppio delle rivoluzioni del 1989, ma che non erano sufficienti. Ci voleva anche un fattore
complementare.
1989 : il fattore umano
Di fatto, mentre la congiuntura generale condiziona uno sconvolgimento e ne fissa i
parametri, questo è innanzi tutto causato dall’azione degli individui. Ma ultimo punto degno di
nota è l’elemento umano che ha influenzato i fattori che hanno provocato gli avvenimenti del
1989.
In primo luogo, M. Gorbatchev obbligato a lasciare l’Europa orientale abbandonata a se
stessa. Quali potessero essere le sue motivazioni lui fece la scelta giusta. Non c’è dubbio che la
sua fosse la condotta da perseguire. Gorbatchev passerà alla storia come una specie di “perfetto
perdente”, ma in definitiva riconosce il diritto all’Europa orientale di scegliere il proprio
destino, la fine della dottrina di Breznev e l’inutilità di sostenere dei dirigenti come Honecker,
ha preparato il terreno alle rivoluzioni. Come gli studenti cinesi lo capirono a loro spese
nell’estate 1989, c’era un altro modo di reagire davanti a questa situazione.
Secondariamente, i riformatori dei partiti comunisti di molti paesi dell’Europa centrale e
orientale non erano obbligati ad accettare l’inevitabilità di questo cambiamento. Non tutti i
252
dirigenti furono accondiscendenti, ad es., Ceausescu in Romania e Honecker in RDA.
furono numerosi a prendere questa decisione, come il governo di Grosz in Ungheria
contribuire a mettere fine a un sistema comunque concepito in maniera egoista
ricompensarli. Scelsero invece disimpegnarsi nella via delle riforme, da loro gestite, ma
finirono per sfuggire al loro controllo.
Ma
e a
per
che
In terzo luogo, i principali detrattori del regime comunista, Walesa, Havel e gli altri non
erano tenuti a mettere a repentaglio la loro esistenza. La loro esperienza personale complessiva,
cioè la storia individuale e il passato del loro paese, avrebbe dovuto metterli in guardia contro
questa contestazione. Decisero, al contrario, di rimettere in dubbio la struttura del potere
conducendo una lotta che nel 1989 sembrava ancora troppo scorretta .
In quarto luogo, le migliaia di persone che manifestarono contro il regime del partito
unico chiedendo risarcimenti per le ingiustizie subite e reclamando l’instaurazione della
democrazia, non erano costretti a mettere a repentaglio la loro vita e a rischiare personalmente.
Di fatto, molti morirono durante i combattimenti. Persino nel 1989, gli spiriti sembrarono non
perdere mai di vista che i movimenti a favore della democrazia non trionfavano ovunque; Gli
studenti manifestanti in piazza Tienanmen a Pechino vissero quella esperienza nel giugno di
quell’anno.
Le rivoluzioni del 1989 furono in definitiva una conseguenza della ribellione dei
numerosissimi cittadini dell’Europa centrale e orientale, stanchi e insoddisfatti delle carenze
economiche e dell’oppressione politica, i quali avevano cominciato a pensare che l’Unione
sovietica e Gorbatchev non avrebbero intrapreso nulla per fare fallire, come per il passato, le
loro rivendicazioni politiche. In altri termini, sebbene importanti evoluzioni del sistema e
cambiamenti strutturali avessero creato le condizioni per un cambiamento, furono finalmente le
popolazioni che lo provocarono.
Conclusione : esame retrospettivo dell’anno 1989
Nel 1992, alcuni anni dopo le rivoluzioni del 1989 e un anno dopo lo scioglimento
dell’Unione sovietica, lo storico Walter Laquer ha formulato due osservazioni sul periodo del
dopoguerra in Europa (centrale e orientale). Egli sottolinea, innanzi tutto, che “la storia
dell’Europa del dopoguerra rassomiglia a un film hollywoodiano un po’ fuori moda, animato da
ogni tipo di tensione e di conflitto, ma che si conclude con un epilogo felice e sorprendente”,
rileva un certo scetticismo al riguardo di quello che accadrà dopo questo “felice epilogo”, che
all’epoca era molto recente.
“Trattandosi dell’Unione sovietica e dell’Europa orientale, è facile elencare i sistemi
politici, sociali e economici che hanno fallito. Ma è impossibile attualmente dire che cosa
accadrà loro”.
Di fatto, contrariamente a un film hollywoodiano, l’anno 1989 non segnò la fine della
storia.
Ne sappiamo di più oggi, quindici anni dopo queste rivoluzioni? Sappiamo che è
succeduto al totalitarismo della guerra fredda? Abbiamo un’idea di ciò che accadrà a questo
paese dominato per tanto tempo da un’ideologia, un sistema politico e una pressione militare
imposte dall’estero?
Si e no. Sappiamo certamente che la fine della guerra fredda e lo scioglimento
dell’Unione sovietica e le rivoluzioni del 1989 hanno avuto un ruolo notevole nella formazione
della mondializzazione attuale e hanno reso ogni ritorno alla bipolarizzazione precedente
praticamente impossibile. Ma noi ignoriamo così come Laquer nel 1992 verso quale destino si
incammina il mondo e quale avvenimento drammatico del tipo 11 settembre 2001 potrebbe
orientare la storia verso una nuova direzione, ancora sconosciuta.
253
Tuttavia sappiamo che gli avvenimenti del 1989 ebbero considerevoli ripercussioni a
livello regionale. Così, il 1989 ha permesso il 2004 e forse il 1995, cioè la prima apertura verso i
paesi neutri che erano l’Austria, la Finlandia e la Svezia. L’apertura verso l’integrazione
europea è senza dubbio una delle principali conseguenze del 1989. Questo permetterà di arrivare
a un’unione più stretta tra questi paesi? E’ un altro quesito. Forse potremo avere la risposta tra
15 anni.
Inoltre gli abitanti dei paesi interessati dagli avvenimenti del 1989 hanno conosciuto
una radicale trasformazione della loro esistenza. Questi cambiamenti sono stati globalmente
positivi. Quali che siano i problemi attuali e la loro gravità, certamente appaiono insignificanti
rispetto a quelli precedenti il 1989, dove regnavano la dittatura totalitaria, la polizia segreta, una
gestione economica carente e la recessione. Per concludere il 1989 appare come un momento di
cambiamento storico radicale, di sconvolgimento imprevedibile dalle conseguenze enormi, che
fu condizionato da fattori strutturali ma scatenato dall’azione degli individui.
Questa evoluzione fu pienamente positiva? No, beninteso. Era impossibile cancellare
semplicemente l’impronta lasciata da due generazioni di regime comunista precedute da
conflitti devastatori.
La memoria storica dei cittadini avrebbe potuto tranquillamente condurre a richieste di
risarcimento perfettamente giustificate, ciò che a volte accadde. Non ci si poteva tuttavia
aspettare che la transizione da un modello economico a un altro avvenisse senza traumi. Di fatto
le economie del vecchio blocco sovietico crollarono negli anni immediatamente successivi il
1989. L’Ungheria ad es., registrò una crescita positiva solo nel 1994. Eppure il 1° maggio 2004,
numerosi paesi del vecchio blocco sovietico, l’Ungheria, la Polonia, la Repubblica Ceca e la
Repubblica Slovacca, così come tre Stati che facevano parte dell’Unione sovietica, l’Estonia, la
Lettonia e la Lituania, divennero membri dell’Unione europea. Se questa idea fosse stata
proposta ad un qualunque ben informato osservatore del 1989, è probabile che costui avrebbe
provato disprezzo o divertimento.
Concludendo ,il 1989 fu una sorpresa, uno choc e una serie di avvenimenti regionali che
modificarono il corso della storia europea e,in definitiva, mondiale.
Bisogna sottolineare che il 1989 fu molto più di questo. Poco importa, tutto sommato,
che queste rivoluzioni non siano state previste da nessuno, se si pensa a ciò che ci dicono sui
fattori imponderabili della storia e il ruolo attivo degli individui, che quello dei semplici
osservatori, nello svolgimento degli avvenimenti. Alla fine, l’importanza delle rivoluzioni del
1989 ci ricordano quello che scriveva in altri tempi Gorge Kennan, probabilmente il principale
artefice di quella dottrina della politica estera americana che preannunciava la fine dell’Unione
sovietica e del comunismo negli anni 1940:
“Non esiste situazione critica in cui può trovarsi un uomo che non possa essere
attenuata dalla sua audacia, se lo stesso è attento nel coltivarla. La posta in gioco consiste
nell’esaminare le possibili soluzioni, poi dare prova di coraggio e di determinazione necessari
per passare all’azione”.
Nel 1989 furono moltissimi quelli che accettarono questa sfida. Ecco un momento
storico che merita di essere ricordato.
254
34. 1989: la fine della guerra fredda ed il crollo dell’Unione Sovietica
Alexei Filitov
Riflettendo sul “ crollo dell’Unione sovietica”, sono giunto alla conclusione che sarebbe
convenuto ampliare l’argomento in modo da presentare una sintesi equilibrata delle variabili sia
interne sia esterne al processo che è culminato con questo avvenimento e che è stato trattato in
modo molto diverso da differenti gruppi sia nel mio paese sia all’estero. Così ho deciso la nuova
versione del titolo della mia esposizione. Quest’ultima verterà sui seguenti punti:
-
la correlazione tra la fine della guerra fredda ed il crollo del regime e dello Stato sovietico;
i meccanismi oggettivi e soggettivi che sottendono questi due fenomeni;
le alternative possibili e le “possibilità mancate”.
Inizierò con una citazione tratta dall’estratto di un articolo pubblicato da un celebre
storico tedesco su una rivista:
“Dieci anni dopo la fine della guerra fredda, il bisogno di riesaminare questo conflitto,
che iniziò con l’affermazione delle superpotenze all’indomani della seconda guerra
mondiale e terminò con il crollo dell’Unione sovietica, si rende sempre più
necessario.”(Loth, 2003, p.157)
La formulazione del problema non dà adito a nessuna obiezione, ma la stesura scelta
dallo storico della rivista per questa frase introduttiva può generare confusione. In effetti,
sembra lasciar intendere da una parte che la guerra fredda sia continuata due anni dopo la caduta
del muro di Berlino ed il summit di Malta (questi due avvenimenti, risalenti ai mesi di
novembre e dicembre 1989, sono generalmente considerati come quelli che ne segnano la fine),
e dall’altra che l’Unione sovietica abbia cessato di esistere due anni prima che la bandiera rossa,
che sventolava in cima alla torre del Cremlino, fosse sostituita dalla bandiera tricolore russa.
Numerosi sono coloro (ivi compreso questo autore) che contesterebbero le due conclusioni
citate. Questa osservazione vale altrettanto per la tacita interpretazione del rapporto causa
effetto: sembra più ragionevole (in ogni caso è questa la tesi che io difendo) supporre che il
processo di “estinzione” della guerra fredda abbia condotto al crollo dei sistemi di tipo
sovietico in Europa, poi infine a quello dell’Unione Sovietica stessa, e non il contrario.
Questa confusione può spiegarsi in buona parte con la semantica. Le nozioni di
“conflitto mondiale”, di “competizione Oriente-Occidente” e di “guerra fredda” sono troppo
spesso utilizzate in modo intercambiabile, perfino quando designano realtà differenti.
L’antagonismo planetario dei due sistemi socio-politici, “Oriente” contro “Occidente”,
“socialismo” contro “capitalismo”, “totalitarismo” contro “mondo libero”, ecc. - questa
enumerazione potrebbe essere continuata a volontà - risale almeno al 1917 (certi autori lo
giudicano di gran lunga anteriore e ne fanno risalire l’origine al tempo della Rivoluzione
francese) e rappresentò un vero e proprio gioco “a somma zero”: uno dei due campi doveva
prevalere sull’altro. La tesi della “convergenza”, formulata per la prima volta nel 1944 dal
filosofo, sociologo ed emigrato russo Pitirim Sorokin, apparve un pio augurio, generato da uno
spirito d’alleanza anti-hitleriano, piuttosto che la base di un’analisi approfondita della situazione
mondiale.
Il fenomeno della guerra fredda è abbastanza diverso, sia nella durata sia nella forma. Si
può legittimamente considerarlo come un’espressione specifica di un conflitto “Oriente Occidente” (benché le relazioni, per esempio, tra l’Unione sovietica e la Iugoslavia fra il 1948
ed il 1953, tra l’URSS e la Cina alla fine degli anni ‘60 e negli anni ’70 oppure ancora fra la
Cina ed il Vietnam alla fine degli anni ’70 possano, anch’esse, mettersi facilmente in questa
categoria). Se si pensa che sia caratterizzato dalla bipolarità generata dalle due “superpotenze”,
255
il periodo della guerra fredda può estendersi dal 1945 (le conferenze di Yalta e Potsdam) fino
alla metà degli anni ’60 (quando De Gaulle in Occidente e Mao in Oriente sfidarono i leaders
dei rispettivi campi). Se viene considerato come una corsa sfrenata agli armamenti, soprattutto
nel campo delle armi d’alta tecnologia ABC (bombe atomiche, missili, guerra chimica e
batteriologica), si possono far risalire gli inizi intorno al 1948 (fino a questa data, la
smobilitazione fu estremamente rapida da entrambe le parti, i bilanci militari crollarono, gli
effettivi rimasero ridotti e la riserva di bombe atomiche degli Stati Uniti, i quali avevano allora
il monopolio di questa “arma vittoriosa”, rimase stazionaria) mentre le ultime manifestazioni
potrebbero riferirsi al periodo fra il 1963 (trattato d’interdizione degli esperimenti nucleari) ed il
1968 (trattato di non-proliferazione), oppure al 1972, al 1979 (SALT-1,2) oppure ancora al 1987
(trattato INF). Tutti gli accordi per limitare la corsa agli armamenti furono il risultato di
concessioni reciproche e nessuno di essi autorizzava una delle due superpotenze a cantar
vittoria.
D’altra parte, la lista dei pretendenti alla corona d’alloro dei vincitori è
sufficientemente lunga: la Francia e la Cina, così come l’insieme dei vecchi paesi satelliti dei
due blocchi, ma soprattutto la Finlandia e la Iugoslavia, che giunsero fin dall’inizio a
disimpegnarsi da questo confronto. E’ tuttavia possibile chiedersi se la loro riuscita sia più
legata all’esistenza della guerra fredda o alla sua fine. Il caso della Iugoslavia pende piuttosto a
favore della prima spiegazione. Qualunque sia la risposta, trattandosi di fazioni avverse, gli
avvenimenti storici del 1989 si caratterizzano prima di tutto per il loro rispettivo ritiro dal
campo di battaglia: una specie di “pace senza vittoria”, per riprendere l’espressione utilizzata
dal presidente Wilson nel suo discorso al Senato del 22 gennaio 1917 (Jonas, 1984, p.121).
Ma torniamo all’argomento che ci interessa. Se il campo dell’Unione sovietica non può
essere considerato come il perdente della guerra fredda (per lo meno non più sconfitto degli
Stati Uniti), come si spiegano i loro differenti destini durante il periodo posteriore a
quest’ultima? L’Unione sovietica si è scissa, la rilevanza internazionale che occupava come
Stato, passando alla Federazione di Russia, è risultata di importanza inferiore (è il minimo che si
possa dire), mentre il suo antico avversario, gli Stati Uniti, ha conservato e, si può dire,
confermato il suo status di “superpotenza”. Ma questo risultato non era garantito in anticipo
quando la guerra fredda finì, cioè nel 1989. Alcuni Sovietici avevano immaginato che i
“dividendi della pace” avrebbero stimolato, dopo un’insensata corsa agli armamenti, l’economia
sovietica che, una volta sollevata dalle spese militari improduttive, non avrebbe mancato di
dimostrare i vantaggi insiti nella natura corrotta del sistema capitalista. Ho detto “avevano
immaginato”, ma sarebbe più giusto dire “avevano sperato”. Poiché si trattava piuttosto, in
questo caso come in quello dell’idea di convergenza, di un pio desiderio. A dire il vero, questa
percezione della situazione era anche la mia, a quell’epoca, proprio mentre, avendo avuto
l’occasione di recarmi in Occidente, contrariamente alla maggior parte dei miei compatrioti,
avrei dovuto mostrarmi meno incline a sogni impregnati di tanta ingenuità.
Ricordiamoci, per consolarci, che alcuni specialisti occidentali molto perspicaci
condividevano delle illusioni in merito alle prospettive di riforma del sistema di tipo sovietico.
Citerei a questo proposito l’allocuzione pronunciata da Arthur Schlesinger Jr in occasione del
seminario sovietico-americano del 27 giugno 1990 sulle origini della guerra fredda:
“Il comunismo, nella forma praticata nell’Unione Sovietica ed imposta nell’Europa
orientale, cioè un regime assolutista fondato sulla dittatura di un credo infallibile, di un
partito infallibile e di un dirigente infallibile, rappresenta molto semplicemente e
chiaramente un disastro economico, politico e morale. Il dibattito politico fra l’Est e
l’Ovest è stato vinto dalla democrazia. L’economia di mercato ha vinto sul piano
economico. L’avvenire riserva ancora delle difficoltà, ma il dibattito essenziale è
chiuso.
Come spiegare il trionfo della democrazia? Dipende dalla maggiore flessibilità di un
sistema politico ed economico libero, dalla sua migliore capacità di adattarsi alle trasformazioni
256
provocate dall’interminabile rivoluzione delle scienze e delle tecnologie. Il comunismo,
preservato da qualsiasi dibattito, da qualsiasi divergenza e da qualsiasi ironia, fossilizzato in
un’ideologia rigida, statica e moralizzatrice, non ha saputo adattarsi al cambiamento e questo
fallimento ha comportato un risentimento, una resistenza e, infine, una rivolta.
Il resto del mondo augura al comunismo di riuscire a liberarsi dalle proprie costrizioni.
Se l’insieme delle nazioni ricava degli insegnamenti dalla guerra fredda, potremo forse godere
in anticipo di un periodo d’armonia senza precedenti, per lo meno in Europa.”
Ancora oggi, lo stile e le caratteristiche interpretative globali di questo capolavoro sono
impressionanti. L’accento posto sullo scacco ideologico del regime sovietico, come pure
l’accenno troppo breve dei fenomeni geopolitici ed economici, tradiscono tuttavia la stessa
presa di posizione ottimista: il principio d’infallibilità era obsoleto, “il dibattito, la divergenza e
l’ironia” erano di moda ed il successo del “comunismo” era assicurato se fosse riuscito a
“liberarsi dalle proprie costrizioni”. In un articolo pubblicato, dopo la disintegrazione completa
del sistema sovietico e dell’Unione sovietica stessa, in un numero speciale della rivista
Diplomatic History, consacrata alla fine della guerra fredda, lo specialista americano omise ben
inteso di formulare gli auguri per il successo del “comunismo” e di annunciare un “periodo
d’armonia” (Schlesinger, 1992, pp.49,53).
Il mio personale contributo, in quello stesso numero di Diplomatic History, testimonia
al contrario le grandi speranze che all’epoca nutrivo ancora. Come mette in evidenza, molto a
proposito, il direttore della pubblicazione della collezione di saggi pubblicata tempo fa in
Diplomatic History,
“per Filitov, il conflitto ha in realtà rallentato l’evoluzione storica verso la democrazia
politica e l’economia di mercato, sia in Unione sovietica sia altrove. E’ giusto affermare
che Filitov, ed in una certa qual misura LaFeber, considerano che la conclusione della
guerra fredda segni un ritorno alla storia e non la fine di quest’ultima. Dopo aver ormai
relegato in secondo piano questo grande conflitto, i Russi e le altre nazioni potranno
riprendere il loro cammino verso le libertà politiche ed economiche che la guerra fredda
aveva interrotto.” (Hogan, 1992, p.4)
In realtà, all’epoca non avevo esitato ad utilizzare delle formule che oggi reputo
inadeguate per la redazione di quell’articolo. La tesi che vi proponevo affermava che senza la
guerra fredda “il trionfo dell’economia di mercato e della democrazia sarebbe avvenuto molto
prima e che il suo costo sarebbe senz’altro stato inferiore” (Filitov, 1992, p.56). Ci penserei
senza dubbio due volte oggi alla scelta della parola “trionfo” per descrivere la situazione del
mondo del dopo guerra fredda, in particolare poiché si tratta del mio paese, anche se il solo
accenno al “costo” delle riforme non era veramente nell’aria all’epoca della redazione di questo
articolo, nel 1991. Le raccomandazioni pratiche che formulavo all’indirizzo delle repubbliche
sovietiche (che esistevano ancora in quel momento), consigliando loro di approfittare
dell’esperienza della NATO per creare la loro nuova struttura difensiva, allora suonavano
perfino come parole vuote ed utopistiche. Tuttavia anche oggi non rinnegherò nel mio bilancio
della guerra fredda di aver tenuto poco in considerazione, contrariamente a Schlesinger, il
fattore degli errori d’interpretazione per spiegare le cause e lo svolgimento di questo conflitto.
La mia opinione concordava con quella di Schlesinger quando mettevamo l’accento
sulle basi e le conseguenze istituzionali della guerra fredda. Non posso resistere un’altra volta
alla tentazione di citare lungamente il suo articolo:
“Negli anni ’50, a Washington, il dipartimento di Stato, il dipartimento della Difesa, la
Central Intelligence Agency (CIA), il Federal Bureau of Investigation (FBI) ed il
Consiglio nazionale di sicurezza concepirono la teoria dell’espansionismo militare
dell’Unione sovietica come loro riserva di caccia. La guerra fredda conferirà a questi
servizi ed ai loro responsabili potere, soldi, prestigio ed influenza pubblica. Secondo un
257
effetto proprio di qualsiasi burocrazia, ricoprirono una parte sempre più importante nel
conflitto. Al di fuori del governo, i fabbricanti d’armi, gli ambienti politici, gli
insegnanti, i pubblicitari, i personaggi pontificanti e i demagoghi consacrarono le loro
carriere e fortune alla guerra fredda.
Col tempo, i servizi nemici incaricati della guerra fredda giunsero ad una specie di tacita
collusione oltre la cortina di ferro. La più gran truffa della guerra fredda fu senza dubbio la
commedia che recitarono regolarmente i generali e gli ammiragli, annunciando la superiorità del
campo avverso per ottenere l’aumento dei propri budget. Come fece notare nella primavera del
1963 il presidente John F. Kennedy a Norman Cousins, capo redattore del Saturday Review, “i
puri e duri dell’Unione sovietica e degli Stati Uniti si nutrono gli uni degli altri”.
Sfortunatamente, le istituzioni non tolgono le tende né si eclissano in modo discreto. Le
idee cristallizzate nelle burocrazie resistono ai cambiamenti. Una volta terminata la guerra
fredda, ogni avversario si deve confrontare con il problema dello smantellamento di servizi
solidamente stabiliti, generati e rinforzati da circa mezzo secolo di concorrenza
scambievolmente proficua. Che si pensi semplicemente, a questo proposito, alle forze che
presero parte alla cospirazione organizzata nell’agosto 1991 contro Gorbatchev.” (Schlesinger,
op. cit., p. 49)
Le mie stesse osservazioni, espresse in uno spirito polemico contro le interpretazioni
che volevano fare della guerra fredda una lotta contro lo stalinismo, erano meno incisive (per
non dire in un linguaggio conciso), ma aderivano globalmente allo stesso spirito:
“La guerra fredda servì unicamente a rinforzare le strutture staliniste nel campo
sovietico ed iniziò ugualmente, col tempo, a minare le fondamenta della società
americana nel dominio dell’economia di mercato e della democrazia… Si può affermare
che coloro che, in Occidente, parteciparono alla guerra fredda, non furono così
desiderosi di “vittoria” o di “superiorità” quanto di mantenere un “nemico” costante,
che servisse loro per uno scopo specifico. La guerra fredda in entrambi i campi tese a
scalzare la democrazia ed, in generale, il buon senso e la razionalità in materia di
politica” (Filitov, 1992, pp. 56,57).
Alcuni critici potrebbero rimproverare ai due autori – l’Americano ed il Russo (a
quell’epoca il Sovietico) – il loro tipo d’approccio “equidistante” dai principali avversari della
guerra fredda. A dir la verità, mi ero sforzato di mettere in luce alcune distinzioni, per spiegare
“il successo dell’Occidente ed il fallimento dell’Est” (ibid, p.58). Ripensandoci, oggi mi
azzarderei a generalizzare di più la situazione, spinto in questo da un motto di spirito formulato
una volta in risposta alla domanda a proposito se l’URSS possedesse il proprio complesso
militar industriale (CMI): il verbo “possedere” è improprio, poiché l’Unione sovietica è un
complesso militar industriale. Questo punto di vista può apparire leggermente esagerato, ma ha
il merito di dare una spiegazione a numerosi interrogativi.
Spiega in primo luogo perché e come l’Unione sovietica, nonostante la disparità delle
condizioni di partenza ed una relativa penuria di risorse, abbia potuto realizzare e conservare
una parità strategica con gli Stati Uniti e risparmiare così al mondo una terza guerra mondiale
che, in assenza di una forza di dissuasione vicendevole, avrebbe potuto facilmente essere
scatenata sotto l’apparenza di un “intervento umanitario” (per utilizzare la terminologia
moderna).
In secondo luogo spiega il carattere intrinsecamente difensivo e reattivo dell’armamento
e della politica straniera sovietici: il CMI sovietico non aveva alcun bisogno di una vittoria
riportata sul “nemico” capitalista, gli occorreva unicamente che questo nemico esistesse, per
giustificare e legittimare la propria esistenza.
258
In terzo luogo spiega l’enormità delle difficoltà incontrate dagli Stati della vecchia
Unione sovietica nel loro passaggio da un modello di “mobilitazione” della società verso un tipo
di società “normale”. Non si trattava di una questione di un nuovo spiegamento di risorse o “di
un’assegnazione” di queste ultime, nel senso generalmente attribuito a questo termine. Mi viene
in mente il commento formulato, se non vado errato, dai mass-media francesi riguardo alla
catastrofe di Tchernobyl: “I Sovietici producono energia allo stesso modo in cui fanno la guerra,
senza tener conto dei costi e dei rischi”. Il problema è che la popolazione sovietica non
conosceva nessun altro modo, non solo di produrre, ma di vivere in generale. Per di più, il
“modello di mobilitazione” sembrava loro giustificato e legittimato dalla loro storia, d’altronde
non senza ragione. Mi asterrò qui dal citare un certo numero di fatti ben conosciuti: l’intervento
dopo la rivoluzione d’ottobre, l’invasione hitleriana, la “diplomazia nucleare” degli Stati Uniti,
ecc.
Tuttavia questa generalizzazione non spiega la ragione per cui i dirigenti sovietici
consentirono a mettere fine alla guerra fredda e, senza dubbio, presero perfino l’iniziativa di
questo processo. Erano forse ciechi al punto di ignorarne le conseguenze evidenti? La
scomparsa “dell’immagine del nemico” avrebbe privato d’ogni legittimità l’esistenza del CMI,
il regime che si basava su questo e, in definitiva, la loro situazione personale di potere. Diverse
ragioni geopolitiche, militari, economiche, sociali e, ben inteso, personali sono state avanzate
per spiegare questo fenomeno. Formulerei alcune brevi osservazioni riguardo ad un certo
numero fra quelle.
Il “fattore cinese” è solitamente anteposto a molte ragioni geopolitiche: i Sovietici, di
fronte ad una minaccia venuta dall’Est, si sarebbero inevitabilmente riavvicinati all’Occidente.
E’ esattamente questo punto di vista che indusse il cancelliere Konrad Adenauer a credere a
delle concessioni sovietiche sulla questione tedesca e ad un’eventuale riunificazione. Possiamo
soltanto valutare gli elementi che diedero luogo a questa convinzione, ma è difficile considerarla
fondata. L’esacerbarsi del conflitto relativo alle frontiere sino-sovietiche negli anni 1968-69 non
sarebbe certamente stato sottovalutato nella descrizione della politica della distensione; non
modificò tuttavia le caratteristiche essenziali della politica estera sovietica e meno ancora quelle
del regime sovietico all’interno stesso del paese. Quando si produsse questo cambiamento, le
relazioni con la Cina erano in realtà in via di miglioramento. Tuttavia, anche se si considera
certa l’ostilità fondamentale tra questi due giganti comunisti, si può immaginare lo scenario
spaventoso che si sarebbe presentato con una guerra fredda di logoramento (vedi a volte
“calda”) “tripolare”, come la descrisse George Orwell in 1984, con questa prospettiva
assennatamente riassunta in una battuta sovietica degli anni ’60: gli ottimisti imparano l’inglese,
i pessimisti il russo ed i realisti il cinese.
L’idea che i Sovietici avrebbero gettato la spugna a causa del rafforzamento della
potenza militare americana sotto la presidenza di Reagan è troppo soggetta ad errore per essere
presa sul serio. L’industria della difesa funzionava nell’insieme piuttosto bene in Unione
sovietica ed era in grado di fare concorrenza con le stesse industrie dei paesi occidentali su un
piano d’uguaglianza.
E’ certamente possibile stabilire la diagnosi di una relativa frattura in materia
d’innovazione di alta tecnologia, ma questo punto debole non presentava nessun carattere
disastroso e i Sovietici nello stesso tempo rimediarono rapidamente e lo compensarono in parte,
da un lato, con la produzione massiccia di armi più tradizionali e, d’altro lato, dal successo delle
loro attività d’informazione.
Sembra più pertinente di ricordare il ritardo subito dal consumo nell’economia
sovietica. Le costrizioni e le difficoltà subite conseguentemente dalla gente “ordinaria” non
preoccuparono tuttavia veramente la classe dirigente, poiché esse non provocarono nessuna
contestazione massiccia. Un esperto competente spiega questa attitudine attraverso quattro
ragioni:
259
“quelli che facevano parte di questa massa male informata si sentivano appagati in
quanto”
(1) il loro impiego era garantito;
(2) il loro affitto era moderato;
(3) avevano i mezzi per acquistare dei prodotti di base (anche se questi sembravano, per una
ragione o per l’altra, sempre più difficili da trovare);
(4) vivevano in un’epoca in cui nonostante innumerevoli difficoltà, il livello di vita non era
“così deprecabile”, paragonato ai decenni precedenti:”( Condor, 2003, p.69)
Questa spiegazione manca un po’ di consistenza. Se era “sempre più” difficile
procurarsi dei prodotti di base, come si sarebbe potuto parlare di un paragone positivo con i
“decenni precedenti”? E’ possibile che la mia memoria sia labile e che la mia esperienza di
cittadino di una metropoli non sia giudicata rappresentativa, ma tutte e due mi portano a credere
che il livello di vita continuasse a crescere anche se in maniera più moderata, e che la vera crisi
si produsse in seguito con la perestroika .
Questo stesso esperto conferma questa affermazione quando dichiara:
“ è da notare che nessuno sciopero sia stato organizzato per esigere un reale
miglioramento del livello di vita fino alla fine dell’era Gorbatchev ; si continuava al
contrario a protestate contro il deterioramento delle condizioni di vita “normali”, che
esistevano all’epoca dell’antico contratto, la cui esecuzione lasciava a desiderare.”
(ibid, pp. 61 –62)
Secondo lui, il cambiamento essenziale non venne dalla “massa male informata”,
neppure dai “colti scettici”, ma dalle “élites privilegiate che servivano il regime (e) erano in
grado di capire in che cosa consisteva l’esistenza al di fuori dell’URSS grazie al loro accesso ai
media stranieri, ai rapporti a diffusione limitata dell’agenzia di stampa TASS, così come alle
opere e alle riviste generalmente proibite” (ibid, pp.67-69). I fattori decisivi furono “l’arrivo al
potere di Gorbatchev e la sua politica di glasnost (che preconizzava una più grande trasparenza
dei media)”:
“la società sovietica annegò sotto un flusso di informazioni che riguardavano la storia e
l’attualità del suo paese, ma anche il mondo esterno che aveva la funzione di specchio
riflettente la povertà e l’abbattimento dello “stile di vita sovietico”. I cittadini sovietici
si resero conto immediatamente che, per il mondo “esteriore” l’esistenza quotidiana in
URSS appariva implacabilmente lugubre e “grezza”. Il desiderio espresso dai dirigenti
sovietici di vedere l’Unione Sovietica raggiungere i ranghi dei “paesi civilizzati”, cosa
che implicava ben inteso il fatto che non ne facesse ancora parte, non migliorò di molto
la situazione (ibid, p.69)
Questa immagine è essenzialmente esatta, ma spiega abbastanza poco il perché le
“élites privilegiate” presero la decisone di rinunciare ai loro privilegi (per lo meno per quanto
riguarda il monopolio dell’informazione e di formulare una aspettativa che equivalesse ad un
rifiuto dei settanta anni precedenti di “civiltà” sovietica. Per capire ciò che spinse queste “élites
privilegiate” (o almeno una parte importante di loro) a schierarsi accanto agli “scettici” (o veri
ed eventuali “dissidenti”) ed a smantellare la “cortina di ferro”, scelta di cui le conseguenze
furono fatali al vecchio regime, conviene ritornare alla nozione di CMI sovietico e alle sue
proprie caratteristiche .
Contrariamente ai loro omologhi dell’Ovest, i membri del CMI sovietico (così come
l’élite dirigente generale, solitamente nominata la nomenklatura) non potevano approfittare dei
loro privilegi se non in modo estremamente limitato. Uno scrittore russo (le cui prese di
posizione erano conservatrici e filo-staliniste) paragonò giustamente il posto che essi
occupavano nella società sovietica a quello di Ostap Bender, eroe di un romanzo satirico scritto
260
da Ilya Il’f e Evgeniy Petrov, che accumulò un milione approfittando della atmosfera di
corruzione che regnava all’epoca della NEP per scoprire poi che in realtà gli era impossibile
spenderlo nel contesto del “socialismo” nascente (Mukhin, 2003, p.709) questo “grande
truffatore” decise allora di convertire la sua fortuna in oro e gioielli e di passare la frontiera, ma
fu depredato da un doganiere rumeno, cacciato dal suo paese, decise dopo tutto di iniziare una
carriera di “upravdom” (responsabile di una infrastruttura edilizia, un posto generalmente
legato ai traffici illeciti se non addirittura alla piccola delinquenza nell’economia statale). Il
parallelo è evidente, quando anche i successori di Ostap Bender fecero fortuna legalmente e
vollero convertire il loro denaro in dollari, e anche viaggiare all’estero. Ma ciò non era possibile
per loro perché dipendevano dall’umore e dai capricci dei loro superiori gerarchici nel partito di
Stato e i diritti dei “detentori segreti” (cioè la maggior parte dei membri del CMI) erano ancora
più limitati. Questa situazione generò un malcontento e una frustrazione.
Permettetemi di fare un esempio personale per illustrare questa affermazione.
Nell’autunno 1983, una delegazione del Consiglio di distretto di Brezhnevski a Mosca, alla
quale ero stato assegnato in qualità di interprete, fu invitata a visitare il distretto di Tower
Hamlets a Londra, con la quale era gemellato. Due persone si videro vietare la partenza in
missione: un ingegnere incaricato della rete cablata e il presidente del Comitato esecutivo del
suddetto Consiglio, che avrebbero dovuto prendere in consegna la delegazione. Il primo era
stato giudicato troppo poco affidabile e il secondo fu sanzionato dal primo segretario del
Comitato del partito della città di Mosca, Victor Grishin, per le cattive condizioni della frutta e
verdura immagazzinate da lui nel deposito del distretto. Nessuno dei due era men che meno un
dissidente, ma erano probabilmente diventati dei partigiani di Gorvatchev, il cui programma si
riassumeva in una idea abbastanza semplice: trasformare l’Unione Sovietica facendola passare
dallo stato di “fortezza assediata” ad una situazione più “normale”.
Questa “normalità” definisce correttamente la società che emerse dopo la caduta del
regime sovietico e la scissione dell’Unione Sovietica? Certamente no. Non è sorprendente, se si
tiene conto delle persone che iniziarono il processo della Perestroika. L’assenza di razionalità
economica e di coscienza sociale, di trasparenza e di responsabilità, senza parlare di altri difetti,
era il segno distintivo del CMI e della nomenklatura e diede la sua impronta naturale alla realtà
postcomunista. Al contrario, le relative limitazioni imposte al CMI e ai dirigenti dei paesi di
democrazia liberale dell’Ovest possono spiegare le transizione meno difficile di questi ultimi
verso l’era posteriore al confronto tra i due avversari e il mantenimento dello statuto di super
potenza degli Stati Uniti. In questo contesto si può comprendere perché il passaggio dal
socialismo al capitalismo avvenne senza frizioni e urti nelle “democrazie popolari”. Queste non
possedevano alcun CMI paragonabile a quello che aveva la vecchia URSS .
E’ il caso di chiedersi se la “decomunistizzazione” e/o la liberalizzazione sarebbe
potuta avvenire in modo più “normale” cioè meno dolorosa. Azzardo una opinione personale,
che nessuno qualificherebbe a torto conservatrice. Diciamo, in poche parole, che si basa
sull’idea che le istituzioni del partito comunista dell’Unione Sovietica (PCUS) avevano un
potenziale democratico sufficiente, che avrebbe potuto essere usato (ma non lo fu) per
riformare lo Stato e la società. In altri termini, il partito democratico avrebbe dovuto avere il
ruolo di locomotiva della società vigilando affinché questo treno non deragliasse.
Su che fondamenti si basa questa tesi? I membri del PCUS erano generalmente
considerati come un gruppo di carrieristi e di servitori del regime. Questa affermazione è
essenzialmente esatta, ma non rispecchia tutta la realtà. Le cellule del partito, almeno in certe
università (di cui ho una precisa conoscenza) erano infiltrate (e talvolta dirette) da quelli che si
chiamavano “i dissidenti intrasistemici”, le cui opinioni divergevano fortemente da quelle dei
membri della nomenklatura (e che arrivavano talvolta a influenzare questi ultimi). E’ difficile
dire se un impulso democratico venuto dalla “base” avrebbe potuto riformare l’insieme della
struttura del partito in modo da smantellare il potere degli apparatchiks. Uno slittamento in
questo senso si è però potuto osservare. Il mio collega dell’Istituto il dr Pyotr Cherkassov, ha
appena terminato una monografia consacrata alla storia dell’IMEMO, un gruppo di riflessione
fondato a Mosca, che presenta il racconto appassionante della lotta mortale tra l’organizzazione
261
del partito di questa istituzione e gli “apparatchiks” del Comitato Centrale e degli organi di
Stato. Questi ultimi dominavano all’epoca di Brejnev e di Andropov, ma il loro trionfo (che
non fu d’altronde mai totale) fu di breve durata. L’avvento della perestroika comportò profondi
cambiamenti così, i candidati al posto di segretario di partito “raccomandati” dai “raikoms”
(comitati di distretto) furono progressivamente silurati nelle elezioni e le cellule del partito
ottennero il diritto di percepire per i propri bisogni la metà delle quote raccolte dai membri. Se
il denaro è una sorgente di potere, questa innovazione poteva portare a una “diffusione del
potere” ed a ciò che si potrebbe riportare una democratizzazione del partito.
Questo processo poteva portare ad una democratizzazione della società? E’ difficile
rispondere a questa domanda. Per i rappresentanti dei “dissidenti esterni al sistema”, la risposta
era categorica e negativa: c’era un parallelo con l’apartheid dell’Africa del Sud, dove le regole
democratiche erano garantite solo per una parte della popolazione, mentre la maggior parte di
questa era esclusa dalla vita politica. Questo paragone era sbagliato. In un caso era impossibile
cambiare il colore della pelle, mentre nell’altro l’accesso al partito era in linea di massima libero
per quelli che desiderassero aderirvi, a condizione che facessero prova di responsabilità sociale.
In questo senso, il PCUS sarebbe veramente potuto diventare il nucleo di una società civile
nascente in URSS, la quale è ben lungi dall’essere una realtà nella Russia di oggi. In ogni caso,
questa idea merita secondo me di essere esaminata come ipotesi.
Più di cinquanta anni fa il pensatore marxista (e anti comunista) Fritz Stenberg
procedette ad una analisi penetrante del regime sovietico, definendolo come una dittatura
terroristica dotata di un immenso potenziale di trasformazione interna in una democrazia
socialista. Prediceva allora che sarebbe stato sbagliato pensare che questa transizionerivoluzione avrebbe potuto prendere la forma di elezioni libere e di una bozza di parlamento in
cui i diversi partiti avrebbero potuto essere rappresentati; secondo lui, i sindacati e le
cooperative rurali avrebbero dovuto dare l’impulso decisivo (Stenberg, 1950, pp.214-16). Si
sbagliava: la rivoluzione, seguendo in ciò un principio della storia russa, venne dall’“alto” e fu
fortemente ostacolata dall’alleanza contro natura tra, da una parte, il CMI e la nomenklatura e,
dall’altra parte, i “dissidenti esterni al sistema” ultraliberali, tramite le elezioni libere ufficiali.
Ma se si considerano i propositi di Fritz Stenberg con un avvertimento contro l’introduzione
prematura e artificiale di norme liberali e parlamentari, sembra giusto affermare che egli aveva
ragione.
Il primo esempio di questa pseudo democratizzazione della vecchia Russia confermò
la sua analisi. Le elezioni del 26 marzo 1989 furono libere nella misura in cui praticamente
ognuno poteva candidarsi e affiggere sui muri la sua foto e il suo “programma” per fare una
buona impressione agli elettori. Tuttavia non è del tutto sorprendente che in questa strana
situazione in cui nessun programma concreto era all’ordine del giorno per sostituire il ruolo già
superato del PCUS e in cui il fascino personale di un candidato importava più delle sue idee o
delle qualifiche, l’organo eletto, il Congresso dei deputati del popolo (la cui prima sessione ebbe
luogo dal 25 maggio al 12 giugno 1989 e la seconda sessione dal 12 al 24 dicembre 1989), non
ebbe alcun ruolo edificante e contribuì in pratica al caos politico ed economico generale.
E’ difficile dire con certezza se la democratizzazione del PCUS sarebbe stata possibile,
e se, in caso affermativo, questo partito democratizzato sarebbe riuscito a riformare l’Unione
sovietica al punto da salvarla dalla disintegrazione; tutto lascia pensare che il fallimento del
partito su questi due temi implicò inevitabilmente la morte dell’URSS. Alcuni autori
attribuiscono lo sviluppo dello Stato sovietico multinazionale unificato a un risorgere di quello
che loro chiamano il “regionalismo” (Akhieser,1997, pp. 653-63). Preferirei definirlo
nazionalismo.
Nelle sue Experiences (un’opera pubblicata nel1967 e che assomiglia a delle
memorie), Arnold Toynbee qualificava il nazionalismo come l’ideologia più potente e più
pericolosa del ventesimo secolo (ivi compreso, secondo lui, “il 90%” delle due altre ideologie: il
“capitalismo” e il “comunismo”). Egli considerava che il solo rimedio contro gli effetti di
262
distruzione di questo sentimento consisteva nell’incoraggiamento dei matrimoni misti.
Stranamente, il grande storico britannico non prendeva in considerazione un mezzo più
pragmatico e più efficace per combattere i demoni degli eccessi nazionalisti: il principio e la
pratica della sopranazionalità, la quale è parte integrante dell’idea e della realtà di integrazione
europea (forse questa dimenticanza è dovuta unicamente alla sua nazionalità britannica, tenuto
conto che le prospettive del Mercato Comune sembravano incerte a molti suoi compatrioti alla
fine degli anni sessanta). Per ritornare al punto che ci interessa, conviene indicare che questo
tipo di sopranazionalità era ugualmente applicato nella vecchia Unione sovietica. La nozione di
“popolo sovietico considerato come una nuova comunità internazionale” non era per così dire
una parola vana.
Alcuni hanno affermato che questa formula era solo una impostura destinata a
mascherare la dominazione della nazione russa, se non addirittura la “russificazione” completa
dell’insieme delle altre nazioni “sovietiche”. Questo tipo di ragionamento mi pare così
convincente come quello degli “ euroscettici”, che temevano che l’Europa unita fosse solo
un’Europa tedesca. Certamente, le garanzie contro il diktat di uno Stato (o di un gruppo di Stati)
in vigore nell’UE erano o sono abbastanza differenti da quelle che aveva un tempo l’Unione
sovietica, questo non significa che quest’ultima non ne avesse nessuna. Esse erano
essenzialmente rappresentate dall’abnegazione implicita e talvolta esplicita, se non addirittura
istituzionalizzata, di cui facevano prova i Russi nel loro stile di vita, l’interazione delle culture
(la cultura russa era più portata all’assorbimento delle caratteristiche specifiche delle altre
culture nazionali piuttosto che all’espansione e alla “proiezione” della sua) e in particolare la
struttura del partito. Il semplice fatto che esistessero dei partiti comunisti in Ucraina, in
Bielorussia, ecc., mentre la Russia non ne possedeva nessuno, permise di rifiutare
l’affermazione secondo la quale la dominazione del PCUS equivaleva a tenere i Russi alla
briglia. Questo contribuì a forgiare l’ideologia dell’internazionalismo o, in altri termini, della
“sopranazionalità”.
Contrariamente, ogni misura tendente chiaramente ad esprimere la “russità”, anche in
virtù dello slogan positivo “i Russi sono uguali alle altre nazioni sovietiche”, serviva alle
tendenze centrifughe della vecchia Unione sovietica. A questo riguardo, la decisione di creare il
partito comunista russo (PCR) fu totalmente disastrosa. La costituzione del Fronte unito dei
lavoratori con un gruppo di comunisti ortodossi di Leningrado (oggi San Pietroburgo),
predecessore del PCR (il suo Congresso costituente ebbe luogo nel giugno 1990), nel mese di
giugno 1989 può essere considerata come il punto di partenza della disintegrazione dell’URSS
(e non unicamente del PCUS).
E’ altresì vero che la formazione dl PCR era legittimata da una sorta di referendum
organizzato dal partito. Persino nel mio distretto di Mosca, che contava numerosi scettici, i due
terzi dei suffragi si pronunciarono a favore del nuovo partito. Era questa l’espressione di una
pratica democratica? Sarebbe più giusto il contrario: tenuto conto dell’assenza di dibattiti
approfonditi e dell’abbondanza di spicciola demagogia e, bisognerebbe anche parlare di una
manipolazione dello scrutinio. Comunque, il fatto che i comunisti della Russia abbiano ceduto
senza difficoltà alle sirene del nazionalismo non fece loro onore. E questa scelta elimina ogni
dubbio sulla possibilità di trovare un metodo più semplice e meno gravoso di accedere
all’”economia di mercato e alla democrazia”.
Ciò fu dovuto principalmente alla forte personalità del dirigente. Dopo tutto, De Grulle
era riuscito a salvare la Francia in una situazione che molti giudicavano catastrofica. Gorbatchev
non ci riuscì. Parecchie ragioni spiegavano il suo insuccesso. Ne citerò una sola: contrariamente
a De Gaulle, egli non disponeva di una squadra disciplinata di consiglieri. Sono venuto a questa
conclusione nel corso delle mie ricerche sulla politica sovietica considerando la riunificazione
della Germania (la questione tedesca dopo la seconda guerra mondiale rappresenta il mio
campo di specializzazione ). Mi compiaccio di ascoltare l’esposizione del prof. Görtemaker su
questo argomento e spero mi sarà possibile fare alcune osservazioni.
263
I punti di seguito riportati riassumono:
I. l’Unione sovietica non ha perso la guerra fredda; ha perso ben più: la lotta tra i sistemi
socioeconomici e, conseguentemente, una buona parte della sua legittimità.
II. La vittoria dell’Occidente non si deve a mezzi militari o ad attività sovversive dirette contro
l’avversario della guerra fredda (questi due fattori l’hanno piuttosto ritardata), ma dal solo
fatto dell’esistenza stessa dell’Occidente, per il fascino che esercitava la sua immagine sullo
spirito delle classi dirigenti sovietiche e nella popolazione intera;
III. Lo sviluppo dell’entità multietnica e largamente “sopranazionale”, che costituiva l’Unione
sovietica, non è dovuto principalmente ai processi di democratizzazione e “dall’introduzione
dell’economia di mercato” in quanto tali; furono questi in effetti la conseguenza della perdita
di controllo di questi processi da parte della società e la vittoria concomitante del
nazionalismo ( e in primo luogo del nazionalismo russo) che suonarono la marcia funebre
all’URSS.
264
35 Eroi, “passati”, protagonisti e popolazione L’Ungheria nel 1989
Janos Rainer
Già quindici anni o appena quindici anni sono trascorsi dal 1989. Questo anno
appartiene in pratica già alla storia, mentre la pagina del 1989 e del processo di trasformazione
non è ancora stata girata. Il 1989 è stato oggetto di numerose analisi, ma la maggior parte della
società che ha vissuto quegli avvenimenti conserva ancora nella propria mente una grande
profusione di ricordi personali. Da allora è cresciuta una nuova generazione che si accontenta di
studiare questi avvenimenti; tuttavia anche per questi bambini , questa storia presenta una
dimensione personale. Benché non l’abbiano vissuta all’epoca come un avvenimento storico e
possano fare riferimento solo alla loro memoria di bambini, essi vivono fianco a fianco con
genitori, nonni, conoscenti e amici i cui ricordi sono di tutt’altro ordine.
Questo è il motivo per cui non posso esaminare il 1989 con lo sguardo di un semplice
analista. Questa data fa parte anche della mia storia personale, troppo personale per permettermi
di delineare gli avvenimenti. Sono addirittura incapace di ricostruire la storia completa di alcuni
dei loro protagonisti. Permettetemi piuttosto di concentrarmi su un avvenimento particolare che
occupò alcune ore di un giorno preciso. E’ certamente possibile fornire un’idea generale o una
veduta d’insieme degli avvenimenti, ma spero che certi ingrandimenti permettano di rivelare
dettagli che faranno rivivere il passato e lo renderanno più vicino al presente. Hanno un
significato diverso, proprio come quel dettaglio di una fotografia nel film Blow Up di
Michelangelo Antonioni (e nel racconto di Julio Cortazar da cui il film è tratto ) assume un altro
senso, raccontando la propria storia.
L’avvenimento che sto per evocare si è svolto il 16 giugno 1989 a Budapest, Hősök tere
- la piazza degli Eroi. Si trattava di una cerimonia di addio ad un morto, Imre Nagy, ex primo
ministro ungherese. Giustiziato, mediante impiccagione, giorno più giorno meno trentun anni
prima, nel cortile di una prigione della periferia di Budapest, riposava da quella data in una
sepoltura anonima nel cimitero di fronte al carcere. Fu inumata una seconda volta nello stesso
posto in quel giorno di giugno.
Budapest possiede due grandi piazze in grado di contenere una folla immensa, entrambe
costruite tra il XIX ed il XX secolo: Una porta il nome di Lajos Kossuth, che guidò la
rivoluzione del 1848 e la guerra d’indipendenza, ed è dominata dal Parlamento. Vi furono
proclamate la prima, la seconda e la terza repubblica ungherese rispettivamente nel 1918, nel
1946 e nel 1989; vi si riunì in massa la popolazione di Budapest il 23 ottobre 1956 per
protestare contro il regime stalinista. Un responsabile politico comunista si rivolse alla folla
quel giorno: Imre Nagy che diventò Primo Ministro l’indomani mattina. Il suo governo fu
sensibile alle rivendicazioni della rivoluzione e proclamò la fine del partito unico, la neutralità
dell’Ungheria e la sua uscita dal Patto di Varsavia. Quella rivoluzione fu schiacciata dalle forze
sovietiche il 4 novembre 1956, ma Imre Nagy non rassegnò le proprie dimissioni né aderì al
controgoverno comunista di Janos Kadar. Fu pertanto accusato di alto tradimento e di
sovvertimento del regime comunista, ragione per cui fu giustiziato.
318
Hősök tere - la piazza degli Eroi è un immenso monumento commemorativo dedicato
alla memoria storica ufficiale dello stato ungherese. Mentre il Parlamento eretto in piazza
Kossuth rappresenta la più importante istituzione dello stato ungherese, la piazza degli Eroi
ripercorre mille anni di storia nazionale, così come questa era sentita agli inizi del XX secolo.
Le statue equestri dei capi ungheresi che conquistarono i Carpazi si ergono al suo centro,
dominate da Árpád: Ai lati, le statue di quelli che all’inizio del XX secolo erano considerati i
più grandi re del paese seguono l'andamento del colonnato. Questo susseguirsi di sovrani inizia
con santo Stefano, fondatore del regno cristiano ispirato a quelli dell’Europa occidentale e si
concludeva un tempo con i monarchi della casa austriaca degli Asburgo che si impossessarono
del trono ungherese nel XVI secolo. L’ultima rappresentazione era quella di Francesco
Giuseppe, che aveva represso nel 1848 la lotta per l’indipendenza, ma aveva raggiunto un
265
compromesso con la classe dirigente ungherese due decenni dopo. Il memoriale raffigurava la
fondazione dello stato ungherese, l’alleanza tra la nobiltà discesa dai capi delle tribù e i sovrani
(cioè a partire dal XVI secolo gli Asburgo) e tramite questo la costituzione aristocratica
ungherese.
Al momento del crollo della doppia monarchia austro-ungarica nel 1918, l’ultimo
gruppo di statue fu smantellato. Il primo maggio 1919, durante la breve dittatura bolscevica
ungherese, l’insieme dei monumento fu ornato con drappi rossi. Sotto il regime autoritario di
Miklós Horthy, che mise fine alla rivoluzione, le statue degli Asburgo furono rimesse al loro
posto. Nel 1929 un monumento in pietra fu posto davanti al gruppo dei capi delle tribù in
memoria degli eroi ungheresi della guerra, il cui epitaffio “1914-1918. Per le frontiere
millenarie” faceva riferimento al trattato di Trianon del 1920. La fine della grande guerra
significò per l’Ungheria ben più della scomparsa della doppia monarchia: la perdita dei due terzi
del suo territorio e della metà della sua popolazione. Quel memoriale esprimeva l’obiettivo del
regime di Horthy, la restaurazione del territorio storico dell’Ungheria:
Trascorso un quarto di secolo , dopo il 1945, gli Asburgo furono nuovamente tolti e
sostituiti dai dirigenti e dai capi di stato ungheresi (compreso Kossuth) che avevano lottato
contro la monarchia asburgica: L’iscrizione del monumento in memoria degli eroi ungheresi fu
cancellata e sostituita con un nuovo epitaffio che proclamava che questi avevano dato la loro
vita per la libertà e l’indipendenza del popolo ungherese.
Il ricordo storico dello stato aristocratico ungherese fu rimaneggiato nello spirito del
programma delle autorità comuniste che avevano preso il potere dopo il 1945; la controversia
non riguardava tanto delle statue precise, ma opponeva il monumento ed il potere che lo
modificava. Il regime comunista era stato infatti imposto dalle truppe sovietiche che
occupavano l’Ungheria contro la volontà della maggioranza della società ungherese.
Tuttavia, lo stesso sistema comunista non volle abbandonare gli archetipi storici. Il
primo maggio 1957, appena pochi mesi dopo la sconfitta della rivoluzione del 1956, Janos
Kadar pronunciò un discorso in Hősök tere davanti a 250000 persone. L’oratore si pose di
fronte a questo quadro storico, identificandovisi solo in parte, prendendo le debite distanze,
dando le spalle alle statue che non erano state né smontate né sostituite.
Poco dopo il primo maggio 1957, Janos Kadar dichiarò in occasione di una conferenza
nazionale del partito comunista:
“una grande parte delle masse laboriose si preoccupa non tanto delle questioni generali
della politica, ma delle soluzioni efficaci ai problemi economici e culturali che incontra
nella vita di tutti i giorni. Tantomeno si forma la sua opinione sul partito e sul sistema
basandosi su questioni politiche”.
Questo truismo a sostegno della “non troppa democrazia” divenne la base del
“consolidamento di Kadar” che consisteva in un tacito accordo. Fin quando il loro livello di vita
continuerà ad aumentare, lentamente ma in modo sicuro e prevedibile, le “masse laboriose”
accetteranno le realtà della politica internazionale e dell’occupazione sovietica, senza rimettere
in causa la legittimità del potere comunista e accetteranno che certe questioni politiche,
comprese le strutture politiche della storia nazionale, siano proscritte. Il caso di Hősök tere
mostra chiaramente che l’Ungheria possiede una forte tradizione di rappresentazione delle storie
epiche del suo passato nazionale.
Il regime di Kadar si è a lungo sforzato di rispettare la sua parte di accordo avvalendosi
di grande accortezza. Le riforme operate alla fine degli anni 60 comprendevano elementi
dell’economia di mercato, ma quel processo fu interrotto all’inizio degli anni 70 su ordine
dell’Unione Sovietica e con grande sollievo da parte dell’apparato del partito ungherese. Quella
decisione portò l’economia ungherese a perdere la sua capacità di adattamento all’evoluzione
dell’economia mondiale, proprio quando le riforme avevano reso la prima maggiormente
266
dipendente dalla seconda. Alla fine degli anni 70, il livello di vita cominciò a stagnare, poi,
verso la metà degli anni 80, a declinare. L’imprevedibile Gorbaciov, determinato ad
intraprendere delle riforme, prese la direzione del partito sovietico nel 1985 provocando
naturalmente un certo malessere nell’élite politica dell’Ungheria e degli altri paesi dell’Europa
orientale.
L’Ungheria presentava altri fattori di crisi specifici. Gli Ungheresi potevano paragonare
il loro livello di vita, ad esempio, con quello della generazione precedente , buona parte della
quale aveva perso tutto in occasione delle due successive catastrofi della prima metà del XX
secolo, o con quello dei loro vicini ad est e a ovest. Circa 250000 persone erano fuggite
all’ovest nel 1956 e la maggior parte di loro erano giovani. Centinaia di migliaia di Ungheresi
furono nuovamente autorizzati ad andare all’estero all’inizio degli anni 60 egli emigrati
poterono tornare a vedere le proprie famiglie. Finché il livello di vita rimase a metà strada tra
quelli dell’est e quelli dell’ovest, il compromesso di Kadar funzionò. Quando, però, cominciò a
perdere credibilità e minacciò (anche se molto lontanamente) di cadere ai livelli di quello dei
Polacchi o dei Cecoslovacchi, lo scontento si diffuse.
Questo si espresse prima tramite gruppi di opposizione, poi attraverso i giovani
tecnocrati del partito e dell’apparato dello stato.
Quei tecnocrati sapevano parlare con buon senso dei mali di cui soffriva il sistema
comunista e delle riforme che bisognava attuare per porvi rimedio. Era loro interesse disporre di
maggiore libertà di parola e ammorbidire il monopolio di comunicazione della classe dirigente.
Le cause di quei mali,però, erano da ricercarsi in un passato del quale dividevano la mancanza
morale con l’insieme del sistema . Il principale ostacolo era lo stesso Kadar. Impersonificava la
sconfitta della rivoluzione del 1956, proprio quando i grandi successi del suo regime negli anni
60 e 70 dieci anni dopo erano solo più un ricordo. Solo l’opposizione democratica era in grado
di sottolineare con chiarezza quello stato di fatto.
Kadar fu rimosso dalla direzione del partito con l’aiuto di Gorbaciov nell’estate del
1988. I suoi successori ci tenevano ad instaurare un dialogo con la minoranza politicamente
attiva e si mostrarono disposti a fare concessioni: riforme economiche, libertà d’espressione e di
riunione parziale e una forma di riesame della situazione. Il peso più ingombrante era quello
della personalità simbolica di Imre Nagy, giustiziato e privo di sepoltura. L’opposizione
ungherese, fra cui i radicali che cercavano di spezzare completamente il sistema comunista, lo
sentivano chiaramente.
“I dirigenti del partito socialista operaio ungherese evocano anche loro una separazione
del partito e dello stato, una forma di pluralismo socialista. Qualunque sia il significato
di questi propositi, ognuno deve capire che nessuna vera apertura politica o
conciliazione sarà possibile finché corpi privi di sepoltura ostruiranno la via di un
compromesso” ,
dichiarò il filosofo Janos Kis, personaggio di primo piano dell’opposizione democratica
in occasione della manifestazione del 16 giugno 1988. Quella stessa estate, un comitato
spontaneo formato da ex condannati politici, il Comitato per la giustizia storica, fece con
successo pressione sul partito comunista affinché si procedesse alla ricerca delle spoglie di Imre
Nagy e dei suoi colleghi e che le loro famiglie fossero autorizzate a seppellirli. Il genio era
ormai uscito dalla lampada. Nel febbraio 1989, il generale Jaruselski si sedette in Polonia al
tavolo dei negoziati con Solidarnosc. In primavera, l’Ungheria vide la costituzione dei partiti
politici che cominciarono a negoziare col partito socialista operaio ungherese: La stampa e la
televisione evocarono sempre più il passato, i morti, la repressione ed il 1956. Le autorità si
ritirarono poco a poco.
267
I funerali di Imre Nagy non potevano limitarsi al cerchio ristretto di una famiglia che dà
sepoltura ad uno dei suo parenti. Fu così deciso che la cerimonia avrebbe avuto luogo in Hősök
tere,la piazza della memoria nazionale ungherese.
Gli attori della transizione democratica ungherese si riunirono così sulla spianata il
mattino del 16 giugno 1989: Non c’erano tutti. La spoglia di Imre Nagy riposava in una bara,
era stata scoperta dopo vari mesi di ricerche nell’angolo più lontano del cimitero di Budapest.
Non era stato il vero spirito di Imre Nagy a riempire la piazza degli eroi: Nagy era appartenuto
alla prima generazione di responsabili politici comunisti ungheresi: Aveva aderito al partito
bolscevico nel 1918, durante la sua prigionia militare in Russia. Vari periodi della sua vita
presentavano ancora zone d’ombra nel 1989 e fra queste il suo esilio in Unione Sovietica negli
anni 30. Si conoscono le sue frequenti prese di posizione con i dirigenti del suo partito, in favore
di una forma di comunismo dal volto umano. Era stato uno dei primi riformatori del partito, ma
le sue idee non erano state accolte in occasione del suo primo mandato da Primo Ministro nel
1953-54. Non fu nemmeno un rivoluzionario nel 1956, benché fosse rimasto un sostenitore
dell’indipendenza dell’Ungheria e più incline a tener conto della volontà potentemente espressa
dalla società ungherese che della politica di Mosca. Fu un comunista, un comunista democratico
nazionale se ciò non fosse una contraddizione di termini.
Il paradosso fu risolto col suo processo e la sua esecuzione. Il 16 giugno 1989, il
comunista Imre Nagy apparve agli occhi del pubblico come un martire del 1956, una vittima dei
comunisti: Quelli che furono sepolti accanto a lui erano anche essi membri del partito
comunista.
Nemmeno il secondo protagonista presenziò alla cerimonia; a settantasette anni,
invalido e condannato dalla malattia Janos Kadar si trovava nella sua villa sull’altra riva del
Danubio: Come Nagy, aveva contribuito all’instaurarsi di un regime di tipo sovietico in
Ungheria, ma contrariamente a lui non aveva mai dubitato della fondatezza del suo operato.
Partecipò al governo rivoluzionario di Nagy nel 1956, ma poi accettò di diventare il Quisling
ungherese. A lui si devono le esecuzioni di Nagy e di numerosi rivoluzionari, dal momento che
la direzione sovietica, alla luce delle attuali conoscenze, non aveva preteso sanguinose
rappresaglie. In seguito fu considerato il miglior riformatore dell’Europa orientale ed ottenne
l’approvazione della maggioranza della popolazione ungherese. Tuttavia negli ultimi tempi fu
terrorizzato da ogni idea di cambiamento e, nel 1989, dalla prospettiva di essere costretto a
rispondere dei suoi atti. Le persone presenti in quel momento in piazza pensavano a Kadar come
all’assassino della rivoluzione ungherese e della libertà, anche se nessuno si decideva a dirlo.
La Piazza degli Eroi era stata sistemata per l’occasione. La scenografia ideata da Gabor
Bachmann e Laszlo Rajk spostò l’attenzione dalla rappresentazione della storia dello stato
ungherese verso un catafalco eretto sul lato sud, davanti al Museo delle Belle Arti. Rajk nacque
nel 1949, ma suo padre, responsabile comunista , fu arrestato alcune settimane dopo e
giustiziato dopo il primo grande processo spettacolare ungherese. Il figlio diventò un militante
di primo piano dell’opposizione democratica ungherese negli anni settanta. La sistemazione
della piazza fatta da Rajk sottolineava l’aspetto plebeo e di sinistra della rivoluzione del 1956 e
creava una atmosfera di lutto atemporale.
Semplici tendaggi bianchi e neri ornavano la piazza. Il simbolo della rivoluzione
ungherese, una bandiera nazionale tagliata al centro, là dove c’erano i simboli sovietici, era
appesa ad una struttura cadente, fatta di pezzi di ferro arrugginiti, che sembrava una gru. Alcuni
ci videro un patibolo, altri l’albero maestro di una nave che affonda.
Il 16 giugno 1989 era un giorno feriale, ma circa 200000 persone assistevano alla
cerimonia che fu trasmessa in diretta e per tutta la giornata dalla televisione di stato, senza
l’accordo né del partito né del governo. Le orazioni funebri furono pronunciate da ex colleghi di
Nagy scelti dal Comitato per la giustizia storica che erano stati condannati dopo la rivoluzione.
Il governo ed il parlamento ungheresi, formati da un partito unico, chiesero al nuovo comitato
per la giustizia storica di deporre la loro corona sul catafalco. Il partito comunista non mando
268
nessun rappresentante. Il comitato politico aveva dibattuto per ore sull’opportunità di
imbandierare la sede del partito e, in caso di decisione positiva, sulla scelta delle bandiere. Alla
fine si decise di esporre una bandiera nera e il tricolore nazionale, omettendo volontariamente il
vessillo rosso del socialismo. Tre giorni prima della cerimonia del 16 giugno, il partito avevo
intrapreso dei negoziati con una coalizione dei partiti di opposizione sulla questione della nuova
costituzione, della legislazione del periodo di transizione e delle elezioni libere. La transizione
che Rudolf Tokes battezzò come”rivoluzione negoziata” era appena iniziata.
Gli oratori che si susseguirono sulla piazza evocarono i morti e la rivoluzione. Non
pensavano ad una prosecuzione o ad una rinascita del 1956, ma ad una transizione pacifica che
si proponesse di realizzare gli obiettivi del 1956.
Regnava un’atmosfera di celebrazione , solenne e leggermente tesa. Risaliva ad appena
qualche giorno prima la sanguinosa repressione degli studenti che manifestavano per la
democrazia in piazza Tienanmen a Pechino. La polizia politica ungherese (sempre diretta da
ufficiali comunisti antico stampo) stabilì un piano d’azione, per assicurare lo svolgimento
pacifico dei funerali. Solo alcuni poliziotti furono visibili durante la cerimonia, perché il
servizio d’ordine era stato assicurato da militanti dei partiti dell’opposizione, gli applausi e le
acclamazioni furono rari e la folla rientrò a casa con calma, alla fine di una cerimonia di
parecchie ore, per seguire alla televisione la sepoltura delle bare. Non ci fu nessun incidente.
Il 16 giugno 1989 segnò una svolta..psicologica nel cambiamento di regime in
Ungheria. Simboleggiò la scomparsa di un’epoca. Come scrisse alcuni mesi dopo il politologo
Peter Kende,
“il fattore morale rappresentò una delle cause principali della caduta del vecchio
regime. Quella cerimonia funebre equivalse all’elevazione dell’ostia che fa fuggire il
Maligno con un gemito.”
Sembrò dopo quel momento che l'élite comunista del paese non avrebbe mai ripreso
l’iniziativa. In realtà, la sua segregazione morale contribuì molto a favorire lo svolgimento
pacifico del cambio di regime in Ungheria. La crisi generale del sistema sovietico, il ruolo di
Gorbaciov ed altri fattori facilitarono in modo evidente l’evoluzione; ma atteniamoci alle
caratteristiche specifiche del caso ungherese.
Spieghiamo ora in poche parole en cosa quel giorno di giugno fece presagire il seguito
degli avvenimenti in Ungheria durante e dopo la transizione. Tra quelli che erano presenti in
Piazza degli Eroi figuravano tre dei cinque futuri primi ministri ungheresi a partire dal 1990:
Jozsef Antall, Viktor Orban e Peter Medgyessy. Appartengono a tre generazioni diverse e la
loro storia, lungi dall’essere normale è sotto molti aspetti caratteristica della transizione
ungherese e del suo strano rapporto con il passato.
Jozsef Antall è nato nel 1932. Suo padre era un alto funzionario del Ministero degli
Interni prima e durante la seconda guerra mondiale, che si era occupato dell’alloggio e del
mantenimento dei rifugiati polacchi. Dopo la guerra, Antall padre era diventato deputato del
partito dei piccoli proprietari e ministro del governo di coalizione, posto che continuò ad
occupare dopo la presa del potere da parte dei comunisti, fino al 1953. Voleva fare di suo figlio
un uomo politico e lo mandò nel migliore istituto superiore religioso di Budapest. Jozsef Antall
fu ammesso all’università nel 1950, diventò professore di storia ma dovette abbandonare
l’insegnamento nel 1959 a causa di pressioni politico-poliziesche. Tuttavia non fu arrestato e
continuò ad esercitare una professione intellettuale. Diventò vice conservatore di un museo alla
fine degli anni 60 e conservatore negli anni 80.
Benché fosse sottoposto per decenni a sorveglianza da parte della polizia - il suo miglior
amico e compagno di classe era un informatore che rese conto di tutto quello che faceva per
trenta anni - non prese parte a nessuna attività di opposizione diretta. Nonostante questo,
269
persone a lui vicine reputarono che avesse la stoffa dell’uomo politico. Competente in storia
come in diritto, risoluto, Antall capeggiò durante l’estate e l’autunno 1989 la delegazione
dell’eterogeneo e populistico Forum democratico ungherese ai negoziati con il partito
comunista. Si mise a capo del movimento in autunno e fu nominato Primo Ministro quando
questo diventò il primo partito del paese dopo le elezioni del 1990. Si sforzò di trasformare il
Forum in un partito conservatore sul modello di quelli dell’Europa occidentale, senza riuscirci
Morì di cancro nel 1993..
Viktor Orban nacque nel 1963 in una famiglia rurale del Transdanubio. I suoi genitori ,
però, non lavoravano più la terra. Suo padre era funzionario in una società mineraria, che fu
privatizzata all’epoca del cambio di regime, il che gli permise di diventare un ricco proprietario.
Suo figlio studiò diritto a Budapest negli anni ’80. partecipò alla creazione di un “circolo di
riflessione” popolare, che prese il nome del filosofo politico Istvan Bibo che aveva servito nel
1956 nel governo di Imre Nagy. Quel circolo specialistico accoglieva regolarmente conferenze
organizzate non solo da universitari, ma anche da importanti personalità dell’opposizione
democratica. Nel 1988, Viktor Orban diventò il membro fondatore del FIDESZ, un partito
radical liberale della gioventù. Fu il solo oratore a prendere la parola ai funerali di Nagy che non
era e non poteva essere vissuto il 1956. Gli organizzatori della cerimonia gli chiesero di
esprimersi a nome della gioventù ungherese; pronunciò il discorso più coraggioso e triste della
giornata, chiedendo il ritiro delle truppe sovietiche e dichiarando che le bare contenevano anche
l’esistenza della generazione cresciuta negli anni novanta, allusione alla difficoltà e al prezzo da
pagare per il cambiamento del sistema. Negli anni 1990, Orban prese un’altra direzione e fondò
un partito conservatore ungherese, strano miscuglio eclettico di democristiani di stile
occidentale, di estremisti di destra sensibili all’autoritarismo degli anni fra le due guerre e di
giovani pragmatici di una generazione ancora più recente della sua.
Peter Medgyessy nacque nel 1941 in una famiglia della Transilvania: Suo padre era un
diplomatico ungherese del periodo comunista, mentre lui frequentava negli anni 1960 la facoltà
di scienze Economiche di Budapest, che era all’epoca il caposaldo della riforma del socialismo.
Medgyssey fu ammesso in seguito nell’apparato dello stato e nel partito comunista. Fu
rapidamente promosso nel Ministro delle Finanze, svolgendo però per alcuni anni in segreto una
attività di funzionario del controspionaggio. Verso la fine degli anni 1980 divenne ministro
delle Finanze, vice-primo ministro e membro del comitato centrale del partito socialista operaio
ungherese. Operò accanto al Primo Ministro Miklos Nemeth all’introduzione dell’economia di
mercato e lo accompagnò quando depose una corona sul catafalco di Imre Nagy. Nel 1989 non
aderì al nuovo partito socialista. Divenne il direttore dalla filiale ungherese di una grande banca
francese e un ricco finanziere. Nel 2002, fu scelto dal partito socialista, come esterno, per
assumere la carica di primo ministro.
Il regime di tipo sovietico in Ungheria crollò nel 1989. Elezioni libere furono
organizzate l’anno successivo e, due anni dopo il funerale, le forze di occupazione sovietiche
lasciarono il paese. L’economia fu riorganizzata sulla base dell’economia del mercato nel giro
di qualche anno e si poté assistere ad una crescita a metà degli anni 1990 dopo una grave
recessione. Misure decisive di trasformazione dell’economia furono prese nel 1995 dal ministro
delle Finanze Lajos Bokros, che era stato autore di analisi pubblicate nei samizdat
dell’opposizione negli anni 1980 con lo pseudonimo di David Ricardo. Il capo del governo dal
1994 al 1998, Gyula Horn, aveva preso le armi contro la rivoluzione del 1956, ma ebbe nel
1998 l’immenso merito di far precipitare, in qualità di ministro degli affari esteri, gli
avvenimenti che contribuirono alla caduta del muro di Berlino, Visto da lontano, il
cambiamento del regime ungherese fu una transizione pacifica e ordinata da una qualità ad
un’altra, cioè da una versione edulcorata del sistema sovietico post-stalinista ad una democrazia
liberale. Varie generazioni, però, ed una moltitudine di strategie entrarono a far parte delle sue
storie individuali vicine. i valori ed i cattivi geni del periodo fra le due guerre, l’eredità morale
del 1956, i successi del periodo di Kadar così come le critiche e le costatazioni dei momenti di
crisi.
270
Lo stesso discorso vale per i veri protagonisti. Perché il 16 giugno 1998 i veri
protagonisti dell’avvenimento furono le 200000 persone ammassate sulla piazza e i milioni di
telespettatori che seguivano la sua trasmissione. Mille pensieri attraversarono la loro mente
mentre guardavano la cerimonia. Solo qualche anno prima del 1989, la maggior parte della
società ungherese non si era totalmente opposta al regime edificato sull'annientamento della
rivoluzione. La catarsi del 16 giugno risvegliò ricordi di cui nessuno si ricordava da tempo:
l’anno dell’instaurarsi del regime sovietico, il 1956 e le rappresaglie che ne seguirono. Per un
breve istante, ciò che quasi tutti provavano apparve in un lampo dai vividi colori: vivere meglio,
come gli Austriaci, per esempio. Se il passato implicava ormai che era impossibile riuscirci
senza libertà né democrazia, erano pronti a crederlo. Importava poco che avessero vissuto bene
dopo il 1956 (benché il loro livello di vita fosse stato inferiore a quello degli Austriaci) e che
non si fossero preoccupati dei ricordi, dei crimini e dei criminali. Importava solamente quel
giorno di lutto, che inglobava tutto. Dopo, il passato sarebbe sparito nella tomba con quèi corpi
e non avrebbero più dovuto affrontarlo. Tutte quelle conclusioni si sono rivelate nel corso degli
ultimi quindici anni in parte esatte ed in parte errate. Da una parte, la diversità delle nozioni e
dei racconti del passato continua a svolgere un ruolo importante nella divisione politica
ungherese, mentre la diversità dei ricordi occupa sempre il primo posto nei discorsi. D'altra
parte, la natura pratica e pragmatica della maggior parte della società ungherese non è cambiata:
Dodici anni dopo il 1989, mia figlia, liceale, ebbe come argomento per un tema la storia della
sua famiglia nel XX secolo. Ecco cosa scrisse a proposito del periodo successivo al cambio di
regime:
“quel periodo ha modificato soprattutto l’esistenza di mio padre. Dal 1989 ha potuto
dedicarsi in piena legalità a ciò che lo interessa: la rivoluzione de1956”.
Questa osservazione, nella sua semplicità, mi sembra essere l’espressione della verità.
La storia del 1989 non è conclusa. Raccontando le nostre storie personali, grandi e piccole,
interrogandoci e riflettendo su quelle domande, contribuiamo a vegliare affinché il vero
messaggio di quella giornata di quindici anni fa, cioè l’importanza di occuparsi del passato,
l’importanza del nostro rapporto con la libertà e l’importanza della sorte degli individui nella
storia, resti e tocchi quelli per i quali questo ricordo si cancella ogni giorno di più.
271
36 - La storia della caduta del comunismo – cantiere delle scienze
socio-umane
Lavinia Betea
Il piano di ricerca: studio del caso - “la rivoluzione rumena” del 1989
Come risaputo, l'anno 1989 ha portato nell’Europa centrale e dell'Est il crollo del
regime comunista e l'inizio di un processo complesso di trasformazione a livello individuale e
collettivo. Ed è una affermazione banale dire che le condizioni precedenti della Romania erano
diverse e che il trasferimento del potere è stato fatto in modo diverso “rispetto alle rivoluzioni di
velluto„ degli altri paesi europei.
Così, nel processo di crollo dei regimi comunisti in Europa, per cambiare il gruppo al
potere, in Romania “si è messa in scena una rivoluzione tipica” (Karnoouh, 2000).
Nella sua analisi che riguarda la rivoluzione della Romania, rispetto ai cambiamenti
degli altri stati comunisti dell'Europa, Gabanyi (1999) ha segnalato le particolarità seguenti del
trasferimento del potere:
1. È in Romania soltanto che è avvenuto un capovolgimento sanguinoso di regime, durante il
quale 1.104 uomini sono stati uccisi e 3.352 sono stati feriti.
2. Si è fatto ricorso alla violenza non soltanto prima della fuga della coppia Ceausescu da
Bucarest, ma ancora di più dopo questa (22 25 dicembre 1989). Lo scopo di quest'azione era
di creare un’apparenza di legittimità nella conquista del potere da parte del nuovo gruppo
dirigente e garantire questo potere attraverso i cambiamenti istituzionali e delle elite scelte.
3. E’ in Romania soltanto che il capo del partito, Nicolae Ceausescu e sua moglie, Elena
Ceausescu sono stati messi a morte dopo un processo che rappresenta un retaggio dei
processi staliniani.
4. Appena dopo questo ribaltamento della dittatura di tipo ideologico nazional-comunista, in
Romania i comunisti riformisti hanno preso il potere.
Le discussioni provocate dal carattere popolare e rivoluzionario della sommossa, le
manipolazioni dell’informazione praticate dai mass media tra il 22 ed il 25 dicembre 1989, la
legittimità della nuova elite che ha preso il potere, il processo dei coniugi Ceausescu e dei loro
sostenitori associati, il ruolo dell’esercito e della vecchia Sicurezza (i servizi speciali) in tutta
questo cambiamento e soprattutto negli attacchi terroristici, a seguito dei quali si è giustificato il
ricorso alla violenza - hanno costituito (simultaneamente e successivamente) un insieme, di
significati diversi e spesso contraddittori, di significati e nuovi significati della memoria sociale
dei Rumeni. Nonostante l'abbondanza dei lavori dedicati al crollo del regime comunista e,
implicitamente, alla rivoluzione sanguinosa della Romania, nessun studio elaborato sino ad oggi
a questo riguardo è conforme alle teorie ed alle metodologie proprie delle scienze socio-umane.
La nostra ricerca si svolgerà su due assi principali:
1. L'investigazione della formazione e della trasformazione dei significati e dei nuovi
significati dovuti ad un avvenimento storico di una portata e di un'importanza
considerevole, nel corso di una tappa circoscritta a 15 anni.
2. Lo studio dei rapporti tra le rappresentazioni sociali di certi fenomeni, istituzioni e caratteri,
come: "La rivolta anti Ceausescu", "i servizi speciali comunisti", "la Sicurezza", "i terroristi
272
e gli eroi della rivoluzione" ecc., ed i fattori, (la propaganda, la commemorazione ecc.) che
hanno contribuito alla trasformazione del contenuto di una certa memoria a significato
sociale.
Lo studio del caso raccomandato utilizzerà come metodologia fondamentale:
1. L'analisi del contenuto dei discorsi (ufficiale, dei giornali), e delle conversazioni registrate
con "gli spettatori impegnati" negli avvenimenti.
2. L'intervista creativa con dei partecipanti agli avvenimenti del dicembre 1989.
3. Il metodo biografico, lo studio dei documenti e i racconti autobiografici.
Con l'aiuto dei metodi di analisi socio-umana, utilizzati nel nostro studio, ci si riferirà
alle teorie ed alle analisi psicosociologiche principali.
Innanzitutto, la nostra attenzione sarà focalizzata sul fenomeno delle rappresentazioni
collettive in quanto forma di conoscenza sociale.
L'analisi della formazione e della trasformazione delle rappresentazioni sociali,
concernente gli avvenimenti che si sono prodotti nel dicembre 1989 in Romania, ci permetterà
di mettere in evidenza alcuni aspetti del rapporto tra il nucleo centrale ed i suoi elementi
periferici, il ruolo del contesto e dell'ideologia nella formazione della memoria sociale.
Con l'aiuto di queste rappresentazioni sociali, si metterà in rapporto la memoria
individuale e la memoria sociale. Sentita come una forma di conversione e di manifestazione del
pensiero sociale, la memoria sociale degli avvenimenti di dicembre 1989 sarà affrontata in
quanto risultato di un approccio sociopolitico. Per quanto riguarda la formazione ed il
cambiamento dei significati della memoria, una riflessione speciale sarà riservata al ruolo degli
avvenimenti pubblici, alle commemorazioni, alle statue, alla nascita di alcune tradizioni
destinate a mettere d’accordo il senso e/o i nuovi significati di alcuni ricordi.
Nello studio che proponiamo, vogliamo riportarci ad una delle prospettive cognitive
della memoria collettiva attraverso l'analisi della memoria di tipo "flash", (M. Conway, 1994),
che gli "spettatori impegnati" hanno conservato delle dimostrazioni e delle proteste che avevano
alla fine portato al crollo del regime comunista della Romania, o di certi momenti tesi di questa
epoca (la fuga "di Ceausescu", "gli attacchi dei terroristi" ecc..)
Si pensa ugualmente che l'analisi, del punto di vista delle teorie e delle metodologie
psicosociologiche, di certi contenuti della storia recente, in questo caso della "rivoluzione
rumena del 1989", fenomeno mondiale tra i più conosciuti tramite i mass media possa
contribuire anche al chiarimento di un argomento storico molto discusso.
Applicazione pratica: l'effetto “groupthink” nella rivoluzione rumena
Bisogna aggiungere che nella Romania comunista, il "regime Ceausescu" (1965-1989)
si è messo in evidenza attraverso il blocco e l'annientamento di ogni forma di resistenza
attraverso il controllo esercitato dalla polizia politica sui cittadini e attraverso la censura
dell’informazione alla quale questi potevano avere accesso.
La spiegazione del fenomeno risiede nel fatto che il leader comunista ha detenuto il
potere, il controllo dei media, della polizia repressiva per un lungo periodo di tempo.
Nel 1965, con il pretesto di “sviluppare la democrazia", Ceausescu ha sostituito il
vecchio Ufficio Politico con il Comitato Politico Esecutivo, il (CPEX,) organismo la cui
struttura era allargata, (79 membri) e i cui poteri erano, in realtà, formali. Nel 1967, dopo avere
preso il potere da due anni, Ceausescu aveva rinunciato al principio della separazione del potere
273
del partito e dello stato per diventare presidente del Consiglio di stato. Nel 1974, il leader del
partito unico si è autoproclamato presidente della Romania. Era al tempo stesso il comandante
supremo dell'esercito ed il dirigente delle organizzazioni collettive e di massa. Nel momento
dell'apogeo del potere, è ricorso a "una dittatura di clan", in quanto le funzioni più importanti
erano compiute da Ceausescu e da sua moglie da altri membri della famiglia e da un numero
ristretto di collaboratori fedeli.
Durante l'ultimo periodo del regime, i meccanismi del potere funzionavano così che non
c'era nessuna altra alternativa di governo. Così, il principio della rotazione dei quadri seguendo
il quale gli attivisti di livello superiore erano sostituiti molto rapidamente impediva l'esistenza di
una relazione più stretta, capace di cristallizzarsi in una forma di opposizione.
Dopo le celebri dichiarazioni contro l'invasione della Cecoslovacchia (1968) che hanno
assicurato a Ceausescu un grande prestigio internazionale, con il pretesto di impedire il
cambiamento del leader da parte dei sovietici, si è deciso che le elezioni del presidente vengano
fatte dai membri del partito. Inoltre, prima degli ultimi congressi, ad ogni riunione del partito,
uno dei punti all’ordine del giorno era “l'approvazione della candidatura” del compagno
Ceausescu con funzioni di segretario generale del PCR. Di conseguenza, i delegati al congresso
diventavano dei semplici messaggeri del mandato di quattro milioni di membri del partito che
all'unanimità avevano approvato la rielezione di Ceausescu in quanto leader supremo.
Così, la sua sostituzione dalla direzione del partito ed implicitamente dal paese era
diventata impossibile da realizzare e sembrava che il suo potere avesse ricevuto il carattere di
eternità.
Il 25 dicembre 1989, durante la festa di Natale, Ceausescu e sua moglie sono stati
fucilati dopo un processo farsa. Questo fatto significa un grande insuccesso della sua politica ed
allo stesso tempo un brutto inizio per la società rumena di transizione. Al livello della
politologia e del giornalismo, l'analisi del passato recente si ferma qui.
Ma in termini psicologici, le cause della situazione descritta potrebbero essere spiegate
per mezzo delle caratteristiche del gruppo dirigente, il Présidium CPEX del C.C. del P.C.R.. La
struttura suprema di decisione e la direzione di tipo oligarchico istituite da Ceausescu spiegano
a livello di rapporti di dirigenti la realtà politica e gli avvenimenti avvenuti nel dicembre 1989.
Il modello "groupthink" adottato secondo I. Janis e L. Mann (1977)
Quando si paragona la situazione della Romania ai movimenti riformatori dei paesi
vicini, da una parte, e le caratteristiche ufficiali del CPEX dall’altra parte, la prima conclusione
è quella di un insuccesso del gruppo dirigente. Il fenomeno potrebbe essere spiegato attraverso"
l'effetto groupthink" secondo la teoria di I. Janis (1977). Conformemente a questa teoria
concepita in seguito ad un studio delle relazioni dentro al gruppo dirigente e dell'efficacia delle
decisioni adottate - tutte le decisioni politiche che hanno rappresentato un fallimento nella
politica americana dopo la seconda guerra mondiale, sono state segnate da "l'effetto
groupthink", gruppo che si caratterizza attraverso una sequenza tipica dei fatti descritti nel
seguente schema,:
Gli antecedenti
1.
2.
3.
4.
Un livello elevato di coesione del gruppo dirigente;
L’isolamento del gruppo dalle influenze esterne;
Un leader potente, autoritario;
L'assenza di norme e di procedure per esaminare le posizioni "per" o "contro" delle azioni
alternative;
5. Lo stress elevato indotto dalle minacce esterne e la debole speranza di trovare una migliore
soluzione rispetto a quella preferita dal leader.
274
Il forte desiderio di consenso (unità totale di opinioni)
I sintomi “dell’effetto groupthink”
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
L'illusione di invulnerabilità;
La convinzione nella moralità del proprio gruppo;
I ragionamenti collettivi;
La percezione stereotipa del gruppo avverso, l'incarnazione del male;
L'autocensura dei dubbi o delle opinioni contrarie, (differenti);
L'illusione dell'unanimità;
La pressione diretta sui dissidenti;
La designazione tacita "dei custodi" ideologici.
Le conseguenze
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
L'inventario incompleto delle alternative;
L'analisi incompleta degli obiettivi del gruppo;
L'insuccesso della rivalutazione dei rischi delle elezioni preferite;
L'insuccesso della rivalutazione delle alternative preferite;
La ricerca precaria delle notizie pertinenti, fatta da esperti;
Le distorsioni selettive nella trasformazione dell’informazione;
L'insuccesso nello sviluppo dei piani adattati alle circostanze.
La probabilità ridotta di un risultato di successo
Per la sua validità in Romania, si considerano le notizie ricevute dagli sténogrammi
pubblicati in occasione del processo dei 24 membri del Présidium CPEX (1991) e le memorie
storiche scritte dagli "spettatori impegnati", (esempio: i membri CPEX, D. Popescu e P.
Niculescu - Mizil, il vecchio capo della Cancelleria del C.C., S. Curticeanu ed il vecchio capo
della sezione della stampa del C.C, C. Mitea). Conformemente a queste fonti, gli antecedenti
dell'effetto tradotto in teoria risiede nelle attribuzioni del gruppo dirigente e nelle relazioni di
lavoro stabilite dalla coppia Ceausescu che monopolizzava la decisione ed allo stesso tempo nel
principio "della rotazione dei quadri" attraverso il quale il dittatore e sua moglie attribuivano
delle differenti responsabilità ad un stesso subordinato in un breve intervallo di tempo.
Le caratteristiche dell'adozione delle decisioni fatte dal CPEX sono state generalizzate a
tutti i livelli di decisioni subordinate, (i comitati dipartimentali di partito attraverso i quali il
collegamento con Ceausescu era mantenuto con l'aiuto di teleconferenze settimanali, locali,
comunali e delle organizzazioni di base). Il principio dell'unanimità imposto nella vita politica
rumena dopo l'instaurazione del culto della personalità, le procedure di selezione e di
promozione degli attivisti di partito, l'adozione delle decisioni di elezione del leader nel
congresso del partito attraverso i delegati che portavano i mandati delle organizzazioni politiche
territoriali di riconferma del dirigente, rappresentano delle forti tendenze all'aspirazione del
consenso al punto che in Romania il malcontento individuale non è riuscito a raggrupparsi
intorno ad un nucleo unificatore. Si può affermare anche che è una situazione quasi simile a
quella della Bulgaria, (dove tuttavia si nota un tentativo riformatore), perché la chiesa è rimasta
completamente asservita al potere. I malcontenti dei rumeni sono stati espressi da quella che è
stata chiamata in seguito "la sincerità di cucina", Iakoviev e Marcou, 1999.
I fatti raccontati dal vecchio capo della Cancelleria del C.C. precisavano le relazioni del
nucleo di potere (Curticeanu, 2000). Così i membri del CPEX erano designati direttamente dalla
coppia Ceausescu. Il loro elenco letto solamente alla vigilia del congresso del partito, per essere
approvato dai partecipanti, era diventato una sorpresa anche per le persone designate. I rapporti
ed i materiali il cui il dibattito e la cui approvazione rappresentavano l'attribuzione dei membri
del CPEX, erano messi a loro disposizione dopo l'entrata nella sala di seduta. Dopo
275
un'esposizione sintetica dei temi, sostenuta da Ceausescu, il leader traeva delle conclusioni
come: ("Dubito che non siate di accordo di approvare..."). Il rapporto doveva essere presentato
poi al congresso del partito ed approvato per i membri del CPEX senza che ne conoscessero la
situazione ("voi vi annoiereste se le ascoltaste prima di riunirvi nella sala di seduta diceva
Ceausescu)
Nell'onnipotenza dell'ideologia rappresentata dal leader, le informazioni e le influenze
sugli altri membri del gruppo, notizie giunte dell'esterno del paese, erano escluse. "Il controllo
tecnico" di quelli che erano addetti nei meccanismi decisionali attraverso la polizia politica,
aveva condotto - nello svolgimento degli avvenimenti del dicembre 1989 - alla informazione dei
membri del CPEX trasmessa esclusivamente da Ceausescu. Le riunioni del gruppo dirigente
sono caratterizzate secondo tutte le testimonianze, da uno stress straordinario. L'invocazione
eccessiva dei comandamenti ideologici del leader del gruppo - la condizione primordiale del
consenso del gruppo dirigente - porta alla situazione registrata nello sténogramma della seduta
del CPEX del 17 dicembre 1989.
Dopo l’informazione snaturata di Ceausescu sugli avvenimenti di Timisoara ("le azioni
sono state pianificate dall'est e dall’ l'ovest riuniti per distruggere il socialismo"), la coppia
Ceausescu si rivolge a quelli che avevano delle responsabilità in seno alle forze dell’ordine,
imponendo, in realtà, in un modo militare, il rapporto dell'esecuzione degli ordini dati.
Alla fine, il leader del gruppo decide:
"Lotteremo fino all'ultimo e dobbiamo sottometterlo all'approvazione perché
l'indipendenza e la sovranità sono conquistate e difese dalla lotta, perché se nel 1968
non avessimo agito così, ci avrebbero invaso come avevano fatto in Cecoslovacchia
quando i sovietici ed i bulgari erano alla frontiera
La valanga di avvenimenti che ha seguito il discorso di Ceausescu al balcone, (tenuto
nella confusione del leader sulle cause degli avvenimenti in corso, la generalizzazione della
rivolta, il crollo del regime dopo la fuga della coppia Ceausescu, rappresentano l'insuccesso
dovuto a "l'effetto, groupthink” che ha per conseguenza la mancanza di un'alternativa di
governo. La situazione aveva all'origine delle diverse cause chiamate "la telerivoluzione
rumena" e " l'affare dei terroristi ".
La post-valutazione delle alternative degli ex membri CPEX ha conosciuto uno
snaturamento nell'apprezzamento delle difficoltà iniziali dopo la scoperta della decisione
corretta. Alcuni di quelli che hanno preso la decisione si sono ulteriormente colpevolizzati per
avere ignorato dei dati essenziali, facili ad osservare, colpevolezza che ha generato delle
reazioni nevrotiche depressive o compensatorie. Così, dopo il processo degli ex membri del
CPEX, alcuni sono morti o si sono suicidati (Giosan, Totu), gli altri hanno scritto le loro
memorie attraverso le quali tentavano, principalmente, di giustificare le decisioni del gruppo di
cui hanno fatto parte (Popescu, Niculescu-Mizil, Curticeanu).
Conclusioni
Le considerazioni esposte rappresentano una visione di insieme su un progetto più
ampio che è in svolgimento. In ciò che abbiamo presentato ci siamo limitati all'esposizione della
motivazione dell'approccio in modo interdisciplinare di questo avvenimento della storia
contemporanea, alla presentazione della metodologia e del riassunto di un capitolo che prova
che le teorie della psicosociologia affermano la loro validità in zone che sono impossibili da
analizzare ricorrendo alla storiografia tradizionale. Certamente, l'estensione dell'analisi nella
prospettiva dei cambiamenti sopraggiunti nella memoria sociale, delle rimanenze di
rappresentazioni, degli stereotipi e dei cliché determinati da un mezzo-secolo di comunismo
suppone un sforzo di lunga durata e di grande intensità, utile al, ricercatore e, implicitamente
276
allo storico preoccupato del passato recente e dai suoi effetti sul presente e sul futuro dei paesi
europei ex-comunisti.
277
37. La risposta degli Stati Uniti agli eventi del 1989
Wolfgang Krieger
Qualsiasi riflessione su questo argomento deve cominciare come minimo con una breve
trattazione della struttura del potere globale dell’America che, in teoria, da a Washington un
gran numero di modi possibili di rispondere alle crisi internazionali. In pratica, tuttavia, il raggio
d’azione globale dell’America rende le cose infinitamente complicate. Ogni passo deve essere
considerato, in primo luogo, alla luce di potenziali contromisure da parte di oppositori potenziali
o reali, in secondo luogo, con un occhio a come ogni mossa potrebbe essere interpretata dagli
alleati dell’America, e in terza istanza, con riferimento alla potenziale escalation di ogni azione.
E’ anche troppo facile mettere in moto una serie di reazioni che possono essere sfruttate
dagli oppositori, fraintese dagli alleati e difficili da ribaltare o persino da controllare. In questo
senso, la struttura di potere globale americana è sia un punto di forza che una responsabilità
quando viene a trovare una risposta appropriata ad una crisi internazionale, in particolare se
quella crisi – come quella che ha interessato la sfera sovietica d’influenza del 1989 – non può
essere confinata geograficamente e in essa le grandi potenze hanno notevoli interessi. (In
aggiunta all’Unione Sovietica la complicata Repubblica Popolare Cinese era continuamente nei
pensieri dei decisionisti di Washington).
A partire dalla seconda guerra mondiale, gli Stati Uniti hanno mantenuto non solo un
certo numero di alleanze militari, soprattutto la NATO e l’alleanza col Giappone, ma anche una
vasta rete di basi militari. Esse comprendono non solo attrezzature portuali, campi d’aviazione,
depositi di munizioni, depositi di carburante e altre forniture, posti di comando, avamposti
militari e attrezzature mediche – per menzionare solo i tipi più ovvi – ma anche un grande
numero di attrezzature tecniche per le comunicazioni e per i servizi segreti. Molte di esse
risalgono ad un uso bellico prima del 1945. In seguito lo sviluppo delle tecnologie militari e
delle comunicazioni ha aggiunto schiere di nuovi tipi di installazioni. Le stazioni di
comunicazione satellitare sono l’esempio più ovvio di quelle tecnologie post-belliche a cui, a
partire dagli anni ‘80, ci si riferisce come a RMA (rivoluzione negli affari militari). Questa vasta
rete di attrezzature è fondamentale per muovere e guidare gruppi di portaerei e sottomarini
americani, le navi da spionaggio, le forze aeree e gli eserciti intorno al globo. In altre parole,
anche se un’altra potenza, diciamo l’Unione Europea, avesse le sue portaerei, sottomarini, flotte
di bombardieri, piattaforme missilistiche mobili, forze speciali e così via, questi assetti non
potrebbero essere schierati attorno al globo e non sarebbero pronti per l’azione senza una
infrastruttura paragonabile a quella americana.
In Europa, tra i primi anni ‘50 e gli anni ‘90, gli Stati Uniti mantennero forze in
uniforme per un totale di circa 320.000 uomini (in seguito uomini e donne), con circa 6.000
armi nucleari nei depositi – per menzionare solo queste due cifre di media (che naturalmente
variavano di anno in anno). Incidentalmente, non ci sarebbe stato modo di mantenere queste
forze stazionate oltre mare, la maggior parte in mezzo ai territori nazionali di nazioni alleate
(circa 240.000 solo nella Germania Occidentale), senza l’esistenza di una rete politica
economica e culturale che si muovesse in parallelo con questa struttura militare.
Tutto attorno all’Europa Occidentale, queste forze erano disposte in schieramenti che lo
storico norvegese, Geir Lundestad, ha definito “impero su invito”. Quello che lui vuol dire con
questo termine è che le nazioni ospitanti hanno accettato questi dispiegamenti di forze
statunitensi perché credevano che fossero nell’interesse della loro sicurezza nazionale. Al tempo
stesso, tuttavia, c’era una costante esigenza di reinventare quelle alleanze. Gli alti e bassi delle
relazioni sovietico-americane, la minaccia di un conflitto nucleare, l’atteggiamento talvolta
“imperialistico” dimostrato dagli USA in Europa e nel resto del mondo ha prodotto delle
innumerevoli crisi NATO, impulsi antiamericani e dimostrazioni sulle strade al grido di “yankee
andatevene a casa”.
278
Spiegare perché questo “impero su invito” è durato così a lungo, perché ha superato così
tante crisi, va oltre lo scopo di questa trattazione. Basti sottolineare che la politica militare da
sola, persino la brutale minaccia della politica estera sovietica, non sono state sufficienti a
disintegrare la NATO. C’è stata una rete di relazioni parallele che hanno tenuto le cose stabili.
Oltre ai crediti e alle merci che sono arrivate in Europa Occidentale attraverso il piano Marshall,
fondi segreti sono andati ad una lunga lista di unioni sindacali, partiti politici, organizzazioni
civili e a leader anticomunisti per sostenere le loro lotte politiche. Il sostegno coperto della CIA
per le elezioni italiane dell’aprile del 1948, è stato soltanto uno degli esempi più eclatanti del
tempo, con molti altri interventi meno conosciuti che correvano in parallelo altrove. Il sostegno
a Solidarnosc in Polonia durante gli anni 80 è stato forse l’ultimo maggiore esempio di questo
segreto e non violento aiuto. Le spedizioni di armi americane ai Mujahedin, che combattevano
l’occupazione sovietica in Afghanistan sono state organizzate dalla CIA più o meno nello stesso
periodo. Fuori dall’Europa, particolarmente in Sud America, gli USA hanno talvolta dato
sostegno segreto per supportare le attività di compagnie private americane in quei mercati.
Basandosi su una vasta rete di investimenti statunitensi e di relazioni d’affari ben
stabilizzate già prima della guerra, gli americani intensificarono notevolmente le loro attività di
affari esteri subito dopo il 1945. Durante gli anni ‘60, così tanti investimenti privati americani
giunsero in Europa che un importante giornalista liberale francese pubblicò un libro chiamato
“Le defi americain” ( la sfida americana). Divenne immediatamente un best-seller. Ovviamente,
toccò una corda nell’opinione pubblica dell’Europa Occidentale. Gli affari degli Stati Uniti
stavano diventando un pericolo per la sovranità dei piccoli e medi paesi industrializzati?
A differenza dei loro principali rivali, gli Usa inviarono un potente messaggio culturale
in tutto il pianeta. Lo “stile di vita americano” (qualunque sia il suo esatto significato) divenne
uno slogan. Milioni di persone in tutta Europa volevano ascoltare la pop-music e il jazz
americano. Indossavano pantaloni jeans, guardavano films di cow-boys e ammiravano il
benessere e lo stile di vita americano, o forse quello che pensavano di sapere riguardo ad esso.
In contrasto, poche persone volevano adottare uno stile di vita sovietico, o ascoltavano musica
folk Russa - poche persone a parte i russi. Non c’erano prodotti di consumo sovietici a
stuzzicare le fantasie popolari. Entro la fine degli anni ’70, al più tardi, lo stile sovietico del
“Socialismo” era stato completamente screditato. La stagnazione economica divenne persino
più evidente, mentre i mezzi di comunicazione portavano lo stile di vita occidentale in un
numero sempre maggiore di case nell’Europa Orientale ed anche in Unione Sovietica.
E’ una questione molto dibattuta se il ruolo globale giocato dagli Usa possa essere
propriamente chiamato “imperiale o egemonico”. Non ci sono dubbi che Washington abbia
assunto una leadership globale, essenzialmente in ciò che si intende essere una lotta globale tra
libertà e dittature totalitarie, o tra democrazia liberale e comunismo di stampo sovietico.
Si comprese che i tutti i conflitti locali e regionali appartenevano a questo contesto non
appena gruppi comunisti o alleati con Mosca ne furono coinvolti.
Quando ci fu lo smantellamento Sino-Sovietico alla fine degli anni ‘50, la Cina venne
considerata come una seconda sfida della medesima natura.
Al tempo stesso, tuttavia, le successive amministrazioni Americane resero chiaro che
esse avrebbero perseguito una politica di coesistenza pacifica con i Sovietici e, in seguito, con i
Cinesi. Nel determinare La grande stratega dell’America contro il comunismo Sovietico, i
presidenti americani Truman e Eisenhower scartarono in modo categorico qualsiasi idea di un
attacco preventivo.
Tali idee erano discusse da una minoranza di esperti militari in un momento in cui i
Sovietici avevano cominciato il loro programma di armamenti nucleari ma non avevano ancora
279
raggiunto una capacità tale da permettere loro di lanciare un attacco nucleare diretto al territorio
Americano.
I due concetti che caratterizzavano largamente la politica statunitense erano
“contenimento” e “deterrenza nucleare”. Il primo era essenzialmente, una tacita garanzia che i
sovietici avrebbero potuto mantenere i loro guadagni territoriali e la vasta zona di influenza
ottenuta con la fine della Seconda Guerra Mondiale. (In un certo senso, potrebbe essere
chiamata una sorta di variazione al concetto di pacificazione portato avanti a partire dagli anni
‘30).
Il secondo si rifaceva ad un concetto di egemonia statunitense perché, nel campo
occidentale, solo gli Usa avevano le risorse per costruire un vero e proprio sistema globale di
deterrenza nucleare. Dal 1961 in avanti, Washington e Mosca (sostenute dalla Gran Bretagna
ma con l’opposizione di Francia e Cina) giunsero ad un concetto di “non-proliferazione “
nucleare, che avrebbero dovuto assicurare che il “grande gioco” di deterrenza nucleare doveva
avere solo due maggiori giocatori ed esattamente le due superpotenze (come vennero chiamate
d’ora in poi).
A dire il vero, questo accordo globale non funzionò in modo adeguato. Esso diede
origine ad un notevole spreco di denaro per gli armamenti. Inoltre non avrebbe mai potuto
completamente assicurare che una guerra non sarebbe più scoppiata o come una conseguenza di
incomprensioni o di giudizi sbagliati, o dovuta ad un sconsiderata leadership da parte delle due
superpotenze. Sia a Washington che a Mosca c’era un paura ben radicata che i loro rispettivi
alleati o persino i loro più distanti stati satelliti avrebbero spinto con l’inganno le superpotenze
ad un confronto diretto. In questo modo si sviluppò un certo sentire comune, che portò ciascuna
parte a concentrare le essenziali funzioni decisionali nei due centri metropolitani.
Al tempo stesso, c’era in ciascuno dei due centri un’acuta prontezza a trarre vantaggio
da qualsiasi debolezza mostrata dall’altra parte e a migliorare la propria posizione o
tranquillamente o in modo palese. Entrambe le parti ritenevano che le molte crisi nel Lontano
Oriente, nel Medio Oriente e in Africa offrissero tali opportunità.
Relazioni USA-URSS da Reagan a Bush.
Alla vigilia delle rivoluzioni internazionali del 1989, gli Stati Uniti e l’Unione Sovietica
erano bloccati in un certo numero di conflitti che determinarono in larga parte l’atmosfera
politica di quel periodo. Dopo la fine della guerra americana nel Vietnam, nel 1973-75, il
collasso dell’impero portoghese, avvenuto nel 1974, fornì all’Unione Sovietica l’opportunità di
allargare la sua influenza nell’Africa del sud. Dalle ex colonie portoghesi dell’Angola e del
Mozambico, il Cremlino cercò di costruire un impero africano con cui poter esercitare pressioni
sul Sud Africa e sul mondo arabo ricco di petrolio. Con il controllo sulle ricchezze minerarie
dell’Africa, Mosca avrebbe guadagnato un enorme influenza economica da indirizzare contro
l’Europa dell’ovest e il Giappone, i quali dipendevano in maniera cruciale dalle forniture di
petrolio dei Paesi del Medioriente. Persino gli Stati Uniti avrebbero risentito delle conseguenze
di una tale influenza sovietica appena conquistata sui prodotti chiave del mondo.
Nell’America centrale, il Nicaragua e El Salvador erano due target essenziali riguardo al
rovesciamento dell’ordine costituito sovietico. In collaborazione con la Cuba di Fidel Castro, i
Sovietici cercarono di guadagnare un punto d’appoggio sul continente americano. Le truppe
militari cubane e della Germania dell’est erano impegnate nelle guerre civili dell’Africa del sud.
Il leader sovietico Leonid Brezhnev pareva aver individuato una strategia indiretta che forse
sarebbe riuscita a minare la forza globale americana evitando nello stesso tempo la guerra tra le
due superpotenze. Un altro lato della sua strategia era quello di coltivare simpatie con i partiti di
sinistra di tutti i Paesi dell’Europa dell’ovest e anche al di là di questa, sia per la sua politica di
“anticolonialismo” nel terzo mondo, sia per l’approccio “responsabile” di Mosca alla deterrenza
280
nucleare, in contrasto alla “sconsideratezza” ideologica e tecnologica americana. La politica dei
diritti civili del Presidente Jimmy Carter incontrò ben poche simpatie tra i neo-marxisti
dell’ovest, che avevano ormai largamente egemonizzato i discorsi intellettuali sin dalle rivolte
studentesche del 1968. La lotta politica sullo schieramento in Europa di missili nucleari a medio
raggio (la crisi INF) diede un duro colpo alla NATO anche se, in termini semplicemente
militari, in gran parte non fu che una tempesta in un bicchiere d’acqua.
Ma i Sovietici si spinsero troppo avanti quando, nel dicembre del 1979, invasero
l’Afganistan con l’invio di numerose truppe. Era la prima invasione di quel tipo da parte
dell’Armata Rossa dal 1945. Piò o meno nello stesso periodo, la lenta ma crescente lotta politica
tra il regime di Varsavia e il sindacato indipendente dei lavoratori Solidarnosc, costrinse Mosca
a una lacerante rivalutazione della sua politica nell’Europa dell’est. Come doveva rispondere il
Cremlino a un movimento non violento ma chiaramente anticomunista? Doveva forse rischiare
una guerra civile e un’operazione militare sovietica su vasta scala che si sarebbe rivelata forse
molto più cruenta degli eventi accaduti in Ungheria nel 1956? O doveva cercare di conservare i
vantaggi che il blocco sovietico aveva guadagnato dagli accordi di Helsinki del 1975, che erano
stati così utili per convincere il pubblico occidentale delle qualità intrinsecamente pacifiche e
benevoli del potere sovietico?
Rimandando una netta risposta alla questione polacca, il Cremlino finì
involontariamente per incoraggiare le forze dissidenti presenti su tutto l’impero sovietico.
Mentre nessuno dei loro attivisti credeva che il potere sovietico fosse intrinsecamente benevolo,
costoro furono sempre più certi che la politica sovietica fosse ormai bloccata in un dilemma
politico. In un periodo in cui Brezhnev era ormai molto anziano, ed era poi stato seguito da due
leader altrettanto anziani (Andropov e Chernenko), non ci si poteva certo aspettare nessuna
decisione coraggiosa, anche se l’avventura militare in Afganistan si era trasformata in un
disastro e nonostante la crescente sfida avanzata dai “gruppi di Helsinki” che erano spuntati
dappertutto, sostenendo di possedere certi diritti civili pubblicamente dichiarati e sottoscritti dai
loro governi nella capitale finlandese
Mentre nei primi anni Ottanta il Cremlino era virtualmente senza una leadership
effettiva, salirono al governo di Londra e di Washington due leader dichiaratamente
anticomunisti. Uno era il primo ministro inglese Margaret Thatcher, decisa a varare un
programma di riforme politiche ed economiche per salvare la Gran Bretagna dalla stagnazione
economica. L’altro era il presidente degli Stati Uniti, Ronald Reagan, essenzialmente un
repubblicano moderato quanto a convinzioni politiche, ma un radicale quando si trattava di
sfidare i presupposti fondamentali in base ai quali gli Stati Uniti avevano condotto la loro
politica interna ed estera dopo la sconfitta nella guerra in Vietnam. Entrambi i leader erano
pronti a fornire massicce forniture di armi a tutte le forze locali del terzo mondo che si
opponevano ai movimenti con chiare simpatie sovietiche. In Afganistan arrivarono persino a
fornire armi di ultima generazione, in particolare i famosi Stinger, missili imbracciati da un
uomo e in grado di colpire aerei in volo, che vennero usati non solo contro le truppe alleate di
Mosca, ma direttamente contro i soldati e gli aerei sovietici. Parlarono apertamente a favore
delle forze dissidenti attive all’interno del campo sovietico. (Quasi certamente, fornirono a quei
gruppi denaro e supporti di vario genere). Nel marzo 1983, il presidente Reagan si spinse fino al
punto di mettere in dubbio la saggezza della “comune distruzione assicurata”, il cui accordo
strategico risaliva al 1972 (il Trattato ABC) secondo il quale le due superpotenze prevedevano
la costruzione di un sistema di difesa missilistico, ritenendo che la comune vulnerabilità fosse il
deterrente più valido e quindi l’aiuto più significativo alla pace mondiale. A quel punto Reagan
propose un massiccio programma di ricerche, dal quale sperava di ottenere un sistema difensivo
missilistico spaziale. Incredibilmente, Reagan si offrì persino di condividere il know-how di un
tale sistema con i Sovietici, una volta che questo fosse stato messo in funzione dagli Americani.
Il pantano afgano e il nuovo messaggio di confronto politico da parte di Londra e di
Washington scosse la leadership del Cremlino alle sue fondamenta. L’economia sovietica
presentava dei tassi di crescita molto bassi. La tecnologia sovietica era inguaribilmente arretrata
281
riguardo alla tecnologia dei computer, punto cruciale per la costruzione di nuove armi e per le
comunicazioni globali. Cominciò così a formarsi un consenso sul fatto che fosse necessaria una
nuova e coraggiosa leadership, una leadership dotata di nuove idee, se si voleva che il potere
sovietico riuscisse a sopravvivere. Nell’aprile 1985, questa nuova leadership venne creata sotto
Mikhail Gorbachev, che avanzò una nuova politica etichettandola sotto i nomi di “glasnost” e
“perestroika”. Al fine di guadagnare il favore dei sovietici, Gorbachev propose più dibattiti
aperti sui difetti dell’economia sovietica e sull’apparato statale sovietico che, secondo lui, aveva
bisogno di una profonda riorganizzazione. Comunque, riforme del genere potevano essere
finanziate solo se la spesa militare sovietica fosse stata ridotta da quei livelli eccessivi a cui era
arrivata, di circa un 20% (o più?) del prodotto nazionale lordo. Ma ovviamente, un
riorientamento del genere richiedeva un nuovo accordo strategico con l’Ovest. La nuova
leadership del Cremlino sperava che nuovi rapporti avrebbero favorito un miglior accesso ai
mercati del capitale occidentale e alle sue tecnologie.
Con grande sorpresa da parte di molti occidentali, Gorbachev andò subito d’accordo con
la Thatcher e con Reagan. Altri governi dell’ovest dovettero farsi largo a spintoni per potersi
sedere al nuovo tavolo dei negoziati, dove la discussione sulla limitazione delle armi prese una
direzione del tutto nuova. Incredibilmente, nel Trattato di Washington del 1987, l’Unione
Sovietica accettò di distruggere tutti i suoi missili più avanzati SS-20 a medio raggio e permise,
per la prima volta, che l’attuazione del trattato venisse accertata da ispezioni in loco.
Non c’è dubbio che le relazioni est-ovest promettevano grossi cambiamenti. Ma in che
direzione? Quali erano gli scopi a lunga scadenza di Gorbachev? Era, costui, essenzialmente un
Brezhnev solo più giovane, deciso a fare cose ancora più temerarie, o stava per smantellare il
repressivo sistema sovietico? Se la sua intenzione era quest’ultima, cosa sarebbe diventata
l’Unione Sovietica dopo qualche anno di riforme? Quali sarebbero state le implicazioni per gli
stati satellite? E quale direzione avrebbe infine preso la politica estera sovietica?
Sembra che la maggioranza dei diplomatici di professione e di coloro che si occupavano
di politica credesse all’ipotesi del “Brezhnev più giovane”. Costoro avevano consigliato alle
potenze dell’ovest di adottare un approccio cordiale ma pragmatico del “restiamo a vedere ciò
che succede”. Il presidente George H. W. Bush, che aveva assunto il potere nel gennaio del
1989, era circondato da consiglieri scettici sul “fattore Gorbachev”, e alcuni di questi lo erano
più di altri. Era significativo il fatto che lo stesso Bush fosse piuttosto ottimista, ma che volesse
comunque procedere con molta cautela. Non c’è dubbio che fosse anche intimidito dall’ala
destra del suo Partito Repubblicano, che riteneva che Bush fosse segretamente un liberale.
Così come andarono le cose, Bush ebbe meno tempo di costruire un suo programma di
quanto avrebbe desiderato. Ciò fu dovuto alla popolarità sempre più crescente che Gorbachev
riscuoteva tra il pubblico occidentale e, ancora più significativamente, tra quello dell’Europa
dell’est, che sperava di sganciarsi definitivamente dal vecchio sistema sovietico. Mentre il
leader sovietico stava ormai diventando un eroe politico del popolo, la squadra di Bush restava
legata alle idee tradizionali sulla riduzione degli armamenti. Lo stesso Bush sperava di
presentare ciò che lui definiva un “ardito” insieme di proposte. Ma non si sentiva certo a suo
agio davanti all’entusiasmo suscitato da Gorbachev. Non riusciva proprio a capire come si
potessero varare profonde riforme senza rischiare un altro fallimento simile a quello della
Primavera di Praga del 1968, che aveva portato solo a una maggiore repressione. Se un simile
movimento riformista fosse stato lanciato e avesse poi dovuto fallire - e questa volta non in un
piccolo paese satellite, ma nella stessa terra sovietica! - il risultato sarebbe stato molto più
destabilizzante che nel 1968. Era inevitabile per i Paesi dell’ovest restare a guardare, impotenti.
I gruppi di Helsinki, che indubbiamente s’aspettavano un supporto da parte dell’Occidente,
sarebbero stati sicuramente abbandonati, perché un aiuto del genere non poteva essere garantito
in nessun modo.
L’idea di Bush prese forma dopo settimane di discussioni. . Il suo punto nodale era
valutare il reale valore delle intenzioni di Gorbachov su due problemi chiave: il controllo delle
282
armi e la politica sovietica nell’Europa orientale, con particolare riguardo per la Polonia e
l’Ungheria. In quelle due nazioni i movimenti democratici avevano lottato tenacemente,
ottenendo un certo successo. Nel dicembre 1988 il governo ungherese aveva annunciato un
piano per legalizzare i partiti non comunisti e per introdurre politiche di riforma. In Polonia il
governo comunista aveva iniziato a negoziare con la leadership di Solidarnosc.
Bush definì i due obiettivi principali. Il primo era la riduzione delle forze
convenzionali. Questa misura avrebbe ridotto la pressione che i Soviet potevano esercitare sui
loro satelliti europei. Il secondo obiettivo era quello di premiare gli stati comunisti che stavano
introducendo riforme veramente democratiche. Si trattava di un mutamento significativo
rispetto alle precedenti pratiche occidentali, che avevano favorito gli stati che in qualche modo
dissentivano dalla linea di politica estera di Mosca mantenendo al contempo regimi repressivi
verso le popolazioni. Il regime rumeno di Nicolae Ceausescu costituiva un esempio
particolarmente negativo del vecchio tipo di approccio.
Bush delineò la sua strategia attraverso una serie di quattro discorsi nell’aprile e nel
maggio del 1998. Elogiò la prontezza della Polonia nel tenere elezioni almeno semidemocratiche e promise sia prestiti USA sia alcune liberalizzazioni commerciali. Uno dei suo
slogan era “Muoversi oltre il contenimento”, un altro era lo sfidare i sovietici a “guadagnarsi”
da soli la strada verso un nuovo tipo di rapporto con gli Stati Uniti. Se voleva provocare un
mutamento drammatico nelle relazioni oriente-occidente nel campo della sicurezza l’Unione
Sovietica doveva abbandonare la sua strategia militare offensiva e trasformare il Patto di
Varsavia in un’alleanza difensiva simile alla NATO:
La reazione tra gli alleati dell’America nella NATO fu piuttosto varia. Molti capi di
stato ritennero che le proposte di Bush fossero basate sul “vecchio tipo di pensiero”. La sua
richiesta di modernizzare le forze militari NATO, in modo particolare il suo arsenale di missili a
testata nucleare a breve gittata (modernizzazione Lance), incontrò una forte resistenza da parte
del governo conservatore-liberale di Bonn, dove il ministro degli esteri, Hans-Dietrich
Genscher, rifiutò totalmente di assecondare tale indicazione. A differenza di molti altri politici
di primo piano Genscher era giunto alla conclusione che le intenzioni di Gorbachov fossero
oneste e che gli si sarebbe dovuta offrire un’ opportunità. E’ abbastanza ovvio che Genscher era
chiaramente conscio della popolarità di Gorbachov. Persino il cancelliere Helmut Kohl, che
aveva mostrato grande coraggio nella battaglia politica per gli schieramenti INF nei primi anni
Ottanta, non ebbe l’ardire di lottare per sistemi missilistici più moderni. Per contro Margatet
Thatcher insisteva sulla modernizzazione nell’intento evidente di rendere la vita difficile alla
Germania, nazione e dove i vecchi sogni di una relazione speciale con Mosca e perfino della
rinascita di una Germania unificata stavano diventando sempre più popolari sia tra i
conservatori che tra i socialisti dell’ala sinistra. (Questi ultimi speravano che in cambio Mosca
domandasse il ritiro della Germania dalla NATO, ottenendo così la liberazione dal “giogo
dell’America capitalista”)
Al summit NATO verso la fine del maggio 1989 Bush si trovò in una posizione
difficile. Molti, all’interno dell’alleanza, preferivano le proposte di Gorbachov a quelle
provenienti da Washinghton. Bush decise di entrare nella “tana del leone”- la Germania dell’Est
- per mostrare alla gente di non essere un guerriero freddo, difensivo e di vedute ristrette. In
svariati discorsi durante il suo viaggio chiese di porre fine alla divisione della Germania,
“un’Europa unita e libera”. Offrì alla Germania una posizione speciale come “partner nella
leadership” (con gli Stati Uniti) e dichiarò il suo sostegno all’unità della Germania a
condizione che si potesse mantenere la stabilità internazionale.
Alcuni giorni dopo, il 3 e 4 giugno, la Cina assistette al “massacro di Tienanmen”.
Alle forze armate fu ordinato di caricare una grande folla di studenti e di cittadini che si erano
radunate nella piazza più grande di Pechino per chiedere che venissero attuate riforme e che si
ponesse fine alla corruzione all’interno del regime comunista. Questo evento ebbe
ramificazioni davvero globali per due motivi: il primo riguardava il futuro del movimento
283
riformatore della Cina ed il secondo concerneva l’impatto che una misura così repressiva
avrebbe avuto sul fragile piano riformatore negli altri stati comunisti.
All’inizio degli anni ’90 la Cina si era avviata verso un suo particolare percorso in
direzione delle riforme. L’idea di Deng Xiaoping, lo spirito guida che stava dietro a tutto il
processo, era basata sulla graduale transizione verso un’economia di mercato ma non prevedeva
una democratizzazione a livello politico. I poteri del partito comunista cinese non sarebbero
stati ridotti, sebbene alcuni dei suoi leaders corrotti fossero stati rimossi dal loro ufficio e
persino processati. Gli zeloti riformisti all’interno del partito sarebbero stati trattati piuttosto
brutalmente.
Fu proprio contro l’ostinato rifiuto di prendere in considerazione le riforme politiche
che gli studenti iniziarono a protestare nell’aprile del 1989. Per questa ragione si sviluppò
rapidamente un movimento di protesta che attrasse ampie simpatie tra i giovani funzionari di
partito. Le loro richieste trovarono eco perfino all’interno delle forze armate. La risposta del
governo fu inizialmente cauta. Vi furono negoziazioni tra i funzionari del governo ed i leaders
della protesta allo scopo di trovare una soluzione pacifica. Durante la visita di Gorbachov a
metà maggio alcune delle sue apparizioni pubbliche vennero disturbate. Alcuni eventi dovettero
perfino essere cancellati. A quel punto la direzione del partito sentì la necessità di asserire la
propria autorità. Alcune unità militari leali furono richiamate a Pechino per porre fine a queste
crescenti rivolte pacifiche. Si trattò di un evento sanguinoso e cruento che suscitò sdegno in
tutto il mondo. Ma la leadership comunista cinese non porse le sue scusa. Ovviamente questa
misura fu presa con l’esplicito consenso di Deng Xiaoping.
Come doveva reagire l’amministrazione Bush di fronte a questi fatti? Il Presidente
Bush, che un tempo era stato ambasciatore USA a Pechino, si impegnò strenuamente per lo
sviluppo ulteriore delle relazioni USA-Cina. Vi era stato in febbraio per una breve visita in
seguito al funerale dell’imperatore del Giappone Hirohito. Si riteneva che la Cina fosse sulla
buona strada per diventare una grande potenza sia in termini economici che militari. La si
considerava un mercato vasto ed in rapida espansione che offriva agli Stati Uniti opportunità di
ricchezza . Era inoltre ritenuta una specie di polizza assicurativa in caso di massiccia inversione
di tendenza da parte dell’Unione Sovietica. Sebbene Bush dovesse scendere a patti con lo stato
d’animo del Congresso e sanzionare la Cina per il suo atto barbarico, egli cercò tuttavia di
mantenere aperto il canale della comunicazione. Infatti inviò Brent Scowcroft, il suo consigliere
per la sicurezza nazionale, in missione segreta a Pechino allo scopo di mostrare il suo profondo
desiderio di appianare rapidamente le cose. I leaders cinesi che incontrarono Scowcroft gli
dissero in chiari termini che erano profondamente scettici nei confronti delle politiche
riformatrici di Gorbachov e che si sarebbero attenuti alla loro agenda. Le riforme economiche
avrebbero avuto la precedenza e quelle politiche le avrebbero seguite in una fase successiva.
Gli eventi di Tienanmen costituirono un modello sul modo di trattare il movimento
democratico. Questo interrogativo fu veementemente discusso in tutto il mondo.
Significativamente, Gorbachov diede anche pubblicamente il suo supporto alla leadership
cinese. I suoi colleghi orientali della linea dura fecero altrettanto. Nella Germania dell’Est l’uso
delle forze armate contro i manifestanti fu salutato con particolare calore. Il capo dello stato,
Enrich Honecker, ed il suo capo dei servizi segreti, Erich MielKe, che erano entrambi molto
critici nei confronti delle politiche riformatrici di Gorbachov, dimostrarono particolare
soddisfazione. Essi avevano persino cominciato a mettere al bando le pubblicazioni ufficiali di
Mosca nelle quali venivano magnificate le riforme di Gorbachov. La linea del partito ufficiale
di Berlino Est fu che quelle riforme non erano necessarie nel loro paese. Il socialismo stava
funzionando bene, grazie.
Il governo della Germania dell’Est era finito sotto forte pressione in conseguenza delle
politiche riformiste del Soviet. Vari gruppi riformatori chiedevano non solo la fine del potere
monopolizzatore del partito comunista ma un ritorno alla nazione-stato tedesca, l’unificazione
con lo stato della Germania dell’Ovest. Migliaia di persone chiedevano visti per l’emigrazione.
284
Il loro numero crebbe drammaticamente quando, il 2 Maggio, la recinzione di filo spinato tra
Austria ed Ungheria venne smantellata nel corso di una cerimonia officiata dai due Ministri
degli esteri che fu trasmessa in TV.
Per molto tempo un’ampia maggioranza di tedeschi dell’Est aveva avuto l’abitudine di
guardare la TV della Germania Federale. Grazie ad essa potevano vedere l’enorme differenza
nelle possibilità di consumo e nel tenore di vita. Vi era ora qualcosa di unico ed insolito da
guardare in Tv: il capo supremo del Soviet che, attraente come un star popolare, nei mesi di
giugno e luglio se ne andava in giro per la Germania dell’Est, la Francia e davanti al Consiglio
d’Europa. Ovunque andasse lui ed il suo programma di riforme erano accolti con crescente
entusiasmo. Il vecchio encomio “imparare dall’Unione Sovietica è imparare ad essere
vittoriosi” assumeva un significato totalmente nuovo.
Il 10 luglio il president Bush visitò la Polonia, cenò con Lech Walesa, il fondatore di
Solidarnosc, nella sua modesta abitazione di Gdansk, parlò al Parlamento Nazionale (Sejm) e
lavorò privatamente per persuadere il leader comunista, generale Jaruzelski, affinché proponesse
il nome di Walesa nelle elezioni presidenziali polacche. Il giorno dopo Bush arrivò in Ungheria,
dove parlò all’Università Karl Marx di Budapest. Solo tre settimane prima, il 16 luglio, una
folla di 250.000 persone aveva presenziato alla nuova inumazione di Imre Nagy, il tragico
leader delle riforme del 1956. In entrambi i paesi le speranze che questa volta le manette
comuniste venissero tolte per sempre erano altissime.
Per essere certo che Gorbachov non monopolizzasse l’attenzione in questa “primavera
delle nazioni” - come fu ribattezzata dallo storico britannico Michael Howard - a Parigi Bush
assistette alle celebrazioni per il 200° anniversario della Rivoluzione Francese nel giorno della
presa della Bastiglia (14 luglio). La sua strategia consisteva nell’incontrare Gorbachov solo
dopo aver individuato una politica coerente e sostenuta dai suoi alleati principali. Si stava
organizzando un summit da tenere possibilmente a Malta verso la fine di novembre. Per
alcune oscure ragioni il comitato di programmazione preannunziò che il meeting si sarebbe
tenuto al largo della costa maltese sulle due navi da guerra usate per il viaggio dei due leaders.
Questa rivelazione si rivelò disastrosa sia perché il maltempo rese difficile passare da
un vascello all’altro sia perché l’insolito luogo di incontro sembrò evidenziare che c’era
qualcosa di particolarmente problematico ed imbarazzante nel meeting stesso. In realtà Bush e
Gorbachov si erano già incontrati ed erano ansiosi di far sì che il meeting avesse un esito
positivo.
Quello che nessuno dei due poteva prevedere erano gli sviluppi drammatici che la
situazione in Europa orientale avrebbe avuto proprio prima del loro incontro programmato.
Il 7 ottobre il capo di stato sovietico visitò Berlino Est per contribuire a celebrare il 40°
anniversario del secondo stato tedesco. I festeggiamenti si rivelarono fonte di grande imbarazzo
per la leadership della Germania Est perché la folla iniziò a gridare “Gorby,Gorby” nell’intento
evidente di mostrare il proprio entusiasmo per il piano di riforme di Gorbachov. Analogamente
la gente comune espresse la propria profonda insoddisfazione verso i suoi leaders, che ancora
rifiutavano di adottare qualunque parte del programma della perestroika. Ma come potevano i
governanti di uno stato satellite impedire che il loro popolo inneggiasse al leader dell’ Unione
Sovietica? Concepite da Erich Honecker come un grosso trionfo nella sua vita politica, le
celebrazioni divennero rapidamente fonte d’ imbarazzo.
Nessuna manifestazione di
trionfalismo poteva far dimenticare alla gente che durante l’intera primavera ed estate del 1989
migliaia di tedeschi dell’Est avevano fatto i bagagli e lasciato il paese. Alla fine le autorità
concessero visti d’uscita ad alcuni di loro. Altri finsero di andare in vacanza in una delle vicine
nazioni “socialiste” e lì trovarono rifugio nelle ambasciate della Germania Ovest. Questi eventi
avvenivano sotto l’attenta osservazione delle telecamere della televisione occidentale ed ogni
sera venivano trasmessi dai principali canali televisivi della Germania Ovest , che potevano
essere ricevuti e visti in molte abitazioni della Germania Est.
285
Esisteva una via d’uscita per il regime della Germania dell’Est? L’Unione Sovietica
avrebbe fornito il supporto per le misure repressive da prendere contro il movimento dissidente?
Il fatto non era assodato ma la leadership della Germania Est stava certamente tentando di
trovare una soluzione. Il 18 ottobre Honecker fu obbligato a fare un passo indietro. Un gruppo
di leader più giovani era pronto a prender in mano la situazione ed introdurre alcune nuove
misure politiche, incluso un regime meno restrittivo in materia di emigrazione. Questi giovani
leaders speravano di ottenere il sostegno di Mosca e forse perfino un certo supporto da parte di
altre capitali occidentali. Dopotutto molti, in Europa, più o meno apertamente erano a favore
della continuazione della divisione della Germania.
Mentre il presidente Bush era a favore dell’unificazione tedesca, il primo ministro
Margaret Thatcher gli aveva fatto chiaramente sapere che non gradiva affatto ciò che lei
considerava un drammatico cambio nella politica Europea. Il presidente francese Mitterand era
indeciso. Non voleva mettere a rischio l’amicizia franco-tedesca ma non era neppure incline a
vedere una Germania più ampliata. Se la Germania Est fosse stata l’unica nazione in crisi nel
blocco sovietico il vecchio modo di intervenire avrebbe potuto avere la meglio. Nell’economia
della Germania Est sarebbe stato riversato più capitale occidentale in cambio di maggiori
concessioni politiche, mentre i quattro poteri avrebbero potuto conservare la loro influenza
politica sulla repubblica di Bonn. Ma nel 1989 la rivoluzione aveva un carattere transnazionale
ed era diretta contro lo stile socialista in tutte le sue forme. Si trattava davvero di un ritorno
delle identità dell’Europa centrale ed orientale. L’unità tedesca non poteva pertanto essere
tenuta fuori dall’agenda di quella rivoluzione, specialmente se i tedeschi dell’est la chiedevano
ed i Soviet la tolleravano. Entrambe le condizioni si verificarono quando nell’autunno del 1989
i tedeschi dell’ Est cominciarono a scendere in piazza ed a condurre la loro “rivoluzione
pacifica”, capeggiata a Lipsia dalle dimostrazioni del lunedì, e quando il Kremlino diede ordine
al governo della Germania Est di non prendere alcuna contromisura armata. Nel novembre
1989, con la “rivoluzione di velluto” in Cecoslovacchia, la Germania Est si trovò ad essere
completamente circondata da governi non comunisti.
Conclusioni
Prima della fine dell’anno era ancora ben lungi dall’essere chiaro come queste
rivoluzioni antibolsceviche sarebbero andare a finire. Il presidente Bush e la sua
amministrazione non avevano ancora stabilito una relazione di completa fiducia con il Kremlino
di Gorbachov e la questione dell’America Centrale costituiva ancora un punto di divisione tra le
due potenze. Il summit di Malta era stato un successo in termini di “atmosfera” ma non aveva
prodotto alcun risultato tangibile. Bush era ansioso di mantenere le sue buone relazioni con la
leadership cinese di Pechino ed in effetti la informava segretamente su tutti gli aspetti del
summit di Malta. Ma uno di essi riguardava una risposta soddisfacente alle rivoluzioni
europee. Era ancora poco chiaro in che modo le istituzioni internazionali, soprattutto la NATO,
il Patto di Varsavia, la Comunità Europea (più tardi divenuta Unione Europea) ed il Comecon,
dovessero essere trasformate per accogliere i nuovi governi post-comunisti europei. Il
preannunziato ritiro delle forze armate sovietiche ed americane doveva essere analizzato alla
luce della nuova ed emergente architettura della sicurezza europea.
In altre parole la maggior parte delle istanze nazionali ed internazionali erano ancora
irrisolte alla fine del 1989. Per l’amministrazione Bush la questione più spinosa consisteva
nello scoprire se il presidente Gorbachov avesse o meno un piano sul come guidare l’Unione
Sovietica attraverso tutti quei cambiamenti rivoluzionari. Quali erano le sue “reali intenzioni”?
Che cosa poteva fare Washinghton per scoprirle?
Il 1989 aveva aperto interrogativi senza precedenti sul futuro politico dell’Europa ed in
senso lato sulle relazioni internazionali a livello globale. I cittadini dell’Europa centrale ed
orientale avevano dimostrato chiaramente che tipo di vita sociale rifiutassero e quali fossero le
loro richieste per il futuro. Alcune risposte erano state date a livello nazionale od erano in via di
286
essere definite. Ma la struttura complessiva del futuro economico e politico dell’Europa
rimaneva dolorosamente incerta.
287
38. La riunificazione della Germania
Manfred Gortemaker
Erano trascorsi più di 15 anni dalle drammatiche scene del 1989, quando la storia era
quotidianamente rivoluzionata dagli eventi. Sono state fatte molte ricerche per trovare
spiegazioni rendere il quadro più chiaro. Abbiamo ottenuto l’accesso agli archivi. Abbiamo
potuto intervistare un ampio numero di testimoni oculari e di quei politici che hanno deciso il
corso degli eventi. Abbiamo letto le loro relazioni. Ed abbiamo fondato istituti di ricerca come
lo Zentrum fur Zeithistorische Forshung di Potsdam, che tratta quasi esclusivamente la storia
del passato recente, talora con risultati sorprendenti. Ad esempio si riteneva piuttosto
seriamente che la DDR non fosse una dittatura ma semplicemente una durchherrschte
Gesellshaft, ovvero una “società accuratamente governata” e che nella DDR fosse stato lo
stalinismo a fallire, e non il socialismo.
E’ giusto dire, comunque, che prima del 1989 nessuno, specialmente in Occidente, era
preparato al collasso della DDR e che molti, nell’Europa Occidentale come in quella Orientale,
non erano lieti di assistere a tale evento. Ciò era particolarmente vero in Francia, dove esisteva
spesso una paranoia nei confronti di una Germania riunificata. Ma l’inquietudine era diffusa non ultimo nel Regno Unito dove il primo ministro Margaret Thatcher avrebbe preferito non
vedere affatto la riunificazione della Germania ma, nel caso ciò fosse avvenuto, avrebbe voluto
porre il processo sotto una qualche forma di controllo internazionale.
Perfino in Germania molti esperti non vedevano la cosa di buon occhio. Solo mesi
dopo il collasso della DDR vi furono insistenze affinché la questione della Germania non fosse
più legata alla riunificazione ma che piuttosto fosse vista come il problema di due stati che
giungevano ad un accordo all’interno del quadro della stabilità Est-Ovest e della sicurezza
europea. Il redattore del settimanale tedesco Die Zeit, Theo Sommer, ad esempio, annotò non
più tardi del settembre 1989:
“Non ci siamo avvicinati di un centimetro alla riunificazione rispetto all’anno scorso, od
a cinque o dieci anni fa (..). Il problema dell’unità della Germania non è più bollente
che mai. Al contrario: esso sta nella parte posteriore del piano di cottura della politica
mondiale ed il fuoco sotto la pentola è spento:”(Die Zeit, 29 settembre 1989):
Sembra che solo gli americani fossero giunti ad accettare veramente la Repubblica
Federale Tedesca come un pilastro responsabile dell’Occidente democratico e che pertanto
avrebbero salutato la riunificazione tedesca come il compimento delle politiche post-belliche e
come una vittoria dell’Occidente nella Guerra Fredda con l’Unione Sovietica. Comunque un
ufficiale francese anziano annotò che la posizione americana era dovuta solo al fatto che “gli
americani sono così scadenti in storia e sono così ingenui da credere che persone come i
tedeschi possano mai cambiare” (citato da J:E:Mroz in Gortemaker, 1994, p:viii)
Restano quindi gli interrogativi più importanti: perché il crollo della DDR è stato quasi
per tutti una sorpresa ? Cosa è stato a causarlo così rapidamente? E soprattutto che cosa lo ha
provocato?
In questo capitolo cercherò di spiegare perché l’improvvisa riunificazione della
Germania non è stata il risultato di politiche accuratamente preparate a Bonn ma piuttosto un
effetto collaterale del crollo del comunismo dominato dal Soviet nell’Europa dell’Est seguito
da un autentico sollevamento della gente nella Germania dell’Est. Spiegherò che la rivoluzione
è stata resa possibile dalle politiche moderate di Mikhail Gorbachov e le azioni dei vicini stati
del Patto di Varsavia, in particolar modo la Polonia e l’Ungheria, e che gli eventi che hanno per
così dire “interrotto il digiuno” nella Germania dell’Est non erano di natura “germanica” ma
288
simili a quelli espressi in altre nazioni dell’Est europeo che erano a quel tempo sotto la
dominazione del Soviet. E cercherò di discutere il fatto che se la Germania dell’Est è stata
effettivamente schiacciata dal peso e dal potere del cancelliere federale Helmut Kohl, questo è
avvenuto dopo, e non prima, la liberazione dal regime comunista.
1. Germania dell’Est, Europa dell’Est ed Unione Sovietica
La DDR è stata posta in essere all’interno della struttura dell’impero sovietico
nell’Europa dell’Est costituito dopo la II Guerra Mondiale. Senza l’aiuto sovietico non sarebbe
stato possibile fondarla. E senza l’appoggio sovietico la DDR non sarebbe sopravvissuta. Nel
corso di tutti i suoi 40 anni di esistenza il regime del PSU (Partito Socialista Unitario) non è
mai riuscito a guadagnarsi la legittimazione da parte della stragrande maggioranza dei suoi
cittadini. Perfino Markus Wolf nelle sue memorie ammette che il regime non era stato mai
accettato completamente da più di un terzo della popolazione - e di solito da un numero di
persone molto inferiore (Wolf, 1991). E Wolf lo dovrebbe sapere bene: è stato a lungo il capo
della Hauptverwaltung Aufklarung, l’organizzazione spionistica della DDR all’interno del
Ministero per la Sicurezza Sociale di Erich Mielke. Fino al momento in cui fu costruito il Muro
di Berlino, nel 1961, un totale di 2,7 milioni di cittadini era fuggito dal paese e si era rifugiato
nel campi profughi della Germania Ovest - circa il 14% della popolazione della RDT nel 1949:
Questo era anche ciò che rendeva la DDR diversa dalle altre nazioni dell’Europa
dell’Est e non le rendeva possibile permettersi libertà e mancanza di repressione. La Polonia
rimaneva Polonia e l’Ungheria rimaneva Ungheria anche senza il regime comunista. Ma senza
il comunismo garantito dal Soviet alla Germania dell’Est, la RDT era quasi certa di fondersi con
l’Occidente prospero e dominante ed avrebbe cessato di esistere come stato. Durante la Guerra
Fredda l’appoggio sovietico non fu mai messo in discussione. Quando la tensione calò e Willy
Brandt si imbarcò nella sua nuova “Ostpolitik” alla fine degli anni ’60, comunque, la RDT
dovette affrontare il dilemma di soppesare l’ambìto valore di cooperazione e riconoscimento
internazionale contro il pericolo di permettere all’Occidente di minare la sua coesione interna
con il cosiddetto “scambio di gente, informazioni ed idee” (Nawrocki,1985). Pertanto la politica
di détente (detensione), non la Guerra Fredda, costituirono la prima seria minaccia all’esistenza
della DDR:
Da un punto di vista occidentale, i tentativi della Germania dell’est di contenere gli
indesiderati effetti collaterali della distensione attraverso una politica di demarcazione e il
rafforzamento della sicurezza dello stato, costituivano una violazione dello spirito di
cooperazione, come per l’ovest l’aumento di contatti personali e la particolare natura delle
relazioni intra-tedesche erano pregi sostanziali e non difetti del processo della distensione.
Willy Brandt, in particolare, aveva compiuto grandi sforzi per difendere la sua politica come
mezzo per creare un ponte, piuttosto che un allontanamento o una divisione, tra l’Est e l’Ovest
(Brandt, 1969). La sua politica era stata improntata all’apertura di nuove possibilità per un
“cambiamento attraverso un riavvicinamento”, come aveva dichiarato Egon Bahr nel luglio
1963 all’Accademia Evangelica a Tutzing, sottolineando piuttosto gli aspetti dinamici che
statici della politica (Bahr, 1988, pp. 325-30). Lo stesso punto di vista era stato espresso da un
altro architetto della nuova Ostpolitik, Peter Bender, che si era dichiarato a favore di una
“distensione aggressiva” nel titolo di un libro pubblicato nel 1964 (Bender, 1964).
La questione adesso era se avrebbero prevalso le forze dinamiche della politica,
portando magari a una rivoluzione democratica nella GDR e a una qualche forma di
riunificazione, o se la leadership della Germania dell’est sarebbe stata in grado di contenere gli
indesiderati effetti destabilizzanti della distensione e trasformarla in un veicolo per il
riconoscimento internazionale con un’accettazione e una prosperità interne. Lo sviluppo della
Ostpolitik, la distensione e le relazioni intra-tedesche, durante gli anni Settanta e anche negli
anni Ottanta, avrebbero fornito una risposta a queste domande.
289
Nei primi anni Settanta, la leadership della Germania Democratica sembrava fiduciosa
del fatto che le implicazioni potenzialmente pericolose dell’accettazione dei termini della
Ostpolitik da parte della Germania dell’Ovest potessero essere tenute sotto controllo. Sotto il
Segretario Generale Leonid Brezhnev, il governo sovietico fornì un deciso supporto, e i
benefici di un riconoscimento internazionale e di una cooperazione con l’Ovest erano troppo
importanti per lasciarseli sfuggire. Eppure, verso la fine del decennio e nei primi anni Ottanta,
sussistevano già i primi segni di una crescente instabilità sociale che trovarono una loro
espressione sotto diverse forme: l’espulsione dei cittadini della Germania Democratica, in
particolare intellettuali e artisti; la formazione di una opposizione della base, iniziata con il
movimento pacifista “Schwerter zu Pflugscharen” e i gruppi ambientalisti, che in seguito
conversero tutti sulla Chiesa Protestante della Germania dell’Est; nonché il crescente numero di
persone che chiedeva il visto d’uscita o che si presentava alle ambasciate occidentali per
ottenere un permesso per lasciare il Paese. L’esempio più eclatante fu Ingrid Berg, una nipote
del Primo Ministro della Repubblica della Germania Democratica Willi Stoph; il 24 febbraio
1984 si rifugiò nell’ambasciata della Germania dell’Ovest, a Praga, dove altri 14 tedeschi
dell’est avevano già chiesto asilo. Nell’ottobre dello stesso anno, l’ambasciata dovette persino
essere momentaneamente chiusa quando più di 100 cittadini della Repubblica della Germania
Democratica cercò rifugio nei suoi locali. Fatti simili accaddero anche a Bucarest, a Budapest e
a Varsavia (Martin, 1986, pp. 55-7).
Una delle ragioni per le quali così tanti tedeschi dell’Est cercavano disperatamente di
uscire dalla Repubblica della Germania Democratica era perché avevano perso qualsiasi
speranza di ottenere delle riforme in un futuro abbastanza prossimo. Secondo un’indagine
dell’istituto di ricerca sulle comunicazioni Infratest di Monaco e dell’Università di Wuppertal,
le ragioni per cui 2000 emigranti (Aussiedler) della Repubblica Democratica tedesca avevano
deciso di lasciare la Germania dell’est erano la “mancanza di libertà di opinione”, la
“repressione politica” o le “limitazioni alle possibilità di viaggiare”. Le ragioni economiche pare
avessero giocato un ruolo minore nella loro decisione di emigrare, anche se la motivazione di
fondo era costituita da un insieme di diversi fattori (Martin, ibid., pag. 98).
La frustrazione della popolazione della Germania dell’est riguardo all’assenza di
riforme nella Repubblica Democratica Tedesca veniva amplificata dagli esempi di cambiamento
da parte della Polonia e dell’Ungheria e persino da parte della stessa Unione Sovietica. Il
fallimento della leadership SED di implementare riforme simili contribuì significativamente alla
perdita di speranza tra i cittadini della Repebblica Democratica Tedesca, che fornì alla fine la
base per la rivoluzione della Germania dell’Est del 1989. In particolare, gli sviluppi avvenuti in
Polonia ebbero un effetto destabilizzante sulla GDR fin dall’estate del 1980, quando una
sommossa di operai si fece sempre più grave nei cantieri di Gdansk e di Gdynia, e il movimento
Solidarnosc si presentò come una pericolosa sfida al governo del partito comunista (Fils, 1988,
pp. 43-54). I disordini nella vicina Polonia distrussero la fiducia della leadership della GDR e
portarono molti dipendenti pubblici a chiedersi se quella sensazione di calma interna che era
stata imposta al Paese durante gli anni Settanta potesse ancora essere mantenuta. Scioperi di
protesta per tutto il Paese e l’organizzazione di sindacati indipendenti da parte degli operai della
Germania dell’Est sembravano ben poco probabili, anche se non impossibili. Il 30 gennaio
1980, il SED Politburo decise di porre fine alla libera concessione del visto per la Polonia e di
imporre rigide condizioni nei movimenti tra i due stati. La demarcazione verso l’Ovest adesso
veniva completata da una delimitazione anche verso l’Est. All’interno della GDR, il Ministro
della Sicurezza dello Stato Erich Mielke giurò pubblicamente che avrebbe aumentato in tutto il
Paese l’attività degli organismi deputati alla sicurezza nazionale. Ciò si rendeva necessario,
sottolineò, per combattere “i piani e le macchinazioni disumane e antisocialiste” delle forze
controrivoluzionarie (Neues Deutschland, 17 ottobre 1980).
Ma i tumulti scoppiarono ugualmente e l’influenza che le riforme della Polonia ebbero
sugli altri Paesi dell’Europa dell’est divenne evidente quando in Ungheria iniziò un acceso
dibattito sul “Comunismo Gulash” di Janos Kadar e sugli obiettivi fondamentali del futuro
economico e politico del Paese (Tokés, 1984, pp. 6-8) e quando simili discussioni iniziarono
290
anche in Cecoslovacchia - luogo della “Primavera di Praga” del 1968. Comunque, i veri
problemi della GDR iniziarono e la situazione cambiò drasticamente quando il 10 marzo 1985
Mikhail Gorbachev divenne il nuovo segretario generale del Partito Comunista dell’Unione
Sovietica. Nonostante vari cambiamenti nella tattica e nella condusione politica sotto Stalin,
Khrushchev, Brezhnev, Andropov e Chernenko, l’URSS era stata un bastione dell’ortodossia
leninista. Per la leadership comunista della GDR, la continuità nella natura del governo
sovietico aveva significato innanzitutto stabilità. Il conservatore Cremlino, temendo
cambiamenti rivoluzionari e sollevazioni democratiche, si era assicurato, attraverso la sola
presenza delle truppe sovietiche, l’uso della forza fisica e delle pressioni psicologiche, il potere
del SED come forza governativa della Germania dell’est. Il ruolo delle 380.000 truppe
sovietiche di stanza nella Germania dell’est erano servite tanto a mantenere il SED al potere
quanto a fornire una sicurezza esterna per il Patto di Varsavia. Fintantoché il comportamento
sovietico non metteva in dubbio la funzione disciplinare della presenza dell’Armata Rossa - che
implicava costantemente il fatto di essere sempre pronti ad usare la forza per prendere di petto
l’opposizione, com’era avvenuto nel 1953 nella GDR, nel 1956 in Ungheria e nel 1968 in
Cecoslovacchia - né la stabilità della GDR né l’esistenza dell’impero sovietico nell’Europa
dell’est erano in gioco.
Tutto ciò cambiò quando Gorbachev salì al potere, anche se non nel giro di una notte. Il
nuovo leader sovietico non possedeva un piano generale di riforme al di là degli slogan glasnost
e perestroika. Il suo approccio era quello di sviluppare gradatamente, come un processo in corso
dipendente dalle sfide che esigevano azioni improvvisate, un concetto per la trasformazione
della politica sovietica. Mentre Gorbachev sembrava possedere un’idea generale - o meglio, una
visione - di una modernizzazione economica assolutamente necessaria e di riforme politiche
nell’Unione Sovietica, così come una generale disponibilità per un ritorno alla distensione e al
controllo degli armamenti nell’Ovest, le sue prime mosse politiche verso i Paesi dell’Europa
dell’est rimasero contraddittorie. Professioni di diversità si alternarono a una richiesta di unità.
Eppure, Gorbachev fece ben poco per scoraggiare aperti dibattiti sui cambiamenti politici ed
economici. Infatti, anche solo trattenendosi dall’applicare la tradizionale pressione sovietica, in
pratica incoraggiò tali dibattiti (vedere Gorbachev, 1987, pp. 73-8; Palmer, 1990, pp. 6-13).
Nella GDR, Erich Honecker accolse favorevolmente gli sforzi di Gorbachev per un
rinnovamento della distensione Est-Ovest, ma disse che non c’era alcun bisogno di maggiori
aperture o di riforme economiche nella GDR (McAdams, 1988, p. 51). In seguito, Honecker
ammise che la nuova politica di Gorbachev era stata per i comunisti della Germania dell’Est una
grossa sorpresa. Diversamente dalle loro controparti dell’Europa dell’Est, Honecker e la
leadership del SED riaffermarono il loro “corso corretto”, sia passato che presente, e
apparentemente non sentivano alcun bisogno di riforme. Honecker insisté perché la GDR non
venisse obbligata ad adottare il modello sovietico, e che le fosse permesso di sviluppare il
socialismo “con i colori della GDR”. Il membro del SED Politburo, Kurt Hager, il principale
ideologo del partito, arrivò persino a dichiarare in un’intervista alla rivista della Germania
dell’ovest, Der Stern, che “una politica volta a imporre sulla Germania il sistema sovietico
sarebbe falsa; una tale politica non corrisponde alle attuali condizioni della Germania”. E,
riferendosi alla visione di Gorbachev di una Comune Casa Europea, Hager aggiunse con un
certo sarcasmo: “Se il tuo vicino decide di cambiare la tappezzeria in casa sua, ti sentiresti
obbligato a fare altrettanto?” (Der Stern, 9 aprile 1987).
Così l’autoisolamento della GDR aumentò. Dopo la demarcazione contro l’Ovest negli
anni Settanta e la delimitazione contro la Polonia nel 1980, il SED adesso si isolò persino dalla
stessa Unione Sovietica. Eppure, quel crescente isolamento della leadership contrastava
fortemente con la crescita politica della popolazione della GDR, soprattutto dei giovani, per i
quali Gorbachev non era una minaccia ma un simbolo di speranza. La perdita di contatto con la
sua stessa sfera interna da parte del SED, così come con il mondo circostante - inclusa l’Unione
Sovietica - sarebbe presto diventato uno dei fattori principali del suo tracollo, quando un
crescente numero di tedeschi dell’est cominciò a chiedersi su cosa si poteva ancora sperare.
291
L’impatto dell’“accerchiamento riformista” della GDR ad opera delle mosse crescenti
verso una più ampia democrazia e pluralismo nell’Europa dell’est, difficilmente potrebbero
venire enfatizzato. Incoraggiati dagli stessi tentativi di Gorbachev di una riforma interna, questi
Paesi furono liberi di muoversi verso direzioni del tutto nuove quando, durante la sua visita a
Praga nell’aprile del 1987, il ripudio di Gorbachev della Dottrina Brezhnev li liberò dal timore
di un intervento sovietico. Diversamente da Leonid Brezhnev, che nel 1968 aveva schiacciato i
moti di Praga con la forza militare, Gorbachev accettò l’idea di una diversità dichiarando:
“Siamo ben lontani dall’invitare gli altri a copiarci. Ogni Paese socialista ha le sue
specifiche caratteristiche, e i partiti fraterni determinano la loro linea politica in base alle
condizioni della loro nazione. (…) Nessuno ha il diritto di reclamare uno status speciale nel
mondo socialista. L’indipendenza di ogni partito, la sua responsabilità verso la propria gente e il
suo diritto di risolvere i problemi dello sviluppo del Paese in maniera del tutto sovrana sono per
noi principi incontestabili.” (Pravda, 11 aprile 1987)
Un nuovo confronto nell’aprile e maggio del 1988 tra gli operai in sciopero delle
acciaierie e dei cantieri navali e il regime del Generale Jaruzelski in Polonia, così come
l’espulsione di Janos Kadar in Ungheria, avvenuta il 9 maggio 1988, lasciarono ben presto
capire che le parole amichevoli di Gorbachev non erano rimaste inascoltate. Entro la fine del
1988 restava da vedersi solo per quanto tempo ancora la GDR sarebbe rimasta una tranquilla
isola di ortodossia in un mare turbolento di strutture politiche, economiche e ideologiche ormai
pronte al cambiamento.
2. L’implosione della GDR
All’inizio del 1989, al nervosismo della leadership della GDR sulle politiche di
Gorbachev della glasnost e della perestroika, e sui tentativi di riforme nell’Europa dell’Est, si
aggiunse il problema delle crescenti agitazioni nella stessa Germania dell’est. Comunque,
quando la situazione esplose, o piuttosto implose, nel 1989, l’improvviso scoppio di
insoddisfazione dimostrò con tutta la sua forza che la passata stabilità era stata una condizione
solo superficiale e che la sostanza della società della GDR da lungo tempo stava attraversando
drammatici cambiamenti che erano sfuggiti sia agli esperti dell’Ovest che ai politici dell’Est.
A parte le proteste e le dimostrazioni piuttosto spettacolari e decisamente visibili del
movimento pacifista, dei gruppi ambientalisti e di vari intellettuali, c’erano almeno altre due
espressioni di dissenso all’interno della società della GDR che, nel 1989, vibrarono un colpo
fatale al regime del SED: la questione degli Uebersiedler e il crescente flusso di rifugiati, così
come le dimostrazioni di massa che si intensificarono in un crescente numero di città della
Germania dell’Est.
Il problema dei rifugiati era già da tempo un argomento scottante. Ma quando il nuovo
governo ungherese decise il 2 maggio 1989 di aprire le sue frontiere con l’Austria, gli eventi
sfuggirono al controllo. Quando il SED Politburo si riunì, due giorni dopo, il 4 maggio, per un
normale incontro e il ministro della Difesa Heinz Kessler riferì l’“informazione ben fondata”
che aveva ricevuto dal suo addetto militare a Budapest, e cioè che il governo ungherese stava
riducendo le installazioni, anche se il controllo alla frontiera sarebbe continuato, i membri del
Politburo provarono un senso di sollievo e proseguirono con la loro riunione e la discussione dei
vari argomenti all’ordine del giorno sulle prospettive per l’industria del potassio nella GDR
(Cordt Schnibben, Der Spiegel, 16 aprile 1990). Gunter Schabowsky, un membro sia del
Comitato Centrale del Sed sia del Politburo, che era presente a quella riunione del 4 maggio, in
seguito si ricordò di essersi subito reso conto della “forza esplosiva” che lo smantellamento
ungherese della Cortina di Ferro avrebbe potuto avere per la Repubblica Democratica Tedesca
ma, come molti altri membri del Politburo, aveva preferito ignorare il suo presentimento poiché
la vivace spiegazione del generale Kessler gli aveva fornito un confortevole alibi
(Schabowski,1991, p.221)
292
Tuttavia 120.000 tedeschi dell’Est avevano già archiviato applicazioni d’uscita entro la
primavera del 1989 e l’apertura della cortina di ferro da parte dell’Ungheria il 2 maggio
incoraggiò immediatamente altri a fare lo stesso o - addirittura peggio alla vista del governo
della Repubblica Democratica Tedesca - presero un rotta diretta via Ungheria ed Austria verso
la Repubblica Federale.
Il 19 agosto circa 660 cittadini della Repubblica Democratica tedesca usarono un pic-nic
della PAN-EUROPEAN UNION vicino Sopron, al confine tra Ungheria e Austria, per la loro
spettacolare fuga ad occidente, mentre le guardie del confine ungherese guardavano
attentamente dall’altra parte e non intervennero. Nel Politburo della Sed, Gunter Mittang accusò
gli ungheresi di “tradimento al socialismo”. Un ministro deputato per gli affari esteri della
Repubblica Democratica Tedesca, mandato a Budapest come rappresentante del Sed “per
calmare le acque” tornò a mani vuote. Gli ungheresi non erano più sotto controllo e, inoltre,
apparentemente non avevano più intenzione di riguadagnarlo. La marcia su Budapest confermò
solo il peggio. L’emissario riportò che il ministro degli esteri ungherese Gyula Horn, era “la
forza trainante dietro lo sviluppo”, mentre i militari continuavano ad essere “fedeli alle
aspettative della Repubblica Democratica Tedesca”, ma non più uniti.
Honecker, perciò ordinò al suo ministro degli affari esteri, Oskar Fisher, di sondare
Mosca se un incontro sul Patto di Varsavia avrebbe potuto essere organizzato per disciplinare
gli Ungheresi. Ma Gorbachev declinò. Era passato il tempo in cui un distacco dalla linea
generale avrebbe potuto essere corretto da una pressione della maggioranza.
La repubblica democratica tedesca era sola. Entro un mese, il numero di Tedeschi
dell’Et che avevano attraversato l’Ungheria e l’Austria per passare alla Repubblica Federale salì
a più di venticinquemila. Il 10 Ottobre, il ministro per le relazione tra le due Germanie in Bonn
riportò che, durante i primi nove mesi del 1989, un totale di 110.000 tedeschi dell’Est si erano
ristabiliti nella Repubblica Federale, con o senza il consenso dell’autorità della Repubblica
Democratica Tedesca. Circa 32.500 residenti della Repubblica Democratica Tedesca si erano
registrati nei centri di accoglienza della Germania Occidentale nel solo settembre.
Tuttavia l’esodo dei cittadini della Repubblica Democratica Tedesca verso l’Occidente
fu solo un catalizzatore del cambiamento. Le dimostrazioni pubbliche contro il regime furono
potenti come il movimento dei rifugiati nel segnalare l’opposizione sempre crescente al regime
SED. Si erano tenuti regolarmente dimostrazioni il giorno sette di ogni mese a partire da giugno,
attirando l’attenzione sulle manipolazioni dell’elezioni locali il 7 Maggio. In aggiunta,
dimostrazioni settimanali di lunedì cominciarono a Leipzig lunedì 4 settembre, dopo che circa
1.200 persone si erano riunite a pregare per la pace nella Chiesa Nikolai e avevano cercato di
marciare verso Market Square nel centro della città, cantando richieste di libertà di spostamento
e il diritto all’assemblea. Entro i primi di ottobre le dimostrazioni del lunedì erano diventate una
tradizione consolidata e il punto focale dell’opposizione nella Repubblica Democratica Tedesca.
Il numero dei partecipanti era cresciuto a circa 5.000 il 25 settembre, e a 20.000 il 2 ottobre.
Incoraggiate dal successo ottenuto dalle dimostrazioni e dalla mancanza di reazione da
parte del governo, nacquero una serie di organizzazioni politiche: il 26 agosto fu fondata la SPD
nella DDR, il 10 settembre New Forum , il 12 settembre nacque Democrazia Ora ed il 14 fu la
volta di Il Risveglio Democratico (Neue Chronik, DDR, Vol. 12, pp. 18-20). La leadership del
SED ora si trovava a dover affrontare tanto il problema dei rifugiati quanto quello di un’
opposizione interna sempre più potente alimentata da dimostrazioni di massa e da gruppi
politicamente organizzati. Le celebrazioni per il 40° anniversario della DDR il 7 ottobre misero
in chiara evidenza la necessità di un cambiamento sostanziale quando Gorbachov, che era stato
invitato a presenziare ai festeggiamenti, utilizzò questa opportunità per dichiarare, durante un
incontro con il Politburo della SED a Niederschonhausen Castle, che il tempo a disposizione
stava terminando e che: “ Abbiamo una solo scelta: andare avanti risolutamente”. Secondo il
protocollo Gorbachov affermò testualmente:
293
“Credo che sia molto importante non mancare il momento giusto e non sprecare
un’opportunità. (...) Se restiamo indietro la vita ci punirà. (…)
Questo è il momento di decisioni importanti. Devono essere decisioni a lungo raggio,
devono essere ben ponderate per generare buoni frutti. Le nostre esperienze e quelle di Polonia
ed Ungheria ci hanno convinti: se il partito (comunista) non risponde alla vita, sarà condannato.
Abbiamo solo una scelta: andare avanti risolutamente, altrimenti saremo battuti dalla vita
stessa” (Berlino-Niederschonhausen, 7 Ottobre 1989, p. 99.
Per la DDR era in realtà già troppo tardi. Le dimissioni di Erich Honecker da Segretario
Generale del SED il 16 ottobre e la sua sostituzione da parte di Egon Krenz poterono alleviare
la tensione solo in minima parte. Il movimento dei rifugiati e le dimostrazioni di massa
proseguirono. Il 6 novembre 500.000 persone si riunirono a Lipsia, 60.000 ad Halle, 50.000 a
Karl-Marx Stadt (Dresda), 10.000 a Cottbus e 25.000 a Schierin. Il giorno seguente l’intero
governo della DDR si dimise e l’8 novembre anche il Politburo diede le dimissioni come
gruppo. Fu sostituito da una nuova leadership formata principalmente da elementi antiHonecker del regime precedente, tra i quali spiccavano Egon Krenz, Hans Modrow e Gunter
Schabowski. Modrow, infine, fu nominato nuovo primo ministro della DDR.
In questo quadro globale l’abbattimento del Muro di Berlino, avvenuta il 9 novembre,
sebbene drammatico e simbolico non fu null’altro che uno dei molteplici gradini in discesa
verso il declino ed il collasso finale della DDR (Krenz, 1990).
Ma la riunificazione della Germania,che era parsa sino ad allora una prospettiva lontana
da quando erano iniziati i fondamentali cambiamenti nell’Europa Orientale e nell’ unione
Sovietica,ora diventava una possibilità concreta quando gioia ed euforia furono espressi sul
muro di fronte alla porta di Brandeburgo.Ora tutto il mondo capiva che era in atto una
rivoluzione e che si stava creando una nuova consapevolezza nazionale del popolo
tedesco,anche se l’unificazione non era stata la richiesta principale dei milioni di persone le cui
dimostrazioni avevano messo in ginocchio la Germania orientale.
L’ex Segretario di Stato statunitense ,Henry Kissinger,indicò un futuro gia’
visibile,quando in un articolo di Newsweek del 4 Dicembre citò il ministro degli Esteri
austriaco del XIX secolo,Conte di Metternich, che aveva scritto:
“La politica è come una commedia in molti atti che si sviluppa inesorabilmente una
volta che il sipario si è alzato. Dichiarare quindi che la rappresentazione non andra’
avanti e’ un’assurdita’.La commedia sara’ portata a termine o dagli attori o dagli
spettatori che saliranno sul palcoscenico.”
E Kissinger aveva ragione: dopo che gli accordi della Guerra Fredda erano stati
indeboliti dall’allentamento della tensione fra gli stati e furono alla fine abbandonati dai”
leaders” dell’Europa dell’ Est e dell’Unione Sovietica,la RDT aveva poche possibilità di
sopravvivenza.Il nuovo Primo Ministro,Hans Modrow fu tra i primi a capire quanto fosse
difficile la situazione,particolarmente in termini economici.Nel Gennaio 1990 anticipò la data
delle elezioni generali da Maggio a Marzo,affermando che la RDT avrebbe potuto cessare di
esistere a Maggio.Il 1° Febbraio presento’ un piano per una confederazione delle due Germanie,
denominata”Per la Germania,Patria riunita”,(Modrow 1991.pp184-5).Alcuni giorni dopo,il 6
Febbraio,sollecito’ il governo federale di Bonn a pervenire ad una rapida soluzione per un
unione della moneta fra i due stati tedeschi,sapendo che se i tedeschi orientali non avessero
avuto il marco tedesco avrebbero tentato di ottenerlo.
Le proposte sorprendenti del capo di governo della Germania Orientale ,fatte nello
spazio di due settimane,chiarirono oltre ogni dubbio che la RDT non poteva piu’continuare ad
esistere.Il regime comunista aveva potuto sopravvivere soltanto come laboratorio dell’impero
sovietico.Ora ,circondato dagli stati riformisti dell’Europa Orientale, costretto ad aprire i confini
294
per permettere ai tedeschi orientali di viaggiare liberamente e a confrontarsi con Gorbachev al
Cremino,il regime comunista non aveva piu’ futuro.Semplicemente non era in grado di far
fronte alle realta’ di liberta’.Poteva soltanto arrendersi e permettere alla sua gente di unirsi alla
Repubblica Federale,come la maggior parte dei tedeschi orientali desiderava da 1945.
3. Il ruolo della Repubblica Federale
Fino alla fine del novembre 1989 il governo della Germania Occidentale era stato
molto cauto a non sfruttare o approfittarsi della delicata situazione che si era sviluppata nella
parte orientale del paese e che avrebbe potuto facilmente esplodere in maniera incontrollata. Nel
suo annuale Discorso alla nazione dell’8 novembre, un giorno prima dell’apertura del muro il
Cancelliere Kohl dichiarò che la Repubblica Federale era preparata a sostenere le riforme
implementate dalla nuova leadership della RDT.Invitò il regime comunista al governo della
RDT ad abbandonare il suo monopolio di potere , permettere partiti indipendenti e assicurare
libere elezioni. Bonn sarebbe stata disposta ,disse Kohl a discutere” una nuova dimensione di
assistenza economica” alla RDT,se ci fosse stata una riforma completa del sistema
economico,la rimozione della pianificazione economica burocratica e lo sviluppo di un libero
sistema di mercato.(Kohl,1989 a,pp.1058-9).
Anche dopo l’apertura del muro,in un altro discorso davanti al Bundestag il 16
novembre Kohl rimase scettico.Invece di indulgere all’euforia sulle possibilità di riunificazione
della Germania,egli semplicemente riportò i fatti dei recenti sviluppi interni in un’analisi sobria
e concisa e confermò che la Repubblica federale avrebbe “ naturalmente rispettato qualsiasi
decisione che il popolo della RDT avesse preso in libera autodeterminazione”
(Kohl,1989,b,p.1108).Tutti i membri del Parlamento,Verdi inclusi applaudirono.Alcune ore
dopo,comunque, l’Ambasciatore statunitense Vernon A.Walter disse ad alcuni funzionari di
Bonn:”Io credo nella riunificazione.Chiunque parli contro di essa sarà spazzato via
politicamente.” ( Teltschik,1991,pp32-3).Il giorno seguente il governo di Bonn ricevette il testo
di un discorso che Gorbachev aveva fatto davanti agli studenti di Mosca il 15 novembre che si
riferiva alla riunificazione.Infine il 21 novembre,Nikolai Portugalov,un esperto sovietico si
presentò in Cancelleria a Bonn e consegnò una nota manoscritta,frettolosamente tradotta in
tedesco,in cui il Governo Sovietico poneva domande precise sulla cooperazione fra i due stati
tedeschi e in particolare sulla riunificazione,sull’adesione della RDt alla Comunità Europea e
sull’ingresso nelle alleanze e sulla possibilità di un trattato di pace.In una conversazione con
Horst Teltschik,il consigliere di politica estera del Cancelliere ,Portugalov aggiunse”Come
potete vedere noi stiamo riflettendo attentamente sopra ogni aspetto della questione
tedesca,persino……..l’inimmaginabile”(ibid,pp.43-4).
Teltschik era naturalmente elettrizzato ,altrettanto il Governo della Germania
Occidentale.Evidentemente le considerazioni della leadership sovietica sulla riunificazione
tedesca avevano progredito molto più di quanto Bonn avesse fino ad allora supposto-anche
oltre quello che allo stesso governo federale fosse concesso di pensare. Così le risposte di
Teltschik alle domande sovietiche avevano dovuto mantenersi evasive e circospette. Ma
naturalmente, egli informò immediatamente il Cancelliere e organizzò un incontro che ebbe
luogo il 23 novembre in Cancelleria.Qui Kohl e i suoi consiglieri decisero di sviluppare una
strategia per il progetto di riunificazione,il famoso “Piano di dieci punti” che fu incorporato in
un discorso che Kohl avrebbe pronunciato al Bundestag il 28 novembre –non in un rilevante
Nuovo Appello sullo Stato della Nazione,ma all’interno di un dibattito programmato sul
bilancio.
La proposta di Kohl per una confederazione tedesca equivalse ad un grande
terremoto.Era la prima volta dagli anni sessanta che un cancelliere tedesco parlava in pubblico
della possibilità di riunificazione,dicendo che “ la riunificazione, la riacquisizione dell’unità
dello stato tedesco”rimaneva l’obiettivo politico del governo federale”(Kohl,1989c,pp.D7323).Riferendosi agli aspetti esterni del suo programma Kohl aggiunse:
295
“Il futuro della Germania è quello di adeguarsi alla futura costruzione dell’Europa
Unita. L’Occidente deve sostenere il processo di pace secondo il proprio concetto di un
ordine di pace permanente europeo.Si chiede alla Comunità Europea di avvicinare gli
stati riformisti dell’Europa centrale,orientale e meridionale con flessibilità e
disponibilità.Questo naturalmente include la RDT.Il governo federale perciò approva la
rapida conclusione di un accordo commerciale e di cooperazione con la RDT. Questo
potrebbe allargarsi e assicurare l’entrata della RDT nel mercato comune,prospettive del
1992 incluse.”(ibid.,pD733).
Ovviamente il Cancelliere continuò ad essere cauto,cercando di evitare qualsiasi cosa
che potesse ulteriormente destabilizzare il già traballante equilibrio politico dell’Europa
centrale. La sua idea prefigurava soltanto cambiamenti a lungo termine e mirava a creare una
struttura europea per ogni fase verso l’unificazione tedesca.Ma quando visitò la RDT tre
settimane dopo e si presentò alla folla davanti alle rovine della Frauenkirche(la chiesa delle
donne) a Dresda il 19 dicembre, si rese conto velocemente che i tedeschi orientali non volevano
un cambiamento a lungo termine,ma immediato,che il tempo si stava esaurendo in fretta e che
soltanto la riunificazione tedesca avrebbe soddisfatto le richiesta dei tedeschi orientali.Infatti i
partecipanti alle regolari dimostrazioni del lunedì avevano già cambiato i loro slogan da”Noi
siamo il popolo”in”Noi siamo una nazione” nei primi giorni di dicembre. Kohl stesso che era
stato influenzato dalle emozioni a Dresda,concluse il suo discorso proclamando:” Dio benedica
la madrepatria tedesca.”(Kohl,1989 d,p.1262)
Successivamente,la proposta del Primo Ministro Modrow”Per la Germania, patria
unita” e la sua richiesta di un'unica moneta furono accolte dal governo di Bonn come passi
nella giusta direzione.
Tuttavia il Cancelliere Kohl non era più disposto a rispettare un governo che non era
stato eletto liberamente dai tedeschi orientali e decise di aspettare il risultato delle elezioni
parlamentari del 18 marzo 1990 prima di continuare le trattative con la RDT. Egli fu
soddisfatto quando L’Unione Cristiano Democratica della Germania est sotto la guida di Lothar
de Maizière,con il 48.1% dei voti riportò una vittoria a valanga sul Partito Socialdemocratico
tedesco che ricevette soltanto il 21.8% e sui movimenti dei cittadini che riportarono un
deludente 2.9%.
In realtà fu una vittoria di Kohl che aveva dato ai tedeschi orientali l’impressione che il
suo governo e il suo partito a differenza di molti appartenenti all’opposizione
socialdemocratica,erano inclini a tener fede alle decennali promesse di solidarietà nei confronti
dei loro concittadini dell’est. Al contrario il Primo Ministro della regione dello SAAR Oskar
Lafontaine nominato il 19 marzo dal comitato esecutivo del PSD (SPD) come candidato del
partito alla carica di cancelliere nell’elezione del Bundestag indette per il 2 dicembre 1990,
aveva ripetutamente fatto appello ad una “cauta transizione “ verso una moneta unica con la
RDT(GDR) che richiedeva una “ attenta preparazione” indicando così di essere contrario alla
corsa verso l’unificazione.(Frankfurter Rundschau,20 marzo 1990).
Tuttavia era la strategia di Kohl non quella di Lafontaine che stava per prevalere.
L’annuncio dell’ultima ora del cancelliere,soltanto cinque giorni prima dell’elezione di :una
conversione 1:1 dei depositi di risparmio si rivelò cruciale nel sovvertire il risultato previsto del
voto. Kohl fece pesare la sua autorità e il potere finanziario della Repubblica Federale per
aiutare il proprio partito a vincere le elezioni.Il risultato fu un forte richiamo ad una rapida
riunificazione e ad una economia di mercato, così come l’indicazione delle promesse persuasive
di Kohl , del Partito Cristiano Democratico e dei colleghi dell’Unione Socialista cristiana(
CSU) che avevano detto ai tedeschi dell’est che soltanto i conservatori cristiani avrebbero
potuto fornire il denaro necessario per far rifiorire la sofferente economia del paese e creare
una Germania unificata senza inutili ritardi. Infatti, l’ampio consenso per il Partito Cristiano
democratico(CDU) o più precisamente per i partiti sostenuti dal governo di Bonn e dal
cancelliere Kohl fu”in realtà una sentenza di morte per la RDT che veniva rapidamente
296
assorbita dalla grande e ricca Germania Occidentale”, annotava Serge Schmemann (New York
Times 19 marzo 1990,p.A1).
In breve:” Kohl si fece avanti all’ultimo momento, soltanto dopo che la RTD era finita
sia politicamente che economicamente,ma quando lo fece, lo fece con grande efficacia. Sarebbe
ingiusto dire che la Repubblica Federale abbia spinto verso il processo di riunificazione in
modo aggressivo o prematuro,prima che il popolo della Germania dell’est l’avesse accettato.
Ma una volta che la decisione fu presa- dal governo Modrow e dall’elettorato del 18 marzo- il
cancelliere Kohl non esitò a prendere la guida e condurre il processo di unificazione nella
direzione da lui voluta.
4. Conseguenze dell’unita’ tedesca
La storia del Reich fin dal 1871 sembrava provare che una Germania unita era
semplicemente troppo grande e dinamica per qualsiasi sistema statale stabile europeo e che la
tendenza tedesca ad una aggressività politica non fosse semplicemente l’espressione del
legittimo perseguimento di interessi nazionali tedeschi,ma anche un segno riprovevole del
carattere proprio della nazione tedesca. Ricordando settantaquattro anni di unità tedesca,due
guerre mondiali,il nazismo e 65 milioni di persone uccise o dalla guerra o nei campi di
concentramento,si disse che il potere politico,economico e militare della Germania minacciasse
inevitabilmente l’indipendenza e il benessere dei suoi vicini e che il carattere tedesco avesse
reso la Germania non solo aggressiva all’estero ma anche incline al totalitarismo in patria.
Dopo la Seconda Guerra Mondiale,la divisione della Germania e l’egemonia sovieticoamericana sull’Europa sembrava aver risolto il cosiddetto problema tedesco. Dividendo e
contenendo il potere e l’ambizione tedeschi,tenendo a freno cosi’ la minaccia tedesca e al sicuro
il popolo tedesco da se stesso,si pensava che l’Europa e il mondo fossero al sicuro dai tedeschi
una volta per tutte. I ricordi del Reich storico sbiadirono ,e l’idea della riunificazione tedesca fu
oscurata dall’integrazione progressiva delle due ex entità tedesche nelle loro rispettive alleanze
e dallo sviluppo delle relazioni fra i due stati. La nuova Ostpolitik di Willy Brandt condusse alle
normali relazioni di buon vicinato di cui si parla nel trattato di base fra la Repubblica Federale e
la RDT del 1972. La Germania e i tedeschi non sembravano più essere una minaccia all’ordine
internazionale,e il mondo si abituò alla realtà di una Germania divisa.
Ora,dopo il 1989, la Germania è nuovamente unita.Anche se la storia tende a non
ripetersi,sorge la domanda su quali potrebbero essere le conseguenze.
Alla luce dei drammatici cambiamenti in corso dal 1989,l’intero assetto
politico,economico,sociale e militare viene preso in esame.Mentre la parte orientale del
continente ha alla fine ristabilito i suoi legami con l’Occidente,l’Europa nel suo insieme sta
tentando di trovare una nuova identità,riabilitare il suo passato,definire i suoi confini e
sviluppare nuove strategie e strumenti per un futuro migliore.In altre parole,la fine della Guerra
Fredda non è”la fine della storia”,come suggeriva in un articolo Francis Fukuyama. E’ vero
l’opposto:l’unificazione della Germania,la liberazione dell’Europa Orientale dal comunismo di
stampo sovietico e il collasso dell’Unione Sovietica hanno scritto un nuovo capitolo nei libri
della storia europea.
Il ruolo della Germania all’interno di questo processo di ristrutturazione dell’Europa è
ancora molto in discussione. Molto tempo prima che l’unificazione della Germania diventasse
una realtà,in un incontro del Forum dei Diritti Umani della Conferenza sulla Sicurezza e
Cooperazione in Europa (CSCE) il 5 Giugno 1590 a Copenhagen,il Ministro degli Esteri della
Germania Occidentale,Hans-Dietrich Genscher,dichiarò che il governo federale
desiderava”rendere il destino della Germania parte del destino d’Europa. Genscher citò anche
l’affermazione di Thomas Mann ”noi vogliamo una Germania europea e non un’Europa tedesca
“. Il giorno dell’unificazione,il 3 Ottobre 1990 ,il Cancelliere Kohl confermò nel suo
“Messaggio a tutti i governi del mondo “che la Germania con la sua ritrovata unità nazionale
297
voleva “servire la pace nel mondo e promuovere l’integrazione dell’Europa”. E il Presidente
Richard von Weizsaecher affermò , durante la cerimonia di stato del Giorno dell’Unità alla
Filarmonica di Berlino, che l’unificazione tedesca era”parte di un processo storico pan-europeo
che mirava alla libertà di tutte le persone e ad un nuovo ordine di pace sul nostro continente”.
La percezione di una Germania post- unificazione saldamente ancorata alla stabile
struttura di un “pan-europeismo” era certamente lo scenario più favorito sia fra i tedeschi che i
non tedeschi. La domanda se uno scenario di una riduzione nelle tensioni fra gli interessi
nazionali aumentasse l’integrazione europea e il fiorire della libertà e della democrazia, era,
comunque,realistica.
D’altra parte la seconda percezione della Germania dopo l’unificazione che prevedeva
un ritorno ad insorgenze nazionalistiche in patria e ad una politica di stampo bismarchiano
all’estero,aveva i suoi lati negativi: la Germania si sarebbe davvero allontanata dall’Occidente
avendo riscoperto gli antichi legami con la Russia e l’Est?Avrebbe seriamente cercato di
ricoprire ancora il vecchio ruolo di mediatrice fra Est e Ovest o contrapporre l’Est e l’Ovest per
il proprio vantaggio? Avrebbe potuto dimentica re le tragiche lezioni della storia tedesca ed
europea del XIX e XX secolo?Avrebbe potuto ripetere gli errori del passato?
La Germania Unita si trova nel centro d’Europa e non può sfuggire agli effetti della
trasformazione dell’ordine europeo dopo il1989-90.Dovrà contribuire a rendere possibile la
transizione dell’Europa orientale e sud-orientale da sistemi dittatoriali repressivi e da economie
a pianificazione statale in democrazie pluralistiche e in economie di libero mercato. Perciò la
Germania non potrà più procedere al riparo delle politiche mondiali,come nel caso dei quarant’
anni di predominio sovietico –americano. Le viene richiesto ora di ricercare e trovarsi un nuovo
ruolo quasi in ogni settore.
Ora sembra plausibile che il futuro della Germania difficilmente sarà caratterizzato da
un ritorno a modelli del passato. L’esercizio di equilibrio politico che il Reich tedesco compì
durante il periodo guglielmino sotto il Cancelliere Bismarck e i suoi successori fra il 1871 e il
1918, e durante la Repubblica di Weimar- escluso il corso nazionalsocialista sotto Hitler- non
era né ragionevole né possibile nello scenario internazionale alle soglie del XXI secolo.Mentre
l’unificazione del Reich nel 1871 aveva portato all’isolamento per tutta la fine del XIX secolo e
agli inizi del XX secolo con risultati disastrosi,l’unificazione della Germania nel 1990 fu
raggiunta sulla base di stabili e continui legami istituzionali con l’Occidente e con l’accettazione
dei paesi confinanti. Mentre il Reich precedente era stato creato dalla guerra ed era vissuto –
e/o in qualche modo poteva essere stato costretto a vivere – in opposizione all’ordine esistente
con dispute sui confini e contrasti sui divergenti interessi nazionali,la Germania unita del 1990
non solo rinunciava a qualsiasi pretesa storica o legale sugli ex territori tedeschi ,ma era stata
creata tramite negoziati nella fase “ due più quattro” e dalla sua istituzione veniva ad essere
parte integrale della comunità internazionale.
Il mantenimento dei legami con le istituzioni multilaterali non era soltanto una
convinzione,comunque,ma anche
qualcosa che riguardava l’interesse nazionale.Sia una
politica incerta “Shauelpolitik” fra l’Est e l’Ovest ,sia il tentativo di stabilire una posizione di
egemonia si erano dimostrati errori fatali.Lo stretto legame della Repubblica Federale con
l’Occidente dopo la Seconda Guerra Mondiale,d’altra parte, aveva favorito la prosperità
economica e la stabilità politica.Un cambiamento di corso ed un ritorno ad una politica
nazionalistica al di fuori di istituzioni consolidate erano così altamente improbabiliassolutamente fuori questione.
L’idea di ringiovanire la “Reichsgedanke” trasformando la Repubblica Federale in un
quarto Reich dopo l’unificazione rimase il sogno di pochi.Il sorgere di un nazionalismo in
Germania - così come
nella maggior parte degli altri paesi europei agli inizi degli anni
90,specialmente all’Est- non fu in realtà il risultato di una nuova affascinante ideologia o
l’espressione di un segreto desiderio di una grande parte del popolo,ma il risultato del collasso
298
del comunismo e un effetto di un disordine sociale ed economico come conseguenza della
rivoluzione del 1989.
Infatti, l’”europeizzazione” della questione tedesca prevalse.Non solo aiutò a rendere
l’unificazione della Germania più chiara agli stati confinanti,ma attenuò anche le difficoltà di
venire a patti con il passato,sia nazista sia della polizia segreta orientale(Stasi)siccome il
dibattito sull’unicità del terrore nazista,paragonato per esempio ai crimini dello stalinismo,fu ora
seguito da penose rivelazioni e da un acceso dibattito interno sui meccanismi e sulle pratiche
della polizia segreta della Germania orientale.
La dimensione europea dell’unificazione tedesca fu sottolineata dal ministro degli esteri
Hans –Dietrich Genscher,all’inizio della prima conferenza due- più- quattro di Bonn il 5
maggio 1990, quando sostenne che ,piuttosto di creare problemi all’Europa, l’unificazione della
Germania avrebbe avuto” un ruolo nell’assicurare una nuova e duratura stabilità”.Inoltre,
Genscher aggiunse, che il governo tedesco considerava
“ la trasformazione di questa percezione della storia europea in una politica per la
Germania e per un’Europa gradualmente unita essere la missione europea della
Germania mentre ci avviciniamo alla fine di questo secolo.”
Quella missione non è cambiata e si espresse adeguatamente
dell’Unione Europea che avvenne il 1 maggio 2004.
299
nell’allargamento
Bibliografia pp.366/367/368
300
39. Il manifestarsi delle differenze nazionali, 1989 – 1992: la divisione
della Cecoslovacchia
Sfondo storico circa la questione Slovacca
La Cecoslovacchia nasce il 28 Ottobre 1918 come conseguenza della Prima Guerra
Mondiale: L’unione dei Cechi con gli Slovacchi fu attuata in base alla similarità delle loro due
lingue.
Il ceco e lo slovacco sono infatti così correlate da risultare reciprocamente
comprensibili.. Questo fatto aveva portato già nel XIX secolo, soprattutto da parte ceca, alla
conclusione che cechi e slovacchi erano soltanto i due rami di una unica nazione
“Cecoslovacca”.
Lo stato cecoslovacco fu salutato favorevolmente sia dai cechi sia dagli slovacchi:
tuttavia essi non intendevano questa unità nazionale nello stesso modo. Infatti, mentre per i
cechi il nuovo stato era solo un ristabilimento del regno medioevale di Boemia allargato ad est,
per la maggior parte degli slovacchi il nuovo stato era piuttosto l’unione di due nazionalità
inquadrate in una unica struttura nella forma di una federazione di entità autonome.
Il fatto più importante era che gli Slovacchi possedevano una propria coscienza
nazionale e non si considerarono mai né cechi, né cecoslovacchi.
Nel periodo 1918 – 1938 la Slovacchia fu soltanto una unità amministrativa all’interno
della Cecoslovacchia, senza alcun speciale statuto di entità autonoma. I movimenti autonomisti
erano comunque forti ed ebbero finalmente successo il 6 Ottobre 1938 come conseguenza
dell’indebolimento dello stato dopo il “diktat” di Monaco.
Sei mesi dopo la Cecoslovacchia cessò di esistere quando la restante parte della Boemia
e la Moravia furono annesse al Reich tedesco; al contempo la Slovacchia fu proclamata
formalmente indipendente sotto la protezione della Germania.
La Cecoslovacchia fu ricostituita nel 1945 e la Slovacchia divenne nuovamente una
entità autonoma; la sua autonomia fu tuttavia gradualmente ridotta, dapprima nel 1946, ed
ulteriormente a seguito del golpe militare comunista del 1948. La nuova costituzione
“Socialista” ridusse l’autonomia della Slovacchia praticamente a zero ( Rychlik, pp. 180 – 200).
Le richieste slovacche per una federazione furono formalmente accettate come parte
della “Primavera di Praga” , il movimento riformista cecoslovacco del 1968.
La Legge Costituzionale No. 143/1968 del 27 Ottobre 1968 ( “Atto Federativo
Cecoslovacco”) istituì sul territorio della precedente Repubblica Socialista Cecoslovacca due
“nuovi” stati nazionali: la Repubblica Socialista Ceca e la Repubblica Socialista Slovacca.
Entrambe le repubbliche erano dotate di un proprio sistema legislativo ed esecutivo:
c’erano pertanto il Parlamento Ceco ( denominato Česká národní rada – ČNR, ossia “Congresso
Nazionale Ceco”) ed il Parlamento Slovacco ( denominato Slovenská národná rada - SNR,
ossia “ Congresso Nazionale Slovacco”) così come anche un Governo Ceco ed un Governo
Slovacco. (Questi parlamenti e governi furono denominati entità nazionali, mentre le autorità
che governavano la Federazione avevano la denominazione di entità federali ).
Secondo il preambolo dell’ “Atto della Federazione Cecoslovacca” entrambe le
repubbliche, sia la Ceca, sia la Slovacca, risultavano teoricamente due stati totalmente sovrani
che delegavano spontaneamente parte della loro sovranità ad organi federali: l’Assemblea
301
Federale ed il Governo Federale. Il Governo Federale poteva prendere decisioni soltanto in un
ambito strettamente definito.
L’Assemblea Federale si articolava su due Camere: la Camera del Popolo e la Camera
delle Nazioni. La Camera del Popolo veniva eletta sulla base della rappresentatività
proporzionale in tutto il paese,. cosicché la Repubblica Ceca (avendo una popolazione più
numerosa) aveva un numero di deputati maggiore della Repubblica Slovacca.
La camera delle nazioni aveva invece lo stesso numero di rappresentanti: ogni
repubblica eleggeva 75 deputati.
La promulgazione delle leggi richiedeva la maggioranza in entrambe le camere, mentre
per la promulgazione di leggi costituzionali era necessaria una maggioranza di almeno i tre
quinti in entrambe le camere. Il sistema costituzionale prevedeva un unica e specifica norma
speciale: il cosiddetto “veto di minoranza” ( zázak majorizace ),
I deputati cechi e slovacchi alla Camera delle Nazioni votavano separatamente. Tutte le
leggi costituzionali e molte altre mozioni richiedevano una maggioranza (una maggioranza
qualificata per le leggi costituzionali) sia da parte dei deputati cechi sia dei deputati slovacchi.
La maggioranza (o la maggioranza qualificata) di entrambe le parti della camera veniva
sempre calcolata sulla base dei 75 deputati, quindi non solo di quelli effettivamente presenti in
aula al momento del voto.
Il veto di minoranza significava che i deputati cechi non potevano “prevaricare” i voti
della rappresentanza slovacca. D’altra parte risultava anche che 31 deputati, eletti nella Camera
delle Nazioni in una singola Repubblica, potevano bloccare qualsiasi legge o qualsiasi
deliberazione laddove era richiesta la maggioranza qualificata dei tre quinti (ad esempio
l’elezione del Presidente).
Il altri termini, la Federazione Cecoslovacca era basata sul principio del consenso delle
rappresentanze ceca e slovacca: tuttavia, se non si raggiungeva tale consenso, non vi era alcuna
soluzione costituzionale e nessuna altra vis d’uscita.
Il passaggio della legge costituzionale relativa alla federazione avviene dopo
l’occupazione sovietica della Cecoslovacchia dell’Agosto 1968. Essa divenne effettiva il 1°
Gennaio 1969 in presenza della cosiddetta “normalizzazione”, cioè contestualmente alla
graduale eliminazione delle riforme democratiche della primavera del ’68 ed alla restaurazione
della dittatura comunista.
Il 17 Aprile 1969 Gustáv Husák,il comunista slovacco padre della federazione e protetto
da Mosca sostituì A. Dubček (anche lui slovacco). Egli eliminò presto ciò che rimaneva del
movimento riformista del 1968. La federazione non fu abolita ma in realtà negli anni 19691989 la struttura federale ebbe una rilevanza minima.
Dal Dicembre 1970 una serie di leggi limitò seriamente le prerogative delle repubbliche
in favore della Federazione (vedi Legge Costituzionale No. 125/1970).
I parlamenti federali Ceco e Slovacco non avevano alcuna rilevanza, né l’avevano le
elezioni in cui gli elettori avevano la “scelta “ di un unico candidato.
Così come i parlamenti anche i governi (federale e statale) erano mere cinture di
trasmissione per il Partito Comunista Cecoslovacco. Il Partito Comunista non era di tipo
federale: ciò significava che le decisioni politiche erano prese a Praga.
Per tutte queste ragioni la federazione ebbe uno strano impatto sulle relazioni CecoSlovacche.
302
I Cechi vedevano la federazione solo come una processione senza fine di funzionari
slovacchi ai ministeri federali e come un trasferimento di risorse dal bilancio federale alla
Slovacchia.
Gli Slovacchi erano altrettanto insoddisfatti dei Cechi poiché la federazione non
soddisfaceva le loro aspettative. Gli Slovacchi volevano che le questioni slovacche fossero
decise a Bratislava, non a Praga. Si aspettavano anche che la federazione desse alla Slovacchia
maggiore visibilità sullo scenario mondiale.
Nessuna di queste aspettative si realizzò. Il mondo esterno continuò a vedere la
Cecoslovacchia come uno stato ceco, infatti gli aggettivi ceco e cecoslovacco erano spesso
intercambiabili nelle lingue straniere.
La Rivoluzione di Velluto e la questione slovacca
La caduta del regime comunista in Cecoslovacchia (17 Novembre 1989) riaprì la
questione delle relazioni ceco-slovacche, un problema con cui la Cecoslovacchia aveva dovuto
confrontarsi dal momento della sua costituzione nel 1918. Nel Novembre 1989 vennero fondate
due diverse organizzazioni: Il Popolo Contro la Violenza (VPN) in Slovacchia ed il Civic
Forum (OF) nelle regioni ceche.
Ci furono anche tentativi di fondare dei Civic Forums in quelle aree in cui i cittadini
possedevano tradizionalmente forti sentimenti pro-Cecoslovacchia, specialmente nel Košice
(centro amministrativo della Slovacchia orientale), ma essi non sopravvissero e furono in
seguito inglobati nel VPN.
OF e VPN stipularono un accordo secondo il quale ciascun movimento sarebbe stato
responsabile dei cambiamenti democratici nella “propria” repubblica e che essi avrebbero
soltanto coordinato la loro politica. Per questo motivo l’OF si focalizzò sui cambiamenti nel
governo federale mentre il VPN si concentrò sul governo nazionale slovacco. E’ significativo il
fatto che il governo nazionale ceco non era a questo punto la principale preoccupazione dell’OF.
Dopo il Novembre 1989, la sovranità della Slovacchia era un punto della piattaforma
politica di ogni partito politico in Slovacchia; le differenze fra di essi riguardavano solo il grado
di autonomia che essi richiedevano per la Slovacchia. A questo proposito il VPN e il Partito
Democratico erano partiti moderati che sostenevano la modifica della già esistente Federazione
Cecoslovacca, mentre il Partito Democratico Cristiano (KDH), guidato dall’ex cattolico
dissidente Jan Čarnogursky, aveva propositi più radicali. Il più radicale a questo proposito era il
Partito Nazionale Slovacco (SNS) di Vit’azoslav Moric e Jozef Prokeš, che proponeva una
connessione Ceco-Slovacca non troppo vincolante.
Sia nel KDH che nello SNS c’erano molti sostenitori di uno stato slovacco
indipendente, ma nella prima metà del 1990 persino l’SNS non aveva ancora formalmente
avanzato questa richiesta.
Nel frattempo i comunisti cechi e slovacchi prendevano gradualmente strade diverse ed
era nato un Partito Comunista Slovacco indipendente (KSS), in seguito Partito della Sinistra
Democratica (SDL), la cui adesione al programma nazionale slovacco testimoniava che i
comunisti slovacchi erano ben inseriti nel nuovo scenario politico.
La Guerra del “Trattino di Congiunzione” e la nuova divisione del potere
All’inizio del 1990 il primo palese conflitto Ceco-Slovacco ebbe luogo nel Parlamento
Federale.
303
A seguito dei cambiamenti politici e socio-economici che si erano verificati dal
Novembre 1989 il giorno 23 Gennaio 1990 il Presidente Václav Havel propose che il nome
ufficiale di “Repubblica Sociale Cecoslovacca” venisse mutato ufficialmente, a far data dal
1960, in “Repubblica Cecoslovacca.”.
Alexsander Dubček, nuovo presidente dell’Assemblea Federale, accettò la proposta
come iniziativa presidenziale e, secondo quanto stabilito nella Costituzione e nell’Atto di
Confederazione del 1968, lo inviò ai comitati dell’Assemblea Federale ed all’esame di
entrambi i consigli nazionali.
Il Consiglio Nazionale Slovacco si oppose al cambiamento richiedendo a sua volta che
il nuovo stato fosse chiamato “Federazione Ceco-Slovacca”: in questo modo il mondo avrebbe
compreso che la Cecoslovacchia non era un formata da un solo stato bensì da due.
Questa proposta fu sostenuta da una forte maggioranza della popolazione slovacca, ma
fu respinta dalle regioni ceche. Per i cechi il nome “Cecoslovacchia” evocava gli amari ricordi
del periodo della post-Monaco (o Seconda) Repubblica durante il quale tempo tale era stata la
denominazione ufficiale del paese.
La maggior parte dei cechi non capivano perché il trattino di congiunzione fosse così
importante per gli Slovacchi. Il 29 Marzo 1990, dopo lunghe discussioni, l’Assemblea Federale
approvò la Legge Costituzionale No. 81/1990.
Il nuovo nome, considerato essere un compromesso, stabilì le due seguenti forme
ufficiali: “Repubblica Federale Cecoslovacca” in lingua ceca e “Repubblica Federale Cecoslovacca“ in lingua slovacca.
Tuttavia questo compromesso non soddisfaceva gli slovacchi perchè non mostrava al
mondo esterno l’esistenza degli slovacchi ( era infatti chiaro che la versione slovacca sarebbe
stata usata soltanto in Slovacchia). Ci furono immediatamente dimostrazioni in Slovacchia e,
per la prima volta, comparvero slogan a favore di una Slovacchia indipendente. Il VPN aveva
accettato il nuovo nome durante le delibere dell’assemblea federale, così ora gli slovacchi che
erano contrari accusavano il partito di tradimento degli interessi nazionali slovacchi.
Alla fine i deputati cechi dell’Assemblea federale cedettero. Il 20 Aprile 1990 un’altra
legge costituzionale (101/1990) proclamò il nome ufficiale di Repubblica Federativa Ceca e
Slovacca ( “ČSFR” in entrambe le lingue).
Il nome non ufficiale, Cecoslovacchia, e l’aggettivo “cecoslovacco” sarebbero stati
scritti in una sola parola in ceco ma con un trattino di congiunzione in slovacco.
La cosiddetta guerra dl trattino di congiunzione (“hyphen”) indicò che le successive
discussioni non sarebbero state semplici e che la parte slovacca avrebbe proposto una
federazione il meno vincolante possibile.
Le prime libere elezioni si tennero l’8 e il 9 giugno1990. Le elezioni si basavano sul
principio della rappresentanza proporzionale ma i partiti che non avessero ottenuto almeno il
5% dei voti (3% nelle elezioni del parlamento slovacco) non avrebbero avuto seggi in
parlamento.
In Slovacchia il VPN vinse con il 29%, seguito dal KDH’s con il 19.2 %, dal SNS’s con
il 13.9%, dal KSS-SDL’S con il 13,3% e dalla Coalizione Ungherese con l’8,7%. Il Partito
Democratico e il Partito Ambientalista dei Verdi (SZ) entrarono a far parte non solo del
Consiglio nazionale Slovacco ma anche dell’Assemblea Federale.
304
Nella Repubblica Ceca vinsero il Civic Forum ed il Partito Popolare (ČSL, di fatto il
Partito Cattolico), che aderì alla coalizione unitamente al piccolo Partito Cristiano Democratico
(KDS). Inoltre ottennero seggi in parlamento anche il Partito Comunista, il Movimento per
l’Autogoverno della Democrazia; ebbe pure seggi in parlamento l’Associazione per la Moravia
e la Slesia (HSD-SMS) che proponevano una federazione a tre soggetti tra Boemia, Moravia e
Slovacchia .
Il nuovo governo federale era costituito da una coalizione fra VPN e Civic Forum con il
supporto dei partiti di centro–destra ceco e slovacco (la coalizione di ČSL-KDS e KDH) ed era
guidato da Marian. Čalfa del VPN, che era già stato primo ministro nel precedente governo
federale.
Il governo ceco era nuovamente guidato da Petr Pithart ma la guida del governo
slovacco cambiò : Milan Čič fu sostituito dall’ex ministro degli interni slovacco, Vladimir
Mečiar ( VPN).
I negoziati fra i governi non ne furono condizionati e continuarono. Ci furono anche
negoziati fra il presidente del Consiglio Nazionale Slovacco František Mikloško (VPN, ma
KDH dopo il 1992) e la sua controparte nella Repubblica Ceca, Dagmar Burešová e i loro
vicepresidenti.
Negoziati ufficiali fra i governi ceco e slovacco avvennero l’8 - 9 Agosto 1990 a
Trenčiaské Teplice. Continuarono il 10 e l’11 Settembre a Piešt’any, il 27 settembre a Kroměřìž
e il 28 ottobre a Slavkov, dove partecipò anche il presidente Havel .Il 5 novembre 1990 le
relazioni ceco-slovacche furono l’argomento dei negoziati fra i primi ministri di tutti tre i
governi. Quattro giorni dopo, Pithart e Mečiar si incontrarono ancora a Luhačovice.
Poiché un accordo sostanziale si rivelò impossibile, i rappresentanti dei partiti di
governo, con il Presidente Havel e i rappresentanti di tutti tre i governi, il 28 Ottobre 1990
emisero una dichiarazione che enfatizzava la loro volontà di mantenere la ČSFR.
Le parti ceca e slovacca concordarono che sarebbe stata riconsiderata la divisione dei
poteri e di conseguenza si sarebbe trovata una soluzione definitiva. la formulazione finale della
divisione dei poteri avvenne alla presenza del Presidente Havel e dei tre premiers al castello di
Praga il 12 novembre 1990. La proposta venne poi valutata dai Consigli Nazionali e passata
all’Assemblea Federale.
Nella versione della legge sulla divisione dei poteri presentata all’Assemblea Federale,
il Consiglio Nazionale ed il Governo Ceco proposero numerosi cambiamenti (alla proposta del
12 novembre 1990).
In questo contesto il praesidium allargato del governo slovacco, guidato da Mečiar,
giunse improvvisamente a Praga il 6 dicembre 1990. Mečiar presentò un ultimatum a Pithart:se
la legge sulla divisione dei poteri non fosse stata adottata nella sua versione originale, cioè se il
Consiglio nazionale Ceco o l’Assemblea Federale avessero modificato la bozza di stesura della
legge, il Consiglio Nazionale Slovacco avrebbe dichiarato la supremazia delle leggi slovacche
sulle leggi della federazione. Questo avrebbe significato di fatto la paralisi e la disgregazione
della Repubblica Federale Cecoslovacca. La parte slovacca enfatizzò inoltre che l’Assemblea
Federale non aveva titolo per interferire nei negoziati Ceco-Slovacchi.
I partiti del governo ceco, specialmente il Civic Forum, diedero istruzioni ai propri
deputati di votare la versione originale della legge che fu adottata il 12 Dicembre come
emendamento costituzionale 556/1990.
La nuova legge della divisione dei poteri riduceva in modo significativo il potere degli
organi centrali (federali). In contrasto con l’emendamento costituzionale del 1968, che sanciva
305
la Federazione, questa legge eliminava la prerogativa esclusiva della Federazione in politica
estera e per la difesa, la qual cosa avrebbe consentito la possibilità futura di stipulare trattati
internazionali separati, ed inoltre anche la possibilità di costituire forze armate facenti capo ad
ogni singola repubblica.
Questa legge non rimuoveva comunque il nocciolo del problema e rappresentava perciò
soltanto un compromesso temporaneo.
Mentre i cechi consideravano l’emendamento come la loro massima concessione per gli
slovacchi rappresentava soltanto il primo passo verso il conseguimento del loro scopo finale: il
raggiungimento di una organizzazione o di una Confederazione Ceco-Slovacca molto aperta per
mezzo della quale la Slovacchia potesse raccogliere i benefici del proprio riconoscimento di
stato a pieno titolo, mantenendo peraltro tutti i vantaggi di uno stato comunitario.
I Negoziati Ceco-Slovacchi del 1991/1992
Nel 1991, il mutato paesaggio politico nella Repubblica Ceca e nella Repubblica
Slovacca trasformò l’atmosfera dei negoziati. Il 24 Febbraio 1991 il Civic Forum si frantumò
nel movimento di centro-destra di Václav Klaus’s (Partito Civico Democratico – ODS) e nel
movimento di centro-sinistra di Jiři Dienstbier’s (Movimento Civico – OH). Subito dopo le
elezioni del Giugno 1990 il Partito Nazionale Slovacco dichiarò che il suo scopo finale era la
completa indipendenza della Slovacchia: Nello stesso periodo sorsero diversi partiti minori e
movimenti che evocavano apertamente le tradizioni dello stato totalitario Slovacco del 19391945.e del Partito Autonomista Popolare del periodo bellico. Il 3 Marzo 1991 la lotta tra
Vladimír Mečiar e la leadership del VPN, soprattutto con Fedor Gál, il rappresentante della sua
ala liberale, causò una crisi acuta all’interno del VPN.
Sotto il patrocinio del VPN Mečiar fondò la propria piattaforma: “Per una Slovacchia
Democratica”. Un mese più tardi si separò definitivamente dal VPN, creando il Movimento
indipendente per una Slovacchia Democratica (HZDS).
Il 23 Aprile 1991, il consiglio di presidenza del Consiglio Nazionale Slovacco revocò a
Mečiar la carica di Primo Ministro del governo slovacco come pure a tutti i suoi sostenitori i
quali si rifiutarono di rispettare le decisioni della leadership del VPN. Il governo venne così
riformato con Ján Čarnogurský, presidente del KDH, vhe divenne il nuovo Primo Ministro.
Čarnogurský, era favorevole all’indipendenza della Slovacchia ma, vista la situazione
contingente, non considerava questa questione la più urgente. Secondo lui la Slovacchia sarebbe
diventata indipendente soltanto dopo l’ingresso della Cecoslovacchia nella Comunità Europea.
In contrasto con i rappresentanti del VPN che sostenevano un vincolo statale durevole con i
Cechi, Čarnogurský considerava la Cecoslovacchia come una formazione temporanea, e non
faceva segreto di ciò.
Mentre negoziava con Petr Pithart, ,un ex dissidente, Carnogursky pretese che la
creazione di una coabitazione ceca e slovacca dovesse fondarsi su un trattato legalmente
vincolante fra le due repubbliche,l’accettazione del quale avrebbe dovuto precedere l’adozione
di qualsiasi nuova costituzione.
Durante il 1991,i negoziati ceco-slovacchi continuarono. Dapprima, Dagmar
Buresova,presidente del Consiglio Nazionale Ceco,rigettò l’idea di Carnogurky di un trattato fra
le due repubbliche.Alla fine,la parte ceca lo accettò come una iniziativa politica.Al contrario,la
parte slovacca pretese che il trattato avesse un carattere vincolante,il che significava ,in effetti,
che avrebbe dovuto assumere la forma di un tra