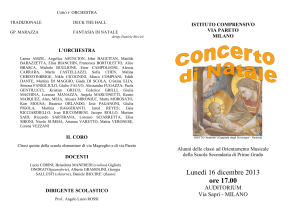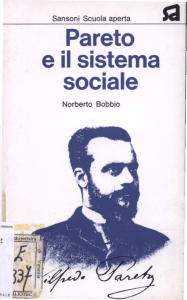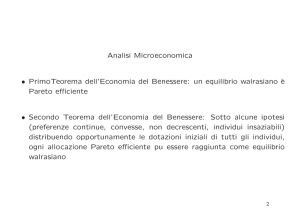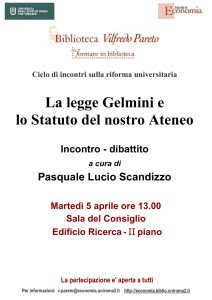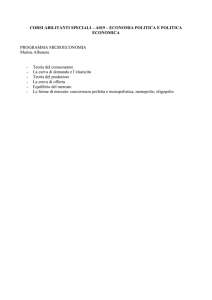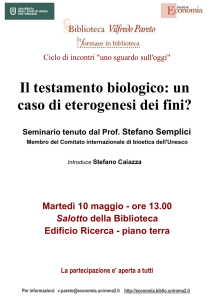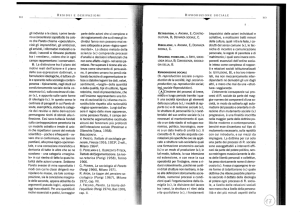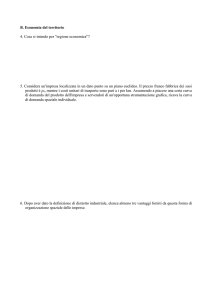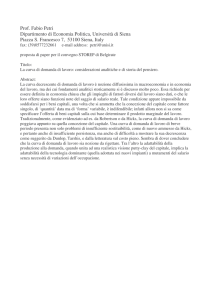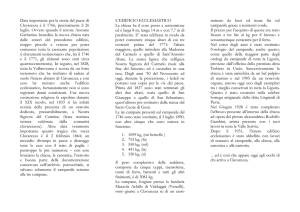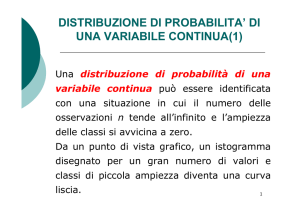Terenzio Maccabelli
I FONDAMENTI “NATURALISTICI”
DELLA CURVA DEI REDDITI:
L’ANTROPOLOGIA SOCIALE DI PARETO
DSS PAPERS STO 2-03
INDICE
Avvertenza ................................................................................... Pag. 4
Abbreviazioni ...................................................................................... 4
1. Introduzione ......................................................................................... 5
2. Razze e disuguaglianze sociali: l’influsso dell’“antroposociologia” 9
3. L’eterogeneità sociale ....................................................................... 23
4. La selezione sociale ........................................................................... 28
5. La selezione e la forma delle gerarchie sociali ............................... 32
6. L’antropologia delle élite .................................................................. 38
Avvertenza
Il presente scritto è una versione preparatoria di un lavoro più complesso dedicato al pensiero di Pareto su gerarchie sociali e disuguaglianze economiche. Rappresenta in particolare un capitolo, ancora molto provvisorio,
di collegamento tra i capitoli dedicati agli aspetti economico-statistici della
curva dei redditi, sviluppati da Pareto nelle opere precedenti il 1900, e quelli
dedicati alla teoria sociologica delle élite, approfondita soprattutto nel Trattato di sociologia generale del 1916.
Il lavoro complessivo intende mostrare come la riflessione sociologica
e politica si innesti progressivamente su quella economica e statistica, ma
sempre nell’ambito di una unitarietà di fondo che caratterizza la concezione
paretiana della scienza sociale. I temi interconnessi della distribuzione della
ricchezza e delle gerarchie sociali rappresentano infatti a nostro parere
esempi emblematici di come Pareto abbia tradotto la propria concezione
della “scienza sociale” come “storia naturale delle società umane”.
In questo paper, per i motivi sopra detti, questa unitarietà risulta sacrificata, in quanto si affrontano soltanto gli aspetti antropologici del pensiero
di Pareto. Si è cercato comunque, per quanto possibile, di rendere il presente
scritto autonomo e indipendente rispetto alle rimanenti parti del lavoro.
Abbreviazioni
Cours: V. PARETO, Cours d’économie politique, vol. I-II, F. Rouge, Lausanne, 1896-1897, trad. it. Corso di economia politica, Einaudi, Torino,
1943.
Systèmes: ID., Les systèmes socialistes, Cours professé à l’Université de
Lausanne, vol. I-II, Giard & Brière, Paris, 1901-1902, trad. it. I sistemi
socialisti, Utet, Torino, 1987.
Manuale: ID., Manuale di economia politica con una introduzione alla
scienza sociale, Società Editrice Libraria, Milano, 1906, rist., Cedam,
Padova, 1974.
Trattato: ID., Trattato di Sociologia Generale, Barbera, Firenze, 1916, Edizione critica a cura di G. Busino, Utet, Torino, 1988.
1.
Introduzione
Per me la scienza sociale è la storia naturale delle
società umane. L’economia politica è, all’incirca, la
scienza che studia le funzioni di nutrizione di quegli
aggregati.
(V. Pareto a F. Papafava, 10 febbraio 1897).
I contributi di Pareto riguardanti la distribuzione della ricchezza e le
gerarchie sociali sono notoriamente tra i più rilevanti nell’ambito della sua
complessa e multiforme produzione. Questi argomenti hanno alimentato una
vastissima letteratura, tanto sul piano teorico quanto storiografico. Anche
solo scorrendo i titoli di questa sconfinata bibliografia si evince immediatamente però la totale separazione tra l’aspetto economico-statistico della celebre “curva dei redditi”, strumento ideato da Pareto per studiare la distribuzione della ricchezza, e la componente politico-sociologica della circolazione delle élite, teoria utilizzata per spiegare i movimenti interni alle gerarchie
sociali. Questa separazione è frutto evidentemente della specializzazione disciplinare sempre più spinta che si è imposta nell’ambito delle scienze sociali, che ha consolidato l’immagine di un Pareto economista distinto e diverso dal Pareto sociologo. La teoria paretiana della stratificazione sociale
viene così solitamente indagata o esclusivamente in chiave economicostatistico, scindendola dall’orpello sociologico che la circonda, oppure solo
in chiave politologica, e in questo caso trascurando le fondamenta statistiche
ed economiche che la supportano.
In questo lavoro cercheremo di focalizzare l’attenzione sull’aspetto che
riteniamo possa essere considerato una sorta di ponte tra la componente
I fondamenti “naturalistici” della curva dei redditi
5
economico-statistica della curva dei redditi e la teoria sociologica della circolazione delle èlite. A nostro avviso questo ruolo è giocato dalle concezioni
antropologiche di Pareto, che svolgono un ruolo decisivo nel Cours, nei Systèmes e nel Manuale (anche se molto meno, invece, nel Trattato).
L’antropologia di Pareto è peraltro legata alla controversa questione
dello statuto scientifico della “legge dei redditi”: formula “empirica”, legge
“statistica” o legge “naturale”? Su questo terreno Pareto si muove con una
certa ambiguità, dando risposte non sempre concordanti. La cautela con cui
invita a guardare alle regolarità statistiche non lo esime infatti dall’attribuire
alla propria legge lo status di legge “naturale”. Scrive ad esempio nel 1896
che i dati statistici rilevano “la presenza di una legge naturale secondo la
quale i redditi tendono a distribuirsi” nella società, ritenendo siano sufficienti per “rigettare interamente la teoria della casualità”1. E aggiunge nel
1897 che “non c’è forse altra legge statistica che abbia in suo sussidio tanta
e tale compia di fatti come ne ha la legge delle entrate”2.
Le ragioni che spingono Pareto ad assegnare alla legge dei redditi lo
status di legge naturale sono solo in parte economiche. L’invariabilità nel
tempo e nello spazio della forma delle gerarchie sociali – e della conseguente disuguale distribuzione della ricchezza – viene infatti dedotta da Pareto chiamando in causa proprio l’antropologia. Il “naturalismo” dell’autore
del Cours nasce su questo terreno, dal fatto cioè che egli rigetta – o comun
1
V. PARETO, La courbe de la répartition de la richesse, Université de Lausanne, recuéil
publié par la faculté de Droit à l’occasion de l’exposition nationale suisse, Geneve
1896, Ch Viret-Genton, Losanna, 1896, trad. it. La curva della distribuzione della ricchezza, in M. Baldassari, P. Ciocca (a cura di), Radici della scuola italiana di economica e finanza. Da Ferrara (1857) a Einaudi (1944), “Rivista di politica economica”,
a. LXXXVII, nn. 8-9, 1997, p. 649.
2
V. PARETO, Aggiunta allo studio sulla curva delle entrate, “Giornale degli economisti”,
a. VIII, vol. XIV, n. 1, 1897, p. 26.
6
I fondamenti “naturalistici” della curva dei redditi
que ridimensiona in misura sensibile – i fattori socio-istituzionali, scegliendo invece di puntare sulle caratteristiche “antropologiche” della natura umana. Egli riconosce infatti tre potenziali “cause” che potrebbero spiegare
l’uniformità individuata nella distribuzione della ricchezza: 1) il “caso”; 2)
l’“organizzazione sociale”; 3) la “natura degli uomini di cui la società si
compone”. Le prime due possibilità vengono però accantonate3, a vantaggio
della terza che si presenta a tutti gli effetti come il nucleo centrale della teoria paretiana delle gerarchie sociali.
L’argomentazione di Pareto si sviluppa attorno a due concetti fondamentali: l’“eterogeneità sociale” e la “selezione sociale”. Le fonti da cui Pareto attinge nel proporre tali concetti sono espressamente dichiarate: si tratta
in particolare di Otto Ammon e di Georges Vacher de Lapouge, esponenti di
punta di una propaggine del darwinismo sociale piuttosto influente negli anni a cavallo del Novecento.
Dei rapporti di Pareto con questi autori non si conosce però molto. Lo
stesso economista di Losanna è piuttosto sfuggente al riguardo. Nel Cours
d’économie politique e nei Systèmes socialistes essi sono frequentemente
citati, con un singolare miscuglio di riverenza e disapprovazione; e in diverse circostanze egli dichiara il proprio debito intellettuale nei loro confronti.
Ma se, da una parte, non si può negare un’eccessiva benevolenza da parte di
Pareto nei confronti di Ammon e Lapouge, propugnatori di discutibili concezioni sociali, dall’altro è indubitabile che egli evochi le loro teorie per poi
3
L’esclusione del “caso” poggia sulla diversa natura della curva del reddito e della curva
casuale degli errori, divergenza che Pareto dimostra nella nota matematica del paragrafo 87 del Cours (cfr. Cours, vol. II, p. 348). Per quanto riguarda invece l’idea che
siano i meccanismi istituzionali a regolare le modalità di ripartizione del reddito, questa viene esclusa in quanto contraddetta dalla circostanza che la medesima curva si ripresenta nelle più diverse organizzazioni sociali, lontane sia nel tempo che nello spazio (cfr. ibid., p. 344).
I fondamenti “naturalistici” della curva dei redditi
7
prenderne risolutamente le distanze. Non è poi secondario il fatto che nel
Trattato di sociologia generale egli rinunci definitivamente alla loro sconveniente presenza. Uno sguardo alle concezioni di Ammon Lapouge appare
a questo punto doveroso, prima di vedere quanto effettivamente Pareto abbia
tratto da questi autori.
8
I fondamenti “naturalistici” della curva dei redditi
2.
Razze e disuguaglianze sociali: l’influsso dell’“antroposociologia”
I piuoli superiori della scala dissero agli inferiori:
“non crediate di essere uguali a noi. Voi state nel
fango mentre noi ci libriamo negli spazi. La nostra
gerarchia, creata dalla natura, fu consacrata dal
tempo ed è pertanto legittima”.
Un filosofo, che passava di là, udito codesto fine ragionamento, sorrise e capovolse la scala (H. Heine).
Ammon e Lapouge costituiscono personaggi “scomodi” nella storia
delle scienze sociali, tanto da essere poco menzionati – se non addirittura
dimenticati – non solo dalle storie dell’economia politica ma anche dalle
storie dell’antropologia o della sociologia. Negli anni a cavallo del Novecento la loro rilevanza era tuttavia notevole, e i loro scritti avevano eco su
riviste di varie discipline scientifiche. I due studiosi sono in effetti difficilmente classificabili dal punto di vista strettamente disciplinare, avendo operato in una nebulosa zona di confine tra antropologia e sociologia. Il loro
progetto scientifico era in verità volto alla costruzione di una nuova branca
del sapere, per la quale avevano coniato le espressioni di “antropologia sociale” o “antroposociologia”4.
Per capire l’humus su cui prendono corpo le teorie di Ammon e Lapouge è necessario tenere conto di quattro fondamentali idee che si fanno
largo nelle scienze sociali dell’Ottocento, in vario modo riguardanti la con
4
“This new school, or new science […], has been called by its creators Anthroposociology, or Social Anthropology, and it is already promulgated by numerous champions, among whom Lapouge in France and Ammon in Germany occupy positions of
special prominence” (A. LORIA, Social Anthropology. A review, “American Anthropologist”, n.s., vol. I, n. 2, Apr. 1899, p. 283).
I fondamenti “naturalistici” della curva dei redditi
9
cezione della natura umana. Per prima cosa, è da ricordare il radicale mutamento che si registra nella letteratura antropologica, verso la metà del XIX
secolo, in merito a quello che nel Settecento – da autori pur tanto diversi tra
loro come ad esempio Burke, Rousseau o Smith – era ritenuto un principio
indubitabile, cioè l’uguaglianza naturale degli esseri umani. La disuguaglianza – tanto da coloro che la condannavano tanto da quelli che la legittimavano – veniva infatti concepita come un fatto “sociale”, ossia il prodotto
esclusivo dell’evoluzione storica5. “Intorno alla metà del diciannovesimo
secolo”, invece, come ha osservato M. Harris,
non c’era ‘verità’ più ‘autoevidente’ del fatto che gli uomini siano stati creati disuguali. Nessuna ‘verità’ esercitò mai un’influenza più dannosa sullo sviluppo della scienza
sociale. Il determinismo razziale fu la forma che assunse l’avanzante onda della scienza
della cultura mentre si frangeva sulle rive del capitalismo industriale6.
L’origine dell’antropologia sociale, a detta dei loro stessi fondatori, rimanda proprio alla scoperta delle differenze e delle gerarchie tra le razze,
così come formulata tra il 1853 e il 1855 dal conte di Gobineau nell’Essay
sur l’inegalité des races humaines. Un secondo tassello necessario
all’edificazione della antroposociologia, ancora assente nella costruzione di
Gobineau, era l’idea che le differenze qualitative tra gli individui potessero
essere trattate alla stregua dei dati quantitativi. Alla nascita dell’antropologia
sociale contribuiva in modo decisivo proprio lo straordinario perfezionamento dei metodi statistici che si stava registrando nel periodo, reso peraltro
possibile anche grazie alla loro applicazione nel campo dei fenomeni sociali.
5
Ciò che divide gli autori ricordati è il giudizio sull’esito di tale processo, se cioè la
creazione della disuguaglianze sia stato un fatto positivo per la civiltà oppure no, ma
non l’uguaglianza originaria degli esseri umani.
10
I fondamenti “naturalistici” della curva dei redditi
Tra i primi a dimostrare le enormi potenzialità dello strumento statistico in
tale ambito d’indagine erano stati soprattutto Quetelet e Galton. Nelle Lettres sur la thèorie des probabilités Quetelet aveva individuato nelle celebre
curva “normale” di frequenza lo strumento statistico attraverso il quale rappresentare la distribuzione delle attitudini umane, ossia la progressiva riduzione della proporzione dei “talenti” e “degli “inetti” ai due estremi e la
concentrazione della popolazione sul carattere medio; Galton, da parte sua,
oltre a insistere sulla distribuzione “normale” delle attitudini umane, aveva
indicato che le qualità mentali, non meno di quelle fisiche, sono soggette ai
principi dell’eredità biologica7. Ed è appunto questo il terzo pilastro della
antroposociologia, l’idea cioè dell’ereditarietà delle attitudini umane, siano
esse positive o negative. Per ultimo è da ricordare il concetto di “selezione
sociale”, emulo della selezione darwiniana, al quale gli antroposociologici
ricorrono in modo massiccio nelle loro opere. Queste quattro intuizioni – la
disuguaglianza “naturale” degli individui e delle razze, la misurabilità dei
caratteri qualitativi, l’ereditarietà degli stessi e l’idea di selezione sociale –
venivano poi racchiuse entro un quadro concettuale costruito attorno alla distinzione formulata da Galton tra “nature” e “nurture”8, funzionale alla tesi
6
7
8
M. HARRIS, L’evoluzione del pensiero antropologico. Una storia della teoria della
cultura, Mulino, Bologna, 1971, p. 109.
J.A. FIELD, The Progress of Eugenics, “The Quarterly Journal of Economics”, vol.
XXVI, November, 1911, p. 5 e p. 6. Cfr. F. GALTON, Hereditary Talent and Character, “Macmillan’s Magazine”, vol. XII, June; August 1865, considerato il punto di
partenza della letteratura “eugenetica”, e il successivo Hereditary Genius pubblicato
nel 1869, dove viene ribadita la tesi fondamentale dell’ereditarietà delle abilità, supportata da un’abbondante materiale genealogico sulla storia delle famiglie degli uomini di genio.
“Nature is all that a man brings with himself into the world; nurture is every influence
from without that effects him after his birth” (F. GALTON, Englihs Men of Science:
their Nature and Nurture, London, 1874, p. 12). La stessa distinzione comare anche in
ID., Hereditary Improvement, “Frasers Magazine” January, 1873, p. 116 (cfr. Grieg, p.
14).
I fondamenti “naturalistici” della curva dei redditi
11
della supremazia della prima sulla seconda, ossia dei “caratteri innati” rispetto alle successive acquisizioni dall’ambiente sociale.
Ammon e Lapouge costruiscono l’antropologia sociale raccogliendo
fermenti dottrinari ormai diffusi nell’intellighenzia europea, grazie “alla
fortuna letteraria delle idee volgarizzate da Gobineau”9, ma dando alle stesse
una bardatura scientifica molto più potente. I due antropologi traducono la
“verità autoevidente” della disuguaglianza originaria in una teoria sociale
dagli espliciti contenuti razziali; inoltre, appoggiandosi ai dati oggettivi
dell’indagine empirica e avvalendosi delle più moderne tecniche statistiche
introdotte nelle scienze sociali da Quetelet e Galton, elaborano una complessa teoria sociale che incorpora i problemi dell’eredità genetica, della selezione naturale, della stratificazione sociale e dell’organizzazione politica10.
A questa ambiziosa costruzione dottrinaria viene dato il nome, come anticipato, di “antroposociologia” o anche “antropologia sociale”11.
Presupposto delle teorie di Ammon e di Lapouge è, da un lato, che le
qualità umane – “genio”, “intelligenza”, “abilità”, ecc. – siano misurabili e,
dall’altro che queste stesse qualità siano “innate” e trasmissibili attraverso
9
Cfr. M. BATTINI, L’ordine della gerarchia. I contributi reazionari e progressisti alle
crisi della democrazia in Francia, 1879-1914, Bollati Boringhieri, Torino, 1995, p.
196.
10
Sui due fondatori della antropo-sociologia, cfr. W. STARK, Natural and Social Selection, in M. Banton (ed.), Darwinism and the Study of Society. A Centenary Symposium, London, 1961. Su Lapouge, in particolare, cfr. J. M. HECHT, The Solvency of
Metaphysics. The Debate over Racial Science and Moral Philosophy in France, 18901919, “Isis”, vol. XC, n. 1, Mar. 1999, pp. 1-24; A. BEJIIN, Le Sang, le sens et le
travail: George Vacher de Lapouge, Darwinist social, Fondateur de
l’anthroposociologie, “Cahiers internationaux de sociologie”, vol. LXXIII, 1982, pp.
323-343.
11
“The establishment of anthro-sociology as a distinct branch of investigation – scrive
Lapouge – dates from my lectures at the University of Montpellier (1886-1892) and
from the publication by Ammon of his researches on the conscripts of Baden” (G.
VAUCHER DE LAPOUGE, The fundamental laws of anthropo-sociology, “The Journal of
Political Economy”, vol. VI, n. 1, Dec. 1897, pp. 54-92.
12
I fondamenti “naturalistici” della curva dei redditi
l’eredità. Su questo terreno i due autori non fanno che radicalizzare gli esiti
delle ricerche di Quetelet e Galton. Fanno però un passo ulteriore, associando le diverse attitudini ad alcune tipologie razziali, per sottolineare il ruolo
del fattore etnico nell’evoluzione delle società umane. Le differenze qualitative tra gli individui vengono ricondotte a un dato oggettivo quantificabile:
l’indice cefalico12. In base ad esso vengono identificate tre fondamentali tipologie razziali – l’Homo Europaeus, l’Homo Alpinus e l’Homo Meditteraneus – il primo dolicocefalo biondo (dalla testa stretta e lunga) e i secondi
brachicefali bruni. A ciascuno di essi vengono associati particolari
“caratteri” e “predisposizioni” attraverso cui spiegare il loro diverso atteggiamento “sociale” e “culturale”. L’Homo Europeus, chiamato anche ariano
da Lapouge e teutonico da Ammon, sarebbe attivo, intraprendente e ambizioso, con uno spiccato orientamento migratorio e un’attrazione irrimediabile per la vita urbana; l’Homo Alpinus e l’Homo Meditteraneus sarebbero
invece più stanziali, concentrati maggiormente nei centri agricoli e poco
propensi al mutamento e all’innovazione. Da questi presupposti vengono derivate le “leggi fondamentali” dell’antropologia sociali, le più importanti
delle quali affermano che, dove le diverse tipologie razziali convivono, i
dolicocefali occupano i gradini più alti delle gerarchie sociali e possiedono
una maggiore proporzione di ricchezza e, più in generale, che l’indice cefalico delle classi elevate è minore di quello dei ceti inferiori13.
12
Calcolato comparando la larghezza e la lunghezza della testa. La nozione di “indice cefalico” si ricollega alla “frenologia” di Lavater e di Gall, anche se la sua introduzione
intorno al 1845 ad opera dello scienziato svedese André Retzius è inizialmente per fini
critici nei confronti dei frenologi (cfr. L. POLIAKOV, Le myithe aryen, Calmann-Lévy,
1971, trad. it. Il mito ariano. Le radici del razzismo e dei nazionalismi, Editori Riuniti,
Roma, 1999, p. 299).
13
Cfr. G. VAUCHER DE LAPOUGE, The fundamental laws of anthropo-sociology, cit., p.
61 e p. 87: “Laws of the distribution of wealth. In country inhabited jointly by Homo
Europeus, the former element posses more than its proportionate share of wealth. […]
I fondamenti “naturalistici” della curva dei redditi
13
Lo sbocco delle ricerche di Ammon a Lapouge sul piano economicosociale è facilmente intuibile: la gerarchia sociale non fa che riprodurre le
differenze originarie degli esseri umani; l’ambiente, l’educazione e in genere
l’organizzazione sociale non possono fare nulla nei confronti di una differenziazione che proviene dalle inesorabili leggi della “natura”. La stratificazione sociale ed economica illustrata dalla statistica dei redditi è quindi il riflesso della diversa dotazione “genetica” degli individui in fatto di intelligenza e abilità. Al riguardo Ammon propone quello che è forse il primo
tentativo di dimostrare la coincidenza tra la “curva dell’intelligenza” e la
“curva della ricchezza”, avvalorando un’ipotesi già sostenute in precedenza
da Galton ma senza il necessario supporto delle statistiche dei redditi.
L’antropologo tedesco aveva infatti esortato a estromettere dall’immaginario
sociale l’idea della piramide; questa avrebbe dovuto essere sostituita da una
figura simile alla “cipolla” come quella sottostante, la “vera” forma appunto
della “piramide sociale”.
Laws of stratification. The cephalic index is lower and the proportion of dolichocephalic greater among the higher classes than among the lower classes in each community”.
14
I fondamenti “naturalistici” della curva dei redditi
In questo modo Ammon, richiamandosi alle ricerche di Galton, aveva
voluto sottolineare l’andamento simmetrico della struttura sociale, con un
ridotto numero di geni e di inetti ai due estremi e una concentrazione nella
zona mediana della mediocrità. Il passo successivo compiuto da Ammon
consisteva nel mostrare come anche la distribuzione della ricchezza avesse
un andamento analogo a quello rilevato nella distribuzione delle attitudini
umane. Scrive infatti l’antropologo tedesco che “due verità” scaturiscono dal
confronto delle due curve:
(1) that the form of the curve of incomes (except at the base) very nearly coincides
with Galton’s curve of the distribution of ability; and (2) that the income curve is not
symmetrical above and below but corresponds more nearly to what we have called the
“true form of the social pyramid” […], which like the income curve, stands upon a horizontal base line14.
Altro concetto cardine degli antropo-sociologi è quello di “selezione
sociale”, i cui fini principali sono, da una parte, di eliminare gli individui
degeneri e, dall’altra, di perfezionare gli elementi superiori. La selezione,
chiarisce Lapouge, è una delle parole chiave dell’antropologia sociale, il cui
motto “Determinismo, Disuguaglianza e Selezione”, in ossequio alla rivoluzione darwiniana, doveva sostituire quello illuministico di “Libertà, Eguaglianza e Fraternità”15.
14
15
O. AMMON, Some social applications of the Doctrine of Probability, “The Journal of
Political Economy”, vol. VII, n. 2, mar. 1899, p. 226, trad. ing. parziale di ID., Die
Gesellschaftsornung und ihre natürlichen Grundlagen, Jena, 1896.
“The naturalness of human inequality seemed to him a major implication of Darwinism, and he praise Royer for being among the first to note this” (L.L. CLARK, Social
Darwinism in France, cit., p. D1039).
I fondamenti “naturalistici” della curva dei redditi
15
Non sempre tuttavia la selezione opera nella direzione voluta: una delle
maggiori ossessioni della letteratura antroposociologica è il rischio di degenerazione degli individui scelti. Ai loro occhi, infatti, nella società moderna
operano processi sociali che tendono a eliminare gli elementi “superiori” e a
moltiplicare gli “inferiori”16, invertendo il fine della selezione di perfezionare lo “stock razziale” dell’umanità17.
Nell’opera Les sélections sociales del 1896, Lapouge sosteneva infatti
che la contaminazione razziale avrebbe avuto effetti nefasti18. Gli elementi
brachicefali, per quanto “‘inferiori’ per grado di civiltà”, possedevano una
maggiore forza riproduttiva, che gli avrebbe permesso di “soppiantare i dolicocefali, attraverso una selezione di ordine complesso, biologico e insieme
16
17
18
16
Pur con differenti punti di vista sul modo di operare della selezione naturale, questo
pericolo attraversa l’opera sia di Ammon che di Lapouge (cfr. R.A. NYE, The BioMedical Origins of Urban Sociology, “Journal of Contemporary History”, vol. XX, n.
4, Oct. 1985, p. 666).
Misurando l’indice cefalico di un vasto campionario di popolazione, Ammon giunse
alla conclusione che la tipologia “teutonica” caratterizzata da individui “long-headed”
fosse irrimediabilmente attratta dalle città, e perciò soggetta al deterioramento fisico e
morale derivante dalle condizioni di vita urbane (Grieg, p. 58). Quasi contestualmente
Lapouge, nel libro Les sélections sociales del 1895, aveva tracciato le linee di una storia naturale delle razze, sottolineando come su queste avesse agito la guerra, la vita
politica ed economica, la religione e il diritto. Lo sbocco di questo affresco storico era
una teoria del miglioramento razziale da realizzare attraverso la selezione sociale
(Grieg, p. 59). “Vacher de Lapouge also deplored the fact that in modern society artificial constraints interfered with the process of natural selection and thereby, he alleged, contributed to racial degeneration. Like the English eugenicist Francis Galton,
he proposed to reverse this trend by preventing unfit human specimens from reproducing and encouraging the physically fit to do so” (L.L. CLARK, Social Darwinism in
France, “The Journal of Modern History”, vol. LIII, n. 1, mar. 1981, pp. D1039D1040).
G. VACHER DE LAPOUGE, Les sélections sociales, Paris, 1896, p. 488 ; G.L. MOSSE,
toward the Final Solution. A History of European Racism, Haward Ferting, New
York, 1978, trad. it., Il razzismo in Europa. Dalle origini all’olocausto, Laterza, Bari,
1980, p. 68.
I fondamenti “naturalistici” della curva dei redditi
sociale”19. Un esempio storico di questo tipo era dato dalla Rivoluzione
francese:
Il fallimento della Rivoluzione – scrive Lapouge – è strepitoso […]. Questa è stata
prima di tutto la sostituzione del brachicefalo al dolico-biondo nella detenzione del potere. […] Attraverso la Rivoluzione il brachicefalo ha conquistato il potere, e con
un’evoluzione democratica questo potere tende a concentrarsi nelle classi inferiori, le più
brachicefali. L’ariano quale l’ho definito è tutt’altra cosa, è l’Homo Europeaus, una razza
che ha fatto la grandezza della Francia e che presso di noi è oggi rara e quasi estinta20.
Come
si
vede,
c’è
nella
concezione
di
Lapouge
un’idea
dell’“avvicendarsi” tra elementi superiori e inferiori che avrà un’influenza
molto forte su Pareto, il quale riuscirà comunque a stravolgerne il significato
estromettendo ogni contenuto razziale.
Nelle mani di Lapouge, invece, la teoria dell’eterogeneità e della selezione sociale ha uno sbocco ineluttabile, facendo da anticamera al nazionalsocialismo e alla “soluzione finale”. Condizione per la rigenerazione della
società, infatti, era “la formazione di una nuova élite politica prodotta dalla
selezione razziale”. Inoltre, questa produzione di “eugenici” di matrice ariana, avrebbe dovuto essere accompagnata dall’eliminazione fisica dei soggetti “inferiori”21. Si tratta di quella forma di selezione che Pareto, con atteggiamento critico, definirà “diretta”. Tanto Ammon quanto Lapouge erano
infatti convinti che si potesse assecondare l’opera di selezione dei soggetti
inferiori istituendo particolari luoghi di attrazione – dove distribuire alcool
gratuito, diffondere il vizio e favorire il libertinaggio – in modo da concen
19
M. BATTINI, L’ordine della gerarchia, cit., p. 199.
G. VAUCHER DE LAPOUGE, L’Aryen, son rôle social, Paris, 1899, p. VII, 22 e 464, cit.
in L. POLIAKOV, Le myithe aryen, cit., p. 305.
21
Cfr. M. BATTINI, L’ordine della gerarchia, cit., pp. 200-201.
20
I fondamenti “naturalistici” della curva dei redditi
17
trare gli individui degeneri e poi farli “sparire”22. Tale progetto non avrebbe
però mai potuto realizzarsi nell’ambito di un’organizzazione liberale della
società, la quale doveva perciò lasciare il posto a un modello dirigistico e
centralizzato di socialismo di stato finalizzato a porre in essere i veri principi
della gerarchia sociale. “Sostituire l’umanità attuale con una razza unica e
perfetta” richiede infatti, scrive Lapouge, “quasi necessariamente, un regime
socialista, e da ciò deriva un’altra difficoltà: il socialismo si è mostrato, fino
ad ora, prevalentemente livellatore e peggiorativo”23. Anche questo aspetto
attirerà l’attenzione di Pareto, il quale avrà modo, commentando questo brano, di estendere la propria critica a tutte le manifestazioni del socialismo.
Ma prima di vedere la riflessione di Pareto su questi temi, è importante
sottolineare
la
considerazione
dell’antropologia
sociale
alla
fine
dell’Ottocento, ritenuta da molti contemporanei di Ammon e Lapouge una
dottrina “scientifica”, “erudita” e “rivoluzionaria”24. “Sfogliando le riviste e
le
pubblicazioni
scientifiche
dell’epoca
ci
si
convince
che
l’‘antroposociologia’ […] era presa molto sul serio. Certo Lapouge faceva
scuola soprattutto in Germania, dove Guglielmo II vedeva in lui ‘l’unico
grande uomo francese’; ma egli ebbe anche dei fautori negli altri paesi europei”25. Un segno dell’incredibile diffusione dell’antropologia sociale è l’eco
di tale dottrina sulle maggiori riviste economiche, alimentata da una martellante campagna pubblicistica condotta da Carlos C. Closson. L’economista
di Chigago divulga le teorie antropo-sociologiche non solo traducendo sulle
22
G. VACHER DE LAPOUGE, Les sélections sociales, cit., p. 471 ; M. BATTINI, L’ordine
della gerarchia, cit., p. 201.
23
G. VACHER DE LAPOUGE, Les sélections sociales, cit., p. 480 e segg. ; M. BATTINI,
L’ordine della gerarchia, cit., p. 202.
24
Cfr. J. M. HECHT, The Solvency of Metaphysics. The Debate over Racial Science and
Moral Philosophy in France, cit., p. 3.
25
L. POLIAKOV, Le myithe aryen, cit., p. 306.
18
I fondamenti “naturalistici” della curva dei redditi
riviste anglosassoni alcuni dei contributi di Ammon e Lapouge ma anche
con numerosi contributi personali26. Closson non nasconde il proprio
l’entusiasmo per le teorie dei fondatori dell’antropologia sociale, ritenute rivoluzionarie proprio per il loro approccio transdisciplinare:
The work of Ammon himself, together with of De Lapouge, has not only brought
statistical anthropology into close relation with politics, economics, ethics, psychology,
the interpretation of history, and especially sociology; but conversely it has also transformed the methods of anthropological investigation itself, enriching that science with
new categories and distinctions, and with a multitude of new problems27.
In generale saggi di Closson non sono che pedisseque ripetizioni delle
teorie di Ammon a Lapouge, alle quali non fa che cercare di aggiungere
nuovi riscontri empirici. Il suo contributo è comunque di rilievo, tanto da essere frequentemente accomunato ad Ammon e Lapouge come esponente
della nuova scuola di antropologia sociale. Tra i suoi saggi vale la pena ricordare quello sulla “selezione sociale”, anche perché attirerà l’attenzione di
Pareto.
Dopo aver di nuovo menzionato Ammon e Lapouge come i fondatori
della “selctionist school of sociology”, Closson articola il discorso sulla selezione indicando due forze principali che operano nella società: la prima è
la forza conservatrice dell’eredità biologica che tende a perpetuare di generazione in generazione le stesse caratteristiche fisiche; la seconda è la forza
26
Cfr. C.C. CARLOS, Dissociation by Displacement: A Phase of Social Selection, “The
Quarterly Journal of Economics”, vol. X, n. 2, Jan. 1896, pp. 156-186; ID., Recent
Progress of Social-Anthropology, “The Journal of Political Economy”, vol. IV, n. 3,
Jun. 1896, pp. 410-412; ID., Social Selection, “The Journal of Political Economy”,
vol. IV, n. 4, Sep. 1896, pp. 449-466; ID., Ethnic Stratification and Displacement,
“The Quarterly Journal of Economics”, vol. XI, n. 1, Oct. 1896, pp. 92-104; ID., Further Data of Anthropo-sociology, “The Journal of Political Economy”, vol. VII, n. 2,
Mar. 1899, pp. 238-252.
I fondamenti “naturalistici” della curva dei redditi
19
evolutiva della selezione che introduce i mutamenti e stabilisce quali specie
devono progredire e quali scomparire28. Queste due forze agiscono sulle razze e la seconda in particolare “is the great force in altering the quality of population”. Il miglioramento, tuttavia, non avviene grazie all’azione
dell’ambiente istituzionale ma avviene esclusivamente sul piano razziale.
Closson ribadisce uno dei pilastri della antroposociologia, cioè la sterilità
della “nurture”: “Education has only a limited effect upon the single individual and even this effect is not in any appreciable degree transmitted to his
descendants; it cannot be relied upon as the primary means of human improvement”29.
L’opera della selezione deve dunque essere tale da favorire lo sviluppo
degli elementi “etnicamente superiori”, cosa che non sempre accade, a causa
di un processo di avvicendamento tra le élite che nelle società moderne ha
finito per favorire le “classi inferiori”30. Il delirio di Lapouge sull’imminente
pericolo per l’Homo Europaeus di essere contaminato dalla razze inferiori
viene quindi ribadito anche da Closson. Il futuro dell’umanità, conclude
quindi Closson, si gioca tutto sulla possibilità di reindirizzare l’opera della
selezione sociale lungo i suoi naturali binari, per realizzare i seguenti scopi:
(1) to constitute a natural aristocracy among a given people; (2) to constitute specialized and distinct castes suited for the different branches of social works, (3) to transform a people a whole in a given direction, (4) to form a universal dominant race, (5) to
improve all humanity by utilizing the most perfect local types, (6) to substitute for existing humanity a single more perfect race, etc. Systematic selection, whatever its ultimate
27
C.C. CARLOS, Recent Progress of Social-Anthropology, cit., pp. 410-411.
C.C. CARLOS, Social Selection, cit., p. 453.
29
Ibid., p. 459.
30
Ibid., p. 462.
28
20
I fondamenti “naturalistici” della curva dei redditi
goal, would have to proceed in two directions: (1) to eliminate the degenerate, vicious
and incapable elements, (2) to increase and perfect the superior elements31.
Tra gli economisti, i soli a noi noti che abbiano cercato di sgonfiare
l’aurea di scientificità attribuita da Ammon, Lapouge e Closson
all’antroposociologia, sono Achille Loria e John Cummings.
L’ampio saggio di Cummings insiste soprattutto sulla totale assenza di
fondamento scientifico di termini come “razza”, “fattore etnico”, o “indice
cefalico”, per sottolineare l’impropria associazione tra quest’ultimo elemento di identificazione razziale e le qualità individuali, caratteriali e intellettuali degli individui32. Ritiene inoltre inconsistente il tentativo di eliminare l’influenza dell’ambiente sociale sulle attitudini umane, poiché, egli scrive, “Environment is the matrix and to conceive man apart from environmental influences is as impossible as to conceive a cast without a mould”33.
Conclude quindi con l’auspicio che questa perversa deriva del darwinismo
sociale venga spazzata dagli orizzonti del sapere umano e che la scienze sociali riprendano il loro consueto cammino:
Anthropologists do non present any data to justify the assumption that the cephalic
index carries any mental attribute or any character with it; nor can any such contention be
maintained in the face of modern psychology, which more and more is coming to regard
the head-form as irrelevant to mental capacity or character, certainly where the size of the
brain is diregarded. Phrenology, like astrology, has had its day; and the sort of racial
phrenology with which modern anthropologists are engaged is bound to go to the same
limbo. Sociology may then breathe again naturally34.
31
Ibid., p. 465,
Cfr. J. CUMMINGS, Ethnic Factors and the Movement of Population, “The Quarterly
Journal of Economics”, vol. XIV, n. 2, Feb. 1900, pp. 181, 201 e 195-196.
33
Cfr. ibid., p. 199.
34
Cfr., ibid., p. 211.
32
I fondamenti “naturalistici” della curva dei redditi
21
Loria si concentra invece quasi esclusivamente su Ammon, comunque
con non minore verve critica. La sua è soprattutto una presa di posizione
contro l’idea che la gerarchia economica sia il riflesso della gerarchia intellettuale.
Di tutt’altra natura la ricezione delle teorie antroposociologiche da
parte di Pareto. Egli sembra l’unico economista intenzionato ad accogliere e
discutere le teorie di Ammon, Lapouge e Closson, dissentendo certamente
su molti punti, ma in sostanza legittimando il loro approccio scientifico.
L’autore del Cours riconosce del resto espressamente questo debito intellettuale e la teoria di Lapouge, da quanto risulta da una lettera a Pantaleoni,
era oggetto di lezione all’interno dei suoi corsi di sociologia, anche se spesso edulcorata a causa della presenza di un vasto pubblico femminile35.
Pareto non arriverà mai ad assumere esplicite posizioni “razziali” ed
“eugeniche”; tuttavia la sua antropologia sociale risulta fortemente debitrice
delle concezioni dei fondatori di tale disciplina. Muovendosi tra le maglie di
questa ambigua concezione sociale, egli cerca di districarsi “salvandone” alcuni fili e rigettando quelli ritenuti più farneticanti. In quest’opera di cernita
e distillazione egli fa dei veri e propri salti mortali; forse se ne rende conto,
se è vero, come avremo modo di vedere, che nel Trattato di sociologia cerci
in qualche modo di emanciparsi da questa imbarazzante influenza culturale.
35
Quest’anno ho tutta una panca piena di signore o signorine che vengono ad ascoltare le
mie lezioni. Quindi oggi, discorrendo delle teorie del Lapouge, ho dovuto tacere molte
cose” (V. Pareto a M. Pantaleoni, 2 novembre 1898, in V. PARETO, Lettere a Maffeo
Pantaleoni. 1890-1925, a cura di G. De Rosa, Edizioni di Storia e Letteratura, Roma,
1962, vol. II, p. 246).
22
I fondamenti “naturalistici” della curva dei redditi
3.
L’eterogeneità sociale
L’idea di “eterogeneità sociale” costituisce uno dei fondamentali pila-
stri della concezione paretiana delle gerarchie sociali. Essa è utilizzata in
opposizione all’idea “illuministica” di eguaglianza, a cui Pareto rimprovera
di avere radicato tra gli intellettuali “pregiudizi” che hanno portato “a misconoscere l’eterogeneità degli individui di una stessa società”36. La società
umana, infatti, anziché essere omogenea, “è costituita da elementi che differiscono più o meno, non solo per caratteri evidentissimi, come il sesso, l’età,
la forza fisica, la salute, ecc.; ma anche per caratteri meno facilmente osservabili, ma non meno importanti, come sarebbero le qualità intellettuali, morali, l’attività, il coraggio, ecc.” (Manuale, p. 98). Sono questi i fattori principali da cui deriva la diseguale ripartizione della ricchezza, per comprendere la quale la teoria economica deve far posto all’antropologia sociale, o alla
“fisiologia sociale”, come recita l’ultimo capitolo del Cours.
All’eterogeneità sociale si deve il fatto che le “qualità”, le “capacità” e
le “attitudini” delle persone siano distribuite in modo che alcuni ne
“possiedono […] in misura più eminente di altri”. Da questa diseguale distribuzione dell’intelligenza e in genere delle “qualità psichiche e fisiologiche” discende la disposizione degli individui lungo un continuum sociale ed
economico – privo di fratture o discontinuità37 – a cui corrisponde una gerarchia di reddito e di ricchezza che è tipica di tutte società umane. Essendo il
36
Cours, vol. II, p. 390. Cfr. Manuale, p. 98: “L’asserzione che gli uomini sono oggettivamente eguali è talmente assurda, che non merita neppure di essere confutata. Invece, il concetto soggettivo dell’eguaglianza degli uomini è un fatto di gran momento, e
che opera potentemente per determinare i mutamenti che subisce la società”. Sul concetto di eterogeneità sociale in Pareto, cfr. J.J. SPENGLER, Pareto on Population, II,
“The Quarterly Journal of Economics”, vol. 59, n. 1, Nov., 1944, in particolare pp.
116-122, in cui si discutono anche le teorie degli antroposociologi.
I fondamenti “naturalistici” della curva dei redditi
23
riflesso di un dato antropologico naturale, deve escludersi che la stratificazione economica derivi da cause ambientali, come “l’educazione ricevuta” o
più in generale la “condizione sociale” familiare38.
Per spiegare la distribuzione della ricchezza Pareto ricorre pertanto in
minima parte alle “leggi” dell’economia, preferendo fondare la sua teoria su
concetti antropologici. L’eterogeneità sociale, intesa in questo senso, viene
assunta addirittura alla stregua della legge di gravitazione universale, quale
postulato cioè in grado di spiegare il costante ripetersi del fenomeno nelle
diverse società. È questo il motivo che spinge Pareto ad attribuire alla propria legge dei redditi lo status di legge “naturale”. Confrontandola con la
legge formulata da Keplero per spiegare il movimento degli astri, l’autore
del Cours implicitamente riconosce che anche un fenomeno “sociale” quale
quello della ripartizione della ricchezza sia governato da una legge equivalente a quella che governa il movimento “naturale” degli astri:
il Newton ha fatto certe ipotesi sull’attrazione dalle quali seguono razionalmente,
mediante altre ipotesi, le leggi del Keplero. Si può fare sull’eterogeneità sociale certe
ipotesi dalle quali segue razionalmente la formula trovata empiricamente per le entrate.
Studi posteriori ci sapranno dire se basta quella dottrina dell’eterogeneità sociale per
spiegare tutti i fenomeni, oppure, come è più probabile, quasi certo, se si deve tenere
conto di altre cause (p. 669)
37
38
Cfr. Cours, vol. II, p. 428.
Cours, vol. II, p. 390. Cfr., in proposito, in commento di Busino: “Questa stratificazione sociale, corroborata anche dalla teoria della distribuzione della ricchezza, è fondata
sulla natura degli uomini, non è il prodotto di forze economiche o di speciali capacità
organizzative. Insomma la ineguaglianza (ché in fondo di ciò trattasi) fra gli uomini è
determinata dal possesso di certe qualità psicologiche. Queste qualità personali fanno
sì che certi uomini cercano ed ottengano l’egemonia ed altri debbano necessariamente
subirla” (G. BUSINO, Introduzione a V. Pareto, Trattato, pp. xxv-xxvi.
24
I fondamenti “naturalistici” della curva dei redditi
Pareto dichiara espressamente che la “dottrina della eterogeneità sociale” è tratta in larga parte dagli scritti di “Ammon, Lapouge ed altri antropologi”39. Tuttavia, nel descriverne le manifestazioni, egli prende le distanze
dalle radicalizzazioni in senso razzista dei due fondatori dell’antropologia
sociale. L’autore del Cours ritiene infatti che siano ancora insufficienti i dati
fattuali sui quali si è costruita la dottrina della gerarchia delle razze:
Nulla autorizza a considerare – scrive infatti Pareto – quali caratteri esclusivi, per
differenziare le razze umane, la forma del cranio e il colore dei capelli e degli occhi. Per
parecchi antropologi è un articolo di fede che esista una razza dolicocefala bionda, molto
superiore alle razze brachicefale brune, che sono qualificate “razze inferiori”. Si adducono in prova fatti poco numerosi, spesso mal osservati e accostamenti forzati (Cours, vol.
II, p. 396).
Come si vede, Pareto segue con molta attenzione la letteratura antropologica, ma ritenendo che essa non sia ancora arrivata a proporre rigorosi
criteri di identificazione delle razze. Sull’argomento Pareto intrattiene una
polemica anche con Cesare Lombroso, al quale rimprovera di ricorrere, nei
suoi studi di sociologia criminale, a un approssimativo concetto di razza,
confuso con quello di “etnia”40. In risposta alla replica di Lombroso, che accusava Pareto di essere troppo prigioniero delle teorie di Lapogue, l’autore
del Cours puntualizza che la “questione delle razze è ora fra le più oscure.
C’è chi seguita a discorrere delle antiche razze etniche, c’è chi dice che bi
39
V. PARETO, La curva delle entrate e le osservazioni del prof. Edgeworth, “Giornale
degli economisti”, a. VII, vol. XIII, n. 10, 1896, p. 443.
40
“Sul concetto di ‘razza’ non sono d’accordo gli antropologi. Il Lombroso seguita a discorrere di razze latine, germaniche, ecc., mentre il Lapouge ci ammonisce che: ‘Il est
bien entendu que dans l’état actuel de la science, on ne doit jamais parler de race
latine, race germanique, race slave’. Ecco un primo punto sul quale sarebbe molto desiderabile di avere un esame critico fatto con criteri rigorosamente scientifici” (V.
I fondamenti “naturalistici” della curva dei redditi
25
sogna invece considerare certe razze zoologiche”, sottolineando che il suo il
suo scetticismo è rivolto non solo verso Lombroso ma anche verso Lapouge.
Pareto ritiene comunque che l’argomento vada approfondito con ulteriori
studi, poiché sulla questione delle razze “deve decidere l’esperienza e
l’osservazione, e non è quesito da sciogliersi con una semplice affermazione”41.
Il giudizio complessivo sulle teorie razziali appare dunque in bilico. Da
una parte egli ritiene che tali ricerche abbiano messo in evidenza fattori rimasti a lungo sottostimati dalle scienze sociali; dall’altra ammonisce a non
fare della razza l’unico fattore di spiegazione storica42. Il concetto di eterogeneità sociale che egli dichiara avere tratto da Ammon e Lapouge viene così fortemente ridimensionato, estromettendo i suoi connotati razziali. Il merito di questi autori è quello di avere dissolto il pregiudizio “egualitario” e di
avere nuovamente posto al centro dell’attenzione l’irriducibile diversità degli individui. Tuttavia, “i modi” in cui essi hanno “presentato la dottrina
dell’eterogeneità sociale han pure contribuito, non poco, a farla respingere
da molti” (Cours, vol. II, p. 391). Nelle mani di Pareto l’eterogeneità sociale
diventa invece un principio che intender spiegare i processi di differenziazione muovendo dalle diverse “qualità individuali” e non dalle diverse forme di aggregazione sociale (“razza”, “classe”, “casta”, ecc.) che sono state
41
42
PARETO, L’uomo delinquente di Cesare Lombroso, “Giornale degli economisti”, novembre 1896, ora in ID., Scritti sociologici minori, Utet, Torino, 1980, p. 111-112).
V. PARETO, Polemica col Prof. Lombroso, “Giornale degli economisti”, giugno 1897,
ora in ID., Scritti sociologici minori, cit., p. 120.
Osserva infatti Pareto che per alcuni “autori, come Lapouge, la razza zoologica degli
uomini spiega ogni cosa. Queste è una di quelle cause X che era stata lasciata
nell’ombra. È meritorio averla ben messa in evidenza, senonché esagerandone
l’azione, considerandola unica, non si fa altro se non del romanzo puro” (V. PARETO,
Del materialismo storico, “Zeitschrift für Sozialwissenschaft”, vol. I, 1898, ora in ID.,
Scritti sociologici minori, cit., p. 158).
26
I fondamenti “naturalistici” della curva dei redditi
di volta in volta proposte43. Secondo Pareto sono pertanto “insostenibili” sia
le teorie che ipotizzano la preminenza di certi aggregati sociali su altri sia
quelle, di segno opposto, che presumono “gli uomini tutti uguali” alla nascita e che ascrivono le differenze sociali “unicamente all’educazione ricevuta e alla condizione sociale” (Cours, vol. II, p. 390).
L’antropologia sociale di Pareto punta in sostanza sul fatto che vi sono
differenze “innate” tra gli individui dalle quali non può che discendere la diseguale distribuzione della ricchezza descritta dalla curva dei redditi. In questo senso è da intendersi il “naturalismo“ di Pareto, dovuto al fatto che egli
spiega questa gerarchia di ricchezza e di status solo in parte con argomenti
socio-economici, privilegiando invece quelli antropologici. L’eterogeneità
sociale è la legge primordiale della specie umana e
a quelle disuguaglianze proprie dell’essere umano corrispondono disuguaglianze
economiche e sociali, le quali si osservano presso tutti i popoli, dai tempi più antichi ai
moderni, ed in qualsiasi luogo del globo, per modo che, tale carattere non mancando mai,
la società umana si può definire una collettività con gerarchia (Manuale, p. 268).
43
“Dire che esistono nella società uomini che possiedono certe qualità in misura più
eminente di altri e dire che esiste una classe di uomini assolutamente migliori del resto
della popolazione non è già la stessa cosa” (Cours, vol. II, p. 392).
I fondamenti “naturalistici” della curva dei redditi
27
4.
La selezione sociale
Il secondo concetto di natura antropologica utilizzato da Pareto è quello
di “selezione sociale”44. Anche in questo caso l’autore del Cours prende
esplicita ispirazione dalle teorie antroposociologiche, ma di nuovo cercando
di espungere le parti a contenuto razziale.
Il testo dove maggiormente sviluppa l’idea di selezione sociale è senza
dubbio Les systèmes socialistes. Anche nel Cours e nel Manuale vi sono
ampi rimandi agli effetti esercitati dalla selezione sui processi di distribuzione della ricchezza e di differenziazione sociale, ma è sopratutto nel libro
pubblicato tra il 1901 e il 1902 che a tale argomento viene dato ampia visibilità. L’idea di selezione sociale verrà invece meno quando Pareto metterà
mano al Trattato di sociologia generale.
La “selezione” è intesa da Pareto come un processo che opera con
uguale intensità sia sul piano “naturale” che su quello “sociale”. Senza le
sue leggi verrebbe meno uno dei principali meccanismi di preservazione degli organismi vitali. Nelle società umane, in particolare, la selezione ha un
“duplice scopo”: da una parte di collocare gli individui nel posto a loro confacente nella gerarchia sociale; dall’altra di eliminare quei soggetti inetti ed
incapaci che potrebbero minare la sopravvivenza degli aggregati sociali (Systèmes, p. 541). Per quanto riguarda il primo fine, Pareto ritiene che esso
possa essere perseguito lasciando agire le leggi del mercato e della concorrenza, come vedremo discutendo la concezione paretiana delle élite. Il rag
44
Sulla “selezione naturale” in Pareto, cfr. J.J. SPENGLER, Pareto on Population, II, cit.,
pp. 116-122; A. MACCHIORO, Vilfredo Pareto, in ID., Studi di storia del pensiero economico e altri saggi, Feltrinelli, Milano, 1970, pp. 568-569; A. LEGRIS, La distribution des revenus chez Walras et Pareto: une analyse comparative, in Les traditions économiques françaises 1849-1939, sous la direction dé P. Dockès, L. Frobert, G.
Klotz, J.-P. Potier e A. Tiran, Paris, Cnrs Editions, 2000, pp. 512-514.
28
I fondamenti “naturalistici” della curva dei redditi
giungimento del secondo scopo della selezione è invece più complesso. “Vi
sono individui”, scrive Pareto, “che possono essere decisamente nocivi e pericolosi per la società”, […] ed è grazie alla selezione, che questi rifiuti sono
eliminati e la specie si conserva”. Come nella natura, anche nella società la
selezione contribuisce alla distruzione degli “elementi inferiori” e impedisce
“ch’essi si riproducano nei loro discendenti” (Systèmes, pp. 540-542). Se
questo non accadesse, se cioè “la razza umana” non fosse investita dalla
legge di “selezione”, essa non potrebbe salvarsi “dal decadere” (Manuale, p.
299). Ma il problema è “come” eliminare gli elementi ritenuti “inferiori”.
Vi sono al riguardo due meccanismi, uno “diretto” e uno “indiretto”. Il
primo ha una efficacia “incontestabile” nel regno animale e vegetale, come
ben sanno “allevatori e coltivatori”: attraverso la selezione “diretta” non solo
si distruggono direttamente “gli elementi inferiori, ma, cosa ancora più importante, se impiegata in tempo, impedisce anche ch’essi si riproducano nei
loro discendenti” (Systèmes, p. 542). Nella società umane risulta invece
molto difficile attuare questa forma di selezione, e i tentativi che vanno in
quella direzione proposti da Ammon e Lapouge vengono condannati da Pareto45. È necessario quindi ricorrere alla selezione “indiretta”, la quale ha
45
Nel Cours Pareto si rammarica che “uno spirito distinto come il Lapouge” sia arrivato
a immaginare una società “eugenica” nella quale la “selezione della razza” non avviene solo attraverso l’eliminazione fisica degli elementi inferiori ma anche “imponendo”
l’esercizio del dovere sessuale solo agli individui “scelti”. Lapouge immaginava che
per realizzare tali obiettivi fosse necessario organizzare in modo socialistico la società,
argomento che permette a Pareto di sottolineare la propria disapprovazione. Dichiarata
infatti la propria “ripugnanza” per le soluzioni avanzata da Lapouge, aggiunge che esse sono comunque istruttive su dove “sbocchi la via, che, iniziata con i monopoli di
Stato, proseguita con i sindacati obbligatori, l’assicurazione obbligatoria,
l’organizzazione collettiva della produzione e la costituzione di uno Stato provvidenza, adduce alla distruzione di ogni iniziativa individuale, all’annientamento di ogni dignità umana e riduce gli uomini al livello di un gregge di montoni (Cours, vol. II, p.
394).
I fondamenti “naturalistici” della curva dei redditi
29
“parecchi mezzi”, anche se purtroppo “molto imperfetti”, attraverso cui eliminare “gli elementi inferiori”.
Di questi “mezzi” Pareto ne ricorda alcuni: il sistema penale di reclusione e di soppressione degli individui pericolosi; i differenti tassi di mortalità e natalità delle diverse classi sociali, che contribuiscono a sopprimere
“in gran numero gli individui deboli e mal formati”; le abitudini viziose che
attraggono gli individui degenerati, come ad esempio l’alcolismo, che accelera la loro “degenerazione” e quella dei loro discendenti.
Tutte queste diverse forme di selezione raggiungono, se pur in modo
imperfetto, il fine di sopprimere gli individui non adatti. Esse incontrano però un grosso ostacolo sulla loro strada: il tarlo “umanitario” che si sarebbe
insinuato presso utopisti, riformatori ed élite degenerate. Agli occhi di Pareto, le riforme di carattere “sociale” impediscono alla selezione di svolgere
compiutamente il proprio scopo. Nella condanna dell’umanitarismo e del
sentimentalismo c’è una totale comunanza di vedute con Ammon e Lapouge. Gli umanitari e i riformatori, scrive Pareto, perseguono infatti
“disperatamente” il fine del “miglioramento degli individui di qualità inferiore”, non rendendosi conto che “ogni speranza nutrita in questo proposito è
stata sempre delusa” (Cours, vol. II, p. 552). Il loro errore nasce dal non
voler
ammettere che nella specie umana, come in tutte le specie di esseri viventi, gli individui non nascono uguali, hanno caratteri diversi, e certi individui sono andati
all’ambiente in cui vivono, altri no. Si crede facilmente ciò che si desidera. Gli umanitari
30
I fondamenti “naturalistici” della curva dei redditi
non studiano il mondo reale qual è; si foggiano un mondo immaginario, quale i loro sentimenti desiderano46.
Citando con approvazione Lapouge, Pareto sottolinea inoltre il modo
perverso in cui si vorrebbe estendere a tutti l’educazione, tendenza che sta
prendendo piede in molte società moderne, ma giudicato totalmente inefficace.
46
Systèmes, p. 554. Cfr. anche Manuale, p. 299: “Gli umanitari possono bene chiudere
gli occhi per volontariamente ignorare questa verità, ma ciò non muta nulla ai fatti. In
ogni razza nascono elementi di scarto, che debbono essere distrutti dalla selezione. I
dolori di quella selezione sono il riscatto del mantenersi e del perfezionarsi la razza;
ed è uno dei tanti casi in cui il bene dell’individuo è in contrasto col bene della specie”.
I fondamenti “naturalistici” della curva dei redditi
31
5.
La selezione e la forma delle gerarchie sociali
La selezione ha poi effetti molto importanti sulla forma delle gerarchie
sociali e sul modo in cui si ripartiscono le ricchezze. Pareto si avvale infatti
del meccanismo selettivo che opera negli strati inferiori della società per
spiegare la discordanza tra la curva dei redditi e la curva delle attitudini.
Quest’ultima, come abbiamo ricordato, è sempre stata ritenuta, da Quetelet e
Galton in poi, una curva “normale“, simmetrica rispetto al valore medio e
modale. La curva dei redditi, diversamente, presenta una forte asimmetria,
che Pareto cerca di giustificare avvalendosi appunto della teoria della selezione.
Nel Cours Pareto si era avvalso dell’immagine della “freccia” per tradurre figurativamente l’idea della gerarchia sociale (in sostituzione
all’immagine della “piramide”, ritenuta impropria). Il particolare accorgimento grafico che gli permette di ottenere la punta della “freccia” consiste
nel far ruotare la curva di redditi attorno all’asse delle ordinate, così da generare un corpo solido dall’aspetto della figura sottostante.
32
I fondamenti “naturalistici” della curva dei redditi
L’immagine della “freccia” viene tuttavia abbandonata da Pareto. Già
nel Cours, ad essa comincia ad affiancare quella della “trottola”47, ritenendo
inizialmente le due figure equivalenti48. Ma nelle opere successive la
“freccia” verrà definitivamente sostituita dalla “trottola”, anche perché essa
gli permetterà di accogliere alcune critiche che erano state rivolte alle sue
prime rappresentazioni geometriche della distribuzione della ricchezza49. Il
passaggio dalla metafora della “freccia” a quello della “trottola” segna
l’acquisizione da parte di Pareto dell’idea che la curva dei redditi, nella zona
inferiore, abbia un andamento opposto a quello della parte superiore. Attraverso l’immagine della “trottola” egli riesce pertanto a incorporare nella descrizione figurativa della gerarchia sociale anche la forma della parte inferiore.
Nelle opere successive al Cours, la rappresentazione proposta da Ammon, che era stata inizialmente criticata, viene rivalutata, fino a diventare
decisivo punto di riferimento nei Sistemi socialisti e nel Manuale. Scrive infatti Pareto che “ciò che si chiama piramide sociale è in realtà, una specie di
trottola”, quale quella “indicata da Otton Ammon, che ci pare assai probabile” (Systèmes, p. 19).
47
Cfr. R. ROY, Pareto statisticien: la distribution des revenus, “Revue d’économie
politique”, 1949, a. LIX, pp. 555-577.
48
Osserva infatti che la distribuzione della ricchezza, assume la forma non “già d’una piramide […], ma invece d’un corpo che ha la forma della punta di una freccia o, se si
preferisce, della punta d’una trottola” (Cours, vol. II, p. 346).
49
Il balletto delle diverse immagini è legato in particolare al problema della parte inferiore della gerarchia sociale. Tanto la “piramide” quanto la “freccia” sottintendono una
relazione tra il reddito e il numero di persone che dispongono dei diversi livelli di reddito che è sempre inversa, e che mostra appunto una concentrazione del maggior numero di persone nella parte più bassa della gerarchia sociale. Pareto. Pareto aveva
chiarito al riguardo che non esistevano sufficienti riscontri empirici per spiegare la dinamica dei redditi più bassi.
I fondamenti “naturalistici” della curva dei redditi
33
Il dato da sottolineare è come Pareto modifichi nel Manuale la rappresentazione grafica della curva, che viene disegnata riportando un andamento
simile a quello delle binomiali asimmetriche.
Se nel Cours il disegno della curva mostrava
un andamento sempre decrescente, che si interrompeva bruscamente al livello della sussistenza per assumere l’aspetto di una retta orizzontale, nel Manuale la rappresentazione assume
la veste di una curva binomiale asimmetrica.
La nuova rappresentazione grafica permette
all’autore del Manuale di discutere più nel
dettaglio il motivo della discordanza tra la curva delle attitudini e la curva dei redditi, essendo appunto la prima simmetrica intorno alla media e la seconda caratterizzata da una profonda asimmetria. Pareto chiarisce che “la curva non è punto
simmetrica intorno” alla media; “la parte superiore” risulta essere “molto
lunga” e la parte inferiore “quasi schiacciata”, con un andamento fortemente
asimmetrico rispetto alla parte superiore. Ma “da ciò non si può concludere
che non vi è simmetria tra le qualità degli individui che si allontanano da
una parte o dall’altra della media”. A intralciare il parallelismo è la circostanza che in fatto di distribuzione del reddito esiste un limite verso il basso
oltre il quale non è possibile scendere, assente nella parte superiore della
scala: “invero, di due uomini che si scostino egualmente dalla media delle
qualità, quello che ha attitudini eccezionali per guadagnare quattrini può ottenere un’entrata altissima; e quello che ha qualità negative eguali non può
cadere, senza sparire, al di sotto dell’entrata minima che basta a sostenere la
vita”(Manuale, p. 271).
34
I fondamenti “naturalistici” della curva dei redditi
Al di sotto del reddito minimo vitale, dunque, opera il processo selettivo attraverso cui vengono eliminati gli elementi inferiori, altrimenti nocivi
per la società. Ciò spiega perché gli individui che hanno attitudini molto al
di sotto della media non compaiono nella statistica dei redditi, appunto per
la loro incapacità di raggiungere la sussistenza. Per sussistere nella zona inferiore della gerarchia sociale ed economica sono necessarie in sostanza attitudini almeno vicine alla media, poiché quelle di molto inferiori metterebbero in azione i meccanismi di selezione.
È da ricordare ancora un ulteriore concetto antropologico che Pareto
discute nel Manuale in modo speculare rispetto al concetto di selezione: si
tratta del concetto di “stabilità”50. A parere di Pareto la società umana è retta
infatti da due principi basilari. Il primo è la “stabilità”, che opera attraverso
la persistenza del passato e della tradizione e a cui contribuisce tra gli altri
l’istituto dell’eredità. Portato al suo estremo, l’elemento di stabilità non fa
che “cristallizzare” tutti i rapporti sociali, come accade negli organismi sociali “con caste rigidamente costituite”. Il secondo principio è invece quello
della “selezione”, o della “mutabilità”, che opererebbe con la sua massima
forza quando fossero sciolte tutte le costrizioni del passato, così da lasciare i
destini degli individui del tutto indipendenti dalle condizioni familiari. La
combinazione dei due principi è ciò che caratterizza le “società moderne”,
dato che in esse opera sia “l’elemento di stabilità”, garantito “dalla proprietà
50
Anche in questo caso, i concetti sono tratti dall’antropologia sociale, ma modificandone il significato. Come abbiamo visto, Closson, nel suo saggio sulla “selezione sociale”, aveva proprio enfatizzato le due forze contrapposte della “conservazione” e
dell’“evoluzione”. Il discorso di Closson verte però sui meccanismi biologici di trasmissione dello stock razziale, mentre Pareto traduce questo processo sul piano economico e sociale analizzando gli effetti dell’eredità patrimoniale. Il saggio di Closson,
è comunque ritenuto da Pareto “un importante contributo” (cfr. V. PARETO, The New
Theories of Economics, “The Journal of Political Economy”, vol. V, n. 4, sep. 1897, p.
502).
I fondamenti “naturalistici” della curva dei redditi
35
privata e dall’eredità”, sia “l’elemento di mutabilità e di selezione”, assicurato “dalla facoltà concessa a tutti di salire quanto è possibile nella gerarchia
sociale” (Manuale, p. 301).
Questi dati oggettivi potrebbero quindi fornire preziosissime armi ai riformatori sociali. Se infatti essi dimostrassero che l’istituzione dell’eredità,
operando esclusivamente sul fattore della “stabilità”, preclude ogni possibilità di azione al meccanismo della “selezione”, avrebbero con ciò stesso
provato la “necessità di restringere, od anche togliere, quell’istituzione”. È
invece singolare, afferma Pareto, “che i socialisti non abbiano scorto l’aiuto
che tale modo di considerare i fenomeni poteva recare alle loro dottrine”
(Manuale, pp. 304-305).
Egli riconosce che nulla indica che lo stato attuale di trasmissione delle
ricchezze “sia perfetto”, o “che debba durare indefinitamente”. Non ci sono
ragioni “economiche” che impediscono di assumere come plausibile
un’ipotesi di intervento redistributivo che sappia togliere in modo efficace
“qualche genere di proprietà privata” o addirittura sopprimere, “in parte od
in tutto, l’eredità”. L’unica certezza sul piano sociale è che verrebbe “molto
affievolito l’elemento di stabilità e rinvigorito l’elemento di mutabilità e di
selezione”. Ma non si può tuttavia “a priori decidere se ciò sarebbe utile o
dannoso alla società” (Manuale, p. 301).
L’agnosticismo velato dietro il giudizio di Pareto è in verità solo apparente. Stabilità e selezione contengono tanto elementi positivi che negativi;
entro certi limiti, rinvigorire una delle due forze sociali può portare a decisi
miglioramenti, non dimenticando però che superata una certa soglia gli effetti positivi verrebbero sopraffatti da effetti di segno opposto. Abbattere
d’un colpo il principio della stabilità, ad esempio attraverso un’abolizione
dell’istituto ereditario, vorrebbe dire fare emergere tutti i lati negativi della
36
I fondamenti “naturalistici” della curva dei redditi
mutabilità, la quale se “spinta all’estremo è penosissima all’uomo, lo disgusta, lo avvilisce, e quindi ne riduce al minimo l’attività”. Quegli stessi che
reclamano l’uguaglianza di condizioni sarebbero poi i primi, secondo la nota
legge della circolazione delle élites, a cercare di consolidare i nuovi vantaggi
acquisiti: “Chi sta peggio di un altro, desidera naturalmente mutare condizione, ma, appena conseguito l’intento, desidera anche maggiormente di
conservare ciò che ha acquistato e di rendere stabile la sua condizione. Le
società umane hanno una fortissima tendenza a dare rigidità ad ogni nuovo
ordinamento, a cristallizzarsi in ogni nuova forma” (Manuale, p. 302).
Insomma, l’opinione di Pareto è che la dialettica tra stabilità e selezione sia la sola che permette all’organismo sociale di persistere, nonostante ci
possano essere momenti transitori in cui uno dei due fattori acquista il sopravvento sull’altro, per poi riportarsi in equilibrio. Stando così le cose, il
fatto che l’eredità permetta a qualche discendente degenere di occupare una
posizione sociale non conforme alle sue attitudini è il minore dei mali. Un
sano organismo sociale permetterà agli “eletti” delle classi inferiori di prendere il posto dei “degeneri” delle classi superiori, e questo movimento potrà
realizzarsi anche quando, sul piano materiale della ricchezza, le condizioni
iniziali delle classi siano profondamente disuguali.
I fondamenti “naturalistici” della curva dei redditi
37
6.
L’antropologia delle élite
Altrettanto importanti sono gli spunti che Pareto trae dalla letteratura
antropologica nel formulare la propria teoria della circolazione delle élite51.
L’idea che vi sia un perpetuo “avvicendarsi” di queste élite è senza dubbio
un concetto che l’autore del Cours condivide con Lapouge e Ammon. Ed è
lo stesso Pareto, in risposta a chi insinua che la sua teoria sia un plagio delle
idee di Gaetano Mosca, a puntualizzare che “dal Mosca non ho preso niente.
Ho bensì preso molto, moltissimo, e l’ho detto chiaramente, […]
dall’Ammon, e un poco anche dal Lapouge. Gli studiosi possono vedere peraltro come in parte da loro dissento e cosa ho aggiunto”52. Di nuovo troviamo quindi Pareto intento a precisare la cernita compiuta sulle concezioni
antroposociologiche, dalle quali cerca, per quanto possibile, di distillare le
componenti ritenute presentabili.
51
La teoria della “circolazione delle élite”, a cui Pareto dà forma più compiuta nei Sistemi socialisti e poi nel Trattato, compare in nuce anche in un brano del Cours, dove si
contrappone la stabilità della forma “esteriore” della gerarchia sociale ai continui stravolgimenti che avvengono al suo “interno”: “Sappiamo – scrive Pareto – che la forma
della curva non varia che molto lentamente. Si può dunque supporre che tale forma sia
quasi costante, in media, e per un tratto di tempo abbastanza lungo. Ma le molecole di
cui l’aggregato sociale si compone, non si mantengono in riposo: degli individui si arricchiscono, altri impoveriscono. Movimenti abbastanza estesi agitano dunque
l’interno della figura. L’organismo sociale assomiglia in ciò ad un organismo vivente.
La forma esterna di un organismo vivente, un cavallo ad esempio, si mantiene quasi
costante, ma all’interno avvengono movimenti ampi e svariati. La circolazione del
sangue fa muovere rapidamente certe molecole; i processi di assimilazione e di secrezione modificano incessantemente le molecole di cui si compongono i tessuti” (Cours,
vol. II, p. 397). L’analogia proposta in questo brano è come si vede di fondamentale
importanza per comprendere la genesi della teoria della circolazione delle élite, su cui
E. RIPEPE, Le origini delle teoria della classe politica, Giuffré, Milano, 1971.
52
V. Pareto a G. Prezzolino, 17 dicembre 1903, in V. PARETO, Epistolario. 1890-1923, a
cura di G. Busino, Accademia Nazionale dei Lincei, Roma, 1973, vol. I, p. 507. Cfr.
anche Manuale, p. 229, dove Pareto menziona le ricerche di Ammon e Lapouge come
“conferma scientifica” del fatto che “la storia della società umana è, in gran parte, la
storia dell’avvicendarsi di aristrocrazie”, e Systèmes, p. 131.
38
I fondamenti “naturalistici” della curva dei redditi
Chi sono dunque, nella concezione paretiana, gli individui “scelti”, un
termine echeggiante il concetto di razza “scelta” di Gobineau ma da cui Pareto espunge il significato razziale? Scrive Pareto che “per ‘soggetti scelti’
intendiamo semplicemente individui la cui attività di vita è più intensa”
(Cours, vol. II, p. 416). È quindi da abbandonare, fino a quando non si
avranno riscontri empirici attendibili53, l’idea che i soggetti “scelti” possiedano specifiche caratteristiche antropologiche:
Ammon e de Lapouge specificano troppo quando vogliono darci i caratteri antropologici di questa élite, di queste razze eugeniche, identificandole coi dolicocefali biondi.
Per ora, questo punto rimane oscuro, e lunghi studi sono ancora necessari, prima di poter
stabilire se le qualità psichiche delle élite si traducono in caratteri esteriori, antropometrici, e poter conoscere quali sono precisamente questi caratteri” (Systèmes, p. 133).
Avendo escluso che siano i tratti antropologici a identificare le élite,
Pareto specifica che il loro riconoscimento non può che avvenire sulla base
delle loro capacità e delle loro azioni. L’operare della “mano invisibile” del
mercato, in particolare, è ritenuto dall’autore del Cours il meccanismo meno
imperfetto che le società umane abbiano escogitato per “selezionare” gli individui più capaci. Questo processo sarebbe certamente più semplice se si
volesse accreditare la teoria delle razze elette di Lapouge, che Pareto ricollega a quella di Platone (dove “la razza d’oro”, nella versione
dell’antropologo francese, “sarebbe quella dei dolicocefali biondi”):
53
Questa sospensione del giudizio sulle teorie dell’antropologia sociale, da lasciare alla
verifica dei fatti, ricorre in diverse circostanze nell’opera di Pareto. A proposito della
tesi sostenuta da Lapouge, ad esempio, che nell’antica Roma, le élite siano decadute a
causa di “un esaurimento di eugenici, di uomini di razza superiore”, Pareto commenta:
“Mancano i fatti per accogliere o respingere assolutamente questa opinione” (Systèmes, p. 157).
I fondamenti “naturalistici” della curva dei redditi
39
Se, infatti, da alcuni segni esteriori, come la forma del cranio, il colore dei capelli,
degli occhi, ecc., si potessero riconoscere i caratteri e le attitudini degli uomini, il problema della migliore organizzazione sociale sarebbe facilmente risolto. Sfortunatamente,
queste teorie hanno rapporti ancora incerti con la realtà, e per il momento non si conosce
altro mezzo di scegliere gli uomini, se non quello di provare che cosa sanno fare, mettendoli in concorrenza gli uni con gli altri. Ciò ha luogo, sebbene in modo assai imperfetto,
nelle nostre società, e la storia ci mostra che i loro progressi sono stati intimamente legati
all’estensione di quest’uso (Systèmes, p. 342).
Soprattutto, però, la differenza con le teorie antroposociologiche si gioca sull’idea che gli individui provenienti dal “basso” possano inquinare le
aristocrazie, concetto che Pareto rigetta sistematicamente. Ai suoi occhi sono invece proprio questi soggetti che permettono al sistema sociale di rinnovarsi continuamente. Contro l’idea propugnata da Lapouge che gli individui
“scelti” dovrebbero organizzarsi in caste chiuse, in modo da riprodurre sempre soggetti con le stesse caratteristiche di superiorità, gioca la stessa selezione sociale, al quale l’antropologo francese dà tanta importanza ma senza
trarne le necessarie conseguenze. La selezione è infatti “un agente” che
permette
ai soggetti scelti, nati negli strati inferiori, l’accesso negli strati superiori. La formazione delle caste è contraria a questa selezione ed è quindi un possente agente di decadenza. Degli autori moderni, alla ricerca di novità, sono stati colti da un grande amore
per l’istituzione delle caste indiane. Questi autori non ci spiegano come mai
un’organizzazione tanto eccellente non abbia impedito che le Indie diventassero preda di
numerosi conquistatori, privi tutti di caste, né come alcune migliaia di inglesi bastino a
mantenere il dominio britannico su di una paese che conta circa duecento milioni di abitanti (Cours, vol. II, pp. 416-417).
Nella concezione paretiana ampio risalto viene quindi dato proprio ai
gradini più bassi della gerarchia sociale. Nemmeno la disuguale distribuzio
40
I fondamenti “naturalistici” della curva dei redditi
ne della ricchezza impedisce ai soggetti “forti” delle classi inferiori di emergere. Solo un reddito inferiore alla sussistenza impedisce alla selezione di
operare, in quanto “la miseria avvilisce e distrugge i buoni come i cattivi
elementi”. Ma appena al di sopra della sussistenza “la selezione opera col
massimo d’intensità. Le entrate non sono assai abbondanti per salvare tutti
gli elementi, siano essi atti o no alla lotta sociale, e non sono tanto scarse da
deprimere i migliori elementi”. La zona inferiore della gerarchia economica
è quindi “il crogiuolo ove si elaborano le future aristocrazie”, fonte continua
di “elementi che salgono nella regione superiore”54.
Nel complesso quindi è senza dubbio vero che la ricchezza sia indice di
“superiorità”55. Tuttavia l’esperienza dimostra che presso gli strati inferiori
esistono spesso individui maggiormente dotati di quelli delle classi superiori. “Chiunque abbia un po’ frequentato gli operai sa che s’incontrano tra di
loro individui ben più intelligenti di quel tale o tal altro scienziato onusto di
titoli accademici”. Un fatto questo, puntualizza Pareto, che riduce molto
l’attendibilità delle ricerche compiute da de Candolle o da Galton sulle genealogie degli uomini di genio (Cours, vol. II, p. 396).
Non è del tutto chiara l’opinione di Pareto sulla trasmissibilità ereditaria dei caratteri “superiori”. Nel complesso, sembra di poter dire che egli
non condivida l’idea degli antroposociologi che le qualità innate si trasmettano ai discendenti. Non si spiegherebbe altrimenti la dura critica all’ipotesi
di istituire caste “chiuse” riservate alle élite e alle loro progenie. E non è
nemmeno chiara l’opinione di Pareto a proposito della misurabilità delle
qualità umane. Egli sembra talvolta accogliere quest’ipotesi, in particolare
54
Manuale, p. 273; Cours, vol. II, p. 414.
I fondamenti “naturalistici” della curva dei redditi
41
quando riconduce la distribuzione della ricchezza alla disuguale distribuzione delle attitudini56; nel Trattato di sociologia egli sembra però superare
quest’impostazione, adattando una strategia simile a quella attuata nel caso
dell’utilità. Anche nel caso della distribuzione delle attitudini, si potrebbe infatti dire che Pareto abbandoni la “cardinalità” a favore di un approccio
“ordinalista”:
Supponiamo – scrive Pareto – che, in ogni ramo dell’umana attività, si assegni a
ciascun individuo un indice che indichi la sua capacità, all’incirca come si danno i punti
negli esami. […] Facciamo dunque una classe di coloro che hanno gli indici più elevati
[…] alla quale daremo il nome di classe eletta (élite). […] Nel concreto, non ci sono gli
esami per assegnare a ciascun individuo il suo posto in queste varie classi e si supplisce
con altri mezzi: con certi cartellini che, alla meglio, raggiungono questo scopo (Trattato,
vol. III, pp. 1043-1046).
Pareto esclude che nelle società moderne questi cartellini che identificano socialmente le qualità “superiori” si trasmettano per eredità. Permane
però l’ereditarietà della “ricchezza”, la quale costituisce un grosso fattore di
disturbo nella formazione delle gerarchie sociali, assegnando in modo improprio i “cartellini” che identificano le élite. L’eredità, pur essendo scomparsa nelle forme “dirette” del passato,
rimane ancora potente indirettamente e chi ha ereditato un gran patrimonio, facilmente è nominato senatore in certi paesi o si fa eleggere deputato, pagando gli elettori e
55
“Le classi dette superiori sono generalmente anche le più ricche. Queste classi costituiscono un’élite, una aristocrazia (nel senso etimologico: αριστος = migliore)” (Systèmes, p. 131).
56
Cfr., ad esempio, V. PARETO, Aggiunta allo studio sulla curva delle entrate, cit., p. 17,
dove Pareto discute il fatto che “La curva delle entrate è in qualche dipendenza colla
legge della ripartizione delle qualità psichiche e fisiologiche tra un certo numero di
individui”, distribuzione che appunto segue un andamento come quello supposto da
Ammon.
42
I fondamenti “naturalistici” della curva dei redditi
lusingandoli, se occorre, col dimostrarsi democratico sbracciato, socialista, anarchico. La
ricchezza, le parentele, le relazioni, giovano pure in molti altri casi, e fanno porre il cartellino della classe eletta in genere o della classe eletta di governo in particolare a chi non
lo dovrebbe avere57.
Non si può negare, in conclusione, che durante il tragitto intellettuale
che conduce al Trattato di sociologia si intravede un graduale abbandono
dei riferimenti alla letteratura antroposociologica. L’eterogeneità sociale rimane un principio basilare della concezione di Pareto, ma definitivamente
emancipata dalla dottrina razziale di Ammon e Lapouge; e per quanto riguarda la teoria della selezione sociale, essa scompare addirittura dal novero
delle questioni oggetto di analisi all’interno del Trattato.
Un mutamento di prospettiva, da questo punto di vista, che emerge in
modo ancora più palese analizzando i testi preparatori al Trattato. Nel Programma e sunto di un corso di sociologia, redatto nel 1905, troviamo ancora, tra gli autori indicati come fondamentali per affrontare il problema delle
gerarchie sociali, Ammon e Lapouge58; e nel capitolo sulle gerarchie sociali
57
Trattato, vol. III, p. 1046. Anche nel Cours Pareto aveva sottolineato l’influsso esercitato dall’istituto ereditario nel permettere agli individui che ereditano “una fortuna” di
collocarsi “in una classe diversa da quella in cui le porrebbero le loro capacità”
(Cours, vol. II, p. 413). Tuttavia egli non sembra dare eccessivo peso all’influsso che
la successione ereditaria, e la conseguente diversa dotazione patrimoniale dei soggetti,
esercita sulla distribuzione finale in termini di reddito, tanto da soprassedere sulla
questione dei rapporti esistenti tra distribuzione dello stock di ricchezza e distribuzione del reddito. Il motivo che spiega l’atteggiamento tenuto da Pareto su questo punto è
da ricondurre essenzialmente alla sua concezione della “mobilità sociale”: una volta
abbattuti gli steccati che nella società di antico regime impedivano l’ascesa, o la discesa, dalla scala sociale, la selezione e la circolazione delle élite fanno si che siano sempre gli stessi individui a occupare i diversi gradi della gerarchia sociale. L’ammontare
di “ricchezza” posseduta e la classe sociale d’origine non sono in altre parole fattori
determinanti in modo esclusivo la collocazione in termini di “reddito” nell’ambito
della curva di distribuzione.
58
Cfr. V. PARETO, Programma e sunto di un corso di sociologia, 1905, ora in ID., Scritti
sociologici minori, cit., p. 298.
I fondamenti “naturalistici” della curva dei redditi
43
di quello che avrebbe dovuto essere il Manuale di sociologia, redatto presumibilmente intorno agli anni dieci, le reminiscenze di tali autori emergono
ancora chiaramente tra le righe. Nel Trattato di sociologia, diversamente, le
tracce dell’antropologia sociale risultano praticamente dissolte.
Tutto questo comporta però un problema non indifferente nella valutazione del pensiero paretiano sulle gerarchie sociali. Attraverso la sua legge
dei redditi egli aveva stilizzato una sorta di “scheletro” della società. Nello
spiegare le forze che fanno muovere questo scheletro, cioè il suo apparato
“nervoso” e “muscolare”, l’autore del Cours si era gettato a capofitto nella
letteratura
antropologica,
abbandonando
il
terreno
dell’economia.
L’antropologia sociale aveva quindi fatto da ponte tra la componente economico-statistica della curva dei redditi e la dimensione sociologica. Il venir
meno del fondamento antropologico ci sembra abbia in sostanza incrinato
quell’unità di fondo che inizialmente caratterizzava la ricerca di Pareto sulle
gerarchie sociali e sulla distribuzione della ricchezza, avendo lasciato un
vuoto tra la descrizione economico-statistica dello “scheletro” e la spiegazione “sociologica” dell’apparato “nervoso” e “muscolare”, ridottesi alla
teoria sociologica e politica delle “élite”.
44
I fondamenti “naturalistici” della curva dei redditi