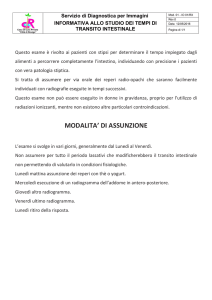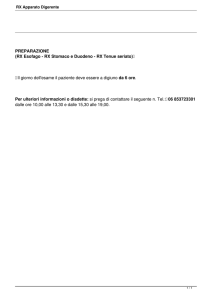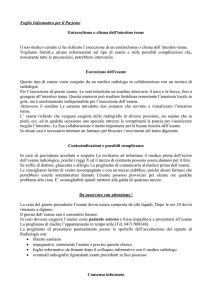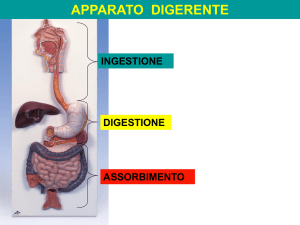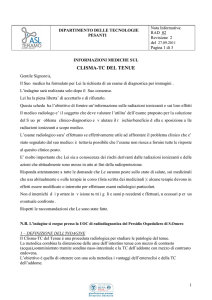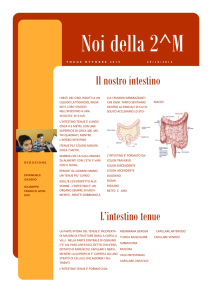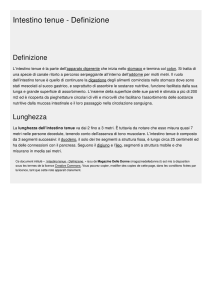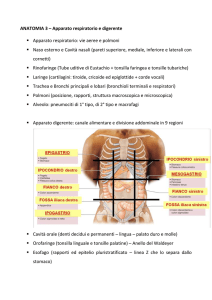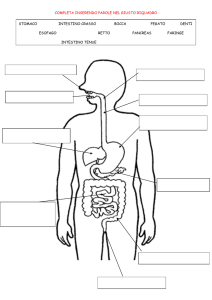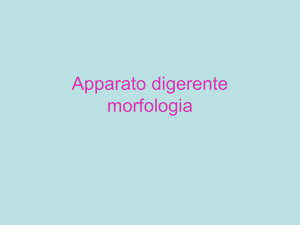TUBO DIGERENTE:
INTESTINO
G. Mazzoni
Tecniche di Radiodiagnostica (MED/50)
A.A. 2015-2016
TUBO DIGERENTE:
INTESTINO TENUE
G. Mazzoni
Tecniche di Radiodiagnostica (MED/50)
A.A. 2015-2016
Tenue: riferimenti anatomici
Comprende quella porzione del
tubo digerente estesa tra
stomaco ed intestino crasso ed è
costituita da tre segmenti:
duodeno, digiuno ed ileo
Il duodeno viene valutato
distintamente per le sue peculiari
caratteristiche morfologiche e
funzionali; il digiuno ed ileo
costituiscono il cosiddetto
intestino mesenteriale che inizia
dall’angolo del Treitz e termina
nello sfintere ileo-cecale in un
ventaglio di anse, lunghe circa 6
metri, che rimangono adese alla
parete posteriore dell’addome dal
mesentere
Lo sviluppo del tenue è tale che la
parte digiunale occupa
prevalentemente i quadranti
superiore e medio di sinistra,
mentre la parte ileale si dispone
nei quadranti medio ed inferiore di
destra
Intestino tenue mesenteriale e crasso
Magnaldi fig. 236 pag. 274
Tenue: riferimenti anatomici
Il digiuno presenta un rilievo
mucoso caratteristico, ricco di
valvole conniventi, cioè pliche
mucose brevi e curvilinee, che
diventano meno frequenti
passando verso l’ileo
prossimale per scomparire a
livello terminale
Sulla superficie di queste
valvole si trovano delle villosità
o «villi intestinali» cui
competono i processi digestivi e
di stimolo al transito del
contenuto intestinale. Anche
essi sono di forma e numero
variabile, più abbondanti nella
porzione superiore del tenue
rispetto a quella inferiore
Clisma a doppio contrasto dell’intestino tenue
1: pliche conniventi – 2: sondino naso-diguinale nei vari
tratti attraversati (dallo stomaco all’angolo del Treitz) – 3:
anse digiunali – 4: anse ileali – 5: colon ascendente
Magnaldi fig. 237 pag. 275
Tenue: riferimenti funzionali
L’attività motoria del digiuno-ileo si
distingue in tonica e fasica
Il tono varia durante la digestione,
è maggiore nella prima fase e
tende a diminuire successivamente
L’attività fasica è caratterizzata da
movimenti peristaltici, pendolari e di
segmentazione:
• la peristalsi progredisce con la
velocità di un cm/sec; è
massima nel digiuno e si riduce
gradualmente nell’ileo
• i movimenti pendolari
consistono in contrazioni
ritmiche, così come i movimenti
di segmentazione; entrambi
mescolano il contenuto
intestinale e ne facilitano la
digestione
Radiografia dell’addome (AP a paziente supino)
1a-b: profili dei muscoli psoas – 2: aria (a: nello stomaco; b:
nel colon trasverso; c: nel tenue) – 3: residui fecali (a: nella
flessura splenica del colon; b: nel colon discendente; c: nel
sigma) – 4: rene destro – 5: fegato
Magnaldi fig. 238 pag. 276
Tenue: esame baritato per os
Lo studio preliminare del tenue può essere effettuato «in coda» allo
studio a DC delle prime vie digestive
Circa 2 ore dopo l’esame dello stomaco e del duodeno, il paziente
viene richiamato per effettuare due radiogrammi panoramici (uno in
decubito ed uno in stazione eretta) per valutare la progressione del
pasto baritato
La osservazione radioscopica delle varie anse, la non interruzione
della loro opacizzazione, la normale distribuzione nei vari quadranti,
la contrattilità vermicolare caratteristica, la opacizzazione in tempo
normale e l’aspetto regolare dell’ultima ansa ileale sono tutti rilievi di
grande importanza per un giudizio di negatività
Rilievi di incertezza diagnostica o alterazioni di tale semeiotica
oppure dati clinici di possibile patologia del tenue devono orientare
per uno studio più selettivo
Tenue: esame per os (tenue seriato)
Lo studio baritato dell’intestino tenue mediante somministrazione
orale di MdC rappresenta un’accettabile alternativa allo studio
selettivo del tenute tramite enteroclisi nel caso in cui quest’ultima
metodica non sia tecnicamente realizzabile
Preparazione del paziente: assunzione il giorno prima dell’esame
(mattina) di un primo purgante ad azione prolungata sul colon
(sennosidi) e di 15 gr di solfato di magnesio (pomeriggio) seguiti
dall’assunzione di 1,5-2 litri di acqua per poi rimanere a digiuno fino
al momento dell’esame
Preparazione del MdC: due dosi di sospensione di solfato di bario a
media concentrazione (60% p/v) ad una delle quali sono aggiunti
due cucchiai di sorbitolo
Tenue: esame per os (tenue seriato)
Proiezioni radiografiche:
•
•
•
•
•
•
Si esegue un primo radiogramma panoramico dell’addome senza MdC
con il paziente in ortostatismo per escludere eventuali livelli idro-aerei
Si invita il paziente a bere la prima dose di MdC baritato
Si acquisisce il primo radiogramma (in decubito) dopo MdC, ottenendo
così la rappresentazione in rilievo dello stomaco
Sotto guida radioscopica si controlla la progressione del MdC,
acquisendo i radiogrammi in successione (in decubito)
Quando si evidenziano le prime anse digiunali, si invita il paziente ad
assumere la seconda dose di MdC contenente sorbitolo che ha il
compito di richiamare liquidi nel tratto ileo-digiunale e di favorire quindi il
movimento peristaltico, facendo progredire il MdC verso il colon
Il transito del tenue giunge a termine quando si evidenzia l’ultima ansa
ileale ed il MdC, attraverso la valvola ileo-cecale, opacizza il colon
Tenue: esame per os (tenue seriato)
Rx in stazione eretta senza MdC
Carriero fig. 4-5-6 pag. 193
Radiogramma in decubito supino
Radiogramma in decubito prono
Tenue: esame per os (tenue seriato)
Radiogramma in decubito supino
Carriero fig. 1-2-3 pag. 194
Radiogramma in decubito prono
Radiogramma in decubito supino
Tenue: esame per os (tenue seriato)
Ultima ansa ileale
Carriero fig. 1 pag. 195
Tenue: enteroclisi (o clisma) del tenue
Questa tecnica consente giudizi di buon dettaglio, globali o di settore nello studio
del tenue
Ha avuto il suo massimo sviluppo negli anni ‘90 e una successiva progressiva
riduzione dopo l’avvento e la diffusione della TCMD: la complessità delle
manovre e tempi lunghi della metodica, la scarsa tollerabilità da parte del
paziente, nonché la elevata dose di radiazioni erogate oltre alla non sempre
affidabilità diagnostica spiegano la caduta di interesse per la metodica
La tecnica prevede l’infusione continua di una discreta quantità (500 cc) di bario
a bassa concentrazione (60%,diluito al 50%), ma a rapido transito (100-120
cc/min) direttamente all’inizio del tenue mesenteriale (angolo di Treitz) attraverso
la sonda di Bilbao-Dotter, inserita per via nasale e dotata di guida metallica
radiopaca
Si eseguono radiogrammi panoramici o di settore con il paziente in decubito
supino, intercalati da visione radioscopica e compressione dosata per
focalizzare e documentare eventuali lesioni
Dati tecnici: tempi di esposizione brevi (0,31-0,05 sec ) – kilovoltaggi alti (120130 kVp), fissi per tutto l’esame – amperaggi medio-alti (420-500 mA),
utilizzando la tecnica automatica dell’esposizione «ad un punto»
Tenue: enteroclisi (o clisma) del tenue
Clisma del tenue
Mazzucato fig. 8.102 pag. 895
Tenue: clisma del tenue a DC
La variante a doppio contrasto (DC) presenta caratteristiche metodologiche del tutto
sovrapponibili alla tecnica a contrasto singolo
Per entrambe infatti, al fine di assicurare il migliore risultato iconografico è necessaria
una buona preparazione intestinale del paziente:
• il giorno prima dell’esame questi assume a colazione un primo purgante ad
azione prolungata sul colon (sennosidi). Nel pomeriggio assume 15 gr di solfato di
magnesio, con azione rapida sul tenue. Fino alle ore 21 assume 1,5-2 litri di
acqua (per ovviare all’effetto di disidratazione del purgante), per rimanere a
digiuno assoluto fino al momento dell’esame
• circa 20 min prima dell’inizio dell’indagine, si può decidere di somministrare 10
mg di metoclopramide (1 fl i.m.) (Plasil) allo scopo di rendere più agevole
l’intubazione (favorendo la distensione del piloro), di accelerare il transito della
colonna baritata e di ostacolare il reflusso entero-gastrico
Prima di introdurre il catetere si esegue un primo radiogramma dell’addome a vuoto in
stazione eretta per valutare l’eventuale presenza di livelli idro-aerei
Successivamente si procede all’introduzione del catetere per via orofaringea o
nasofaringea (preferita) sotto guida radioscopica fino all’angolo di Treitz, preferendo
l’uso di sondini con palloncino (per evitare il reflusso di MdC) e con cavetto a controllo
di torsione
Tenue: clisma del tenue a DC
Addome a vuoto in stazione eretta
Carriero fig. 3 pag. 200
Radiogramma a vuoto con il sondino in situ
Carriero fig. 4 pag. 200
Tenue: clisma del tenue a DC
Dopo aver introdotto il sondino, viene eseguito un secondo radiogramma a paziente
supino per documentarne il posizionamento
Si procede quindi all’introduzione del MdC attraverso il catetere. La somministrazione
può avvenire manualmente con siringhe di varia grandezza o con pompe peristaltiche
La quantità di MdC è di circa 350-450 ml a concentrazione superiore a quella indicata
per l’enteroclisi con tecnica standard (80% p/v) ad una velocità di 90-110 cc/min
La progressione del bario deve essere seguita in scopia, acquisendo radiogrammi
mirati in caso di sospetta patologia
Dopo la valutazione delle prima anse digiunali, si introduce la metil-cellulosa-0,5%, ad
una velocità di flusso superiore a quella utilizzata per il bario, il cui compito è quello di
spingere verso le pareti il bario favorendo l’effetto della verniciatura, distendere il lume
intestinale e creare il doppio contrasto, facendo contestualmente progredire il MdC
baritato nelle anse ileali
L’indagine termina quando il MdC baritato attraversa la valvola ileo-cecale
I radiogrammi a DC vengono ripresi con il paziente prevalentemente in decubito
prono
Tenue: clisma del tenue a DC
Pompa per infusione di bario e metil-cellulosa
Carriero fig. 1-2-3 pag. 202
Tenue: clisma del tenue a DC
Progressiva opacizzazione delle anse digiuno-ileali
Carriero fig. 1-2-3 pag. 201
Tenue: clisma del tenue a DC
Clisma del tenue
(radiogramma panoramico)
Ultima ansa ileale
Carriero fig. 4 pag. 201
Carriero fig. 5-6 pag. 201
Tenue: clisma del tenue a DC
Clisma del tenue
Mazzucato fig. 8.103 pag. 895
TUBO DIGERENTE:
INTESTINO TENUE
G. Mazzoni
Tecniche di Radiodiagnostica (MED/50)
A.A. 2015-2016
TUBO DIGERENTE:
INTESTINO CRASSO
G. Mazzoni
Tecniche di Radiodiagnostica (MED/50)
A.A. 2015-2016
Crasso: riferimenti anatomici
E’ il segmento terminale del tubo
digerente che comincia con
l’intestino tenue mediante la valvola
ileo-cecale e si apre all’esterno con
l’orifizio anale
Si divide in sei porzioni: cieco,
ascendente, trasverso, discendente,
sigma e retto:
•
il cieco si trova nella fossa
iliaca destra, inferiormente ad
un piano passante per la
valvola ileo-cecale
•
il colon ascendente segue il
cieco e si estende fino alla
flessura epatica dove trapassa
nel trasverso
•
il colon trasverso si estende
dall’ipocondrio destro al
sinistro, descrivendo una curva
a largo raggio a concavità
rivolta verso l’alto e raggiunge
la flessura splenica
L’intestino crasso nelle sue diverse porzioni.
Carriero fig. 1 pag. 203
Crasso: riferimenti anatomici
•
il colon discendente va dalla
flessura splenica al sigma e si
differenzia dalle porzioni
precedenti per il minore
calibro e per le austra che
sono più piccole e distanziate
tra loro
• il sigma si estende dalla
cresta iliaca sino al 3^
metamero sacrale
• il retto si continua al colon
sigmoideo e termina nella
linea pettinea da dove inizia il
canale anale che si estende
fino all’orifizio esterno
La parete del colon è costituita da
una tonaca sierosa (peritoneo),
da una tonaca muscolare, da una
tonaca sottomucosa e da una
tonaca mucosa
L’intestino crasso nelle sue diverse porzioni.
Mazzucato fig. 8.125 pag. 923
Crasso: riferimenti anatomici
La tonaca muscolare è
formata da uno strato interno
circolare ed uno esterno
longitudinale le cui fibre si
raccolgono in tre fasci detti
tenie (mesocolica, omentale o
epiploica e libera)
Ai lati delle tenie la parete si
solleva in gibbosità separate
tra loro da solchi diretti
trasversalmente; ai solchi
corrispondono, sulla superficie
interna, le pliche semilunari
che formano delle
concamerazioni chiamate
austra, il cui disegno è più
evidente nel colon trasverso,
mentre va diminuendo nel
discendente e nel sigma
Sezione sagittale; le tenie e le pliche semilunari
determinano le concavità australi
Mazzucato fig. 8.108 pag. 903.
Crasso: riferimenti funzionali
Le funzioni principali del
colon sono il riassorbimento
ed il trasporto
Il riassorbimento dell’acqua
avviene nella porzione
prossimale del colon
Il trasporto si compie
mediante due tipi di
movimenti del crasso che
sono:
• le contrazioni locali che
conferiscono
all’intestino un aspetto
«a fisarmonica»
• i movimenti colici che
provocano la costrizione
del lume intestinale
Colon in fase di contrazione.
Il rilievo mucoso risulta increspato con cancellazione
delle pliche semilunari e delle austra
Mazzucato fig. 8.112 pag. 905.
Crasso: clisma opaco
Il clisma opaco tradizionale è nato con la radiologia e per molti
decenni è rimasto l’unico esame utilizzato per lo studio dell’intestino
crasso, nonostante i suoi limiti diagnostici nello studio del lume
colico. La metodica permette infatti di apprezzare lesioni stenosanti
od infiltranti, ma è scarsamente sensibile nel rilievo delle lesioni
vegetanti
Tale metodica è oggi riservata soltanto per ricercare eventuali
varianti morfologiche, per lo studio dei neonati e dei lattanti, per il
controllo immediato di interventi chirurgici e nella stipsi del bambino
Attraverso una sonda rettale viene introdotta una sospensione
baritata in quantità tale da distendere l’intero colon (circa 800 cc)
La progressione della colonna baritata è attentamente seguita sotto
scopia in modo da individuare qualsiasi arresto temporaneo-duraturo
I radiogrammi vengono ripresi nelle proiezioni opportune in modo da
dissociare tutte le volute delle anse
Crasso: clisma opaco
Clisma opaco tradizionale con il
paziente supino in proiezione OAD
Mazzucato fig. 8.124 b pag. 922
Crasso: clisma a doppio contrasto (DC)
Il clisma a DC, sviluppato a partire dagli anni ’70, deve il suo
successo all’avvento di più elementi fra i quali giova ricordare la
produzione di:
•
•
•
•
•
•
sospensioni baritate micronizzate (dell’ordine di 3-4 micron), arricchite
da sostanze anti-schiuma ed anti-bolle (dimetil-polisilossano e sostanze
a base di carbossi-metilcellulosa) e caratterizzate da alta densità,
elevato grado di adesività e bassa viscosità, al fine di ottenere sottili
pellicole vernicianti opache, stabili ed uniformi
catene televisive digitali ad elevato potere risolutivo, particolarmente utili
per le visioni scopiche
tubi radiogeni di adeguata potenza ed efficienza, in grado di esprimere
piccole macchie focali
immagini radiografiche digitali (IB con telecamera CCD ed oggi i
moderni sistemi digitali a flat panel)
farmaci ipotonizzanti (Buscopan) in grado di facilitare la distensione
della mucosa in fase di insufflazione, riducendo lo spesso delle pliche
semilunari
Sonde (tipo Muller) a grossa oliva distale con fori di uscita anche
laterali, predisposte per tre vie di comunicazione: una all’imbocco del
raccordo per il contenitore del bario, una seconda via per la sacca di
scarico ed una terza via per l’insufflazione di aria
Crasso: clisma opaco a DC
Al fine di assicurare il migliore risultato iconografico, è necessaria una buona
preparazione intestinale del paziente:
• il giorno prima dell’esame questi assume a colazione un primo purgante ad
azione prolungata sul colon (sennosidi). Nel pomeriggio assume 15 gr di solfato di
magnesio, con azione rapida sul tenue. Fino alle ore 21 assume 1,5-2 litri di
acqua (per ovviare all’effetto di disidratazione del purgante), per rimanere a
digiuno assoluto fino al momento dell’esame
Prima di introdurre il catetere si esegue un primo radiogramma dell’addome a vuoto in
stazione eretta per valutare l’eventuale presenza di livelli idro-aerei
Quindi si invita il paziente ad assumere la posizione di decubito laterale e si introduce
nell’ampolla rettale la sonda a grossa oliva distale di calibro adeguato (lubrificata con
olio di vaselina)
Si posiziona il paziente in decubito prono e si fa defluire per effetto gravitazionale il
MdC baritato (1500-2000 ml) (80% p/v) sotto visione radioscopica fino al
raggiungimento della porzione ciecale. Se possibile e necessario, alcuni giri su se
stesso del paziente sono utili per la migliore l’adesività della sospensione baritata su
tutti i segmenti del colon
Si esegue un secondo radiogramma panoramico con paziente in decubito prono a
completo riempimento del viscere
Crasso: clisma opaco a DC
Radiogramma dell’addome a vuoto in stazione eretta
Carriero fig. 4 pag. 206
Radiogramma a pieno riempimento in posizione prona
Carriero fig. 5 pag. 206
Crasso: clisma opaco a DC
Si provvede a drenare nella sacca di scarico, collegata alla sonda rettale, il
quantitativo di bario in eccesso e quindi libero nel lume intestinale (di solito pari a
circa la metà o poco più della sospensione iniettata) in modo che le pareti del colon
risultino appena verniciate dal MdC baritato
Vengono successivamente iniettati e.v. 20 mg di N-butilbromuro di Joscina
(Buscopan) in modo da ridurre il tono e la motilità del colon per tutta la durata
dell’esame
Si procede infine ad insufflare aria nel colon sotto controllo radioscopico tramite
apposito dispositivo di gomma collegato alla sonda, per completare la distensione
delle anse resa possibile dall’effetto ipotonizzante, favorire l’adesione del MdC
baritato alla parete mucosa del viscere e generare il doppio contrasto. Il variare dei
decubiti può perfezionare la distribuzione omogenea dell’aria nei vari tratti del crasso
Si esegue un radiogramma dopo vuotamento e dopo insufflazione con il paziente in
decubito prono
Successivamente:
• Radiogramma mirato sul retto a paziente prono con il raggio inclinato craniocaudalmente di circa 30°
• Radiogramma mirato sul retto in proiezione LL sinistra o destra
Crasso: clisma opaco a DC
Radiogramma mirato sul retto a paziente prono
Radiogramma dopo vuotamento in decubito prono
Radiogramma mirato sul retto in proiezione LL
Carriero fig. 6 pag. 206
Carriero fig. 3 pag. 206
Carriero fig. 4 pag. 207
Crasso: clisma opaco a DC
Successivamente vengono eseguiti i seguenti radiogrammi:
• Radiogramma panoramico a paziente supino
• Radiogramma mirato sul sigma, con paziente obliquato di circa 45° (posizione
dello schermidore: OAD)
• Radiogramma mirato sul cieco (AP)
Quindi al paziente viene posto in ortostatismo per completare l’esame con i seguenti
radiogrammi:
• Radiogramma panoramico in AP
• Radiogramma mirato sulla flessura epatica con paziente obliquato di circa 45°
(posizione del pugilatore: OAS)
• Radiogramma mirato sulla flessura splenica con paziente obliquato di circa 45°
(posizione dello schermidore: OAD)
L’esame può essere integrato con vari radiogrammi (sia panoramici che soprattutto di
dettaglio a varia inclinazione) per dirimere dubbi sulla natura di certe immagini che
pongano alternative diagnostiche di tipo organico o di tipo fittizio o immagini parassite
Crasso: clisma opaco a DC
Radiogramma mirato sul sigma (OAD)
Radiogramma panoramico a paziente supino
Radiogramma mirato sul cieco (AP)
Carriero fig. 5 pag. 207
Carriero fig. 6 pag. 207
Carriero fig. 3 pag. 207
Crasso: clisma opaco a DC
Radiogramma mirato sulla flessura epatica (OAS)
Radiogramma panoramico in ortostatismo
Radiogramma mirato sulla flessura splenica (OAD)
Carriero fig. 3 pag. 208
Carriero fig. 4 pag. 208
Carriero fig. 2 pag. 208
Crasso: clisma opaco a DC
PROIEZIONI
1.- AP
a paziente eretto, a vuoto (panoramica)
2.- PA
a paziente prono, a pieno riempimento (panoramica)
3.- PA
a paziente prono dopo vuotamento (panoramica)
4.- PA
a paziente prono con inclinazione di 30° (mirata sul retto)
5.- LL
in decubito laterale destro o sinistro (mirata sul retto)
6.- AP
a paziente supino (panoramica)
7.- OAD
a paziente supino con inclinazione di 45° (mirata sul sigma)
8.- AP
a paziente supino (mirata sul cieco)
9.-AP
a paziente eretto (panoramica)
10.-OAS
a paziente eretto (mirata sulla flessura epatica)
11.-OAD
a paziente eretto (mirata sulla flessura splenica)
Nei radiogrammi in posizione supina il bario si raccoglie nel retto e nelle flessure epatica e
splenica che sono posteriori, mentre l’aria tende a distendere il sigma ed il trasverso; viceversa
avviene nella posizione prona
Nei radiogrammi in ortostatismo bario ed aria assumono la posizione propria dei livelli idro-aerei
TUBO DIGERENTE:
INTESTINO CRASSO
G. Mazzoni
Tecniche di Radiodiagnostica (MED/50)
A.A. 2015-2016