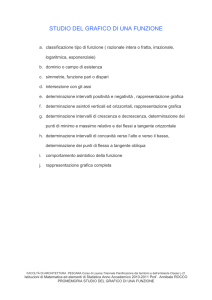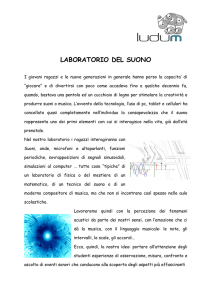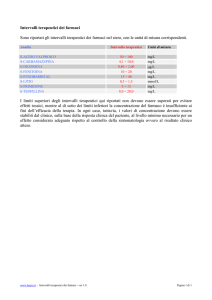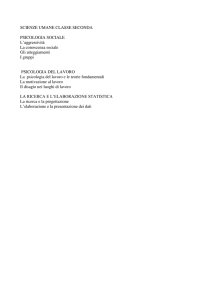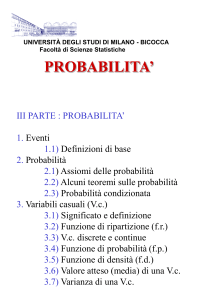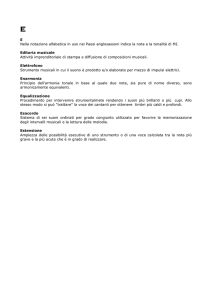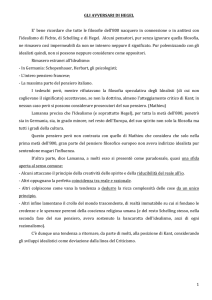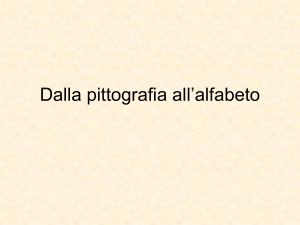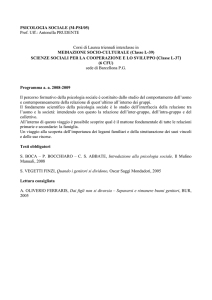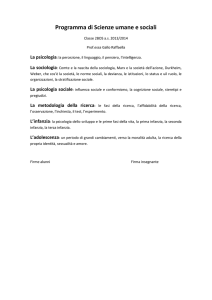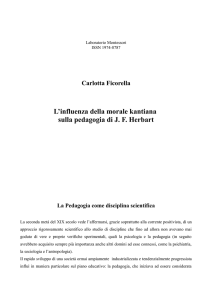Nadia Moro
ARMONIA E CONTRAPPUNTO
NEL PENSIERO DI J.F. HERBART
EDIZIONI
UNICOPLI
INDICE
p.
7
9
Ringraziamenti
Elenco delle abbreviazioni
11
1. INTRODUZIONE
23
2. JOHANN FRIEDRICH HERBART
UNA BIOGRAFIA MUSICALE
39
39
43
45
49
53
3. LA PSICOLOGIA DI HERBART
I. Il programma di una psicologia scientifica
II. Esperienza
III. Metafisica
IV. Matematica
V. Nozioni fondamentali
65
65
72
4. ANALISI PSICOLOGICHE DEL SUONO MUSICALE
I. Matematica e scienza: il ruolo della musica
II. L’ottava
1. Il problema: consonanza ed opposizione. 2. Modello
lineare dell’ottava. 3. Ottava e nota estesa. 4. Modello
quadrato dell’ottava. 5. Il punto di vista sulla nota. 6.
Ottava come modulo. 7. Il meccanismo psicologico. 8.
Musica e psicologia (una soluzione teorica). 9. Aporie.
99
III. Gli intervalli
1. Note di metodo. 2. Calcolo delle ampiezze. 3. Quinta
diminuita, quinta giusta e quarta. 4. Terze e seste.
5. Seconde e settime.
127
IV. Le triadi perfette
1. Impostazione e metodi. 2. La consonanza. 3. La frazione psicologica. 4. La differenza tra maggiore e minore.
6
p. 141
V. Consonanza e dissonanza
1. Gli intervalli. 2. Gli accordi. 3. L’accordo diminuito.
4. La settima di dominante. 5. Confronto fra gli accordi.
157
162
VI. Il temperamento equabile
VII. La melodia
1. Fondamenti armonici. 2. Intervalli melodici. 3. Sviluppo armonico della melodia.
175
5. OSSERVAZIONI TEORICHE SULLA PSICOLOGIA
DEL SUONO
175
180
182
188
I. La linea tonale
II. Pregnanza della dimensione armonica
III. Le forze psichiche nella formula della soglia
IV. Dalla psicologia alla musica: un percorso teorico
1. Un approccio preliminare. 2. «Gli elementi primi della musica». 3. La consonanza: intervalli e triadi perfette. 4. Dalla dissonanza al temperamento equabile. 5. La
distinzione della seconda.
198
200
V. La logica secondo Zimmermann
VI. Teoria musicale e psicologia
205
205
208
217
6. APPUNTI DI ESTETICA MUSICALE
I. Herbart e l’estetica
II. L’estetica musicale herbartiana
III. Il pensiero musicale
223
7. CONCLUSIONI
233
APPENDICE
Traduzione di Psychologische Bemerkungen zur Tonlehre
257
Indicazioni bibliografiche
Elenco delle abbreviazioni
SW
J. F. Herbart, Sämtliche Werke. In chronologischer Reihenfolge, a cura di K. Kehrbach, O. Flügel, 19 voll. (voll. 16-19:
Briefe von und an Herbart, a cura di Th. Fritzsch), ristampa
dell’edizione Beyer, Lagensalza 1887-1912, Scientia, Aalen
19642; seguito dal numero romano indicante il volume di riferimento e dal numero di pagina.
AM
J. F. Herbart, Allgemeine Metaphysik nebst den Anfängen
der philosophischen Naturlehre. Zweiter, systematischer
Teil, 1829, in SW, VIII, pp. 1-338; trad. it. Metafisica generale con elementi di una teoria filosofica della natura. Parte sistematica, a cura di R. Pettoello, Unione TipograficoEditrice Torinese, Torino 2003.
HM
J. F. Herbart, Hauptpuncte der Metaphysik, 1808², in SW,
II, pp. 175-226; trad. it. Punti principali della metafisica, a
cura di R. Pettoello, Thélème, Torino 2001.
LEP J. F. Herbart, Lehrbuch zur Einleitung in die Philosophie,
18374, revisione critica a cura di W. Henckmann, Meiner,
Hamburg 1993; seguito dal riferimento a SW; trad. it. Introduzione alla filosofia, a cura di G. Vidossich, Laterza, Bari 1927².
LP
J. F. Herbart, Lehrbuch zur Psychologie, 1834², riedito a cura
di M. Kaiser-El-Safti, Königshausen & Neumann, Würzburg
2003; seguito dal riferimento a SW; trad. it. Manuale di
psicologia, a cura di I. Volpicelli, Armando, Roma 1982.
10
PBT J. F. Herbart, Psychologische Bemerkungen zur Tonlehre,
1811, in SW, III, pp. 96-118; trad. it., infra, pp. 233-256.
PU
J. F. Herbart, Psychologische Untersuchungen, 1839, in
SW, XI, pp. 45-176.
5
OSSERVAZIONI TEORICHE SULLA PSICOLOGIA DEL SUONO
Le analisi psicologiche herbartiane hanno condotto ad una varietà di risultati specifici che intendono dimostrare la convergenza
della teoria psicologica con i fondamenti della teoria musicale cui
essa è stata applicata: gli intervalli con i loro valori armonici, gli
accordi perfetti e dissonanti variamente costituiti, la connessione,
infine, di armonia e melodia. Si sono già segnalati i luoghi critici
dell’argomentazione herbartiana, laddove essa presenta incoerenze ed aporie che invalidano taluni suoi esiti anche rilevanti. In
particolare, la crescente complessità delle questioni affrontate ha
indotto Herbart ad adottare una serie di soluzioni particolari che
spesso risultano estranee o perfino inconciliabili con i presupposti
psicologici più generali, così da legittimare – in apparenza – tutti i
dubbi che, storicamente, sono stati sollevati relativamente alla
validità stessa dell’approccio herbartiano.
Tali risultati specifici, corretti od erronei, non esauriscono però la
rilevanza di alcuni aspetti generali che caratterizzano l’impostazione
herbartiana della questione e che emergono proprio dal suo svolgimento. La ricostruzione concettuale (e critica) delle dottrine
esposte permette, a questo punto, di evidenziarne i caratteri fondamentali e di elaborare una linea interpretativa che metta in luce
la coerenza del percorso teorico svolto.
I. La linea tonale
La costruzione psicologica delle relazioni tonali si è basata sulla
presupposizione di una linea tonale a priori, che, in quanto tale,
non fa mai la sua comparsa nell’esperienza, e tuttavia risulta necessaria per elaborarne un quadro coerente.
176
N. MORO
Nel corso della trattazione sono emerse le peculiarità che vanno
ascritte al continuo tonale affinché esso adempia alla funzione di
integrare i dati sonori con il pensiero. Per definizione, esso è unidimensionale, infatti «i suoni formano un continuo di una sola
dimensione, che noi vogliamo chiamare la linea tonale»1. I suoi
punti presentano un ordinamento seriale secondo l’altezza dei
suoni, che consente di stabilirvi relazioni di grandezza. Inoltre, la
linea tonale è continua in senso matematico, ossia è tale per cui vi
è sempre un terzo punto (suono) compreso tra due dati. Essa può
essere scandita mediante l’indicazione dei punti che, al limite,
sono suscettibili di una determinazione di luogo attraverso una
misura psicologica. La linea è tendenzialmente omogenea, rendendo così possibile la fissazione di un’unità di misura approssimativamente costante (il semitono), che permette il confronto dei
segmenti tonali (gli intervalli) tra loro. La linea tonale è infinita
nelle sue due direzioni e risulta quindi doppiamente percorribile,
allo stesso modo in senso ascendente e discendente.
La ragione teoretica per la necessità di porre una linea tonale
con le caratteristiche indicate risiede nel particolare metodo proprio della metafisica herbartiana, della quale la psicologia è una
parte applicata2. La metafisica generale svolge un compito funzionale alla spiegazione dell’esperienza, che si esplica nel rendere
coerente quel dato che, a livello empirico, presenta contraddizioni
insolubili al proprio interno. La metafisica, dunque, oltrepassa
l’esperienza attraverso la posizione di un reale che, sì, la trascende,
ma soltanto funzionalmente e soltanto come necessaria integrazione dei dati nel pensiero: in tal modo essa mira ad offrire, rispetto al dato esperito, un quadro razionalmente organizzato e pensabile senza contraddizione.
Per poter dare conto, dunque, della molteplicità di suoni e della
varietà delle loro determinazioni, occorre innanzitutto rimandare
ad un loro superiore ordinamento che, in certa misura, li renda
tutti quanti possibili e li liberi da ogni incompatibilità reciproca.
La stessa dissonanza risulterebbe inspiegabile se non fosse riconducibile a relazioni determinate, come avviene, invece, assegnando
precisi valori a ciascun intervallo e poi confrontandoli tra loro. Il
riferimento alla linea tonale permette, dapprima, di calcolare
l’ampiezza degli intervalli in base alle leggi psicologiche e, poi, di
1
2
SW, V, p. 299.
Cfr. LP, p. 3; SW, IV, p. 297 e LP, p. 6; SW, IV, p. 301; trad. it., p. 19.
5. Osservazioni teoriche sulla psicologia del suono
177
assumere la trasponibilità ad altezze diverse delle grandezze ricavate, per combinarle tra loro. In tal modo esse possono essere
rapportate e condurre finalmente alla chiarificazione del fenomeno della dissonanza: il confronto della posizione dei punti acquista
un senso quando essi vengano collocati l’uno dopo l’altro lungo la
linea tonale, in riferimento alla quale soltanto assume significato
la compressione degli intervalli cui si è ricondotta la dissonanza.
L’articolazione spaziale del suono che viene posta alla base della
sua analisi è dunque preliminare alla possibilità di spiegare i fenomeni tonali, che si realizza mediante il ricorso ad un modello
generale di approccio.
Il primo fatto che la psicologia contempla è quello per cui
da ciascun suono a piacere si può passare in maniera continua a suoni più
alti e più bassi, senza che sia possibile indicare in maniera determinata i
suoni più alti o più bassi che si possano udire, ed in generale pensare3.
È dunque al livello stesso della psicologia che si apre la via
all’introduzione di una nozione di linea tonale come quella descritta, perché l’esperienza del suono ne rivela fin da subito
l’andamento seriale potenzialmente infinito. La psicologia, tuttavia, ha sempre a che vedere con fatti specifici della coscienza e, per
la loro spiegazione, deve delimitare secondo criteri propri lo sviluppo originariamente infinito del suono.
Così, una volta riconosciuto alla linea tonale il valore di fondamento che le spetta nei confronti della legalità psicologica, ne emerge anche la radicale alterità rispetto a qualsiasi scala musicale,
nella quale i suoni si susseguono discreti, nel senso che hanno
altezze determinate e non trapassano l’uno nell’altro in maniera
continua. Sempre in una scala, poi, le note sono già scelte secondo
un principio di organizzazione di tipo prettamente musicale (per
esempio, cromatico o diatonico)4. Herbart distingue espressamente tra le due nozioni, quando completa in nota la definizione di
linea tonale, «da non confondere con scala, che contiene solo singoli punti di quella linea»5.
Egli dichiara a più riprese il proprio disappunto per la scarsa
attenzione che i filosofi hanno prestato alla musica, mentre essa
PU, p. 69.
Cfr. PU, p. 103.
5 SW, V, p. 299.
3
4
178
N. MORO
rappresenta, a suo avviso, un proficuo punto di riferimento per
una ponderata riflessione sull’a priori6. Proprio la linea tonale,
infatti, si offrirebbe, accanto allo spazio ed al tempo, per
un’indagine sulle molteplici forme dell’esperienza e sulle varie
connessioni che avvengono nella psiche, promuovendo insieme
un’opportuna ridiscussione dell’intera dottrina kantiana. Herbart
si interroga sulla possibilità e sullo statuto dei giudizi sintetici a
priori7 e si inserisce, con ciò, in un dibattito di matrice kantiana; le
soluzioni che egli offre risultano parzialmente estranee al kantismo, pur senza porsi in radicale antitesi rispetto ad esso.
Con Herbart, la musica fa un ingresso quanto meno sorprendente in metafisica, in virtù della sua capacità di retrocedere, per
così dire, alle radici stesse dell’esperienza, figurando tra le sue
forme fondamentali ed ottenendo un posto accanto a quelle che,
per Kant, ne erano la condizione di possibilità. La linea tonale
viene prepotentemente affiancata a spazio e tempo, dei quali condivide appieno lo statuto a priori: le due forme kantiane perdono,
in Herbart, la loro esclusività e, su questa base, anche la musica e
le relazioni tonali da essa esibite acquistano una pregnanza altrimenti inaudita.
Si può approfondire la questione attraverso l’analisi di una discutibile presa di posizione di Kaiser-El-Safti. Ella pretende di
riscontrare una discordanza fra il dettato della Psychologie als
Wissenschaft, in cui si parla espressamente di «giudizi sintetici a
priori»8, e quanto sostenuto nelle Osservazioni psicologiche sulla
teoria musicale, dalle quali si evince il rifiuto categorico di una
molteplicità di forme originarie nell’anima, giacché le aporie conseguenti alla derivazione del molteplice dall’uno sanciscono «ovunque ed in generale la fine e la rovina di ogni sana metafisica»9.
Secondo Kaiser-El-Safti tale affermazione «contesta che il carattere formale della musica possa riposare su una qualche apriorità»10,
contraddicendo quindi le asserzioni della Psychologie als Wissenschaft.
In realtà, nelle stesse Osservazioni psicologiche sulla teoria
musicale, dunque contestualmente al rifiuto delle forme originarie,
Cfr. SW, VI, p. 165 e PBT, p. 117; trad. it., infra, p. 255.
Cfr. PU, p. 50.
8 SW, VI, p. 165.
9 PBT, pp. 102-103; trad. it., infra, p. 238.
10 M. Kaiser-El-Safti, «Johann Friedrich Herbart und Carl Stumpf», cit., p. 80.
6
7
5. Osservazioni teoriche sulla psicologia del suono
179
Herbart lamenta la negligenza nella considerazione filosofica della
linea tonale e del suo confronto con lo spazio ed il tempo11: un
rimando piuttosto evidente all’a priori. Inoltre, la Psychologie als
Wissenschaft contiene un passaggio dedicato a questa tematica
che non è più soltanto un cenno e merita un riferimento:
Se le rappresentazioni di tutti i suoni nella linea tonale fossero innate,
egli [l’uomo] potrebbe, con la semplice spontaneità, portare alla coscienza
ogni volta due e tre o quattro di tali rappresentazioni. Se, poi, egli non
udisse mai uno strumento, mai una voce, nondimeno l’ottava sarebbe per
lui il rapporto dell’opposizione piena, proprio come ora […]. Perché le
ragioni per cui tutto ciò dev’essere così sono generalissime, e sono le stesse per lo spirito incorporeo e per noi, uomini sensibili12.
Al di là delle forzature più o meno legittime del testo, la questione concerne direttamente l’interpretazione herbartiana dell’a
priori e le obiezioni a Kant che ne derivano. La linea di continuità
fra i due filosofi, a mio avviso, è molto più diretta di quella che
Kaiser-El-Safti perfino stenta ad ammettere, seguendo peraltro la
scia delle aspre polemiche herbartiane. L’a priori inteso come forma innata viene senz’altro rigettato da Herbart, per esempio nel
passo citato13, ma, prima di lui, lo stesso Kant aveva rifiutato
l’innatismo, quantunque Herbart lo fraintenda e giunga ad imputargli una concezione dell’a priori alla stregua di un’idea innata,
facendone per giunta un ritornello polemico.
Se l’a priori kantiano, di per sé, non è completamente avulso
dall’esperienza, in Herbart l’appello al dato assume una rilevanza
decisamente superiore. Nel timore che l’a priori kantiano implichi
l’ipostatizzazione di ciò che, in realtà, è solo una necessità di chiarificazione del dato a livello razionale, Herbart rifiuta le condizioni
trascendentali del soggetto e sottopone l’a priori ad una severa
ridefinizione. Egli ritiene che sia l’esperienza stessa ad offrire le
forme, le quali vanno dunque colte nella loro pregnanza sensibile e
poi elaborate concettualmente. Di fatto, esse assurgono soltanto
allo statuto di concetti psicologici, costitutivamente impossibilitati
Cfr. PBT, p. 117; trad. it., infra, p. 255.
SW, VI, p. 71. Il passo citato è introdotto da un’osservazione che conferma ulteriormente il riferimento herbartiano all’a priori: «La fusione prima
dell’impedimento può verificarsi, certo, nelle sensazioni sensibili e mutarle in
un sentimento, ma essa non è in alcun modo legata alla sensibilità» (ibid.).
13 In realtà, è proprio Herbart a sostenere una forzatura del concetto kantiano in direzione psicologica, per poi rigettarla radicalmente.
11
12
180
N. MORO
ad affrancarsi dalla loro genesi sensibile, mentre non raggiungono
mai la purezza dell’a priori kantiano, paragonabile semmai ai concetti logici herbartiani, ossia al limite irraggiungibile cui i concetti
psicologici tendono. L’a priori herbartiano va dunque inteso, in
termini matematici, come il limite cui tende l’integrazione razionale dei dati esperiti, alla stregua di una struttura logica assolutamente coerente, all’insegna della quale si svolge l’elaborazione del
dato, rendendolo pensabile senza contraddizione.
Inteso in questo senso, l’a priori risulta affatto compatibile con
la linea tonale e rende consistente il riferimento herbartiano a
queste due nozioni nel contesto della fondazione psicologica della
teoria musicale. La linea tonale funge, infatti, da struttura a priori
preliminare (logicamente, non geneticamente) alla definizione delle
relazioni tonali, perché queste sorgono sulla base dell’ordinamento
originario che essa esibisce. In altri termini, prima di poter confrontare due intervalli, occorre porre una serie di condizioni (come
la disposizione dei suoni secondo l’altezza e l’omogeneità delle loro
distanze) che, nel loro complesso, danno la struttura della linea
tonale.
Il procedimento che, in metafisica, conduce dal dato all’essere
ed ai reali, si riproduce in maniera analoga anche nella psicologia,
quando, per spiegare le relazioni tra le rappresentazioni dei suoni,
è opportuno porre con il pensiero la linea tonale, che, in virtù delle
sue peculiarità, fonda la consistenza psicologica dei rapporti tonali
musicalmente significativi.
II. Pregnanza della dimensione armonica
Herbart affronta pressoché tutti i temi musicali da un punto di
vista armonico, privilegiando la dimensione “verticale” della musica in una misura tale per cui la melodia stessa (che si esplica nella
dimensione “orizzontale”) deve necessariamente ammettere possibilità di armonizzazione14.
La pregnanza dell’aspetto armonico si misura, per esempio, nel
fatto che i moti della melodia vengono condizionati dalla frazione
operata dalla quinta, che conferisce stabilità alla fondamentale
degli intervalli melodici: in questo caso, la scelta dell’armonia va
14
Cfr. PU, p. 103.
5. Osservazioni teoriche sulla psicologia del suono
181
ricondotta all’equilibrio psicologico derivante dalla frazione corrispondente. Per il suono che assumerà il ruolo di tonica, ossia di centro tonale per un certo passaggio, va elaborata un’armonizzazione
che lo rafforzi in tale sua funzione e «con la quinta la tonica è stabilita»15; se, invece, si proponessero contesti armonicamente differenti – possibilità che, a livello estetico, rimane comunque aperta
– essi comporterebbero però ben altri risultati anche a livello psicologico.
La priorità della dimensione armonica viene ulteriormente potenziata dalla sua contestualizzazione a livello contrappuntistico:
l’armonia, presa per sé sola, detta regole e manifesta in ciò la propria autonomia, ma non esaurisce ancora l’intero ambito del musicale. Piuttosto, essa trova il proprio inveramento quando venga
congiunta alla melodia, e, più specificamente, in una conduzione
contrappuntistica16: se la melodia presuppone varie possibilità di
armonizzazione, il contrappunto permette la connessione di diverse melodie e delle relative armonie, assurgendo così a sommo
svolgimento delle relazioni tonali.
La ragione per la pregnanza della dimensione armonica nella
teoria psicologica risiede nella concezione relazionale del suono: la
musica consiste di rapporti che possono essere variamente posti
tra i suoni; la psicologia, dal canto suo, dispone della frazione tra
le rappresentazioni come strumento di analisi particolarmente
PU, p. 108.
Cfr. SW, IX, pp. 109-114. Ciò emerge anche dalla breve analisi che compare nel testo herbartiano e riguarda le ultime battute della variazione V sul
corale Vom Himmel hoch, da komm ich her BWV 769 di J. S. Bach. Le analisi
sarebbero state scritte da un «amico erudito» (PU, p. 116), del quale Herbart
non rivela l’identità e, in merito, Bagier scrive in nota: «Il pastore Flügel ha
comunicato con estrema cortesia che, stando alla tradizione orale, quelle argute osservazioni provengono da L. Spohr. Per queste relazioni, purtroppo, non è
stato possibile rintracciare alcuna prova più attendibile» (G. Bagier, op. cit., p.
133). Le riflessioni, informa poi Herbart, vengono inserite nel testo così come
gli sono pervenute dalle mani dell’amico, perché gli manca il tempo di rielaborarle prima della stampa. Tra l’altro, esse rivendicano l’importanza che il
pedale assume, insieme con ritardi e note tenute, per la composizione di più
melodie in un tutto; a questo proposito trova spazio il riferimento al corale
bachiano, che presenta, in sole tre battute, la connessione di quattro melodie
tratte dalle strofe, due imitazioni per moto contrario della prima di esse e
pedale inferiore. In merito a tale passaggio si afferma che, «considerata armonicamente, questa frase è piuttosto sgradevole, ma l’unificazione di più melodie in sé compiute urge alla chiusura comune; si debbono soltanto percepire le
melodie in maniera sufficientemente determinata e distinta» (PU, p. 117).
15
16
182
N. MORO
funzionale all’indagine di tali relazioni. La frazione, infatti, rende
comprensibili le connessioni tra i suoni, risalendo all’effetto che
ciascun suono provoca in ogni altro ed agli eventi rappresentativi
corrispondenti. Qualsiasi combinazione di suoni, dalle più semplici negli intervalli a quelle più complesse nelle cadenze e nel contrappunto, dà luogo a specifici equilibri psichici, ai quali Herbart
riconduce, con più o meno successo, tutti i fenomeni musicali.
L’illustrazione psicologica delle relazioni tonali si svolge, infatti,
indicando con esattezza il rapporto di maggiore o minore conflittualità fra uguaglianza ed opposizione, che è determinante rispetto
al valore armonico e costituisce il livello più elementare cui tutti i
dati musicali sono riconducibili.
Una simile concezione del contrappunto affonda le proprie radici nella nozione di ‘nota estesa’ che Herbart ha introdotto
all’inizio delle proprie analisi, e che permette di definire ed elaborare il suono attraverso il sistema di rapporti che su di esso fa perno. In tal modo viene istituita, già a livello psicologico, una proficua relazionalità che troverà massima valorizzazione nell’estetica,
disciplina che è fondata sui rapporti e sull’assiologia che, secondo
Herbart, ne deriva immediatamente. Il contrappunto stesso, peraltro, assurgerà, nella sua concezione, a modello per il rigoroso sviluppo di un’estetica saldamente fondata:
la musica mostra assai chiaramente che possono nascere le combinazioni
più artistiche quando più serie del bello successivo (più voci melodiche) si
svolgono insieme siffattamente che sieno sempre simultaneamente adempiute le esigenze dell’armonia17.
III. Le forze psichiche nella formula della soglia
Insieme con la frazione delle rappresentazioni in parti di uguaglianza ed opposizione, la formula della soglia rappresenta il criterio chiave per la spiegazione dei fenomeni tonali a livello psichico;
essa viene infatti applicata ovunque sia opportuno stabilire e
calcolare la gerarchia tra le forze rappresentative, che decide anche
ciò che compare effettivamente nella coscienza.
I calcoli eseguiti si basano, per la maggior parte, sulla formula
della soglia, tanto che non sarebbe del tutto fuori luogo accusare
17
LEP, pp. 156-157; trad. it., p. 122.
5. Osservazioni teoriche sulla psicologia del suono
183
Herbart di averne abusato: pur di far corrispondere le forze ai
rapporti da essa stabiliti, egli considera ora l’uguaglianza intera,
ora la sua metà (il calcolo della terza minore ne è un esempio inequivocabile), e poi, ancora, le opposizioni, prese singolarmente
oppure nella loro somma, infine le rappresentazioni originarie e
rafforzate. Deve pur esservi un intervallo a partire dal quale una
delle due grandezze semplicemente sprofonda sotto la soglia, senza mantenersi al suo limite e, quindi, senza dover forzosamente
equivalere alle relazioni espresse dalla formula predefinita. Herbart, invece, non ammette che uguaglianze ed opposizioni negli
intervalli potrebbero rapportarsi diversamente da quanto indicato
nella formula e s’arrovella a dividerle e moltiplicarle, al fine di
mostrare come esse facciano pur sempre al caso suo. Inoltre, anche nello studio degli accordi, la formula della soglia costituisce il
criterio principale sul quale si basa l’analisi psicologica e viene
applicato alle parti fratte di ciascuna nota dell’accordo, prive di una
determinazione qualitativa (uguaglianza od opposizione) univoca18.
L’indagine herbartiana si concentra su quanto avviene al di sopra della soglia e si trova effettivamente nella coscienza, mentre
ciò che viene spinto al di sotto di essa interessa soltanto nella misura in cui può riaffiorare, ossia può essere riprodotto al di sopra
della soglia grazie all’azione delle rappresentazioni che vi si trovano. Qualora, invece, si volessero indagare le forze nel loro sprofondare, l’analisi non disporrebbe di strumenti in grado di stabilire
i rapporti di uguaglianza ed opposizione, perché, in concomitanza
con lo sprofondare delle rappresentazioni, diviene impossibile
assegnare loro un preciso valore numerico e, nello specifico delle
relazioni musicali, si perde la capacità di determinare le ampiezze
intervallari ed i rapporti di forza negli accordi. Qui sta, a mio avviso, il senso del ricorso, forse abusato ma privo di alternative, alla
formula della soglia: essa costituisce il criterio generale secondo
cui le rappresentazioni si combinano nella coscienza, ragione per
cui l’analisi non può che scomporre le forze fino a che esse corrispondano a tali rapporti matematici. Gli intervalli musicali e gli
18 Per esempio, negli intervalli la consonanza è il risultato dell’assenza di
scontro fra le tendenze unificante e repulsiva, ma non si può generalizzare tale
definizione alle triadi perché, a causa delle molteplici attribuzioni delle parti
fratte dovute alla doppia frazione (ciascun suono viene scomposto dagli altri
due), non si riesce a stabilirvi se una data parte sia uguaglianza od opposizione, e, di conseguenza, non si può nemmeno calcolare la conflittualità fra le due
tendenze, in quanto dipendono da quella determinazione qualitativa.
184
N. MORO
accordi consentono di ricondurre alla formula della soglia le relazioni tra i loro elementi ed esse possono essere esibite mediante i
segmenti tonali rappresentati negli schemi, sia pure tramite varie
approssimazioni.
La varietà delle forze considerate ed il loro molteplice adattamento alla formula della soglia, quindi, appaiono legittimati dal
procedimento psicologico, che consiste appunto nella scomposizione delle rappresentazioni e nel loro successivo inserimento in
un sistema esplicativo che ne illustri (secondo rapporti matematici) le modalità di interazione, al fine di rendere comprensibile lo
svolgimento del flusso della coscienza.
Analoghe osservazioni valgono, a mio avviso, per quanto riguarda l’ulteriore differenza di approccio che distingue intervalli
ed accordi: in effetti, la formula della soglia si applica, nei primi, a
tutte le forze in gioco, ossia a tutte le parti derivanti dalla frazione
dei suoni, mentre negli accordi le quantità che compaiono nella
formula della soglia sono riferite esclusivamente ad un campione
delle forze, scelto all’interno di un unico suono, nella cui frazione
si rispecchierebbero funzionalmente i rapporti vigenti nell’intero
accordo.
La spiegazione della consonanza degli intervalli non avrebbe
potuto basarsi sulla frazione di una sola rappresentazione (una
sola nota estesa, come nel caso degli accordi), perché in essa compaiono soltanto due parti (un’uguaglianza ed un’opposizione),
mentre, secondo la psicologia herbartiana, occorrono almeno tre
forze per scatenare un conflitto nella coscienza19. Herbart è dunque costretto a ricorrere al totale delle forze in gioco, il cui rapporto finale può essere espresso, invece che direttamente in termini di
uguaglianza ed opposizione, nella loro formazione superiore in
tendenze: queste sono soltanto il risultato semplificato dello scontro tra le forze, o la traduzione di esso rispetto alle rappresentazioni, che si fondono ed impediscono esattamente nella misura indicata dalle due tendenze.
19 Se una rappresentazione soltanto si trova sulla scena della coscienza,
non vi è bisogno di frangerla, perché nessun’altra le si oppone; nel caso di due
rappresentazioni, invece, subentra necessariamente una frazione, perché due
rappresentazioni non possono dominare contemporaneamente la scena della
coscienza e va pertanto calcolato il rapporto in cui esse si spartiscono il dominio. Nella frazione di due rappresentazioni sorgono tre forze: l’uguaglianza che
esse hanno in comune e due opposizioni, una per ciascuna rappresentazione,
ed al rapporto di tre forze si può applicare la formula della soglia.
5. Osservazioni teoriche sulla psicologia del suono
185
Il diverso punto di vista che Herbart adotta per l’analisi degli
accordi trova una prima giustificazione di natura pragmatica: egli
è ben consapevole che l’uguaglianza non può essere la medesima
nei due intervalli che costituiscono l’accordo, perché essa viene
definita da due punti di vista diversi e reciprocamente irriducibili;
più semplicemente, i tratti di segmento tonale che la indicano non
coincidono per i due intervalli20. Inoltre, per completare il quadro
delle forze che intervengono in una triade, le opposizioni per le sue
tre rappresentazioni dovrebbero essere sei (ciascuno dei tre suoni
si oppone, infatti, ad entrambi gli altri), come emerge anche da un
passo delle Psychologische Untersuchungen21.
È ora evidente la complessità dell’elaborazione di una formula
matematica che esprima la relazione sussistente tra un numero
tanto elevato di forze; naturalmente non si tratta tanto di difficoltà
di calcolo, quanto di poter rendere adeguatamente conto delle
relazioni all’interno della coscienza. In essa, i rapporti di forza
vengono risolti e notevolmente semplificati attraverso la selezione
di fatto delle rappresentazioni più forti, che, connettendosi, instaurano un equilibrio e respingono le più deboli al di sotto della
soglia rappresentativa.
Inoltre, Herbart omette di specificare l’opportuna distinzione,
valida per le triadi, tra i singoli suoni e gli intervalli: la frazione di
ciascun suono componente, infatti, dà luogo a tre forze che si relazionano approssimativamente come indicato dalla formula della
soglia; tali rapporti si stabiliscono sul piano dei singoli suoni e tale
connessione a tre risulta irriducibile, ossia non ulteriormente
scomponibile in una somma di relazioni a due (corrispondenti agli
intervalli). Invece, affrontando il tema della dissonanza, spiegata
attraverso la compressione degli intervalli più piccoli in quelli più
grandi, l’argomentazione presuppone che l’accordo venga scomposto non più in singoli suoni, ma in intervalli: il legame a tre (o
quattro, per esempio nel caso degli accordi di settima) è quindi ora
riconducibile alla somma di più connessioni a due, tante quanti
sono gli intervalli che compaiono nell’accordo.
Per quanto riguarda l’analisi delle triadi, Herbart fornisce una
giustificazione che si basa sulla considerazione del rapporto dei tre
suoni al loro interno. Il confronto tra le varie frazioni specifiche
per ciascun suono, infatti, permette di legittimare la riconduzione
20
21
Cfr. fig. 6, supra, p. 129.
Cfr. PU, p. 82.
186
N. MORO
della molteplicità di rapporti a quelli evidenziati all’interno di un
suono soltanto, la cui struttura riproduce fedelmente anche i rapporti quantitativi esibiti dagli altri22. Ciò comporta una riduzione
della complessità, che non può tuttavia eliminare la consapevolezza metodologica rispetto all’astrazione compiuta per meglio condurre l’indagine: il dato – l’accordo udito – presenta un suono
(Klang) soltanto, nel quale tuttavia se ne fondono molteplici, ed il
compito dello psicologo consiste appunto nel risalire, mediante
l’elaborazione concettuale e la formalizzazione dei rapporti tonali,
alla pluralità di suoni che si compongono e si confondono nel tutto
udito. Il pensiero, quindi, introduce una separazione metodologica
e chiarificante, indispensabile alla comprensione razionale di quel
dato23 che si presenta pur sempre nella sua compattezza.
Sia la teoria musicale sia il procedimento herbartiano riconducono, poi, gli intervalli di maggiore ampiezza a somme di quelli più
piccoli, e, nel caso delle indagini psicologiche sulla musica, tale
relazione è all’origine della dissonanza. Quest’ultima consiste infatti senza eccezione in un rapporto problematico tra gli intervalli,
che, tuttavia, non si può in alcun modo leggere nei segmenti tonali
né trova ragion d’essere nella frazione reciproca dei suoni, mentre
quest’ultima costituisce, altrove, lo schema interpretativo privilegiato dall’indagine psicologica. Il piano dei rapporti intervallari,
pertanto, costituisce un criterio ulteriore, irriducibile a quello della
frazione, per valutare le relazioni tonali e consente di rendere conto di fenomeni fondamentali (quali la dissonanza o, ancora, la
determinazione delle terze in conformità alle triadi perfette) che
resterebbero altrimenti privi di spiegazione.
Non escludo la legittimità del doppio livello di lettura, che può
trovare fondamenti nella costituzione del suono e nella sua elaborazione teorica; non è neppure necessario assegnare alcuna priorità all’uno o all’altro modo di considerazione: ciò che manca, nella
trattazione herbartiana, è piuttosto l’esplicitazione della differenza
che pure sussiste tra i due piani di analisi e degli eventuali rapporti
che tra loro intercorrono. Essi rispondono all’esigenza di guadagnare un fondamento per la maggior parte delle relazioni armoniche,
nell’intento di compilare un quadro pressoché completo dei loro
principi psicologici, ma una teoria che riconduca fenomeni omogenei (quali sono quelli musicali) a fattori esplicativi reciprocamente
22
23
Cfr. PU, p. 97.
Cfr. PU, pp. 83, 121.
5. Osservazioni teoriche sulla psicologia del suono
187
irriducibili (o comunque privi di rapporti espliciti) paga inevitabilmente un alto prezzo in termini di sistematicità.
A questo proposito, la conseguenza teorica più marcata – e singolare – risiede nell’asimmetria delle definizioni di consonanza e
dissonanza, ossia di termini opposti che, in linea di principio, dovrebbero potersi ricavare dalla negazione l’uno dell’altro. Herbart
riconduce la consonanza al rapporto tra le parti fratte, la dissonanza, invece, alla pressione che sorge nella relazione tra gli intervalli:
in tal modo egli adduce eventi psicologici diversi ed estranei (nel
linguaggio herbartiano, “disparati”) a fondamento delle due categorie armoniche “contrarie”.
Un ulteriore aspetto problematico concernente la triade minore
deriva dalla mancata chiarificazione del livello dei suoni e degli
intervalli all’interno degli accordi. La giustificazione addotta per la
differenza tra maggiore e minore, infatti, si basa su di un criterio
che diverrà decisivo nel caso della dissonanza, ossia sulla compressione di un intervallo all’interno degli accordi. Tale spiegazione, che già Bagier taccia di finzione24, rischia oltretutto di rendere
incoerente la classificazione della triade minore come accordo
perfetto, proprio perché introduce un elemento che, appena rafforzato, genera la dissonanza25.
L’appello, nel caso delle triadi perfette, al criterio caratteristico
per la dissonanza, rende ancor più urgente la tematizzazione esplicita delle connessioni tra gli intervalli all’interno degli accordi,
perché, ove sorgano delle compressioni, gli intervalli stessi vengono in varia misura snaturati, perdendo quindi le proprie peculiarità armoniche. Se, quindi, nelle triadi perfette era parso necessario
ammettere che gli intervalli conferissero il proprio carattere consonante agli accordi in cui figurano, ciò viene parzialmente smentito nel caso dell’accordo minore, ed esso viene irrimediabilmente
allontanato da quella perfezione che pure gli spetta per definizione.
Cfr. G. Bagier, op. cit., p. 119.
È peraltro vero che, a causa del suo carattere meno perentorio rispetto al
maggiore, il minore non ha sempre goduto di una considerazione a tutti gli
effetti paritetica rispetto ad esso. Non vi sono tuttavia esplicite asserzioni che
permettano di ricostruire la posizione di Herbart in merito, ad eccezione
dell’esposizione delle peculiarità delle triadi perfette, che attribuisce innegabilmente parità ai due modi.
24
25
188
N. MORO
IV. Dalla psicologia alla musica: un percorso teorico
1. Un approccio preliminare
Le analisi psicologiche che Herbart conduce sulle relazioni musicali fondamentali rielaborano l’articolazione armonica del suono
e ne mostrano il progressivo sviluppo dal semplice al complesso.
In tal modo esse ripercorrono certamente l’indice di un qualsiasi
manuale di armonia, ma è possibile, a mio avviso, rintracciare un
ulteriore filo teorico che lega tra loro, svolgendole in maniera conseguente, anche le tematiche specifiche della scienza dell’anima.
Il primo compito che la psicologia deve assumersi consiste nella delimitazione del materiale stesso dell’indagine, al quale vanno
poi applicate le categorie scientifiche, saggiandone la consistenza
ed il valore predittivo. A fronte della continuità metafisica della
linea tonale e del sistema di relazioni in cui i suoni musicali sono
inseriti, si rende quindi necessaria una chiarificazione anche concettuale dell’oggetto in senso proprio della teoria musicale e della
sua costituzione psicologica.
La serie delle note che si combinano nella musica, infatti, è soltanto uno dei punti di vista dai quali considerare la successione
continua in cui i suoni si dispongono, e va preliminarmente spiegato come da questa si passi a quella. Se, poi, l’analisi è di tipo
psicologico, occorrerà anche selezionare il materiale secondo i
parametri propri della disciplina, considerando i suoni secondo le
modalità della loro presenza nella coscienza, nei rapporti reciproci
che essi vi istituiscono, prima ancora che sulla base delle connessioni canoniche offerte dalla musica.
Prendendo le mosse da un continuo di tipo matematico, caratterizzato da una densità infinita tra i suoi punti, si tratta poi di
proporne una scansione, e con ciò una discretizzazione, in virtù
della quale i punti vengano scelti in maniera necessaria sulla base
dei meccanismi psicologici. Se, al limite fra metafisica e psicologia,
si intende ora il continuo come il passaggio attraverso tutte le rappresentazioni possibili dei suoni, ordinate per altezza26 (la linea
tonale), vi saranno dei punti ad esso appartenenti i cui rapporti
d’altezza saranno suscettibili di una pura distinzione. Il criterio
26 L’ordine di altezza va, a mio avviso, ricondotto ad una valutazione di
grandezza, senz’altro pensabile come la retta matematica dei numeri, quindi
come una resa geometrica della successione e perciò indirettamente spaziale.
5. Osservazioni teoriche sulla psicologia del suono
189
della distinguibilità è innanzitutto di carattere euristico, perché è
implicita la funzione che esso assumerà, rispetto al continuo tutto,
nel costituire l’unità che si ripete costantemente, a garanzia della
densità omogenea del continuo. Al tempo stesso, la distinguibilità
è psicologicamente determinata, perché i punti che la segnano si
offrono con una propria evidenza percettiva27, e le rappresentazioni che loro corrispondono rimangono distinte – ma non disgiunte
– nella coscienza.
Considerando la tematizzazione specifica del materiale tonale
in questi termini, soltanto l’ottava risponde a tutti questi criteri: è
l’unità che si ripete regolarmente, presenta sempre la medesima
struttura interna, le rappresentazioni dei suoni che la compongono
non si fondono perché la loro opposizione è completa28. Il reperimento dell’ottava, dunque, avviene sulla base di premesse metodologiche ed euristiche, introdotte nell’indagine per garantire un
oggetto adeguato alla ricerca stessa, sul quale condurre poi tutte le
analisi opportune. L’ottava così individuata, quindi, non è un presupposto semplicemente ammesso per poterne derivare a piacimento tutti gli altri elementi, come sostiene Bagier29, ma si rivela
l’unica soluzione euristicamente proficua per stabilire il punto
d’inizio dell’approccio psicologico alla musica.
Congiungendo tra loro i due punti trovati in base alla teoria
della pura distinguibilità si ottiene un segmento che può essere
assunto a misura, perché lo si può collocare ripetutamente lungo la
linea continua, facendo combaciare le estremità delle sue iterazioni
successive. Inoltre, si può ulteriormente suddividere il segmento
27 La plausibilità anche fenomenologica di tale evidenza si può giustificare
con la coincidenza del punto di massima distinguibilità con la ripetizione
dell’uguaglianza completa: l’ottava è sì il luogo dell’opposizione completa, ma
il circolo che segna l’alternanza tra uguaglianza ed opposizione si chiude appunto con l’ottava, equivalente all’unisono, nel quale si rinnova dunque anche
l’uguaglianza completa che introduce un nuovo ciclo della relazione tra le due
forze.
28 Soltanto l’uguaglianza, infatti, determina la tendenza necessaria alla
unificazione.
29 Cfr. G. Bagier, op. cit., pp. 98-105. Il ruolo di presupposto che Bagier assegna alla concezione herbartiana dell’ottava come completa opposizione è
fondato sul fatto che, ammettendo un’ottava siffatta, risulta plausibile il procedimento herbartiano per ricavare tutti gli altri intervalli; in altre parole,
l’analisi dell’ottava in termini di uguaglianza ed opposizione conduce necessariamente alla concezione degli altri intervalli così come Herbart la presenta.
Mi preme ribadire, però, che l’ottava, a sua volta, è stata scelta in base ai criteri euristici e, se si vuole, epistemologici dell’indagine.
190
N. MORO
così ottenuto secondo criteri geometrici; analogamente, anche la
parte di linea tonale ora isolata è suscettibile di un’ulteriore scansione interna, i cui principi, tuttavia, non saranno più semplicemente geometrici, ma psicologici.
2. «Gli elementi primi della musica»
Dopo aver individuato nell’ottava la relazione psicologicamente
fondamentale, ci si può volgere alla ricerca degli elementi più
semplici che si possano distinguere lungo il segmento dato: essi,
propriamente, saranno punti, ma una loro determinazione è possibile solo indicandone, funzionalmente, la distanza che li separa
da ciascuna estremità del segmento cui appartengono. I criteri
psicologici dai quali dipende tale definizione sono i rapporti numerici che esprimono le proporzioni tra uguaglianza ed opposizione nei vari gradi del passaggio da un’estremità all’altra dell’ottava,
l’unità data.
Fra tutti i punti che così si potrebbero individuare, ve ne sono
alcuni per i quali il rapporto tra uguaglianza ed opposizione segna
una nuova situazione rappresentativa: le relazioni tra le loro forze,
infatti, assumono valori tali da comportare variazioni nell’equilibrio
sulla scena della coscienza e, quindi, alterazioni nel predominio di
talune rappresentazioni sulle altre. Si sono viste le ragioni psicologiche del cambiamento che avviene nei punti in questione e che va
ricondotto alle varie forme assunte dalla proporzione tra le forze
espressa dalla formula della soglia. I luoghi ove tali variazioni si
verificano corrispondono ai punti notevoli validi non soltanto per
le relazioni psicologiche (tra rappresentazioni), ma anche per la
musica. Sulla base dei rapporti fondamentali già stabiliti per uguaglianza ed opposizione si può ora calcolare la distanza reciproca di
quelli che diverranno gli intervalli musicali, incominciando
dall’unisono ed avvicinandosi all’ottava. A rigore, solo tracciando
tali punti lungo il segmento di linea tonale e confrontandoli con le
indicazioni fornite dai musicisti circa l’ampiezza degli intervalli se
ne scopre la coincidenza – sia pure semplicemente approssimativa.
A questo punto trova giustificazione il fatto che, nell’analisi della musica, la considerazione degli elementi semplici non verta in
realtà sui singoli suoni, come ci si potrebbe attendere, bensì sulle
relazioni intervallari che tra loro intercorrono. Ciò si desume sia
dal procedimento argomentativo herbartiano, che di fatto ignora i
5. Osservazioni teoriche sulla psicologia del suono
191
suoni singolarmente presi, sia da una fugace, ma illuminante apposizione, che fa riferimento «agli intervalli di suoni semplici, agli
elementi primi della musica»30. Se, da un punto di vista metafisico, il semplice detiene il primato logico rispetto ai rapporti in cui
viene poi calato, la psicologia non può metodologicamente varcare
la soglia che separa la relazione dall’irrelato, così che i suoi elementi primi consistono nelle relazioni più semplici cui le sia dato
pervenire e mai nei membri stessi del rapporto.
Herbart si serve, a questo punto, della rappresentazione grafica
del segmento tonale, inteso come estensione del suono all’ottava:
si tratta, naturalmente, di una schematizzazione, della quale si
possono ora valutare pregi e difetti. Rispetto alle tacche, va notato
che la distanza costante che le separa non corrisponde esattamente
alla grandezza degli intervalli temperati; si tratta, semmai, del
modo più semplice per rappresentare una serie nella quale si presupponga una certa omogeneità. Le distanze che vi figurano sono
necessariamente finite, ma esse fungono da esibizione notevolmente semplificata della successione delle grandezze psicologiche
(tra le quali figurano numeri periodici ed illimitati) che Herbart ha
determinato servendosi di vari passaggi matematici.
Un ulteriore elemento che distingue la rappresentazione schematica del segmento tonale dal calcolo delle parti psicologiche
risiede nella maggiore complessità della frazione dei suoni in uguaglianze ed opposizioni. Ciascun singolo suono, nel rapporto
con gli altri, subisce effettivamente una frazione in due parti solamente (una di uguaglianza ed una di opposizione), ma, già nel
calcolo delle proporzioni dell’intervallo, le parti da considerare
sono almeno tre, se l’uguaglianza viene considerata come intero (a
rigore, essa consiste di due metà, alle quali si aggiungono poi le
opposizioni di ciascun suono). È quindi evidente che la schematizzazione riesce nella semplificazione cui è finalizzata, ma rischia di
cancellare la complessità degli elementi di cui pure deve dar conto.
3. La consonanza: intervalli e triadi perfette
Dalla considerazione degli intervalli semplici, il filo logico delle
riflessioni herbartiane passa alla combinazione di almeno due di
essi negli accordi, che pone insieme la questione della consonanza.
30
SW, VI, p. 69.
192
N. MORO
Quantunque l’approccio metodologico della frazione sia diversificato negli intervalli e negli accordi, è qui opportuno riproporre
congiuntamente i due aspetti, al fine di misurarne l’analogo significato rispetto al problema della consonanza.
Gli intervalli si basano, a livello psicologico, sul rapporto tra le
forze derivante dalla scomposizione, o frazione, delle loro unità
costitutive (le note estese) in parti di uguaglianza ed opposizione.
S’intende che sussiste una certa affinità sia delle opposizioni fra
loro sia, dall’altro lato, delle uguaglianze fra loro: tale affinità permette di astrarre dalla molteplicità delle parti, per considerarle
soltanto secondo la loro diversa qualità di uguaglianza e di opposizione. A questo livello superiore si sviluppano le due tendenze,
unificante e repulsiva, che sortiscono effetti contrapposti e che si
trovano in un conflitto reciproco. La consonanza degli intervalli è
stata spiegata proprio in base alla stabilità o meno che segue allo
scontro, a seconda che il rapporto tra le tendenze sia tale da permettere all’una di affermare il proprio dominio sull’altra (consonanza) o che esse siano di entità troppo simile perché una possa
vincere l’altra, situazione che corrisponde all’insolubilità del conflitto stesso (dissonanza).
Le triadi perfette si compongono di due intervalli di terza, che
ne formano uno di quinta. Parrebbe conseguente ritenere che la
loro consonanza risulti dalla combinazione di tutte le parti di uguaglianza ed opposizione degli intervalli costituenti, analogamente a quanto descritto per gli intervalli, ma ad un livello superiore di
complessità. Herbart, invece, ha qualche ragione per semplificare
notevolmente il procedimento, ricorrendo alla quantificazione
(senza l’attribuzione delle qualità di uguaglianza ed opposizione)
delle parti in cui una soltanto fra le note dell’accordo viene fratta.
Il filo logico che applica gli stessi criteri esplicativi a fenomeni
omogenei, quale che sia il loro grado di complessità, è ora spezzato.
Lo stesso Herbart, peraltro, provvede a riannodarlo, soltanto
un po’ più indietro. Con la sua semplificazione, infatti, egli ritorna
al punto della frazione, che viene ora riproposta nella variante per
tre note (l’accordo) anziché due (l’intervallo). Riprendendo il rapporto fra le parti della frazione ed applicandovi, come di consueto,
la formula della soglia, egli giunge a stabilire la proporzione che
deve sussistere tra le parti affinché producano una situazione non
conflittuale nella coscienza (consonanza). Una volta trovato che
5. Osservazioni teoriche sulla psicologia del suono
193
essa coincide proprio con – e soltanto con – la proporzione fra le
parti nelle triadi perfette, si è con ciò ricavata la ragione psicologica della loro consonanza e del monopolio per cui le triadi perfette,
uniche tra gli accordi, sono consonanti.
Il filo argomentativo herbartiano, quindi, mantiene una certa
coerenza, che si basa sull’appello alla frazione ed alla formula della
soglia come leggi generali della relazione reciproca tra rappresentazioni. Quando, infatti, i rapporti di forza tra le parti fratte sono
riconducibili alle proporzioni espresse dalla formula della soglia,
l’equilibrio nella coscienza è garantito dal fatto che la risoluzione
del conflitto è matematicamente certa – e musicalmente consonante.
4. Dalla dissonanza al temperamento equabile
Con le frazioni degli intervalli e delle triadi perfette non si esauriscono né le frazioni possibili né quelle in cui la musica trova il
proprio materiale. Si tratta, a questo punto, di analizzare e vedere
quali altri tipi di frazione presentino peculiarità psicologiche tali
da renderle suscettibili di un uso armonico-musicale.
Nella prospettiva qui delineata trova spazio la trattazione herbartiana degli accordi dissonanti, in particolare quello diminuito e
quelli di settima, per i quali, però, occorre anche mutare significativamente punto di vista rispetto alla considerazione delle triadi
perfette. La dissonanza negli accordi sorge, infatti, dalla difficile
convertibilità della somma di almeno due intervalli in uno più
grande e va ricondotta alla pressione che gli intervalli sommati
esercitano finché non trovino spazio sufficiente nell’accordo che
pure dovrebbe contenerli.
Tutte le spiegazioni si erano finora basate sulla frazione delle
rappresentazioni e sulle parti che ne risultano; adesso, invece,
occorre anche operare con esse, sovrapponendole e confrontandole. Se, fin qui, si poteva presupporre un segmento omogeneo nelle
sue parti, ora ne vanno evidenziate le tensioni interne, dovute alla
convertibilità soltanto approssimativa degli intervalli fra loro. In
questo senso la rappresentazione grafica offerta da Herbart continua a mostrare, sì, le proporzioni fra le parti, ma non è più sufficiente ad indicare il luogo del problema e perde in perspicuità
rispetto all’analisi.
194
N. MORO
I valori ottenuti in sede di determinazione psicologica della
ampiezza degli intervalli, considerati in ordine di grandezza, si
discostano dai punti corrispondenti alla semplice moltiplicazione
di un’unità minima, che si potrebbe altrimenti prendere a riferimento per tutte le relazioni tonali (il semitono temperato). Ne
segue che, sovrapponendo la somma di due intervalli ad uno ad
essi maggiore, essa ne risulta inevitabilmente superiore, e proprio
da un’incongruenza di questo tipo sorge la pressione che, negli
accordi, è sentita come dissonanza. Tale scarto non è, come tale,
razionalmente ammissibile ed esige, perciò, una soluzione che lo
elimini e, al di là delle soluzioni specifiche che Herbart propone in
accordo con la prassi musicale, è opportuno analizzare ancora una
volta la struttura logica dei problemi in questione.
Il pianoforte accordato esemplifica per antonomasia il temperamento equabile, che assegna a tutti i semitoni una grandezza
costante, e risulta affatto adeguato a far apprezzare la dissonanza e
la sua risoluzione. La proposta herbartiana di sperimentare
l’effetto dissonante al pianoforte scordato, poi, mirava ad illustrare
come la dissonanza vera e propria sia intimamente connessa con
l’esatta estensione degli intervalli, ossia con la pressione che si
scatena quando essi non trovino l’ampiezza loro propria. A questo
punto, è difficile resistere alla tentazione di rimandare la soluzione
della questione della dissonanza ancor oltre le leggi psicologiche e
quelle musicali, collegandola direttamente con il temperamento
equabile.
Il sistema temperato offre un’organizzazione modulare e combinatoria del materiale tonale, che lo rende internamente più omogeneo ed idoneo all’uso musicale. In tal modo, viene agevolato
il lavoro di connessione non soltanto delle ottave tra loro, ma anche dei segmenti minori ad esse interni, escludendo per definizione la possibilità di una compressione degli intervalli simile a quella
che si dà in psicologia. La percezione e tutto il suo portato psicologico, tuttavia, non si lasciano facilmente sottomettere alle soluzioni razionali adottate per una maggiore operabilità tecnica, e tendono a riconquistare le dimensioni loro proprie: sussiste dunque
una tendenza a riportare gli intervalli temperati alla loro ampiezza
psicologica, rendendo precarie (ma, si anticipa, musicalmente
ricche) alcune delle connessioni interne al sistema temperato.
Confrontando le ampiezze intervallari temperate con quelle reperite per via psicologica, emerge che il temperamento equabile
5. Osservazioni teoriche sulla psicologia del suono
195
comprime gli intervalli nella loro determinazione psicologica analogamente a quanto accade negli intervalli psicologici stessi (o,
almeno, in quelli di maggiore estensione). Entrambe le determinazioni, temperata e psicologica, degli intervalli dissonanti (quinta
diminuita e settime) sono tali da provocare la tensione tra gli intervalli addendi, e questo fenomeno è appunto l’artefice del tipo di dissonanza di cui ci si serve in musica. Ciò avviene esattamente nella misura – anche e soprattutto psicologica – in cui è possibile, successivamente, recuperare un equilibrio stabile, nel quale si risolva il conflitto
scatenato tra le parti, concedendo loro lo spazio che pretendono.
La necessità del passaggio al temperamento, rispetto alla dissonanza, risiede nella discrasia che sorge tra gli intervalli psicologici e l’estensione che il sistema basato sul calcolo assegna loro.
Tale scarto assume proprio la grandezza psicologica necessaria a
giustificare la tendenza ad una diversa proporzione fra le parti,
che, musicalmente, corrisponde alla risoluzione della dissonanza in
un accordo consonante. Sono, peraltro, le tensioni dissonanti ad innescare la transizione al successivo, ampliando la dimensione verticale
dell’armonia alla distensione temporale della melodia, nei limiti posti
dalla concezione prevalentemente armonica della musica: ciascuna
voce deve presentare una coesione interna, sviluppata in rigorosa
conformità con l’articolazione verticale del tessuto armonico.
Oltre alla riconduzione della dissonanza allo scarto tra le ampiezze intervallari, la novità introdotta da Herbart concerne la
giustificazione del temperamento equabile da un punto di vista
psicologico, che permette di apprezzare maggiormente la proficuità del sistema temperato, ben al di là del suo valore strumentale. Il
ricorso al temperamento per ragioni tecniche (e di razionalizzazione), dunque, costituisce insieme il fondamento di uno fra gli aspetti più rilevanti dell’armonia musicale, ossia la necessità di risolvere
la dissonanza, ed entra perciò in intima connessione con il pensiero musicale stesso. Non si tratta più, semplicemente, di una convergenza esteriore, ma dell’uso sapiente che una tecnica artistica
sa fare delle legalità psicologiche e degli accomodamenti pragmatici insieme.
5. La distinzione della seconda
La legalità psicologica incontra, invece, varie difficoltà quando
venga chiamata a rendere conto delle seconde, per la cui trattazione
196
N. MORO
Herbart introduce criteri non applicati agli intervalli ed accordi
delle precedenti indagini: un analogo della nozione metafisica di
autoconservazione, la distinzione tra rappresentazione originaria e
modificata (rafforzata) con l’aggiunta della metà uguaglianza, la
riproduzione confusa della rappresentazione della fondamentale.
Il ricorso a categorie eccezionali di analisi accomuna quindi tutti i
punti di vista della tematizzazione della seconda, e pare legittimo
generalizzare a tutte le seconde la già citata affermazione, ovvia
eppure rilevante, che Herbart riferisce all’intervallo melodico omonimo: «La seconda viene udita come un altro suono, che non è
del tutto il primo»31.
Alla difficoltà della fondazione psicologica di un dato, la seconda, che si sottrae al consueto metodo esplicativo, fa riscontro
l’appello herbartiano alla rappresentazione semplice ed assoluta,
non ancora irretita nelle relazioni della coscienza: essa compare
dichiaratamente nella distinzione tra rappresentazione originaria e
modificata e, implicitamente, anche nella riproduzione, confusa o
meno, della rappresentazione, giacché tale riproduzione presuppone qualcosa da riprodurre, e si tratta appunto della rappresentazione semplice già data di un suono.
Da un punto di vista teorico, la seconda costituisce il complementare dell’ottava rispetto al problema della distinguibilità:
nell’ottava, infatti, l’opposizione completa giustifica e fonda la
distinzione logica dei suoi estremi, che, nondimeno, ha per risultato la loro equivalenza armonica; questa, a sua volta, finisce per
costituire, musicalmente, un’identità, che funge da presupposto
per la trasponibilità delle ottave l’una di seguito all’altra. Quanto
alla seconda, invece, si fatica ad addurre una ragione logica e, soprattutto, psicologica per la distinzione delle sue note componenti,
eppure la differenza al suo interno è inequivocabilmente data ed
irriducibile.
La prassi musicale si serve della seconda minore, come semitono, quando introduce gli accidenti: in questo modo, una nota mantiene la stessa denominazione pur oscillando di un intero tono tra
il suo bemolle ed il suo diesis. È chiaro che, musicalmente, la differenza di altezza di un semitono è significativa e la sua importanza
scontata, così come ne è certa anche la distinzione a livello percettivo: per la seconda manca ancora, semmai, un criterio logico (per la
31
PU, p. 105.
5. Osservazioni teoriche sulla psicologia del suono
197
scansione del continuo) e, insieme, psicologico (per la definizione
del rapporto in termini di uguaglianza ed opposizione) analogo al
principio dell’identificazione degli altri intervalli.
Il problema posto dalla seconda, inverso a quello dell’ottava,
consiste allora in una distinzione senza distinguibilità. Con una
proposta che prende soltanto spunto dal dettato herbartiano, si
potrebbe leggere in questa formulazione della questione la necessità di ricorrere, per la seconda, ad un criterio di determinazione
altro da quello adatto agli altri intervalli. Nella sua datità irriducibile eppure non spiegata, la seconda sembra esigere un ulteriore
avvicinamento alla rappresentazione semplice, non ancora modificata dalle relazioni nella coscienza. Seguire tale procedimento,
tuttavia, significa imboccare la via della massima approssimazione
al dato, nella sua più schietta qualità, ed insieme della più grande
astrazione da esso, alla ricerca di quel semplice che va, sì, presupposto, ma non è mai oggetto immediato d’esperienza diretta.
Un’impostazione del genere, inoltre, pretende che si varchi il
limite di semplicità già posto per gli elementi della musica: esso è
stato finora reperito negli intervalli, in funzione dei quali soltanto
ha senso parlare di note singole, in quanto loro costituenti; al contrario, nella seconda si deve piuttosto astrarre ulteriormente, per
raggiungere davvero il suono nel suo isolamento più completo. La
psicologia si impegna così a descrivere le modalità percettive basilari, risalendo, per quanto possibile, alla genesi delle sensazioni
particolari più semplici. Emerge, a questo punto, tutta la distanza
che intercorre rispetto alle posizioni kantiane: se, da un lato, la
psicologia herbartiana propone una ridiscussione dell’estetica e
della logica trascendentale, occupandosi della costituzione della
oggettualità, dall’altro, si misura la differenza dell’approccio di
Herbart, che indaga la genesi esperienziale dell’oggetto ed istituisce un collegamento tra quaestio iuris e quaestio facti, i due poli
che Kant riteneva inconciliabili.
Se «la paradossalità è una delle caratteristiche della filosofia
herbartiana»32, questo ne è un esempio. Da una parte, infatti,
l’appello al dato assume, nel caso della seconda, un’urgenza maggiore che negli altri intervalli, effettuando il tentativo di scendere
al livello più basso della percezione; dall’altra parte, si deve fronteggiare un’esperienza inevitabilmente sfuggente, che fa intuire
32 R. Pettoello, «Introduzione», in J. F. Herbart, Punti principali della metafisica, cit., p. X.
198
N. MORO
una differenza senza lasciarne scorgere gli elementi, e necessita
quindi di un’ennesima integrazione nel pensiero: occorre instaurare una relazionalità che, se non è data, va tuttavia pensata.
In tal senso, la questione della seconda funge da complementare teorico all’ottava perché, con il suo richiamo al dato percettivo
quasi immediato33, àncora all’esperienza la logica musicale imperniata sull’ottava, fissandone un elemento che, dal basso, deve prestarsi in realtà a spiegare anche i fenomeni più complessi. Oltre al
semitono, che vede nella seconda la distanza costante tra gli intervalli, è una seconda a dar conto, in ultima analisi, della dissonanza
negli accordi e delle loro formule risolutive – mentre la dissonanza
non dipendente dalla seconda, come quella dell’accordo diminuito,
non ammette una vera risoluzione – così come delle autoconservazioni che, negli intervalli melodici, provocano la connessione con
la sensibile, anche quando si voglia mantenere la fondamentale
come sottostante a tutti i gradi della scala.
L’ottava, dunque, fissa l’unità entro la quale, poi, è l’intervallo
di seconda, con le relazioni che esso rende possibili, ad offrirsi
come elemento psicologico irrinunciabile ed a produrre alcuni tra
gli effetti musicalmente più significativi.
V. La logica secondo Zimmermann
Zimmermann ha richiamato l’attenzione sulla natura logica del
continuo tonale herbartiano34: secondo la sua analisi, Herbart
sovrapporrebbe ad un continuo matematico, caratterizzato dal
fatto che tra due punti ve ne è sempre un terzo tra essi compreso,
un continuo logico, che, invece, non ammette alcun terzo punto tra
due contigui. In sostanza, per Zimmermann, Herbart avrebbe preso una serie di suoni, che ripetono all’infinito (nelle due direzioni
di una retta) rapporti finiti35, costruendo un continuo ulteriore che
33 Nel ‘quasi’ va inteso il ricorso al limite, così caratteristico della speculazione herbartiana, che rivela ad un tempo la consapevolezza metodologica
dell’indagine e la finezza delle soluzioni teoriche proposte (cfr. R. Pettoello,
L’objet et ses limites, cit.).
34 R. Zimmermann, op. cit.; oltre ad analizzare il procedimento herbartiano rispetto alla teoria musicale, la relazione di Zimmermann è tutta tesa a
mostrare la convergenza strutturale della psicologia della musica con la filosofia pratica di Herbart, in particolare con le cinque idee morali.
35 Cfr. ivi, p. 17.
5. Osservazioni teoriche sulla psicologia del suono
199
è una commistione di quello logico, con la successione all’infinito
di elementi discreti contigui, e di quello matematico, nel quale
l’infinito si trova anche nel piccolo (infinitesimale). Da tale combinazione – se non proprio confusione – sorge la linea tonale, lungo
la quale si distinguerebbero le relazioni intervallari per eccellenza
(ottava, quinta diminuita, quinta, quarta, seconda).
Nella sua ricostruzione teorica, Zimmermann si lascia però
sfuggire, a mio avviso, una distinzione indispensabile alla comprensione del discorso herbartiano ed assolutamente coerente con
il sistema in generale: la linea tonale, in realtà, è densa esattamente quanto il continuo matematico (tra due punti ne è sempre compreso un terzo), essa assume uno statuto a priori e, come tale, non
è data nell’esperienza. Costituito da elementi discreti è, propriamente, soltanto il materiale tonale utilizzato nella musica36. La
posizione di un continuo tonale a priori rappresenta l’opportunità
di cui il pensiero dispone, a livello metafisico, per fondare la possibilità e la plausibilità di quanto avviene a livello psicologico.
I punti notevoli che si distinguono lungo la linea tonale vengono definiti in base alle stesse leggi psicologiche che concernono i
rapporti fra uguaglianza ed opposizione, quindi la loro corrispondenza con le relazioni tonali della musica sancisce più il successo
esplicativo della psicologia che non quello del modello di formalizzazione adottato, ossia ciò che, per Zimmermann, è la sovrapposizione di una struttura logica ad una matematica. Inoltre, il calcolo
dei punti notevoli deve presupporre necessariamente una linea
tonale continua che ripeta una densità di tipo matematico, almeno
per salvare la coerenza con i risultati ottenuti da Herbart, nei quali
ricorre, con una certa frequenza, la radice di due. I calcoli eseguiti,
peraltro, riguardano gli intervalli nella loro ampiezza psicologica,
che non sono immediatamente quelli musicali, pur essendo suscettibili di una ridefinizione nel contesto delle relazioni fra intervalli e
temperamento.
36 A rigor di termini, poi, anche il materiale tonale del quale la musica si
serve è già molto più denso di quello ammesso da Zimmermann (che considera solamente ottava, quinta diminuita, quinta, quarta e seconda) e pure di
quello costituito dall’allineamento per altezza delle note di una scala. Almeno
il ricorso agli intervalli non temperati da parte del cantante o del violinista
rimanda, infatti, ad una particolare densità in corrispondenza dell’“intorno” di
quelle note che ammettono varie determinazioni a seconda del contesto armonico.
200
N. MORO
Allora non desta più stupore il ricorso ad una struttura matematica del continuo ai fini dell’elaborazione concettuale della linea
tonale, la cui essenza supera di gran lunga la mera somma di tutte
le scale possibili. Così essa soltanto può garantire una costruzione
psicologica del materiale tonale che non si riduca a semplice elenco di elementi musicali già presupposti.
Secondo l’interpretazione di Zimmermann, inoltre, non si potrebbe giustificare in alcun modo la difficoltà, per esempio, di individuare con precisione l’estensione della terza: assumendo la
possibilità di molteplici metodi per la determinazione degli intervalli e senza presupporre il temperamento equabile37, la varietà di
suoni a disposizione è davvero molto superiore a quella effettivamente utilizzata, nella teoria come nella prassi musicale, e maggiore di quella che, calcolata psicologicamente, le si vuol far corrispondere. È evidente che le note nelle scale non si trovano sullo
stesso piano del continuo tonale dei suoni possibili, ma tale distinzione risponde all’esigenza teoretica di dar conto dell’omogeneità
soltanto tendenziale di una serie discreta di suoni, e tutto ciò si
realizza anzitutto a partire logicamente dal piano metafisico della
continuità di tipo matematico.
VI. Teoria musicale e psicologia
Il percorso che ha delineato le relazioni tonali musicalmente significative da un punto di vista psicologico è suscettibile di
un’ulteriore lettura nei termini di un’analisi logica della musica,
della quale emergono ora gli elementi costitutivi38. La serie dei
suoni continua più in basso di quello più grave e più in alto di
quello più acuto (i limiti, semmai, sono di natura fisiologica ed
acustica, non musicale); tra una nota e l’altra si collocano le loro
alterazioni, che non sempre coincidono enarmonicamente tra loro
37 Al di fuori del sistema temperato, infatti, non è ancora stabilita la validità di principio delle equivalenze enarmoniche, per esempio, di fa diesis e sol
bemolle, ma anche di fa doppio diesis e sol, che sarebbero tutti suoni diversi
l’uno dall’altro.
38 Non si tratta, chiaramente, di un elenco completo né esaustivo, perché
esso vale soltanto nei limiti in cui Herbart ha dato conto della musica da un
punto di vista psicologico. Vi sono molti altri parametri musicali oltre a quelli
trattati da Herbart, basti citare il timbro, la dinamica e l’agogica, ma non si
vorrà ridurre la portata teorica delle analisi svolte per i loro ovvi limiti storici.
5. Osservazioni teoriche sulla psicologia del suono
201
e rendono così plausibile il riferimento ad un continuo denso. Le
note, il materiale discreto di cui la musica si serve, sono ordinate
secondo rapporti di grandezza, gli intervalli, suscettibili di ulteriori
combinazioni tra loro, a formare accordi e successioni melodicoarmoniche. Su questa base trovano fondamento anche consonanza
e dissonanza, che, almeno secondo Herbart, rappresentano relazioni particolarmente rilevanti per la musica, il cui carattere immediatamente dato può essere ricostruito anche a partire dalla
combinazione degli elementi psicologici già a disposizione.
Si è dunque rinvenuta una struttura comune a teoria musicale e
psicologia, che si sviluppa dal semplice al complesso e riesce, nel
generale più che nel particolare, a dar conto dei fondamenti della
dottrina dei suoni.
Le frequenti obiezioni specifiche mosse contro l’una o l’altra
spiegazione proposta da Herbart lasciano emergere un limite che
riguarda in generale le sue analisi. Si è notato come egli muti spesso il punto di vista, facendo ora riferimento alle rappresentazioni,
ora alle forze loro interne, poi, ancora, prendendo in considerazione le rappresentazioni originarie e passando poi a quelle modificate. In certa misura, gli riesce in tal modo di render conto dei fenomeni codificati dalla teoria musicale e di sviluppare anche un percorso teorico conseguente. Questo suo successo, tuttavia, non gli
permette di evitare varie complicazioni eccessive dell’analisi e
perfino qualche incoerenza con i presupposti generali: essi, infatti,
paiono talora incapaci di offrire una spiegazione complessiva dei
fenomeni, lasciando il campo a metodi reciprocamente estranei o
ipotesi ad hoc.
Il passaggio dall’impostazione psicologica generale alle sue applicazioni particolari nell’ambito della dottrina dei suoni si rivela
dunque privo di linearità, giacché il dato empirico si sottrae parzialmente alla forte modellizzazione che gli viene imposta e la sua
integrazione a livello concettuale non coglie sempre nel segno.
Vacilla pertanto il risultato metodologico cui tutte le analisi herbartiane sono tese, ossia la conferma epistemologica della psicologia che sarebbe dovuta emergere dall’applicazione dei suoi principi
alle relazioni tonali.
Cade, così, la cornice generale delle indagini sulla musica, ma
questo fatto non equivale alla condanna senza appello delle teorie
herbartiane, come pure tanti critici hanno voluto. A mio avviso, invece, resta saldo il valore teorico delle analisi svolte e dell’approccio
202
N. MORO
relazionale che le sostiene. Herbart elabora una dottrina dell’anima
fondata sui rapporti rappresentativi, che rompe radicalmente con
la concezione sostanzialistica tradizionale (esemplificata dalle
varie facoltà); anche la sua metafisica si distingue per la rilevanza
assegnata ai rapporti tra enti logici e non sostanziali. Herbart concepisce la musica come un sistema relazionale che, grazie alla codificazione elaborata dalla teoria musicale, esibisce con particolare
evidenza le proprie peculiarità ed i rapporti vigenti al suo interno.
Il tentativo di ricondurre anche i fenomeni musicali alla struttura
relazionale della psiche, cercando di fondare i rapporti armonici
sui rapporti rappresentativi nella coscienza risulta pienamente
coerente con l’eliminazione di ogni residuo sostanziale e segna la
volontà di guadagnare un fondamento oggettivo alla speculazione.
In un periodo in cui la psicologia muoveva i suoi primi passi come
autonoma disciplina scientifica, i saggi herbartiani testimoniano
l’avvio di una linea di ricerca che ha aperto la strada alle ricche
indagini della Tonpsychologie, sia pure passando attraverso la
critica di parecchi presupposti herbartiani.
Oltre all’indubbio valore storico dei lavori herbartiani, ne va
sottolineato anche quello teorico, che il lettore odierno può tuttora
apprezzare: la pregnanza assegnata alla dimensione armonica
rispecchia le concezioni musicali dell’epoca e funge da base per la
conseguente impostazione dell’analisi psicologica dei dati musicali, che ne illustra le relazioni di volta in volta decisive rispetto al
contesto armonico. Lo stesso schema interpretativo proposto per il
percorso seguito da Herbart mette in luce la coerenza di fondo
dello svolgimento delle questioni, quantunque essa vada spesso
perduta nelle soluzioni specifiche delineate. Infine, la trattazione
dell’ottava rivela un approccio consapevole alle strutture musicali
ed articola l’indagine in maniera tale da far emergere l’intera morfologia delle relazioni tonali. Il tentativo herbartiano di fondare
psicologicamente la musica ha pertanto condotto all’analisi delle
strutture che in essa ricorrono e tale analisi conserva la propria
validità logica anche quando le venga sottratta la valenza psicologica che pure Herbart credeva di aver ottenuto.
Gli elementi spiegati costituiscono soltanto una parte di tutti
quelli che di fatto intervengono nell’arte dei suoni: si sono indagate le relazioni tonali, non ancora la musica intera né tutti i suoi
aspetti; non sussiste, infine, alcuna volontà riduttiva rispetto alla
5. Osservazioni teoriche sulla psicologia del suono
203
complessità ed alla stratificazione della musica, che, in quanto
arte, è oggetto dell’estetica almeno quanto lo è della psicologia.
Si potrebbe, per esempio, cercare una spiegazione per il procedimento, tipico dell’analisi psicologica della teoria musicale, che
consiste nell’assumere un punto di vista per la considerazione
delle note, che le pone in una multiforme connessione reciproca,
negli intervalli e poi, ancora, negli accordi. In realtà, in una prospettiva prettamente armonica, le combinazioni tra i suoni vengono classificate anzitutto secondo il grado di stabilità, ossia di consonanza. Il procedimento herbartiano, al contrario, si basa sulla
scansione tutta psicologica dei casi fondamentali nel rapporto fra
uguaglianza ed opposizione o fra le parti fratte: il loro valore armonico, sempre determinato, è soltanto la conseguenza del rapporto sussistente su di un piano superiore, quello sancito dalla
formula della soglia; la musica, da parte sua, si giova di tali relazioni ad un livello estetico, che Herbart non oserebbe mai ridurre
né sminuire.
Psicologia ed estetica risultano infatti intrecciate nella condivisione di uno stesso materiale d’indagine, e tanto più nel caso della
musica. Allo stesso tempo esse si mantengono affatto distinte,
perché considerano le relazioni o l’arte con cui hanno a che fare
secondo criteri estremamente diversi e, in parte, riguardano anche
oggetti diversi: i suoni o la musica, le connessioni psicologiche
delle rappresentazioni o le loro peculiarità armoniche ed estetiche.